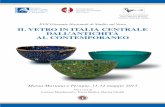Uniti dallo schermo. Il Risorgimento nel cinema italiano
-
Upload
independentscholar -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Uniti dallo schermo. Il Risorgimento nel cinema italiano
...t.f .,B...6.:l.rl;I.....,.. 2. o..I,I:,l..' )r §,ò,!.,'5;;ivèi§àrior,rU-nitàrr d'l I ralià
Quaderni dell'Ac cademiaAccademia []dinese di Scienze, Lettere e ArtiNUMERO UNICO 2OO9.2OI1
ffi:' ,1r-.,J.u+;i Ì-t;}ji r,lrl
Questa rivistaesce con il contributo dellaFondazione Cassa di Risparmiodi Udine e Pordenone
FONDMIONEC{'
Quaderni dell'Accademia
Anni XI - XII - XIII, Numero unico 17, 2009-2011
Direttore responsabi le
Gaetano Cola
Direttore di redazione
Massimo Bortolotti
Redazione
Francesca Agostinelli, Alberta Maria Bulfon,Ugo Falcone, Enrico Folisi,Bruno londero, Paolo Tomasella,Marco Maria Tosolini, Simone Volpato
Comitato scientificoGiuseppe BergaminiGiovanni ComelliGianfranco ElleroRoberto ForamittiGiuseppe FornasirGiovanni FrauGianpaolo GriFederico MarconiGian Carlo MenisIvonne Pastore ZrnarolaPaolo PecorariUgo RozzoCesare ScalonBruno Vidal
Ditaionc e Ammin is trazi o n e
Accademia Udinese di Scienze, Lettere e ArtiP|zualeCadorna, I - Udine
frrur{,lOGVhlmanova
ttufudorg ùl trifunab di UdineN- rSdd t6l9lr995
*Étcitnrc hfo"t". Gli oiginali dci testi, i disegni e le
*;frliial wn i rctiatisono, salao preaentiai accordi con laE*rulr,
giùbic&ophioni compete ai singoli Aamri.
.:1P l 4É:'+.er:$:$§si:lij: i t::;i :
Quiderni dell'AccademiaAccademia (Jdinese d.i Scienze , Lettere e Arti
t7
NUMERO UNICO 2009.2rfi
mmdrto
Editoriale
SAGGI
Uomini d'arme e di pensiero del Risofgimento friulano
Ritratti e annotazioni biografiche
di Enrico Folisi
La cravatta rossa
Tita Marioni, un sogno repubblicano nel Risorgimento d'Italia
di Luca De Ckra'\,
La questione ferroviaria in Friuli prima e dopo l'Unità. d'Italia
di Romano Wcchiet
«Gioisci delle arance che raccogli,,.
Caratteri della prosa di Antonio Caccianiga (1823-1909)
di Andrea Romano
Uniti dallo schermo. Il Risorgimento nel cinema italiano
di Enrico Biasin
Note a margine della mostra udinese per i 150 anni dell'Unità d'Italia 81
di Ugo Falcone
La mostra udinese per il 150' anniversario della scomparsa
di Ippolito Nievo
di Francesca Thm burlini
.-v
39
51
63
69
85
IJ niti dallo schermo.
Il Risorgimeruto rue I ciruemt italiano
Vorrei iniziarc, innanzitutto, da una constatazio-ne storica essenziale. Quando rifettiamo sul genere
di cinema che nel corso del Novecento ha effettiva-mente rappresentato l'Italia sul grande schermo e,
contestualmente, unito gli italiani al proprio Paese,
proviamo una certa difficoltà nel ricordare film qua-li Senso (1954) di Luchino Visconti o 1860 (1934)di Alessandro Blasetti. Piuttosto, il filo della memo-ria corre a pellicole come ad esempio Il signor Max(1937) di Mario Camerini, Ladri di biciclette (1948)
di Vittorio De Sica e Il sorytasso (1962) di Dino Risi.
Cioè, da un lato, a opere che, a partire dal primocinema sonoro per arrivare all'era paleotelevisiva,hanno dato concretamente corpo alla tradizione del-la "commedia all'italiand'; dall'altro, a lavori appar-
tenenti all'alveo culturale del neorealismo cinemato-
grafico italianol.'Credo che una delle motivazioni di questa man-
cata assimilazione del cinema di argomento risorgi-mentale al cinema nazionale tout coart risieda nella
effettiva difficoltà del primo di assecondare adegua-
tamente le aspettative dello spettatore autoctono/\redio contemporaneo, pressoché disinformato e
verosimilmente disincantato di fronte alle vicende
storiche che hanno punteggiato le complesse fasi diedificazione dello Stato unitario italiano. Eppure, iltema del fusorgimento ha regolarmente attratto l'in-teresse dei cineasti nazionali, desiderosi di misurarsi
con alcuni momenti forti della storia patria.In questo breve intervento la mia intenzione è
quella di dare una sistematica descrizione di come
la complessa tematica risorgimentale sia stata re-
golata, articolata e raccontata dal mezzo cinemato-grafico prima e da quello audiovisivo in seguito. Ilmio proposito non è comunque quello di entrarenel dettaglio dei singoli testi audiovisivi che hannocostellato il panorama cinematografico italiano nel
corso del Novecento e del primo decennio del se-
colo successivo. Il mio obiettivo è di proporre duecoordinate di analisi che necessariamente si vanno a
ENRICO BIASIN
incrociare dando luogo a una serie di isotopie ideolo'
giche che interessa la materia storica in questione. Inprimo luogo, fornire una mappatura del territorio,organizzando la sintesi cartografica secondo campi-ture omogenee e storicamente coerenti. In secondo
luogo, identificare i dispositivi ideologici che hanno
ripetutamente delineato le configurazioni cinemato-grafiche e audiovisive concernenti la materia risorgi-mentale, e che quindi ne hanno favorito le "condi-
zioni di possibilità" discorsive2.
L'irudustria cuburale del NsorgimentoRecentemente, a più riprese, lo storico Alberto
Mario Banti ha fornito delle chiare indicazioni su
come vada interpretato quel vasto ed eteroclito insie-
me di materiali culturali (raccolte poetiche, romanzi,
saggi storici, articoli di giornale, tragedie, melodram-mi, pitture) che, nell'arco di tempo considerato frala celebrazione del Congresso di Vienna e la rivolu-zione del 1848, ha contribuito in maniera signifi-cativa a portare gli abitanti della penisola italiana a
immaginarsi finalmente nazione. La tesi di Banti è
che questo variegato complesso testuale e interme-diale abbia rielaborato "in vari modi il mito della
nazione italiana, della sua storia passata, delle sue
vicende recenti, strutturando una narrazione piut-tosto coerente e comPatta intorno a specifici temie figure"3 di quello che gli storici a seguire avreb-
bero chiamato "Risorgimento". È indubbio che tale
processo possa essere considerato nella sua valenza
ed effettività sincronica, nel senso che è proprio at-
trayerso questo primo quadro d'insieme narrativosul Risorgimento che una buona parte degli italianiiniziò a pensare a una propria nazione e magari a
battersi per essa con le armi o con il semplice uso
della parolaa. Ma è altrettanto vero che le formazionidiscorsiue che emersero nel corso di quella che puòessere definita come la fme originale della "industria
culturale" del Risorgimento italiano assumeranno unruolo e un efficacia misurabili in termini diacronici
70
S aggi
e prolettici, fornendo immagini, narrazioni, stili dirappresentazione e personaggi alle stagioni storichesuccessive.
Quello che vorrei mettere in luce è che nei cen-tocinquanta anni dell'unità d'Italia la storia delRisorgimento è stata creata, almeno sul piano deldiscorso pubblico, attraverso l'interpolazione di te-sti di varia natura mediale - dai romanzi best sellerdi Massimo d'Azzeglio ai numerosi siti Internet de-dicati all'argomento. Le operazioni compiute in talsenso non sono state guidate da scelte storiografi-che e culturali di tipo neutro, ma hanno obbeditoa logiche interessate, di volta in volta, alla gestionedel potere, alla creazione di un comune sentire, e al
profitto economico in termini di industria culturaledell'intrattenimento di massa.
Lo sviluppo di due recenti assi di rifessione te-orica ha contribuito a stimolare, e quindi a creare,questo particolare schema interpretativo circa ilRisorgimento italiano. Da un lato, in ambito sto-riografico anglosassone si sta affermando un inten-so lavoro di critica nei confronti delle metodologiee dei parametri interpretativi secondo i quali sonostate organizzatele singole storie nazionali europee,denunciando la spregiudicata sovrapposizione fraindagine storica, fondazione di mitologie e creazio-ne di memoria collettiva5. Dall'altro lato, in strettacomplementarietà con il fronte di ricerca appena ci-tato, nel campo degli studi sui media si evidenzia ilfenomeno della proliferazione di una nuova formadi storia, dispensata al di fuori del discorso storicoformale e dalle tradizionali istituzioni accademiche, e
articolata per il tramite di apparati di comunicazioneaudiovisiva quali il cinema, la televisione e i museistorici multimediali. Una storia in grado di forma-
Manifesto dal fil m Un garibaldino al conuento diYir,orio O. Si., ( f q44. '
re la memoria culturale dei suoi fruitori con.grandeefficacia di penetrazione sociale. Anton Kaes ha de-scritto in questi termini il potere omogeneizzante diquesto genere di produzione storiografica:
Superando le scuole e le università, il cinema e Ia televisione
sono divenuti i più efficaci (e paradossalmente meno ricono-
sciuti) veicoli istituzionali per la formazione della coscienza
storica. Essi sono influenti poiché possiedono la potenzialità
di rendere la storia più viva di quanto 1o possano fare i discorsi
commemorativi, le conferenze, le mosffe o i musei; essi sono
in grado ricollocare il passato nell'esperienza immediata dello
rp.tt"tor.6.
Come osserveremo fra breve, il cinema italiano,facendo principalmente leva su un intertesto cul-turale pregressoT, ha rapidamente contribuito allafondazione di una memoria storica risorgimentale,decretando laformalizzazione di una serie di attributidi significato e di strutture iconografiche capaci direstituire al grande pubblico nazionale un immaginesocialmente condivisa e collettivamente accettata delperiodo storico in questione. Lelemento su cui peròvorrei appuntare l'attenzione non riguarda tanto lard??resentazione delle immagini di contenuto risor-gimentale erogate sotto specie audiovisivas, quanto ildispositivo - oyvero quell"'insieme di determinazio-ni che inglobano e infuenzano la totalità del rappor-to individuale con le immagini"e - che presiede allaproduzione delle stesse. Il mio approccio all'oggettonon costituisce tanto una presa di posizione a fayoreo contro le nuove possibilità offerte dai media audio-visivi di "fare storia" nei confronti del Risorgimento;quanto invece una rifessione sulla fase di transizioneche si è prodotta lungo tutto il Novecento - e che direcente ha trovato il proprio momento critico nella"svolta digitale" introdotta da Internet - fra la con-Fotogramma dal film 1860 di Alessandro Blasetti (1934)
E. BIASI
cezione del passato inteso come un oggetto di studioscientifico e quella del passato valutato come un Pro-dotto di consumo culturalelo.
La fa"se liberale: la naziorualizzazione del mezzo
Uno dei caratteri salienti della fisionomia nazionale
della moderna industria culturale italiana corrispon-
de, secondo Fausto Colombo, alla costante alternan-
za ftala vocazione a porsi come agenzia pedagogica
e la missione piìr squisitamente votata alla logicadell' intrattenimento e alla comm er cializzazione dei
propri prodottill. In particolare, nel periodo giolit-tiano - una fase storica del primo Novecento carat-
terizzata, com'è noto, da una forte ambiguità sociale
e politica - la trasmissione di contenuti culturali ad
alto gradiente di massa si fonda sulf incontro fra la
disponibilità delle classi sociali dominanti a garantire
e a sostenere delle forme di propagazione del sapere
ad ampio raggio e la necessità delle vaste schiere con-
tadine e lavoratrici italiane di impadronirsi di stru-menti interpretativi efficaci, e finanche dilettevoli,sul piano dell'acquisizione dei contenuti.
Si può dire [...] che I'industria culturale iniziò i suoi primi
passi nel nostro paese con la maschera della scuola parallela,
mediando fra le forme tipiche della cultura delle élites ot-
tocentesche - che furono le autentiche protagoniste del suo
sviluppo - e l'esigenza di incontrare un pubblico che poteva
nascere soltanto dalla diffusione dell'analfabetismol2.
Lassortimento di spettacoli ottici di vario tipo (ca-
mere oscure, pantomime, lanterne magiche e lastre
fotografiche) presente per tutta la Penisola, soprat-
tutto a Partire dal secondo Settecento, e la posteriore"-TaBparizione del cinematografo creano gli apparati
di visione più consoni perché lo spettatore italianosprolvisto della cultura scolastica più elementare
possa facilmente impadronirsi delle nozioni chia-ve pertinenti agli ambiti disciplinari della geografia
e della storial3. Non è dunque un caso che il pri-mo film italiano in ordine cronologico - La presa diRoma - 20 settembre 1570 (1905) di Filoteo Alberini,prodotto dalla Alberini & Santoni in occasione del
)OOCV anniversario della Breccia di Porta Pia - cele-
bri il sogno dell'unità nazionale finalmente raggiun-
tola. Il film, che si articola in sette quadri - I'ultimodei quali, introdotto dalla didascalia'Apoteosi", raP'
presentante i Padri della Patria (Garibaldi, Mazzini,Vittorio Emanuele II e Cavour) ai piedi dell'Italiaturrita in veste di donna benedicente -' punta aomogeneizzare la realtà storica, dando un immaginedel Risorgimento nominale ("questi sono i padri del-
la patria") ed epurata da qualsiasi idiosincrasia dottri-nale ("l'unica ideologia risorgimentale è quella nazio-
nale")tr. Il mezzo di comunicazione della modernitàfa quindi la sua comparsa in Italia impostando una
propria storiografia sull'argomento: una nuoYa tec-
nologia della visione, lo Stato italiano e un settore
assai promettente dell'industria culturale autoctona
collaborano insieme perché il significato storico-cul-turale del Risorgimento si addensi su alcune figure
essenziali e parimenti si definisca secondo una retori-ca laica ma ideologicamente ecumenica.
I film a soggetto risorgimentale realizzati nell'arco
di poco più che di due lustri si definiscono però secon-
do numero poco consistente - circa una trentina dititoli, con una media, dunque, di tre pellicole all'an-no. Ma questo è sufficiente perché si formi un filonecinematografi co dominante, quello "garibaldino". La
prima casa di produzione a lanciarsi nell'impresa è la
romana Cines (Garibalài ll907l di Mario Caserini,
Il picco lo garibaldino [ 1 909], Anita Garibaldi U9 l0),Eroico pastorello [1 9 1 0] , Per la pania lEpopea garibal-dirual ll9l0), Goffiedo Mameli [1911], Stirpe d'eroi
[1911], Garibaldi a Marsala LI9l2), LTtalia iè desta
ll9l4l), seguita dalla Milano Films (Il raccoruto del
nonno tl9101 di Giuseppe De Liguoro), dalla Helios(Lafucilaziorue di Ugo Bassi e d.el garibaldino Giouanrui
Liuraghi [1911]), dalla Ambrosio di Torino (I Mille
ll9l2) di Alberto Degli Abbati, Le campane delle
morte lEpisodio della riuoluzione sicilianal [1913],Vat d'Oliui [1916]), dalla Vera Film (1/ campanile
della uittoria lRacconto di Natale) ll9l4l di AldoMolinari), dallaTiber Film (Ciceruacchio [1915] diEmilio Ghione), dalla Etna Film (1/ nemico [1915]di Giuseppe De Liguoro), dalla Dora Film (Gloria
ai caduti t19151) e dalla Robert Frlm (Seppe morire
e fu redento [1915])16. D'altro canto, la rievocazione
dell'epopea risorgimentale funziona da tramite per
riattestare, sul piano della memoria storica, l'eroi-
Fotogramma dal frlm Senso di Luchino Visconti (1954)
7)
S aggi
smo militare tutto maschile di alcuni combattentipartecipanti alla II guerra di indipendenza (Nozze
d'oro fAmbrosio, 1910] e La lampada della ruonna
[Ambrosio, l9l3], entrambi di Luigi Maggi). E lastessa lefteratura del e sul Risorgimento è traspostasul grande schermo al fine di creare strutture melo-drammatiche di forte richiamo spettatoriale (/acopo
Ortis L19l8l di Giuseppe Sterni, Tbsca llgl9) diAlfredo De Antoni, Jacopo Ortis ll92ll di LucioD'Ambra).
Poiché negli Stati Uniti vengono realizzati, in que-sti quindici anni, circa quattrocento film aventi persoggetto la nascita della nazione americana, è lecitochiedersi, a questo punto, il perché del basso numerodi film italiani dedicati al Risorgimento durante que-sto stesso periodo. Pierre Sorlin ci ha consegnato unaspiegazione che ci riporta a quanto affermato nellerighe introduttive del presente saggio17. Secondo lostudioso francese, la tematica risorgimentale mal si
addiceva alla comunicazione cinematografica di al-lora, dato che le competenze storiche del pubblicodel tempo - un pubblico essenzialmente formato damembri appartenenti alla classe lavoratrice - eranopiuttosto esigue e, in ogni caso, si caratterizzava-no "da un'accentuata predominanza di cultura nonstampata (visiva, p^rl^t^, musicale) su quella a stam-pa e da una diffusa presenza di prodotti culturali nonnazionali di ogni genere"18. D'altro canto, sono glistessi produttori, distributori ed esercenti cinemato-grafrci - non ancora assoggettati alle imposizioni e
censure di uno stato totalitario e non del tutto ac-
cerchiati da un apparato legislativo interessato allaregolamentazione dello spettacolo del grande scher-mo - a essere animati dall'obiettivo di confezionarepellicole esportabili nei mercati esteri. Ecco quindiche la scelta propende per la produzione di film a
lungometraggio, awincenti sotto il profilo della tra-ma, e soprattutto degni di essere apprezzati sia dal-le platee nazionali che internazionalile; ecco quindiche l'unico filone di tematica risorgimentale che puòsvilupparsi in modo consistente è quello che effigiala figura ayventurosa, ideologicamente plasmabile e
cosmopolita di Giuseppe Garibaldi.
Le forme del Risorgimento cinematografco -;>
nello Stato fascistaNel corso del triennio 1932-1935, gli istituti sto-
rici italiani sono sottoposti a un processo di radicaleriorganizzazione, poiché, per volere di Mussolini,tutti i passaggi della storia italiana, dalla Roma an-tica alla Grande guerra, avrebbero dovuto rientraresotto l'egida ferrea delle organizzazioni del regime.La Società nazionale per la storia del Risorgimentosi trasforma quindi in Regio Istituto per la storia delRisorgimento (ISR), e il compito di sovrintendere al
funzionamento degli istituti storici è affidato, sinoal 1943, a Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon.Durante la presidenza di quest'ultimo, I'ISR si qua-lificò come "lo strumento operativo ftnalizzato a
saldare, nelle intenzioni del quadrunviro, la visionesabaudocentrica del Risorgimento con l'ideologia na-zionalista del fascismo"2o.
Coincidenza vuole che, mentre il regime fasci-sta procede alla riconfigurazione dell'immagine delRisorgimento per tentare di costituirsi quale anel-lo di congiunzione fra le élites di potere e le masse
popolari utilizzando la chiave di volta della retoricapatriottica e nazionalezl, l'intera compagine del ci-nema italiano è soggetta a una fase di profondo asse-
starnento istituzionale, economico ed estetico. Thntosul piano qualitativo quanto su quello quantitatiyoil cinema prodotto nel Paese, a partire dall'iniziodegli anni tenta, guadagna in numeri e in terminidi apprezzamento critico e spettatoriale, creando unsistema di generi tutto sommato stabile e votato a
premiare la commedia sentimental e e leggera2z.
Lalveo naturale di raccolta dei contenuti risorgi-mentali è, durante il fascismo, il film di genere sto-rico, che, seppure destinato a non costituirsi comeforma audiovisiva predominante del ventennio, è ilprodotto cinematografico pir) sostenuto dalle sov-venzioni statali23. Le pellicole di genere storico diven-gono così il sito più immediato e palese di una nego-
Manifesto del film Viaa l'halia di Roberto Rosselini (1961)
BIASI
ziazione che si opera fra il discorso propagandisticoed esigenze di ordine spettacolareza. In questo senso,
l'endiadi articolata dalla industria culturale liberalepost-unitaria viene funzionalmente ritoccata in unodei suoi termini, cosicché al binomio pedagogia-eva-
sione si sostituisce la coppia propaganda-evasione.Nel corso degli anni Venti, il Risorgimento fa la
sua comparsa nei film a soggetto secondo un prin-cipio puramente volontaristico, dettato soltantodal desiderio, condiviso dai cineasti e dalle case diproduzione, di assecondare per via cinematograficala rivoluzione fascista in atto25. Queste pellicole -fra le quali ricordiamo Il grido dell'aquila (1923) diMario Volpe, La caualcata ardrnte (1925) di CarmineGallone, Anita o Il romanzo d'amore dell'eroe dei due
mondi (1926) di Aldo De Benedetti, Garibaldi e isuoi tempi (1926) di Silvio Laurenti-Rosa, Un balilkdel '48 (1927) di Umberto Paradisi, Martiri d'Ita-lia (1927) di Domenico Gaido, Redenziorue d'ani-me (1928) di Silvio Laurenti-Rosa, Brigata Firenze(1928) di Gian Orlando Vassallo - sono espressione
di una esplicita (auto)fascistizzazione della società e
delle cultura nazionale in atto, e possono quindi es-
sere considerate quali una delle ultime testimonianzedi quell'attivismo rivoluzionario combattentista che,
come ha ricordato lo storico Emilio Gentile2s, è an-cora indenne da quella svolta statalista imposta da
Mussolini dalla metà degli anni Venti.Con 1860 di Blasetti e Villafranca (1934) di
Giovacchino Forzano il cinema italiano raggiunge ilmassimo consenso appoggiandosi alle tesi storiogra-fiche ufficiali sul processo di unificazionenazionaJe2T.
In questi due film - il primo prodotto dalla Cines-
-,Pittaluga, il secondo dalla Fono Roma/Forzano Film
-7-= lx vi5lsne nazionalista, populista e continuista della
storia italiana propagandata e divulgata dal regimeper il tramite degli istituti storici trova il suo apice.
Esattamente all'opposto della tesi gramsciana im-prontata ad un analisi del Risorgimento in terminidi mancata sintonia fra I'elitario progetto unitariodelle classi sociali dominanti e le reali condizioni divita delle masse popolari oppresse dalle forze neofeu-dali, 1860 falsifica abilmente le carte e propone larealtà di un Risorgimento interclassista (invece che
eminentemente borghese) e armonico (piuttosto che
politicamente disgregato).Ma l'interpretazione e la rappresentazione unila-
terali del Risorgimento avanzate dai film di Blasettie di Forzano non trovano delle adeguate corrispon-denze nel repertorio cinematografico appartenenteall'ultima fase del ventennio. A cominciare da Tèresa
Confalonieri (1934) di Guido Brignone - per poi
proseguire con lavori quali I due sorgenti (1930 e ild.ottor Antonio (1937), entrambi di Enrico Guazzoni,Pietro Micca ( 1 938) di Aldo Vergano, Giuseppe Wrdi(1938) di Gallone, Il caualiere di San Marco (1939)
di Gennaro Righelli, La notte delh bffi (1939)di Carlo Campogalliani, Ohre l'amore (1940) di
Fotogramma dil, frlm Bronte di Florestano Vancini (7972)
Manifesto del frlm Le cinque giornate di Dario Argento (1973)
74
S aggi
Gallone, Tbsca (1940) di Carlo Koch28, La compagnia
della teppa (1941) di Corrado D'Errico, e per giun-gere ai paradigmatici Piccolo mondo antico (194t) diMario Soldati e Un garibaldino al conuento (1942)di Vittorio De Sica -, infatti, non solo il propositorevisionista storiografico più radicale allenta la pre-sa, lasciando il posto a una epistemologia storica delRisorgimento assai pir) consona alla vulgata scolasti-
ca e manualistica che veniva dispensata nelle scuole
primarie e secondarie del Regno; ma gli stessi filmsi trasformano in brillanti superfici audiovisive peruna tavolozza intermediale che offre cinema (quel-
lo soprattutto hollywoodiano), pittura (il realismoitaliano ottocentesco), letteratura (dai romanzi best
seller giàmenzionati del periodo antecedente all'uni-tà alla produzione letteraria successiva) e musica (la
tradizione operistica italiana)2e. Tale mutamento diatteggiamento nei riguardi della materia risorgimen-tale è indicativo del fatto che qualcosa sta cambiandodi segno nella società italiana e nella prospettiva che
questa adotta nei confronti del passato.
La trasmissione del sapere storico e storiograficonon è più infatti oramai monopolio esclusivo delleagenzie abitualmente considerate conferite di talefunzione (gli istituti storici, la pubblica istruzione,l'università); ma essa investe altresì altre forme d'in-trattenimento di massa (il cinema, la stampa a ro-tocalco, il teatro popolare, la radio, il mercato deldisco, il fumetto). Per di più, come ha recentementechiarito Raffaele De Berti, il progetto politico tenta-to dal fascismo di appoggiarsi al cinema di finzioneal fine di realizzare film dichiaratarnente propagandi-stici e tesi celebrare la continuità storica della vicendanazionale - dalle mitiche origini del popolo italicoalla stessa marcia su Roma, passando appunto perl'awentura risorgimentale - è destinato a fallire sot-
to il peso della nuova sensibilità culturale, estetica e
mediale dello spettatore italiano medio. Lipotesi diDe Berti è che, nella seconda metà degli anni Thenta,
l'invenzione della tradizione e delf identità italiana fatta dal
fascismo sia un grande "monumento" storico a cui gli italiani
aderiscono, ma che sia strutturalmente debole, soprattutto a
livello di mass-media, perché non riesce a intercettare alcune
trasformazioni sociali moderne, che stanno awenendo, "no-
nostante il fascismo"30.
Il lungo dopoguerra italianoIl processo di ampliamento e di modernizzazione
dell'industria culturale italiana, in atto, come si è ap-
pena visto, già dalla metà degli anni tenta, guada-gna uno stadio di ulteriore espansione nei tre decenni
successivi3l. La comparsa della televisione nelle abi-tazioni degli italiani a cavallo tra gli anni Cinquantae Sessanta rappresenta l'aspetto più evidente di talefenomeno, investendo di una serie di cambiamenti ilcoevo assetto del panorama mediale audiovisivo. Per
quello che concerne il nostro tema di discussione, cilimitiamo a osservare in proposito due aspetti. Da unlato, la televisione amplifica i canali informativi entroil contesto di diffusione della notizia, proponendosiquale mezzo di erogazione assai capillare di contenutistorici e quindi quale nuovo strumento per organiz-zare programmi e palinsesti tematici studiati ad hoc.
"Forse - scrive al riguardo Peppino Ortoleva -, la no---y__
vità più importantà che si può ricollegare all'avvento Fdella TV è il superamento del carattere carismatico e
personalistico della leadership radiofonica, cinemato-grafica, monumentale degli anni tenta, e l'affermar-si di una retorica dell'oggettività"32. Dall'altro lato,anche in virtù della fenomenologia mediale appenaaccennata, il film storico italiano - almeno per i due
decenni centrali allo sviluppo della stagione indu-striale italiana - sembra in parte rinunciare a quegliaspetti didascalici ed esplicitamente ideologici che loaveyano contraddistinto durante il periodo liberale,e in particolare nel corso del ventennio, per rilanciarelo spettacolo della Storia attraverso l'utllizzazione digeneri cinematografici di marca hollyrvoodiana (we-
Manifesto del, frlm Allonsanfan di Paolo e Vittorio Tàvia ni (197 6)
BIASI
stern e melodramma) e di un variegato star system
È sintomatico a tal proposito il caso di Senso.
Com è noto, vi fu una densissima polemica circa lanozione di realismo che il film articolava, una discus-
sione che vide contrapporsi, sulle pagine della rivista"Cinema nuovo", due distinte posizioni al riguardo.Da una parte, v'erano coloro che ritenevano che
Visconti, con questa pellicola, rinunciasse all'impe-gno neorealista e alla cronaca sociale, imboccandola strada dell'estetica e dello spettacolo fini a se stes-
si. Dalla parte opposta, chi, come Guido Aristarco,guardava a Senso come campo di sperimentazione e
di rielaborazione dell'esperienza neorealista appog-giandosi al dispositivo della messa in scena dellaStoria33. Comunque sia, film come Senso - al qua-le potremmo accostare Caualcata di eroi (1949) diMario Costa, che stilizzalo sfondo della RepubblicaRomana del 1849 per narrare una storia d'amore an-
cora una volta controversa, Camicie rosse (1952) diGoffredo Alessandrini e Francesco Rosi, che trasPone
il genere western all'interno dell'epopea garibaldina,Il Brigante di Thcca del Lupo (1952) di Pietro Germi,che fa del duro conflitto fra i bersaglieri del Regnod'Italia e i briganti del sud un yero e proprio racconto
d'awenture, fino al celebre Il Gattopardo (1963) diVisconti - accolgono di fatto la lezione del romanzostorico, interpolando alla struttura narrativa di gene-
re le "scansioni garantite dalla memoria collettiva"3a.
Il Risorgimento che ci viene presentato da simili testise da un lato incontra i gusti del pubblico italianopoiché l'articolazione del processo che ha portatoalla unificazione del Paese è inserita nella cornice delr_omanzesco, dall'altro lato tale rappresentazione con-
4ibr.ir.. a intensificare il coevo-iibattito politico e
culturale che su questo stesso periodo storico si stava
rigenerando in Italia grazie allaprima pubblicazionedei Quadrrni del carcere di Antonio Gramsci.
Degno di interesse appare invece il caso di due al-tre pellicole della prima metà degli anni Cinquantaappartenenti al genere della "cineopera" - Giuseppe
Wrdi (1953) di Raffaello Matarazzo e Casa Ricordi(1954) di Gallone -, le quali, riproponendo in chiave
musicale e colta l'esperienza del Risorgimento italia-no, creano un ulteriore scansione dell'immaginariolegato al tema della edificazione dell'identità italianae operano sul suggestivo livello del legame interme-diale fra musica, melodramma e cinema35.
L interpretazione storio grafrca del Risorgimentofornita dal cinema di questi decenni non sarebbe
organicamente completa se non venissero citate al-tre due opere, La panuglia sperduta (1953) di Pietro
Nelli e Viua I'halia (1961) di Roberto Rossellini36. La
prima, prodotta dalla Vides di Franco Cristaldi, pro-pone una lettura antagonista della storia risorgimen-
tale. Superando in termini di radicalismo ideologicole stesse opere sull'argomento di Visconti o di Germi,il film ridisegna la geografia del Risorgimento attuan-
do una prospettiva sul passato prossimo del Paese mi-rante a intensificare lo sguardo delle masse subalter-ne, coinvolte in un conflitto armato voluto da chi poiavrebbe unificato la penisola a prescindere dai reali
bisogni delle classi sociali popolari. Con Viua l'Italia,invece, realizzato su commissione nel quadro del pri-mo centenario dell'unità, l'accento viene posto sullafigura di Garibaldi, mentre lo stile di regia adottato
- sintomatico e anticipatore del modello storiogra-fico che Rossellini ttilizzerà. nei suoi successivi filmtelevisivi - si affranca dalla tradizione risorgimentaleagiografi,ca e monumentale per orientare il raccontoverso la cronaca e il reportage in diretta.
La 'rilocazione" idrologica e audiouisiua
del Risorgimento
Con l'ingresso degli anni Settanta sulla scena dellastoria nazionale, il Risorgimento italiano, inteso tan-to come oggetto di analisi storiografica quanto come
prodotto di una serie di investimenti culturali, su-
bisce due sostanziali modificazioni epistemologiche.Per quanto attiene al primo ordine di mutamenti,
se il dispositivo cinematografico, alla vigilia dell'epo-
ca neotelevisiva degli anni Ottanta, conserva la sua
predisposizione a volersi occupare delle vicende che
hanno contraddistinto il sorgere della nazione italia-na, ciò awiene seguendo in parte la lezione del filmdi Nelli, La pattuglia sperduta. Se attraverso Napoli1860: La f.ne dei Borboni (1970) Blasetti, a distan-
za di quasi quarant'anni, ritorna sui fatti d'armi che
portarono alla caduta del Regno delle Due Sicilie
Fotogramma daJ. film I Vicerè di Roberto Faenza (2008)
76
S aggi
scegliendo la prospettiva degli sconfitti, in particola-re di Federico II di Borbone, all'interno di altre opere
dello stesso decennio lafocalizzazione narrativa gioca
nuovamente a favore della sensibilità dei ceti sociali
più bassi. In Correua I'aruno di grazia 1870 (I97t),ove si racconta di un gruppo di oppositori - perlopiìimassoni e anticlericali - e della loro pervicacia nel
voler restare reclusi in carcere piuttosto che piegar-si al nuovo ordine costituito, Alfredo Giannetti dà
conto della forza irriducibile della ideologia libertariae repubblicana. In Brorute - Cronaca di un massacro
che i libri di storia ruoru ltanno r*ccontato (1972) diFlorestano Vancini opera il proposito, vieppiù radi-cale, della "ricostruzione della storia dalla parte dei
vinti e delle classi subalterne"3T, favorendo la dele-
gittimazione della mitologia risorgimentale interclas-
sista rimasta per lungo tempo il terreno di mano-vra della passata storiografia. In Le cinque giornate(1973) Dario Argento cerca invece di far afEorareall'interno del tessuto storico-narrativo della rico-struzione della Milano del 184838 i valori e i temidella "controcultura" sessantottesca, proprio come
Ennio Lorenzini nel suo Quanto è bello lu murire ac'ciso (1976) restituisce al gesto di Carlo Pisacane una"immagine dialettica"3e , capace di tenere conto dei
vari punti di vista dei soggetti coinvolti nell'impresa
rivoluzionaria (l'esercito borbonico, Pisacane stesso
e i contadini).Lungo lo stesso tracciato interpretativo del
Risorgimento si pongono due film - Allonsanfan(1976) di Paolo e Vittorio Tàviani e Domani accadra(19SS) di Daniele Lucchetti - che, seppur relativa-
mente distanti sul piano cronologico, adottano lamedesima ottica emancipante nei confronti delle as-
sodate categorie ermeneutiche della storia nazionale:
attraverso la messa in scena del passato è possibile ri-flettere sul presente, e quindi richiamare l'attenzionesulla necessità di rispettare le proprie responsabilitàin vista della battaglia politica.
Nell'ultimo decennio, il confronto con la storiarisorgimentale da parte del cinema non è venutomeno. Se da un lato, film come il discusso Li chiama'rono... brigaruti! (1999) di Pasquale Squitieri rilanciacon estremo vigore il tema della "questione meridio-nale", riaprendo il dibattito sulla reale condizionedelle masse popolari del sud all'indomani dell'annes-
sione del Regno delle Due Sicilie ai Savoia, le ultimeprove cinematografiche sull'argomento pongono una
serie di problemi riguardo alle modalità secondo cuila rappresentazione audiovisiva del Risorgimento è
stata considerata e trattata dalla contemporanea in-dustria culturale italiana.
IJimpressione odierna è che prodotto culturale ci-nematografico di interesse storico-risorgimentale sia
entrato in una nuova fase di sviluppo e di program-mazione spettacolare, che ottempera alla necessità diallagare il raggio di utenza spettatoriale e di confron-tarsi con un sempre più variegato sistema di piatta-forme mediali e di dispositivi della visione. Quellache potremmo definire con l'espressione di rilocazio-ne del testo cinematografico di tematica risorgimen-tale - mutuando la nozione da Francesco Casetti, ilquale con tale espressione concettuale intende desi-
gnare sia "il processo in virtù del quale un'esperien-za, qualunque essa sia, 'trasmigra' da un luogo a unaltro", e sia la possibilità, per noi persone fisiche, dirivivere una precisa esperienza mediale nell'ambitodi una differente situazione comunicativa4o - corri-sponde a un'operazione che si è compiuta e che si sta
producendo rispettivamente tanto sul piano diacro-nico quanto su quello sincronico.
Lungo l'asse diacronica, è possibile individuare due
stadi di estrinsecazione, in parte sovrapposti e che in-vestono il dispositivo cinematografico e la Program-mazione televisiva:
ManiFesto del Noi credzuama di Mario Martone (2010)
E. BIASI
. Il primo stadio di evoluzione equivale all'entratadelle forme audiovisive di argomento risorgimen-tale nel contesto dei palinsesti televisivi italiani,awenuta intorno agli anni Cinquanta e Settanta(L'alfiere di Carlo Alianelh 11956l di Anton GiulioMajano [sceneggiato televisivo Rai di 6 punta-te), Ottocento di Saluator Gottd. [1960] di AntonGiulio Majano [sceneggiato televisivo Rai di 5
puntatel, Giuseppe Wrdi fl963) di Mario Ferrero
[sceneggiato televisivo Rai di 5 puntate], Le mieprigioni U9691di Sandro Bolchi [sceneggiato te-levisivo Rai di 4 puntate], Le cinque giornate diMilano 11970) di Leandro Castellani [sceneggia-to televisivo Rai di 2 partl), Le uhime lettere diJacopo Ortis [1973] di Peter Del Monte [film perla televisione Rail, Il giouane Garibaldi ll974l diFranco Rossi [sceneggiato televisivo Rai di 6 pun-tate], poi continuata negli Ottanta (Wrdi 11982)di Renato Castellani [serie televisiva Rai di B pun-tatel, Garibaldi il Generale lI9B7l di Magni [serietelevisiva Rai di 4 puntate] , e maturata nel cor-so degli ultimi due decenni (La famiglia Ricordi
ll994l di Mario Bolognini [serie televisiva Raidi 4 puntate], Cuore [2001] di Maurizio Zaccaro
[serie televisiva Mediaset di 6 puntate], Piccolo
mondo antico [2001] di CinziaTorrini [serie tele-visiva Mediaset di2 puntate], La ruotte di Pasquiruo
12003) di Magni [film per la televisione Mediaset]e Erauamo solo mille 120061di Stefano Reali lfilmper la televisione Rai])41.
. Il secondo stadio di sviluppo diacronico si con-cretizzanel momento in cui i testi cinematograficidi argomento storico-risorgimentale pensati peril consumo di sala assumono delle caratteristiche
\"rticolari che li rendono immediatamente fun-zionali a una loro fruizione casalinga, e quinditelevisiva. Così, pellicole di recente realizzazione
- quali Il resto di niente (2004) di Antonietta De
Lillo, che sceglie di giocare le sue carte migliori suitoni melodrammatici e su una nutrita schiera diinterpreti e personaggi; I uicerè (2008) di RobertoFaenza, che sottopone il romanzo di Federico DeRoberto a una confezione "di qualità" televisiva e
che si serve di attori piuttosto affermati nell'arenadel piccolo schermo (Lando Buzzanca, AlessandroPreziosi, Guido Caprino); e Noi credeuamo (2010)di Mario Martone, che, presentato in concorsoall'ultima edizione della Mostra Internazionaled'Arte Cinematografica di Yenezia con un me-traggio di 204 minuti, sembra il prodotto idealeda spendersi all'interno dei palinsesti Rai - assicu-
rano quel principio di reciproco scambio interme-diale che caratterizzal'odierna rilocazione del testo
audiovisivo di matrice tematica risorgimentale.Lungo il secondo asse di riposizionamento, quellosincronico, invece, l'impiego a vasto raggio e se-
condo diverse proporzioni, in forma talvolta fram-mentata, di materiali cinematografici e audiovisi-vi afferenti all'alveo semantico del Risorgimento(dai siti Internet dedicati all'argomento alle nu-merose rassegne cinematografiche, dai musei delRisorgimento che fanno uso di apparati multi-mediali alla riedizione di "classici" del cinema che
hanno narrato e illustrato le varie tappe del rag-
giungimento dell'unità italiana) ha generato unmessaggio storico diffuso, coprendo alcune aree diinteresse e lasciandone sguarnite altre.Alla luce di quanto appena descritto in quest'ul-tima sezione del presente saggio, se è senz'altrocondivisibile, e anzi auspicabile, l'uso dei testi au-
diovisivi per studiare e divulgare il nostro passato,
è altrettanto necessario però prendere coscienza
del fatto che, senza una :utTlizzazione critica dellefonti, la storia rischia di dissolversi in un sistema
di segni autoreferenziale, dove il mito si confondecon l'esperienza e con la memoria.
78
S aggi
NOTE
I Per una formulazione della commedia italiana e del cine-ma neorealista in termini di "cinema nazionale", si vedano due
gruppi di tesri. Da un lato, GnNrRaNco BpttntINt, Una fab-brica rnetastorica dellbuasione. Il cinema italiano dal 1926 al 1940,
in "Vita e Pensiero", a. [XXI, n. l, gennaio 1988, pp.39-54;JAMEs HAY, Popular Filrn Cubure in Fascist ltaly. The Passing ofthe Rex,Indiana Universiry Press, Bloomington and Indianapolis1987; JaceurLINE RErcH, Prnno GeRopelo (a cura d1), Re-
uietoing Fascism: Italian Cinema, I 922- I 943, Indiana UniversityPress, Bloomington-Indianapolis 2002. Dall'altro, JoHN Dtcr«n,Imagined balies, in Davto Forcacs, RosBRT LuvrBv (a cura di),balian Cubural Studies: An Innoduction, Oxford University Press,
Oxford 1996, pp. 19-33; Prcnnn SonuN, halian National Cinema,
Routledge, London-New Yo * 1996, pp. 88-1 07.2 Mi attengo alla classica definizione di dispositiuo proposta da
Michel Foucault, orrrero un sistema di relazioni stabilite fra ele-
menti eterogenei che, in un contesto storico particolare, regola le"condizioni di possibilità" del discorso che forma la realtà sociale,
culturale e scientifica di quella data epoca. MICHEL FoucAULT,
L'archeologia del sapere (1969), tuzzoli, Milano 1999, pp. 157-158.3 ArnBnto Marue BeNrI, Il Risorgimento italiano, Roma-Bari,
Latena2004, p.54.4Ilimportante lavoro di BenedictAnderson sulle "comunità im-
maginate" sottolinea proprio questo aspetto: la cultura tipograEcadella nascente società borghese, che si estrinsecò soprattutto attra-
verso la forma del romanzo e del giornale quoddiano, fornì, nella
seconda metà del XWII secolo, f intelaiatura necessaria perché inEuropa e in altri continenti si formasse per la prima volta una vera
e propria cultura nazionale. BpNrotcr ANDERSON, Comunità im-maginate. Origini efornna dei nazionalismi (1991), manifestolibri,Roma 1996. Cfr. anche DoNero M. Lo.wr, History of Bourgeois
Perception, The University of Chicago Press, Chicago 1982.5 Cfr. STuART HALr, The Question ofCuhural ldznrzT in Sruanr
HALL, DAVID Hrtp, Toruy McGn-evz (a cura di), Modernity andhs Future, Poliry Press/The Open Universiry Press, Cambridge1992, pp. 273-316. Srr,reN BeRcen, On the Role of Mltths andHistory in the Construction of National ldenti4t in Modzrn Europe,
in "European History Quarterly'', vol. 39, n. 3,2009, pp. 490-502. CHPJS LopaNz, Drauting the Line: "Scientifc" History betwe-
en Myth-Making and Myth-Breaking, in StrraN Btncon, LINasEp.trsoNas, ANDREùr MycocK (a cura d1), Nanating the Nation:Reltresentations in History, Media and the z4rrs, Berghahn Books,Oxford-New York 2008, pp. 35-55.
6 ANrou Ktss, History and Film: Public Memory in the Age ofElectronic Disseminafion, in "History and Memory", vol. 2, n. 1,
1990, p. 111. Cfr., inoltre, ArolaNDRo BAIR" Consuming Historyand Mernory through Mass Media Products, in "European JournalofCultural Studies", novembre 2001, vol. 4, n.4, pp.49l-501.
7 Saranno le élites culturali borghesi che s'incaricheranno dimediare il passaggio da una cultura tipografica a una cultura "dimassa", essenzialmente non stampata e accessibile al gusto delle
classi popolari. Cfr. Stefano Piva;to, L'organiz,znzione cattolica dzlla
cubura di massa durante il fascismo, in "Italia Contemporanea", n.
132, luglio-settembre 1978, pp. 3-25.8 Lavoro egregiamente svolto da Pierre Sorlin nel suo volume Za
storia nei flm. Interpretazioni dzl passato (1980), La Nuova Italia,Firenze 1985, pp. rc3-124.
e Jacqurs AuuoNr, L'immagine (2005), Lindau, Torino 2007,
P. 137.
r0 ANNa Ltsa Tora, Narrating the Shoah: From Maus to LifeIs Beautiful, in In-unBm Scur,r.l«, Mancnrr TnÒHLER, YvoNNEZIvtvlptveNN (a cura di), Film - Kino - Zuschauer: FilmrezeptionlFilm - Cinema - Spectator: Film Reception, Schiiren Verlag,Marburg 2010, p.342.
11 FAusto Colouno, La cubura sottile. Media e industria cul-turale in halia dall'Ottocmto agli anni Nouanta, Bompiani, Milano1998, pp. t5-2r.
t2 lbidrm,p.9t.13 Cfr. DoNara PpsBNrt CaupacNoNt, Wrso il cinema.
Macchine, spettacoli e mirabili uisioni, UTET, Torino 1995, pp.
7t-157.la Sulle vicissitudini produttive del film, si veda MlcHr,rB
CaNose (a cura di), 1905. La presa di Roma. Alle ori§ni dcl cinema
italiano, Le Mani, Recco 2006. \15 Cfr. GnN Pnno BRuNerrA, Cent'anni di cinema italiand,,
Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 1-2.16 GtovaNNI Ltst, Garibaldi e I'epopea garibaldina nel cine-
mA muto italiano. Dalle origini alk Prima guerra mo,ndiale, in"Storicamente", n. 7, marzo 2017, http://wwwstoricamente.org/05-studi-ricerche/lasi-garibaldi-film.htm, pp. l-21 (ultima
visita 14 aprile 2011).17 PIBRRT Sonrnq, La storia nei film. Interpraazioni del ?assdto,
itt., p.42.r8 D,q.tp Forcecs, L'industrializzazione della cuhura italiana
(1880-1990) (1990), il Mulino, Bologna 1992, p.371e Rlccanoo Rz»t, Cinema mato italiano (1596-1930),
Marsilio, Yenezia 1999, pp. 69-73.20 Messluo Beroxt, Fascismo e Risorgimento. Llstituto per h sto-
ria dzl Risor§mento italiano, in "Passato e presente", n.41, maggjo-
agosto 7997, p. 46. Ck. anche STur.tr J. §7oorr, Risorgimento
e fascismo: il senso della continuità nella storiografia italiana, in"Belfagor", n. 1, 31 gennaio 1965, pp.7l-91.
2r Prpn Gtorclo ZuNINo, L'ideologia delfascismo. Miti, ctedenze
e ualori nelk stabilizzazione del regtme, il Mulino, Bologna 1985,p. 88-98.
22 Et tpuco BltslN, Cinema italiano anni Wnti e Tienta. Genere e
identita nazionale, in ArpsseNoRo FACCIoLI (a cura di), Schennidi regime. Cinema ialiano drgli anni Tienta: la produzione e i generi,
Marsilio, Venezia 2010, pp.32-44.2: Cfr. lEaN A. Gru, Stato fascista e cinematografa. Repressione
e promozione, Bulzoni, Roma 1981, pp. 52-54. LUIcI Fnpou, 1/
cinema. Il goaerno dell'immagine (1949), Centro Sperimentale diCinematograÉa,/Gremese, Roma 1994, passin.
" J*N A. GIu, Film storico e flm in costurne, in RrccanooRrot (a cura di), Cinema italiano sotto ilfascisma, Marsilio, Venezia
t979, pp. 135-136.25 Vtttop.to MARTINELLI, Primi approcci tra cinema e fascismo,
in "Immagine. Note di Storia del Cinema", n. 2, aprile-giugno1985, pp.7-12.
26 Etttrtlo GrNrtI-E, Le origini dell'ideologia fascista (1918-1925),il Mulino, Bologna 1996, p. 10.
27 MtNo ARGENTIERI, Ilflm biografco, Bulzoni, Roma 1984,
P. 91.28 LJna nuova versione cinematografica dell'omonima opera di
Giacomo Puccini ve:-r:à rcalizzata nel 1973 col titolo di La Tbsca e
sotto la direzione di Luigi Magni.2e GturteNa Muscto, Il fbn piàr fascista è il flrn storico, in
AresseNono Faccrorr, op. cit, p.53. Sul rapporto rra cinema e
pittura nei film citati, si veda Roarnto CAMIArJ, Il fantasma delbelh, Marsilio, Venezia 1994, pp. 25-50.
E. BIASI
30 RerrertB Da Brnu, Cinema e identità nazionale, inMARTAGRAZIA FeNcHI, Err'Na MoscoNt (a cura dt), Spettatori.
Forrne di consutno e pabblici del cinerna in halia. 19i0-1960,Marsilio, Venezia 2002, p. 105.
31 Prppruo OnroLBve, Mediastoia. Comunicazione e carnbia-
mento sociale nel mondo contemporaneo, Pratiche, Parma 1995,pp. t3t-132.
32 lbidern, p.96.33 Cfr. ArspRTo AsoR Rosa, 1/ neorealismo o il trionfo del
narratiao, in Gtorclo TtN/.zzt, MentNe ZeNceN (a cura di),Cinema e letteratura dtl neorealismo, Marsilio, Venezia 1990, pp.83-87.
3a LIon Dn FnoErlucrs, Letteratara e storia,Laterza, Roma-Bari1998, p.32.
35 Glq.N PtrRo BruNrrrt, Storia del cinema italiano. Dalneorealismo al miracoh econornico. 1945-1959, vol. 3, EditoriRiuniti, Roma 1993, pp.544-549.
36 A cui aggiungiamo il poco citaro Eran trecento (L952) di Gian
Paolo Callegari, conosciuto anche come La spigolatrice di Sapi.37 GmN PIpro Brrxrrre, Storia del cinema italiano. Dal mi-
racoh economico agli anni Nouanta, vol.4, Editori Riuniti, Roma
t993, p.29538 Ploro Noro, Risorgimento e cinem.a itali.ano del dopoguena,
in "Storicamente", vol. 7, marzo 201 1, http://www.storicamente.
org/04-comunicare/paolo-noto-film-risorgimento.htm, p. 2 (ul-
tima visita I 4 aprtle 20ll).3e Cfr. GtoveuNl GMzzINI, Quanto è bello lu muire acciso, in
"Corriere della Sera', 5 marzo 1976.40 FReNcrsco C,qsprt, The Last Supper zz Piaz,za dzlk Scak,
in "Cinéma & Cie: International Film Studies Journal", n. l l,2008, pp. 8-9.
41 Naturalmente, l'elenco dei prodotti televisivi non è completo,
ma serve a dare un'idea del fenomeno e della sua continuita nel
corso dei decenni.
i]iri
t:rì,l:ltl
1:
tlI
rl
]r
:iill
,l
il
,l
i
I
i
I:li
iiii
il
il
i
rl
i
I
rliirl
tl'I,l
I
:i
i
tii
ri
ril
.-7-X.....-