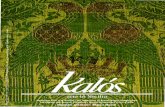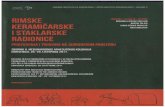Milazzo. I materiali dallo scavo della fattoria di Via Ciantro: ceramica fine e anfore da trasporto
Transcript of Milazzo. I materiali dallo scavo della fattoria di Via Ciantro: ceramica fine e anfore da trasporto
201
lasciato aperto ma di particolare interesse proprio nel caso di Mylai, fondata da Zancle anche per la straordinaria feracità dell’ampia Piana, tanto decantata nelle fonti letterarie, in una zona control-lata prima della fondazione della colonia dai centri indigeni presenti sulle prime digitazioni collinari.I dati sin qui riportati offrono spunto ad alcune considerazioni di sintesi. L’evidenza acquisita per la prima volta all’interno di questo cantiere e in questo settore della Piana di una presenza stabile di epoca tardoromana-proto-bizantina, è di particolare interesse, considerati i pochissimi elementi di cui a tutt’oggi disponiamo su queste epoche33. Nel caso specifi co, mentre l’esi-stenza in zona di una struttura utilizzata in epoca tardoantica non stupisce, ma si allinea con la docu-mentazione offerta dalle contrade Archi, Reilla e S. Gaspano dove sono stati individuati i resti di tre ville utilizzate almeno fi no al IV sec. d.C.34, le tombe bizantine, pure da ricollegare ad un edifi cio rurale, restano assolutamente isolate35.La piccola struttura d’età ellenistica rinvenuta getta nuova luce su un momento storico molto impor-tante quale fu quello della prima età ellenistica, nel quale, come è noto, si assiste al moltiplicarsi di impianti agricoli, anche di un certo rilievo36. Ben-ché in parte danneggiato dallo sbancamento, il complesso offre un buon esempio di installazione a carattere permanente, di tipo unifamiliare, e inte-gra signifi cativamente i dati assai lacunosi acquisiti su strutture dello stesso tipo rintracciate nella zona di Milazzo negli ultimi decenni. Non v’è dubbio che le nostre conoscenze sui tempi e sui modi di occupazione del territorio della Piana, a partire
dalla fondazione della colonia, siano ancora agli inizi e moltissimi sono gli interrogativi che restano senza risposta37.
I MATERIALI DALLO SCAVO DELLA FAT-
TORIA DI VIA CIANTRO: CERAMICA
FINE E ANFORE DA TRASPORTO*
Caterina Ingoglia
Nel 1998, durante uno scavo d’urgenza effettuato a Milazzo, in via Ciantro, in seguito allo sbanca-mento operato per la costruzione di fabbricati destinati ad abitazioni (Coop. Medusa), è stato restituito un complesso di materiali, stratigrafi ca-mente correlato a strutture relative ad un impianto interpretato come fattoria38.I materiali si riferiscono, in maggior numero, a vasi in ceramica, ma sono documentati anche esemplari di statuette, di oggetti in metallo e – con una sola attestazione – di vetro, oltre ad un frammento di capitello ionico in terracotta. La ceramica presentata in questa sede proviene in gran parte dallo scavo dei vani 1-4 della fattoria39. Raggruppa vasellame fi ne da mensa, anfore da tra-sporto e unguentari40 ed è databile complessiva-mente all’età ellenistica. Sono stati presi in considerazione anche i materiali provenienti dai tagli superfi ciali dello scavo (in una situazione stratigrafi ca compromessa dal passaggio del mezzo meccanico) e dal terreno di risulta dello sbancamento (“sporadico”). Tra questi, un ridotto
settembre-3 ottobre 2000), “Problemi della chora coloniale dall’occidente al Mar Nero”, voll. I-II, Napoli 2001 (in particolare per l’area magno greca e siceliota, si vedano i contributi di Greco
2000, pp. 171-194; Di Stefano 2000,pp. 689-670; Belvedere 2000, pp. 707-747, Morel 2000, pp. 487-489; De Siena 2000, pp. 757-768; Carter 2000, pp. 771-792; Quilici-Quilici Giglio 2000, pp. 973-806; Bianco 2000, pp. 807-818). 33 Per la documentazione archeologica, Tigano 1998-1999b, pp. 532-543; Fuduli 2006, pp. 15-33.34 Tigano 2008a, pp. 87-88.35 Le poche sepolture di epoca bizantina note sono state rintrac-ciate nella Penisola e nell’Istmo. È da riferire problematicamente ad epoca bizantina la serie di casse-ossario rintracciata in via Cumbo Borgia a livello superiore rispetto alle tombe tardoromane (Tigano 1997-1998b, pp. 533 e 539-540); un sepolcro bizantino è noto all’inizio della attuale strada panoramica (Tigano 2008a, p. 84).36 In generale, vedi Martin-Vallet 1979, p. 338; Martin-Pe-
lagatti-Vallet 1979, pp. 420-424.
37 Sulle problematiche connesse all’occupazione della chora oggetto di rifl essione e dibattito in relazione ai dati acquisiti in altre aree della Sicilia e della Magna Grecia ove la ricerca sul campo ha avuto carattere di sistematicità, vedi note 25 e 32 e bibliografi a citata.
* Desidero ringraziare la dott.ssa Gabriella Tigano, direttore dello scavo, per avermi affi dato lo studio di questi materiali, seguendone l’evoluzione in tutti i suoi aspetti; un ringraziamento và anche al dott. Piero Coppolino, responsabile dello scavo. Sono grata a Cate-rina Persiani per aver curato con pazienza e dedizione l’elaborazione grafi ca di questo lavoro. I disegni sono di Rocco Burgio, Giovanni La Scala e Caterina Persiani; le fotografi e di Antonino Cupitò.38 Tigano 2003a, p. 291; Tigano 2005, p. 308. 39 Cfr. Tigano, supra, pp. 197-201.40 La coroplastica, i vetri e i metalli saranno oggetto di una prossima pubblicazione da parte di chi scrive. La ceramica da cucina è in corso di studio da parte del dott. Piero Coppolino.
202
numero di attestazioni, che comprende Magenta Ware, ceramica a pasta grigia, campana B o B-oide e un’anfora punica, è riferibile alle fasi più recenti di frequentazione del sito che scendono sino ad età repubblicana41.Lo scavo ha restituito anche alcuni frammenti di ceramica a bande del tardo-arcaismo, da conside-rarsi residuali.
Ceramica Fine da Mensa
Ceramica a vernice nera e a vernice nera sovrad-Ceramica a vernice nera e a vernice nera sovrad-dipintadipinta
La classe è attestata da un gruppo abbastanza nume-roso di frammenti riferibili a diversi esemplari, appartenenti per lo più a forme aperte, databili tra la fi ne del IV ed il II sec. a.C.: si tratta in netta preva-lenza di parti di labbro, spesso con relativa porzione della parete della vasca o, in quantità minore, di fondi con piedi. In nessun caso è stato possibile sta-bilire un rapporto di appartenenza allo stesso vaso tra frammenti di labbro e di piede. Tutti gli esemplari, ad eccezione di uno, possono attribuirsi a produzione “locale”, intendendo con questo termine “di Milazzo o zone limitrofe”. Non è possibile, infatti, distinguere la produzione di Milazzo da quella di altri centri vicini, perché non sono noti, fi no ad ora, ritrovamenti riferibili ad impianti produttivi. È per questo motivo che è stato avviato un progetto di analisi archeometriche volto a verifi care i centri di produzione delle ceramiche di età ellenistica attestate a Milazzo, e tra queste della ceramica fi ne. Al momento, possediamo già interes-santi risultati per i campioni di patere a v.n., che siamo in grado di attribuire, in base alle caratteristi-che minero-petrografi che e geochimiche, alla pro-duzione cosiddetta locale42.In generale, si osserva una qualità tecnica un po’ sca-dente dell’artigianato locale, di cui non è stato possibile, sino a questo momento, individuare forme caratteri-stiche. Le forme attestate non sono ancora stan-dardizzate e presentano molte varianti nel profi lo.
All’osservazione autoptica, questa produzione non presenta caratteristiche unitarie, almeno per quanto attiene alle ceramiche a vernice nera: è contraddi-stinta da una grande varietà di esiti di cottura dell’ar-gilla, diversi per colore, consistenza, granulometria con presenza di mica in quantità variabile. Anche la vernice, di solito stesa ad immersione, presenta caratteristiche molto diverse: talvolta diluita, talvol ta luminescente, spesso opaca, a volte scistosa. La documentazione più antica di ceramica a v.n. risale alla fi ne del IV-prima metà del III sec. a.C.: sono abbondanti infatti le coppe su piede modanato con o senza decorazione graffi ta o sovraddipinta (che richiama l’ultima fase dello stile di Gnathia), le coppette con orlo rientrante delle specie Morel 2710 e 2720, le patere della specie Morel 1530, tutte ben attestate in Sicilia fi no alla metà del III sec. a.C. ca. Di gran lunga inferiore appare il numero di esem-plari di vasi a v.n. riferibili al secolo successivo: la patere della specie Morel 1310 si datano tra la metà del III e la metà del II sec. a.C., la patera della serie 1535 riporta al II sec. a.C.; mentre i frammenti spo-radici di piatto a pasta grigia e di coppa in ceramica B-oide, anch’esso sporadico, farebbe scendere il termine ultimo di frequentazione del sito alla fi ne del II o addirittura al I sec. a.C. Subito dopo la seconda guerra punica si assiste ad un cambiamento nelle produzioni e nella diffusione della ceramica a v.n. del Mediterraneo occidentale43. Di questo cambiamento non c’è traccia nella docu-mentazione di contrada Ciantro, dove non è atte-stato, ad esempio, alcun frammento di campana A.Nelle pagine che seguono, la presentazione della ceramica a vernice nera e a vernice nera sovraddi-pinta è organizzata per forme funzionali: tra le forme aperte, sono documentate coppe e skyphoi per bere/mangiare; patere per mangiare; forme chiuse per contenere/versare. Le ridottissime dimensioni dei pochi frammenti di vasi chiusi non consentono di riconoscere la forma originale.In generale, la frammentarietà dei vasi non ha reso facile il riferimento alla classifi cazione del Morel che spesso risulta incerto: laddove possibile, si sono richia-mati il genere, la specie o la serie di appartenenza.
41 Per le sepolture del settore A, vedi Coppolino, infra, pp. 233-245.
42 Vedi in questo stesso volume, Barone et alii, p. 283.43 Morel 1981b, pp. 87-89; Bechtold 2007, pp. 59-60; 64-67.
203
Coppe e skyphoiCoppe a parete concavo-convessa. Nella letteratura archeologica, la defi nizione si riferisce a un vaso “per bere/mangiare” di medie dimensioni, con vasca pro-fonda, profi lo concavo-convesso, quasi verticale nella parte superiore; orlo appena estrofl esso e per lo più assottigliato; fondo spesso ombelicato; anse di solito ad anello verticale, variamente foggiato; piede tronco-conico, modanato. La forma presenta a volte una decorazione interna semplice, con poche linee orizzontali sovraddipinte, e una decorazione esterna sulla parte superiore della vasca, con due semplici linee orizzontali graffi te o dipinte sopra e sotto le anse o un tralcio vegetale graffi to con foglioline o baccellature sovraddipinte, secondo un gusto che imita i prodotti dello stile di Gnathia44.Nell’opera di Morel, l’insieme di queste caratteristi-che è ritenuto identifi cativo delle coppe genere 320045; in particolare, la specie 3210 è considerata peculiare della Sicilia e della Calabria meridionale dov’è datata al secondo quarto del III sec. a.C.46
Gli esemplari esaminati47 si riferiscono per lo più alla parte superiore della parete che si presenta più o meno concava, a volte diritta, con orlo più o meno estrofl esso (ventidue frammenti), e a piedi tronco-conici, modanati, comprendenti anche il fondo della vasca (venticinque frammenti). Tutti sono caratterizzati da precise peculiarità tecni-che osservabili ad occhio nudo: l’argilla ha un colore che varia dal rosa-nocciola (M7.5YR 7/4-6/4-7/6 o simili) al beige-giallino (M2.5YR8/3 o 10YR8/3), all’arancio-rosa (M5YR7/6-6/6) e, ad occhio nudo, sembra abbastanza depurata e compatta, soprat-tutto nei frammenti di colore beige o nocciola, con-tiene mica, anche se non in grandi quantità, e qual-che piccolissimo incluso bianco. La vernice appare di qualità abbastanza scadente, a volte opaca, tal-volta iridescente, di colore nero o nero-marrone,
poco aderente. Si tratta di una produzione abba-stanza caratterizzata la cui tipicità ci ha consentito di riferire anche i numerosi piedi tronco-conici modanati di viaa Ciantro alle coppe concavo-con-vesse dallo stesso sito, pur osservando che nel com-plesso non c’è un’esatta corrispondenza numerica.Sebbene non sia attestato alcun esemplare integro, l’evidenza ci porta a stabilire che a Milazzo la coppa prevalente sembra avere le caratteristiche di un vaso con vasca di media profondità dalle pareti più o meno concavo-convesse, a volte semplicemente emisferica, con orlo più o meno estrofl esso: ne deriva che gli esemplari milazzesi possono considerarsi talvolta assi-milabili alla serie Morel 3211, talvolta alla serie 3131. Alcuni frammenti, inoltre, conservano anche l’ansa, che, tranne in un caso (1919), non è mai a nastro con doppia scanalatura, come richiederebbe la serie 321148, bensì a doppio bastoncello “annodato”, sor-montato cioè da una barretta orizzontale o pseudo-nodo (4-84-8, tav. I e tav. 12, nn. 1-2), caratteristica della specie Morel 313049 a cui appartengono le coppe a vasca quasi emisferica delle serie Morel 3131-313350, datate generalmente dalla letteratura alla prima metà del II sec. a.C. nelle produzioni di Campana A e nelle sue imitazioni, ma presenti già nelle produ-zioni a v.n. di ambito siceliota e magnogreco alla fi ne del IV-prima metà del III sec. a.C.51.Numerosi sono i frammenti con decorazione sovraddipinta e/o graffi ta. Tra questi, alcuni (55, 1212, tav. I) esibiscono semplicemente linee bianche e rosse all’interno; altri conservano solo la decora-zione esterna con semplici linee orizzontali graffi te (88, 99, 1010, 1111, tav. I)52; talora, nella parte superiore della parete, nella zona sottostante il labbro (44, 77, tav. I; 1313, 1414, tav. II), accanto alle linee graffi te sono disposti obliquamente boccioli o foglie in bianco sovraddipinto. In particolare, si segnala la decora-zione di 1414 (tav. 12, n. 3) che, sulla vernice arancio,
44 Cfr. ad esempio, Orlandini 1957, p. 155, tav. LX.45 Morel 1981a, pp. 246-255, tavv. 86-90.46 Morel 1981a, pp. 255-256.47 La gran parte degli esemplari proviene dai vani 3 (17 fram-menti) e 4 (14 frammenti); pochi sono stati restituiti dai vani 1 (4 frammenti) e 2 (3 frammenti); mentre 9 frammenti hanno una provenienza sporadica.48 Morel 1981a, p. 255, tav. 90.49 Morel 1981a, p. 249.50 Tutte a vasca emisferica e con piede modanato si distinguono per l’orlo, più o meno verticale (serie 3131), svasato (serie 3132), o sot to-lineato da una scanalatura (serie 3133): Morel 1981a, pp. 249-250.
51 Per la Sicilia, cfr. Gentili 1954, p. 366, fi g. 19, forma 9, 20; Orlandini 1957, p. 155, tavv. LX, LXVIII; Pelagatti-Curcio 1970, p. 469, fi g. 40; Bisi 1970, pp. 548-549, n. 77, fi g. 38; Bisi 1971, p. 727, fi g. 66e (necropoli di Lilibeo, t. 28 Tamburello); Caflisch 1991, p. 124, tav. 18, nn. 579-586; M.L. V, pp. 91, 105, fi gg. 284b, 276c; Campagna 1998, pp. 383-392; Bechtold 1999, pp. 65,79, tavv. V, n. 46 e XII, n. 11 (presentati come kantharoi). Per l’Italia meridionale, cfr. Locri II, pp. 219-224, tav. XXIX, nn. 246-253; Preacco Ancona 1992, p. 129, tav. XLVII, nn. 62-64; Oppido Mamertina, pp. 280-282, fi g. 294, nn. 476-488; Laos I, p. 66, tav. 9, n. 13; Poseidonia-Paestum III, p. 127, fi g. 93, n. 33. 52 Cfr. dalla necropoli di Assoro, Morel 1966, p. 163, fi g. 51d.
204
ossidata in cottura, presenta, nella zona compresa tra le anse, su un lato, un tralcio di foglie di edera a s., graffi to e dipinto, sull’altro, un’iscrizione dipinta di cui si conserva solo la E, probabilmente iniziale del nome di una divinità invocata53.Le caratteristiche morfologiche sopra evidenziate e la decorazione sovraddipinta e/o graffi ta possono facil-mente riconoscersi come peculiarità delle cosiddette “offi cine dello Stretto”54, a cui riportano anche gli aspetti tecnici osservabili a occhio nudo. La presenza, a Milazzo, di coppe concavo-convesse a vernice nera sovraddipinta, peraltro attestate in numero abba-stanza consistente, si rivela di grande importanza nella defi nizione dell’area interessata dalla koinè pro-duttiva che caratterizza il III sec. a.C. nella Sicilia nord-orientale55. Le ceramiche dello Stretto risultano ben attestate, sul versante siciliano, a Messina56, dove la forma della coppa emisferica a parete conca-vo-convessa sembra godere di un particolare favore57, e lungo la fascia tirrenica a Tindari58. Per questo motivo, i rinvenimenti di Milazzo accrescono, con la loro consistenza di dati, l’area di diffusione delle ceramiche sovraddipinte dello Stretto, il cui arco cronologico di produzione è stato recentemente assegnato, grazie ad una messa a punto di U. Spigo basata su dati forniti da contesti tombali di Lipari, al periodo compreso tra la prima metà del III sec. a.C. (specie nel secondo venticinquennio) e la fi ne della prima guerra punica o poco dopo59. Sarebbe interes-sante indagare a questo punto, con l’ausilio di analisi archeometriche, su quali siano state le modalità e i centri di produzione delle ceramiche dello Stretto,
tanto più che l’osservazione ad occhio nudo dei reperti rivela caratteri simili tra le attestazioni dei vari centri, siciliani e calabresi60. Per questo motivo abbiamo avviato un programma di ricerca che com-prende, nell’ambito dello studio archeometrico delle ceramiche ellenistiche della costa tirrenica della pro-vincia di Messina61, anche l’indagine sugli esemplari milazzesi. Allo stato attuale del lavoro, l’analisi petro-grafi ca eseguita su un solo campione non ha dato risultati determinanti: non si esclude l’ipotesi che possa trattarsi di una produzione locale, ma, più prudentemente e in attesa dei risultati delle analisi, anche chimiche, su un maggior numero di esem-plari, preferiamo attribuire l’esemplare indagato genericamente all’area dello Stretto62.
Coppe con orlo rientrante. Tredici sono le coppe con orlo rientrante, quasi tutte frammentarie.Alla specie Morel 2710, datata tra la fi ne del IV e l’inizio del III sec. a.C.63 assegniamo 2020 e 2121 (tav. II), entrambe caratterizzate dalla parete non molto spessa che prosegue con un orlo vigorosamente rientrante, superiormente assottigliato. In partico-lare abbiamo ritenuto probabilmente attribuibili alla serie Morel 271464, ben attestata in Italia Meri-dionale e in Sicilia65, le coppe 2222-2626 (tav. II) con curvatura all’orlo meno accentuata e parte supe-riore dell’orlo più o meno assottigliata. Una variante può essere considerata 2727 (tav. II) con vasca poco profonda, orlo ingrossato, bombato, e appena ricurvo rispetto alla parete.A Milazzo, è attestata la specie Morel 2720, già rite-
53 Bacci 2001, pp. 12, 44-45, cat.VM/86; Spigo 2003, p. 64.54 Cfr. Spadea 1986, pp. 337-360. Per un aggiornamento delle problematiche storico-archeologiche della classe, considerata anche nei suoi rapporti con le offi cine eoliane, utili per un cor-retto inquadramento cronologico della produzione, cfr. Spigo 2003, pp. 59-68. Vedi anche Alexandropoulou 2002, pp. 73-75, 88, 96, 106-108.55 Per quanto riguarda il fronte calabrese, il raggio di diffusione delle ceramiche dello Stretto da Reggio si propaga sino a Palmi, sul versante tirrenico: cfr. Spigo 2003, pp. 61-62. Allo stesso gusto, in Sicilia, possiamo riferire vasi di Siracusa (cfr. Fallico 1971, p. 599, fi g. 24, A21-A34; p. 616, fi g. 38, B8); della necropoli di Leontinoi (cfr. Rizza 1955, p. 302, fi g. 18, n. 6; p. 305, fi g. 21, n. 15); della necropoli di Lilibeo (cfr. Bisi 1971, pp. 727-728, fi g. 66e); della necropoli di Assoro (Morel 1966, p. 238, fi g. 9); da Akrai (Pelagatti-Curcio 1970, p. 469, fi g. 42, n. 16).56 Griffo 1942, p. 76, fi g. 12, nn. 4 e 81 (necropoli Orti della Maddalena); Spadea 1986, pp. 342-343, 350-352 (senza prove-nienza); Ingoglia 2000, pp. 170-173, 201, cat. CST/9 (pozzo di Casa dello Studente/is. 141); Pavia 2001, p. 23, 33-35, catt.
VM/35-38 (via dei Mille/is. 145); M. Ravesi in Scibona 2001a, p. 67, VSM/60 e 61 (necropoli via S. Marta).57 Spigo 2003, p. 59.58 Spigo 2003, p. 62; Pavia 2008, pp. 128-130. Ad “ambito cul-turalmente prossimo, ad una stessa temperie di gusto” U. Spigo, in Spigo 2003, p. 64, assegna due skyphoi dalla necropoli di San Gio-vanni a Milazzo; cfr. Tigano 2002, pp. 92-93.59 Spigo 2003, p. 61.60 Spigo 2003, pp. 62 e 65.61 Il lavoro di analisi archeometrica delle ceramiche c.d. “dello Stretto” di età ellenistica è stato, in fase preliminare, avviato, sotto la guida della scrivente, su esemplari provenienti dal pozzo della Casa dello Studente, a Messina, cfr. Barone et alii 2003, pp. 107-108 (in particolare campione Me 19).62 Barone et alii, infra, p. 283.63 Morel 1981a, p. 208, tav. 66.64 Morel 1981a, p. 209, tav. 67.65 Per la Magna Grecia, cfr. Oppido Mamertina, p. 279, fi g. 293, cat. 461 con riferimenti; per la Sicilia, Caflisch 1991, p. 119, n. 539 ss., fi g. 16 (Monte Iato).
205
nuta tipica della Sicilia orientale e centrale tra gli ultimi decenni del IV e la prima metà del III sec. a.C.66, caratterizzata da un ingrossamento nel punto in cui la parete della vasca si fl ette nettamente verso l’interno proseguendo con l’orlo rientrante. In par-ticolare, abbiamo assegnato la coppa 2828 e forse 2929 e 3030 (tav. II) alla serie 272467, dalla vasca più larga e bassa rispetto alla serie 272568 attestata invece, nella forma piccola, con 3131 (tav. II).
Skyphoi. Dodici sono gli skyphoi riconosciuti con sicurezza (11 orli ed un piede). Di questi, possiamo assegnare al genere 4300, verosimilmente alla specie 437069, lo skyphos 3232, databile tra la se con da metà del IV e la prima metà del III sec. a.C.In particolare, il fondo 3333 (tav. V), è riferibile alla serie Morel 437570 attestata per la Sicilia alla fi ne del IV sec. a.C., come documentato nella tomba 91 della necropoli di Lipari71. Non può escludersi la possibilità che gli skyphoi 3434-3636 (tav. V), molto lacu-nosi, appartengano alla stessa serie.
PatereRilevante è la quantità di patere restituite dallo scavo potendosi conteggiare ben cinquanta esem-plari, di cui si presentano in questa sede i più signifi cativi.Di questi, il maggior numero è riferibile alla specie Morel 1530, di cui è ben attestata la serie 1534 (3939-4242, 46, 46, tavv. III-IV), datata dal Morel nella seconda metà del III sec. a.C.72. Con orlo convesso e più o meno pen den te, le patere di questa serie sono molto apprezzate nell’area dello Stretto dove sono datate tra la fi ne del IV e la prima metà del III sec.
a.C. a Lipari73, Romet ta74, Messina75; in Sicilia, sono documentate anche, sul versante orientale, a Sira-cusa76, e ad ovest, a Monte Iato77 e a Segesta78. Alla serie 1531, diffusa in area etrusca e nell’Italia settentrionale, tra il IV ed il II sec. a.C. può asse-gnarsi 4343 (tav. IV e tav. 12, n. 5), con orlo convesso poco pendente e vasca poco profonda79. La serie è attestata in Sicilia, forse a Monte Iato, dove è datata al IV-III sec. a.C.80. Un esemplare (4545, tav. IV) è assegnabile alle serie 131581, datata al III sec. a.C.Tra i grandi piatti menzioniamo 4444 (tav. IV), carat-terizzato da un orlo poco pendente e una vasca molto poco profonda.Il piattello 4747 (tav. IV), della serie Morel 1335, non è altrimenti attestato in Sicilia82: la sua data-zione, nella produzione attica, si colloca alla fi ne del II sec. a.C.83.
PissidiSono attestati due coperchi di pisside, 4848-4949 (tav. V), entrambi riferibili alla serie Morel 285684, nota in Sicilia85 e in Italia meridionale: 4949, in particolare, presenta, un anello rilevato tra due linee sovraddi-pinte in bianco all’attacco tra il saliente ed il labbro, quest’ultimo decorato da una linea rossa86.
Forme chiuseTre frammenti di anse verticali (5050-5252) a sezioni più o meno ovoidali, con differenti dimensioni e carat-teristiche morfologiche non consentono di riconoscer ne le forme chiuse di appartenenza. Lo stesso vale per l’orlo estrofl esso con imboccatura ad imbuto (5454). Il frammento di imboccatura ad estre-mità superiore ingrossata e appiattita e appendice
66 Morel 1981a, p. 210. Attestata a Lipari nelle serie 2723 e 2724 (Campagna 1998, p. 383, fi gg. 1f-1g), nella necropoli di Assoro (Morel 1966, p. 259, n. 9, fi g. 44b), a Gela (Orlandini 1960, p. 177, n. 4, fi g. 18a), nella necropoli di Naxos (Ciurcina 1984-1985, p. 462, n. 7, fi g. 177), ad Akrai (Pelagatti-Curcio 1970, p. 469, n. 18, fi gg. 42a, 56c).67 Morel 1981a, pp. 211-212, tav. 67.68 Morel 1981a, p. 212, tav. 67.69 Morel 1981a, pp. 311-313, tavv. 131-132.70 Morel 1981a, pp. 311-312, tav. 132.71 M.L. II, p. 36, t. 91b, tav. f, n. 1.72 Morel 1981a, pp. 120-121, tavv. 21-22.73 M.L. II, p. 48, t. 136, tav. f, n. 9; M.L. V, p. 5, tav. XXI, fi g. 54a (t. 1183, prima metà III sec. a.C.); Campagna 1998, p. 383, fi g. 1a.74 Griffo 1941, p. 129, fi g. 1.75 Pavia 2001, p. 33, VM/32.
76 Gentili 1954, fi g. 19, forma 8 (dalle thysiai dell’ara di Ierone II).77 Caflisch 1991, pp. 112-113, tav. 15.78 Parra 1991, p. 855, n. 2, tav. CCLXII.79 Morel 1981a, p. 120, tav. 21.80 Caflisch 1991, p. 112, tav. 15.81 Morel 1981a, pp. 104-105, tav. 13.82 A Lipari è attestato un grande piatto della serie 1333, della se conda metà del III sec. a.C.: cfr. Campagna 1998, pp. 382-383, fi g. 1c.83 Morel 1981a, p. 108, tav. 15.84 Morel 1981a, p. 233, tav. 78.85 Cfr. in particolare M.L. II, tav. h, n. 5, tomba 89 bis; Morel 1966, p. 238, fi g. 10q (Assoro); Morel 1981a, tipo 2856c, p. 233, tav. 78.86 La ceramica a v.n. sovraddipinta è attestata a Milazzo soprat-tutto con la forma della coppa a parete concavo-convessa: vedi supra, pp. 202-203.
206
pendula (5555) può assegnarsi forse ad una pseudo-lekythos della serie Morel 5471 o 5472 della prima metà del III sec. a.C.87.Un frammento di corpo e piede di lekythos ary-ballica88 (5656) può assegnarsi, invece, alla specie Morel 545089 e datarsi nel III sec. a.C.
Ceramica a pasta grigia e vernice neraCeramica a pasta grigia e vernice nera
Un solo vaso, frammentario e di provenienza spora-dica, può assegnarsi alla classe della ceramica a pasta grigia e vernice nera, la cui diffusione è datata genericamente nel corso del II-I sec. a.C.90.L’argilla di colore grigio medio, compatta, netta in frattura e la vernice nera opaca, spessa, di 575791 (tav. V) sono assegnabili ad una fabbrica di vasi cotti in atmosfera riducente di ambito locale, come è stato evidenziato dalle analisi archeometriche92. In Sici-lia, l’esisten za di produzioni che adottano queste caratteristiche tecniche è stata più volte segnalata dopo l’identifi cazione della campana C, di fabbrica siracusana, effettuata da Lamboglia93, ma si attende ancora uno studio puntuale che chiarisca il quadro dei centri di produzione dell’isola, evidenziandone, attraverso l’esame archeometrico94, innanzitutto gli aspetti tecnici, e chiarendone quelli morfologici e cronologici95 nel quadro più ampio della koinè siciliana del periodo.
Nel caso di Milazzo, del frammento di piatto di cui si conservano soltanto il piede e buona parte del fondo della vasca con tre gruppi di sottili cerchi concentrici incisi all’interno, non è riconoscibile la forma intera, a causa della sua lacunosità.
Ceramica campana B o B-oideCeramica campana B o B-oide
L’unico esemplare, 5858 (tav. V), sporadico, ha piede basso, molto obliquo, vasca che piega verso l’alto con una carenatura nella parte bassa della parete, all’altezza del fondo, e orlo leggermente ingrossato. È riferibile alla serie Morel 2311 databile tra la fi ne del II ed il I sec. a.C.96. L’argilla di colore nocciola, molto compatta, dura, depurata, la vernice nero-bluastra, densa, aderente rimanda alle caratteristi-che tecniche delle produzioni in Campana B e B-oide97, ma per un’esatta attribuzione il solo esame macroscopico non è suffi ciente98. Il problema della provenienza della ceramica cam-pana B-oide attestata in Sicilia è ancora lontano dall’essere risolto, anche perché, in generale, le conoscenze sui contesti di epoca repubblicana sono molto limitate. In particolare, vasi in Campana B e B-oide sono noti da Lipari99, ma si tratta di pochi problematici frammenti di III-II sec a.C., mentre è ben attestata nel relitto A (Roghi) di Filicudi datato alla prima metà del II sec. a.C.100.
87 Morel 1981a, p. 367, tav. 173.88 Un altro frammento, molto lacunoso, può assegnarsi, in via ipotetica, alla stessa forma.89 Morel 1981a, pp. 364-366, tavv. 171-172.90 Per l’inizio della diffusione nel II sec. a.C., piuttosto che alla fi ne del III sec. a.C., in Sicilia, cfr. Pelagatti-Curcio 1970, pp. 472-473; Morel 1979, p. 156; Stone 1981, pp. 98-99.91 Di provenienza sporadica.92 Barone et alii, infra, pp. 273-301.93 Cfr. Lamboglia 1952, pp. 140, 156-163; Morel 1963, p. 17; Pelagatti-Curcio 1970, pp. 470-476; Morel 1981a, p. 47; Olcese-Picon 1998, pp. 31-37. Per Morgantina, cfr. Cuomo di
Caprio 1992, pp. 89-96. Per i rapporti tra la fabbrica siracusana e quella di Morgantina, cfr. Caflisch 1991, pp. 204-205. Per l’iden-tifi cazione di produzioni locali di ceramica a pasta grigia cfr., in Italia Meridionale, Giardino 1977 (Heraclea); Giardino 1980 (Metaponto); Hempel 1996 (Taranto); Mirti et alii 1998 (Sibari e Locri), pp. 312, 325-326. Per la Sicilia, oltre che da Lipari (cfr. Campagna 1998) e da Tindari (Pavia 2008, pp. 131-132) sono stati segnalati pochi esemplari da Siracusa, Licodia Eubea, Solunto, Agrigento, Heraclea Minoa, cfr. Campagna 1998, pp. 389-392, nota 76 con riferimenti. Attestazioni sono segnalate anche da Termini Imerese, cfr. Termini Imerese, pp. 246-248.
94 Per la caratterizzazione della campana C, vedi Morel-Picon
1994, pp. 44-46. Cfr. anche Morel 1998, p. 12.95 Importante sarebbe verificare quanto proposto sulla base della documentazione di Akrai (Pelagatti-Curcio 1970, p. 469) e Morgantina (Stone 1981, pp. 125-126, 129-131) a pro-posito di una diffusione differenziata delle ceramiche campana C e campana A. La presenza di quest’ultima molto abbondante nella Sicilia occidentale e meridionale, sarebbe poco attestata nella Sicilia orientale dove invece prevarrebbe in maniera consistente la documentazione relativa alla Campana C. Sul significato della diffusione della campana A nella Sicilia occi-dentale e meridionale cfr., recentemente, Bechtold 2007, pp. 59-60, 62-65. In particolare per Lipari, cfr. Campagna 1998, pp. 383-392, per le produzioni a v.n. da Palermo, M. Iato, Ter-mini Imerese, cfr. Belvedere et alii 2006.96 Morel 1981a, p. 163, tav. 46.97 La prima defi nizione della ceramica campana B è dovuta a Lamboglia 1952, pp. 143-155. Cfr. anche Morel 1963, pp. 7-58; Morel 1981a, p. 47; Gliozzo-Memmi Turbanti 2004.98 Morel 1981b, pp. 95-97.99 Campagna 1998, pp. 392-394. Per il relitto di Filicudi cfr. Morel 2004, pp. 87-95.100 Cavalier 1985, pp. 114-120.
207
In attesa dei risultati delle analisi di laboratorio, possiamo solo constatare che gli elementi tecnici del vaso in questione si distinguono da quelli riscontrati in generale nella ceramica a v.n. di Milazzo, lasciando aperta l’ipotesi che possa trat-tarsi di un prodotto importato, non necessaria-mente da area etrusco-campana. Del resto, l’esi-stenza di offi cine locali o regionali che imitano prodotti della campana B è già un fatto assodato101, che ha trovato conferma anche nella Sicilia occidentale102.
Vasi Plastici (Magenta Ware)
Diversi frammenti di vasi plastici sono assegnabili alla classe della cosiddetta Magenta Ware. Tutti sono caratterizzati da un’argilla di colore rosa-beige (M10YR7/4) e da una particolare vernice arancio, densa, compatta in qualche punto sovraddipinta col colore crema che certamente sarà stato utilizzato per indicare i dettagli delle fi gure rappresentate. In generale, lo stato di conservazione frammentario di fi gure plastiche fa si che l’iconografi a non risulti di
facile lettura, sempre che tra i frammenti non si con-servi qualche dettaglio particolarmente indicativo. I frammenti in esame, dieci in tutto, combaciano solo parzialmente, lasciando ipotizzare l’appartenenza ad un unico vaso, ma non possiamo escludere che possa trattarsi di due o tre vasi.Di questi, soltanto per uno (5959, tav. 13, n. 1), di cui è stato possibile ricomporre parte della parete, siamo in grado di proporre l’identifi cazione della scena rap presentata. Dell’altro (6060, tav. 13, n. 2), anch’esso ricomposto, si conservano piccole porzioni delle pareti di due lati, ma il riconoscimento della scena o dell’animale rappresentato appare diffi cile. Un fram-mento di dimensioni ridotte (6161, tav. 13, n. 3), carat-terizzato da una vernice più scura tendente al rossic-cio, potrebbe appartenere all’uno o all’altro degli esemplari sopra distinti, ma anche, non avendo ulteriori elementi discriminanti, confi gurarsi come l’unico frammen to di un terzo vaso.Lo studio della Magenta Ware, così defi nita da Beazley nel 1953103, appare ancora lungi dall’essere defi nito104, sia nei suoi aspetti cronologici105 che per le determinazioni di origine106. La gran quantità di vasi plastici in Magenta Ware attestata nell’area dello Stretto (a Lipari107, a Mi -
101 Morel 1981b, pp. 95-97; Morel 1998, pp. 12-15.102 Caflisch 1991, p. 196 ss.103 Beazley J., in Richter G.M.A., The Metropolitan Museum of Art. Handbook of the Greek Collection, 1953, p. 132.104 Higgins 1976, pp. 5-15, ha raccolto tutta la documenta-zione allora disponibile, individuando problemi fondamentali, a tutt’oggi ancora aperti, della classe: la funzione dei vasi, l’identifi -cazione dell’iconografi a, i centri di produzione, la cronologia. Esaminando tutti gli esemplari noti, lo studioso ha proposto una suddivisione tipologica, sulla base degli elementi funzionali del vaso e distinguendo tre gruppi, da lui defi niti lampfi llers (gruppo A, 120-70 a.C.) (lucerne con serbatoio?), handled fl asks (fi aschetta a mano?) (gruppo B, 80-1 a.C.) e strainer fl asks (fi aschetta con fi l-tro) (gruppo C, 80-1 a.C.).105 Il problema della datazione e del luogo di produzione fu ripreso da Szilagyi 1983, in occasione della pubblicazione dei lampfillers del Museo delle Belle Arti di Budapest ed in seguito dallo Sguaitamatti 1981, 1988, 1991, che dedicò diversi studi all’analisi della classe, che deve essere condotta, metodologica-mente, con gli stessi criteri di classificazione della coroplastica (Sguaitamatti 1991, p. 120). Entrambi gli studiosi conclu-dono piuttosto per una datazione più alta per l’inizio di tale produzione, da ricondurre alla seconda metà del III sec. a.C. in varie officine dell’Italia Meridionale e della Sicilia, ma anche in Grecia, in Egitto, in Russia meridionale (Szilagyi 1983, pp. 362-364; Sguaitamatti 1981, pp. 109-112; Sguaitamatti 1991, pp. 136-137) in continuità con la produzione dei vasi plastici a vernice nera e in stretta connessione con la coropla-stica (Sguaitamatti 1991, pp. 136-137). Un importante recente
rinvenimento, effettuato proprio nella necropoli di Milazzo, confermerebbe tale ipotesi, come già evidenziato da R. Leone nella sua disamina degli esemplari di Magenta Ware conservati nei magazzini del Museo di Messina (Leone 1997, p. 61). La tomba 5 di c.da San Paolino a Milazzo ha restituito un vaso con filtro (strainer flask) a forma di oca con ghirlanda al collo data-bile per analogia con la cronologia degli altri elementi del cor-redo alla metà del III sec. a.C. (Tigano 1989, p. 53, fig. 1; Tigano 1993-1994, pp. 1073-1074; Tigano 1994, p. 79, fig. 33; Tigano 2002, pp. 120-121 con riferimenti. In particolare, ter-mini ad quem o post quem per la datazione della tomba sono due monete bronzee siracusane con al D/testa giovanile di Zeus laureato volto a ds. e al R/aquila ad ali aperte su fulmine della metà del III sec. a.C., per le quali vedi Carbè A., in Tigano
2002, p. 123). Una proposta di datazione era già stata presen-tata da M.A. Mastelloni che nell’esibire un askos a protome equina in Magenta Ware dal Museo di Messina avrebbe indivi-duato un elemento di datazione della classe per così dire interno nelle anfore che costituiscono la soma sul dorso del cavallo dell’askos che riprodurrebbero il tipo greco-italico più antico, della metà ca. del III sec. a.C. (Mastelloni 1993, pp. 39-40; Leone 1997, pp. 62-64). 106 Pur non conoscendo, se non sporadicamente, i contesti di provenienza dei vasi presi in considerazione, poiché per lo più appartenenti a collezioni private, Higgins 1976 avanzò l’ipotesi che la produzione di questa classe fosse da assegnare all’occidente greco ed in particolare ad una fabbrica campana e ad una siceliota attive nel II-I sec. a.C.107 M.L. II, p. 8, t. 10, tav. CCXV, nn. 1-2, 4.
208
lazzo108, a Messina109, a Reggio Calabria110)111 non lascia dubbi su un’incontestabile preferenza degli abitanti di quest’area per i vasi plastici a vernice rossa o arancio, spesso scelti come elementi di cor-redi tombali.Ne consegue la formulazione dell’ipotesi di una produzione in loco, in un’offi cina unica per tutta l’area o in più offi cine: per questo motivo sono state avviate le necessarie indagini archeometriche. I risultati, ancora preliminari, poiché comprendono al momento soltanto analisi petrografi che su sezioni sottili, hanno fornito dati non ancora defi -nitivi, compatibili con una produzione locale o dell’area dello Stretto112. La varietà di iconografi e note per la Magenta Ware non è suffi ciente per consentirci di interpretare i soggetti a cui appartenevano i frammenti di Milazzo in questione, né d’altro canto siamo in grado di sapere se si trattava di lampfi llers, handled fl asks o strainer fl asks poiché in nessuno dei pezzi si conserva parte di un’apertura, né di un fi ltro. Soltanto per il frammento 1 riteniamo ragionevolmente di potere effettuare un’interpretazione, assegnandolo ad una scena di leone che azzanna un toro o similia. Si riesce infatti a distinguere, oltre alla zampa di un ungulato, quella unghiata di un felino cui apparteneva forse il pelo agitato. Cosa potessero indicare i due tratti bianchi sulla destra del frammento non siamo in grado di dirlo. Nella letteratura archeologica pochis-simi sono gli esemplari in Magenta Ware con questo soggetto113, peraltro stilisticamente non confronta-bili con il nostro frammento. Si conoscono diversi vasi confi gurati a ungulati114, qualcuno a felini115, ma tra di essi nessuno è assegnabile a fabbriche o a mani identifi cate. Nel frammento 2, in cui riusciamo a distinguere soltanto due rigonfi amenti sopra lo zoc-
colo di base del vaso, sull’altro lato, dove la vernice arancio si schiarisce fi no a diventare gialla, si osserva la presenza di segni incisi lacunosi, la cui compren-sione risulta impossibile. Il terzo frammento di pic-cole dimensioni è di diffi cile lettura.Quanto alla cronologia i nostri esemplari possono dire ben poco anche perché provenienti dalla quota superfi ciale di scavo del vano 4.
Unguentari
Sette sono gli unguentari fusiformi restituiti dallo scavo della fattoria di via Ciantro: di questi solo uno è integro (6262, tav. V). Tutti caratterizzati da un argilla fi ne, depurata, di colore molto chiaro, sono ornati da una semplice decorazione, ottenuta immergendo l’orlo e parte del collo in un bagno di vernice nera opaca e diluita. Insieme con l’unguentario a base tripartita, l’un-guentario fusiforme è senza dubbio il vaso da corredo più attestato nella necropoli orientale di Milazzo, come del resto avviene in gran parte delle necropoli magno-greche e siceliote di età ellenistico-repubblicana116. Pertanto, si è suppo-sto che la forma, essendo molto richiesta per le esigenze dei rituali funerari, sia stata prodotta “in loco”117, ipotesi che i primi risultati delle analisi petrografi che non escludono, anche se in maniera non defi nitiva118.Morfologicamente, i nostri esemplari possono assegnarsi al tipo V della Forti119, tradizional-mente datato nell’ultimo quarto del III sec. a.C. e ben documentato nella necropoli di Milazzo, in tombe con corredi assegnati al III-II sec. a.C.120.
108 Tigano 1989, p. 53, fi g. 1; Tigano 1993-1994, pp. 1073-1074; Tigano 1994, p. 79, fi g. 33; Tigano 2002, pp. 120-121.109 Mastelloni 1993, p. 93; Mastelloni 1996, p. 753, n. 395; Leone 1997, pp. 62-64. 110 Cristofani 1968, pp. 227-229, fi g. 9, nn. 22-24 (da abitato); Spadea 1986, p. 358, tav. 35, n. 2; Spadea 1987, p. 99 (da necropoli). 111 Sempre nell’area orientale della Sicilia, un esemplare di askos a protome equina pubblicato dal Libertini 1930, pp. 205, 870, tav. XCIX e conservato nel Castello Ursino di Catania, riporta alla medesima produzione. V. anche Leone 1997, p. 65, nota 8.112 Barone et alii, infra, p. 283.113 Higgins 1976, cat. nn. 79-80, fi gg. 47-48 (dalla zona di Viterbo, da Knossos).114 Tori: Higgins 1976, cat. nn. 27-34, fi gg. 21-22 (da Tarquinia,
Pozzuoli, Ampurias, dalla Cirenaica, da Capua); arieti: Higgins
1976, cat. nn. 35-41, fi gg. 23-24 (dalla Siria, dall’Italia, dall’Etru-ria, probab. dalla Sicilia); capre: Higgins 1976, cat. nn. 42-44, fi gg. 275-279 (da Rodi, dall’Italia). 115 Leoni: Higgins 1976, cat. nn. 25-26, fi g. 20 (dall’Italia, da Budva); leopardi: Higgins 1976, cat. nn. 81-86, fi gg. 49-51 (da Taormina, da Siracusa, da Leukas, da Morgantina, dall’Italia).116 Tigano 2002, p. 98. Cfr. anche Hempel 2001, p. 103.117 Per il problema della localizzazione dei centri di produzione cfr. Camilli 1999, pp. 30-37, note 101-110.118 Barone et alii, infra, pp. 283-284.119 Forti 1962, pp. 151-152, tavv. VII-VIII. Cfr. anche Camilli 1999, p. 25, forma B, serie 32.120 Cfr. in particolare l’unguentario inv. 3633 dalla tomba 37, di S. Paolino, via Ciantro (coop. Serena) in Tigano 2002, p. 109.
209
La recente revisione della cronologia del tipo, effettuata da Hempel121, ci induce piuttosto ad attribuire i nostri unguentari alla seconda metà del II sec. a.C. e oltre122.
Anfore da Trasporto
Le anfore da trasporto dal cantiere costituiscono un nucleo abbastanza signifi cativo, contribuendo in maniera considerevole ad arricchire le conoscenze sulla diffusione di questa classe di materiale lungo la costa tirrenica della Sicilia in età ellenistica. Lo stato di conservazione delle anfore, tutte in frammenti non ricomponibili, non ha facilitato l’analisi della classe. La classifi cazione, pertanto, si fonda essenzialmente sulla considerazione dei frammenti di orlo cui soltanto sporadicamente è stato possibile attribuire frammenti di collo o altre parti del corpo. Ridottissimo è il numero delle anse e dei puntali. In un solo caso siamo stati in grado di distinguere una spalla. In generale, non il solo frammento di orlo rende impossibile una completa e sicura ricostruzione della forma.La gran parte delle anfore è morfologicamente rife-ribile alle cosiddette greco-italiche e può attribuirsi a produzioni di età ellenistica di area magno-greca e siceliota. Frammenti di orlo attestano la presenza di due anfore pseudo-chiote e un’anfora punica.Nello studio degli esemplari, ci è parso opportuno privilegiare il problema del luogo di produzione delle anfore; e a tal fi ne, unitamente agli aspetti morfologici, sono state tenute in debito conto le
caratteristiche tecniche degli impasti osservabili macroscopicamente, poiché riteniamo che, anche in assenza di analisi chimiche, possano fornire ele-menti utili per la distinzione di reperti prodotti in aree diverse.
Anfore pseudo-chioteAnfore pseudo-chiote
Due frammenti di orlo con sezione “a mandorla” allungata sono assegnabili a due diversi esemplari di anfore cosiddette pseudo-chiote che si aggiun-gono agli esemplari già noti da Milazzo, utilizzati come enchytrismoi nella necropoli di S. Giovanni123. L’attribuzione alla classe è facilitata nel frammento 6363 (tav. VI e tav. 13, n. 4) dalla forma rigonfi a della piccola porzione di collo conservata, caratteristica che accomuna le anfore di questa classe alla produ-zione dell’isola di Chio124, da cui deriva la denomi-nazione più frequente in letteratura125. Negli ultimi decenni, diversi contributi hanno san-cito l’origine occidentale del tipo, distinguendo al momento pochi centri o aree di produzione. In particolare, studi condotti da M. Barra Bagnasco sulla documentazione di Locri126 hanno indivi-duato nel sito un importante centro di produzione, confermando in via defi nitiva quanto precedente-mente intuito da V. Grace127. La fabbrica locrese ben attestata sia in Magna Grecia128 che in Sicilia129 potrebbe aver avuto un ruolo propulsore per l’affer-mazione della forma in Occidente, come ha propo-sto di recente G. Spagnolo130.Un’altra importante area di produzione è da conside-rarsi quella campana, il Cilento in particolare secondo
121 Hempel 2001, pp. 39-40, 104-105, 139-140, tav. 11, tipo 611, 7.122 Cfr. Coppolino, infra, p. 241.123 Tigano 1993-1994, p. 1067; Spagnolo in Tigano 2002, p. 83, t. 180.124 Vandermersch 1994, pp. 65-69 denomina queste anfore MGS II attribuendole ad ambito occidentale; più spesso queste anfore sono designate con appellativi che richiamano la somi-glianza con la forma tipica della produzione dell’isola di Chio: “pseudo-chiote”, “cosiddette chiote”, “di tipo chiota”. 125 Come ha defi nitivamente osservato Whitbread 1995, pp. 135-153, la comunanza con le anfore prodotte nell’isola di Chio si riferisce esclusivamente agli aspetti morfologici, mentre appare chiaro che le caratteristiche tecniche visibili ad occhio nudo, evi-dentemente diverse da quelle della anfore “bulgy neck” chiote e la particolare concentrazione di ritrovamenti in ambito occidentale deve necessariamente riportare la produzione di queste anfore ad area magno-greca e siceliota. 126 Barra Bagnasco 1990, pp. 30-35, 45-47, catt. a-d, tavv.
I-III; Barra Bagnasco 1992, pp. 211-214, cat. nn. 191-197, tavv. LXI, LXVI-LXVII; Barra Bagnasco 1995, pp. 77 ss., fi gg. a-c.127 V. Grace in Stoop 1974-1975, p. 164.128 Barra Bagnasco 1992, p. 211, tavv. LXI, LXVI; Barra Bagna-
sco 1995, pp. 78, fi gg. 1d-1f; 2-3, 6 (Locri); Kaulonia I, p. 97, fi g. 64, nn. 488-490; Stoop 1974-1975, p. 164, tav. LXXVI, nn. 2-4 (Franca-villa Marittima); Arthur 1990, p. 280, fi g. 191, nn. 371-373 (Roc ca-glo rio sa); Tomasello 1972, fi gg. 15f, 23h e 4m (Monasterace Marina).129 Alla fabbrica locrese Spagnolo 2003, p. 43 ha assegnato gli esemplari editi in Albanese Procelli 1996, pp. 118-120 (Sicilia); Polizzi 1997, pp. 97, 101-102, fi gg. 2 e 5, nn. 12-15 (Solunto); Spagnolo in Da Zancle a Messina, vol. I, VLF/117, VLF/120,
VLF/126; Pavia 2001, VM/20 (Messina); Spagnolo in Tigano
2002, p. 83 (Milazzo). La fabbrica è attestata anche nel relitto di Porticello (Jones Eiseman-Sismondo Ridgway 1987, pp. 48-50, tipo 3, fi g. 4, C31) e nel relitto H di Marzamemi (Parker 1976-1977, p. 630, fi g. 1, n. 1).130 Spagnolo 2003, p. 43.
210
la proposta di P. Arthur131 recentemente ripresa da V. Gassner nei suoi studi su Velia132. Prodotti campani sono ben attestati sia in Sicilia133 che in Magna Gre-cia134, come ha evidenziato G. Spagnolo135, sporadi-camente in Grecia136 e a Cipro137, con documenta-zione a partire dai primi decenni del V sec. a.C. Altri centri possono individuarsi presumibilmente tra il Bruzio e la Campania meridionale138.Per la Sicilia, un centro di produzione proposto è Selinunte139, mentre recentemente è stata ricono-sciuta una produzione dell’area dello Stretto carat-terizzata da un orlo ad echino alto e assottigliato con doppia nervatura all’attacco con il collo, impa-sto di colore rosato, mica a scagliette e piccoli inclusi bianchi e grigi con attestazioni della seconda metà del V sec. a.C.140.Il successo delle anfore pseudo-chiote iniziato presu-mibilmente alla fi ne del VI sec. a.C. continuò fi no alla fi ne del IV sec. a.C.141, ma non è possibile assegnare datazioni precise alle varianti che caratterizzano la forma. L’ipotesi che la forma con orlo allungato, supe-riormente assottigliato possa essere più tarda, della seconda metà del IV sec. a.C.142, non ha trovato sino a questo momento conferme defi nitive, richiedendo studi più approfonditi. Del resto, anfore con caratte-ristiche simili sono attestate in contesti più antichi risalenti anche alla metà del V sec. a.C.143.Alla luce di quanto sopra esposto, possiamo ricon-durre gli orli di Milazzo alla produzione locrese caratterizzata dall’argilla di colore rosa chiaro (M7.5YR 7/4) con molti inclusi piccoli e medi bian-chi e leggera scialbatura superfi ciale. Non siamo in grado però di stabilire con precisione la loro cronolo-
gia poiché gli aspetti morfologici, come si è accen-nato, non sono signifi cativamente indicativi. Se con-sideriamo i nostri esemplari come i frammenti più antichi del contesto di provenienza bisognerebbe proporre per loro una cronologia bassa nell’ambito della produzione delle pseudo-chiote, nell’ambito della seconda metà del IV sec. a.C.
Anfore con orlo a quarto di cerchioAnfore con orlo a quarto di cerchio
L’anfora 6464 appartiene alle anfore con “orlo a quarto di cerchio” del gruppo Vandermersch III144. Il tipo, considerato di transizione dalle anfore greche classi-che alle greco-italiche145, presenta alcune varianti morfologiche, entrambe prodotte contemporanea-mente146. L’orlo dell’esemplare milazzese è caratte-rizzato dal profi lo esterno a quarto di cerchio e la parte superiore appiattita e, per la forma, trova riscontro morfologico in alcune anfore prodotte a Locri tra fi ne IV e inizi III sec. a.C.147.Dal punto di vista tecnico all’osservazione ad occhio nudo presenta un’argilla abbastanza depurata, di colore rosa (tra 5YR 7/4 e 7.5YR 7/4), con inclusi scuri piccolissimi, a frequenza bassa, e bianchi, piccolissimi, a frequenza bassa. La superfi cie è ben levigata sia all’interno che all’esterno e ingubbiata con un bagno di colore rosa148. L’esistenza di offi cine che producevano anfore con orlo ad echino è stata ipotizzata in diversi centri dell’Italia meridionale (Montegiordano, Thourioi, Crotone, Paulonia, Hèrakleia Lucana, Medma, Pomarico Vecchio, Velia) e della Sicilia (Naxos),
131 Arthur 1990, p. 281, nn. 371-373, fi g. 191.132 Gassner 1999; Gassner 2005, pp. 497-501.
133 Cavalier 1985, pp. 39 ss., fi gg. 8-9, 18b-18c, 20; tavv. VII-XII-XXIII, nn. 21-23, 26-27, 29-32, 34-35, 105-107 (Lipari); Tam-
burello 1969, p. 294, tomba 13, fi g. 261 (Palermo); Camerata
Scovazzo-Castellana 1981, fi gg. 12-13, 19-20, 23 (Palermo); Spagnolo 1995, cap. III, gruppo P, pp. 270-272 (Gela).134 Arthur 1990, p. 281, nn. 371-373, fi g. 191 (Roccagloriosa); Di Sandro 1981, pp. 49 ss.; Albore Livadie 1985, pp. 140-141, fi g. 31 (Campania); Di Sandro 1986, pp. 44, 59 ss., tavv. 9-10, 12-13 (Pithecusa); Poseidonia-Paestum II, pp. 114-115, n. 164, fi g. 65 (Poseidonia); Cipriani 1996, p. 79, cat. 36, 26 (Eboli); p. 150, cat. 58,9 (Gaudo); Kaulonia I, pp. 95-96, fi g. 64, nn. 482-484; Sibari II, p. 356, n. 599, fi g. 364 (Sibari).135 Spagnolo 2003, pp. 38-39.136 Williams 1979, tav. 45c (Corinto).137 Calvet-Salles 1993, fi gg. 236, 240, n. 578 (Kition).138 Vandermersch 1994, pp. 67-69.
139 Fourmont 1992, p. 66, fi g. 15, n. 79/2240.
140 Spagnolo 2000, VLF/129; Pavia 2001, VM/20, fi g. 10;
Spagnolo 2003, p. 44.141 Vandermersch 1994, p. 67; Albanese Procelli 1996, pp. 116-118; Spagnolo 2003, p. 43.142 Albanese Procelli 1996, p. 118; Parra et alii 1995, p. 60, fi g. 40, n. 3.143 Vedi, ad esempio, Stoop 1974-1975, p. 164, nn. 6-7, tav. LXXVI, nn. 2-4, datate intorno alla metà del V sec. a.C.144 Vandermersch 1994, pp. 69-73.145 Locri IV, p. 215.146 Locri IV, pp. 215-216; Campagna 2000, pp. 448-449. Per i problemi terminologici, Maggi 2004.147 Barra Bagnasco 1990, pp. 38-39 e 47, g-h, tavv. V-VI, fi gg. III-IV; Locri IV, pp. 216-217, tav. LXII, tipo A.148 Cfr. impasto 4 delle greco-italiche, di provenienza locale o da area non defi nita: vedi, infra, p. 212.
211
sulla base di rinvenimenti di scarti di fornace o di considerazioni macroscopiche149, ma esse furono certamente prodotte anche a Locri e ad Ischia, dove è stata identifi cata una produzione locale grazie ai risultati delle analisi di laboratorio150. Quanto alla diffusione sono attestate in Italia meri-dionale, da scavi di Roccagloriosa151, Vaste152, Ca -ria ti153 ed Oppido Mamertina154; in Sicilia, dalla necropoli di Portinenti a Lipari155 e dal relitto di Marzamemi156. In generale, i contesti di rinveni-mento riportano ad una datazione di questo tipo di anfora tra la seconda metà del IV e gli inizi del III sec. a.C.
Anfore greco-italicheAnfore greco-italiche
Le anfore greco-italiche o con orlo a sezione triango-lare157 sono ben attestate: tutte frammentarie sono riconoscibili dall’orlo; solo raramente si sono con-servate anche porzioni di collo e spalla e di anse. La gran parte proviene dallo scavo del vano 3 che ne ha restituito otto esemplari158. Dopo la Lyding-Will che, nel 1982, ha presentato la prima sistemazione tipologica delle anfore greco-ita-liche distinguendone cinque tipi, denominati dalle lettere a-e159, è stato il Vandermersch che, nel 1994, nell’ambito di uno studio sulla circolazione del vino e
dei contenitori che lo trasportavano, ha introdotto una nuova suddivisione morfologica, denominando i tipi con i numeri romani da IV a VI160. Lo studioso ha discusso, insieme all’inquadramento cronologico dei contenitori da trasporto, le problematiche sui centri di produzione di area magno-greca e siceliota, per cui, nella defi nizione dei tipi, il numero romano cor-rispondente ad ogni forma è preceduto dalla sigla MGS (=magnogreca e siceliota)161. Il quadro proposto è stato accolto, da allora, negli studi sulle anfore greco-italiche, pur nella consape-volezza che un lavoro di classifi cazione tipologica sistematica della classe, che tenga conto dei diversi aspetti – morfologico, tecnologico, epigrafi co – deve ancora essere elaborato162. Ai fi ni dell’attribuzione tipologica e cronologica delle anfore di Ciantro abbiamo adottato i tipi del Vander-mesch, denominandoli però soltanto con i numeri romani, ed escludendo la sigla MGS, il cui signifi cato risulta troppo generico allorquando si affronta il problema della determinazione di origine163.La principale diffi coltà nello studio delle anfore greco-italiche è costituita dall’esistenza di numerosi centri di produzione: di questi soltanto pochi, tra quelli individuati, sono stati studiati in maniera articolata, utilizzando cioè i diversi approcci – archeologico, archeometrico, epigrafi co – necessari164; mentre tante produzioni locali devono ancora essere riconosciute.
149 Vandermersch 1994, pp. 71-72.150 Per Locri, Barra Bagnasco et alii 2001; per Ischia, Olcese 2005-2006, p. 64.151 Arthur 1990, pp. 279-281, nn. 362-363, fi g. 190.152 P. Caggia in Archeologia dei Messapi, p. 165, nn. 284-285.153 Guzzo-Luppino 1980, p. 837, n. 45, fi g. 1.154 Oppido Mamertina, p. 299, cat. 565, fi g. 309.155 Campagna 2000, p. 447, cfr. in particolare, per la forma dell’orlo, cat. n. 13, fi g. 4b.156 Parker 1976-1977, fi g. 1, n. 3, da Marzamemi.157 Per la prima denominazione cfr. Blanck 1978, Manacorda 1981, Lyding Will 1982. La seconda denominazione è stata pro-posta in seguito da M. Barra Bagnasco in Locri IV, p. 219. Recen-temente Coretti ha adottato, per le anfore greco-italiche antiche, la denominazione di “greco-occidentali recenti”, e, per le greco-itali-che recenti, di “anfore con orlo a sezione triangolare”. La proposta, pur contribuendo, nel primo caso, a sottolineare “la tendenza a privilegiare gli elementi di continuità rispetto alla tradizione delle anfore greco-occidentali di V e IV sec. a.C.”, di cui le greco-italiche costituiscono “l’ultimo sviluppo”, non risolve i problemi storico-archeologici della classe, limitandosi a determinare una generica origine della classe in area greco-occidentale con la prima defi ni-zione, una notazione morfologica con la seconda. Cfr. Corretti-Capelli 2003, pp. 296, 302 con riferimenti.158 Sette provengono dal recupero del materiale sporadico effettuato dopo lo sbancamento dell’area da parte dei mezzi mec-
canici. Sulle modalità e sulle condizioni dello scavo, cfr. Tigano, supra, pp. 197-199.159 Lyding Will 1982.160 Vandermersch 1994, p. 161. Per alcuni problemi insiti nella proposta di classifi cazione del Vandermersch, cfr. Asensio i Vila-
rò-Martin i Menéndez 1998, pp. 142-143; Campagna 2000, p. 444; Olcese 2004, nota 14.161 Vandermersch 1994, pp. 160-161. Lo stesso Vandermersch nel 2001, mantenendo la stessa numerazione proposta nel 1994, distingue con la sigla RMR le anfore greco-italiche prodotte in area laziale (Latium vetus e Latium adiectum), cfr. Vandermersch 2001, in part. p. 172. Ma, come osserva Olcese 2004, p. 184, senza le analisi sulle determinazioni di origine, non è possibile distinguere le anfore di produzione magno greca o siceliota da quelle romano-repubblicane, soprattutto se prive di bollo. Per questo motivo, in Bechtold 2007, si adotta accanto ai numeri per la denominazione dei tipi, la sigla cumulativa MGS/RMR.162 Tra i lavori più recenti, cfr., per esempio, Campagna 2000; Olcese 2004; Olcese 2005-2006.163 Cfr. Olcese 2004, pp. 172-173.164 Purtroppo, nelle pubblicazioni, il più delle volte non sono presentati i dati archeometrici necessari per le verifi che e i con-fronti; in pochi casi, anche se sono state effettuate analisi di tipo sia fi sico che chimico, sono proposti soltanto i dati petrografi ci (ad esempio, Thierrin Michael 2000 per le anfore di Pech Maho (Francia). Cfr. Barone et alii, infra, pp. 287-288.
212
Determinazione di origine: dati macroscopiciAlcune osservazioni effettuate ad occhio nudo sulle anfore di via Ciantro, in particolare sul colore della ma trice argillosa, la frequenza, la dimensione e il colore degli inclusi hanno consentito di distinguere 5 impa-sti165. Questi, sempre in base all’osservazione autoptica, possono distinguersi in due grandi raggruppamenti. Il primo gruppo, che comprende gli impasti 1 e 2 entrambi caratterizzati dall’abbondanza di inclusi neri, è stato identifi cato grazie al confronto autoptico con anfore già attribuite, in base ad analisi archeome-triche, all’Italia centrale e pertanto è stato defi nito delle “anfore campano-laziali”: in questo possiamo includere il maggior numero di esemplari da Milazzo. Il secondo, invece, comprende gli impasti 3, 4, 5 che ad occhio nudo, presentano caratteristiche completa-mente diverse dal primo gruppo: lo abbiamo defi nito “delle anfore locali o di aree non defi nite”.
Descrizione degli impasti
Gruppo di provenienza campano-laziale
Impasto n. 1Argilla di colore arancio più o meno rossiccio (2.5YR6/8), frattura più o meno regolare, qualche vacuolo. Inclusi: scuri piccoli a frequenza elevata e distribuzione irregolare; neri, lucenti a frequenza bassa; bianchi, piccoli e medi, a frequenza media e distribuzione irregolare; tracce di mica; chamotte bianche (di terracotta?).I numerosissimi inclusi neri sono ben evidenti anche all’esterno.La superfi cie è ben levigata sia all’interno che all’esterno e presenta un’ingubbiatura di colore beige-rosato.Cat. nn. 69, 70, 72, 87Cat. nn. 69, 70, 72, 87.
Impasto n. 2Argilla di colore da rosa (tra 2.5YR8/4 e 10YR8/4) a viola-ceo, più o meno granulosa, frattura irregolare, con vacuoli e fessurazioni. Inclusi: neri, piccolissimi e a frequenza molto elevata, alcuni lucenti; neri, medi, molto radi; bianchi, pic-coli e medi, a frequenza media e distribuzione irregolare; tracce di mica; chamotte bianche o scure (di terracotta?).I numerosissimi inclusi neri sono ben evidenti anche all’esterno.La superfi cie è ben levigata sia all’interno che all’esterno e ingubbiata con un bagno di colore chiaro.Cat. nn. 65, 67, 71, 74, 75 (?), 77, 81, 84, 86, 88Cat. nn. 65, 67, 71, 74, 75 (?), 77, 81, 84, 86, 88.
Gruppo di provenienza locale o da aree non defi nite
Impasto n. 3 (locale)Argilla di colore arancio più o meno rossiccio (2.5YR6/8), frattura irregolare. Inclusi: scuri piccoli a frequenza bassa e distribuzione irregolare; bianchi, piccoli e medi, a fre-quenza media e distribuzione irregolare; inclusi grigi medi a frequenza bassissima; inclusi rossicci medi e grandi a frequenza bassissima; inclusi litici medi e grossi a fre-quenza bassissima; tracce di mica.La superfi cie è ben levigata sia all’interno che all’esterno e ingubbiata con un bagno di colore beige-rosato.Cat. n. 66.Cat. n. 66.
Impasto n. 4Argilla abbastanza depurata, di colore rosa (tra 5YR 7/4 e 7.5YR7/4), frattura più o meno netta, con vacuoli e fessura-zioni. Inclusi: scuri piccolissimi, a frequenza bassa; bian-chi, piccolissimi a frequenza bassa.La superfi cie è ben levigata sia all’interno che all’esterno e ingubbiata con un bagno di colore rosa. Cat. nn. 64, 73, 83Cat. nn. 64, 73, 83.
Impasto n. 5Argilla abbastanza depurata, di colore rosa (tra 5YR 7/4 e 7.5YR8/4), frattura irregolare, con vacuoli e fessurazioni. Inclusi: scuri piccolissimi, a frequenza media; bianchi, pic-colissimi a frequenza bassa.La superfi cie è ben levigata sia all’interno che all’esterno e ingubbiata con un bagno spesso, di colore giallino. Cat. nn. 79, 85Cat. nn. 79, 85.
Dati tipologici e cronologiciLa lacunosità degli esemplari esaminati riferibili per lo più all’orlo, rende parziale, in un certo senso incerta, qualsiasi considerazione tipologica. Nelle pagine che seguono, abbiamo proposto un’attribu-zione a tipi noti da considerarsi ipotetica, perché circoscritta alla sola parte del vaso conservata, con-sapevoli che la disponibilità del collo e dalla pancia dei contenitori avrebbe certamente consentito di effettuare confronti puntuali, rendendo più facile e defi nita l’assegnazione tipologica. In base alla morfologia degli orli conservati, abbiamo ascritto cinque esemplari al gruppo V166
(65-6665-66167, tav. VI), tre al gruppo che Vandermesch defi nisce “di transizione” dal V al VI168 (67-6967-69, tav. VII), quattordici al VI (70-8370-83169, tavv. VI-VII)170, e
165 Per la descrizione dal punto di vista petrografi co, cfr. invece Barone et alii, infra, pp. 288, 295-296.166 Vandermersch 1994, pp. 76-80.167 Cui adde inv. 17192 e 17198, in condizioni di conservazione non buone.168 Vandermesch 1994, p. 82. Cfr. per la forma dell’orlo,
Pelagatti-Curcio 1970, pp. 493-494, fi g. 83i; Ingoglia 2000, pp. 172, 202, cat. CST/97, probabilmente da assegnare al gruppo VI.169 Cui adde inv. 15881, 15971 in condizioni di conservazione non buone.170 Vandermersch 1994, pp. 81-87.
213
tre “alla transizione” dal VI alla Dressel 1171 (84-8684-86172, tav. VII). Impossibile risulta, al momento, stabilire il tipo di pertinenza dei due frammenti di anse con bollo 87-8887-88 (tav. VII).
La maggiore larghezza dell’orlo, meno inclinato rispetto al tipo VI, ci ha fatto ritenere 65-6665-66 (tav. VI) anfore di tipo V173 (corrispondente alle greco-italiche antiche di Manacorda174 e al tipo a1 della Lyding-Will175). Il tipo è documentato, per quanto riguarda l’area dello Stretto, a Lipari, nella necropoli di Porti-nenti176, a Messina dalla discarica del l’is. 145 di via dei Mille177; in Calabria, ad Oppido Mamertina178. In Sicilia meridionale è attestato anche ad Agrigento179 e a Poggio Marcato di Agnone di Licata180; in Sicilia occidentale, ad Entella181, Segesta182, Lilibeo183.Le anfore del gruppo V sono comunemente ritenute di origine campana, ma si sono ipotizzate anche altre aree di produzione184 nel Golfo di Taranto, in Lucania e in Sicilia centrale e orientale185. Luoghi di origine accertati dalle analisi di laboratorio sono l’offi cina di Santa Restituta dell’isola di Ischia (Olcese et alii 1996, gruppo chimico 1186), altre offi cine ad Ischia e nella Baia di Napoli (Olcese et alii 1996, gruppo chimico 2187)188, l’area della Campania settentrionale, e molto probabilmente Napoli189 e il nord dell’Etruria190.
Un buon numero di esemplari, diversi tra loro per le caratteristiche morfologiche dell’orlo e del corpo, sono attestati nei carichi dei relitti Roghi 1 di Pana-rea191 (325-250?), Capo Graziano B di Filicudi (325-300 a.C.)192, Secca di Capistello di Lipari (300-280 a.C.)193, databili complessivamente tra gli ultimi de -cenni del IV sec. a.C. e la metà del III sec. a.C.194.
Una certa diffi coltà esiste nelle defi nizione delle caratteristiche morfologiche delle fasi “di passag-gio” iniziale e fi nale del gruppo VI. Lo stesso Vandermersch, per quanto riguarda la fase iniziale del passaggio dalle greco-italiche antiche alle greco-italiche recenti, ha notato che, in alcuni casi, come, per esempio, nel deposito della stoà ovest di Camarina (anteriore al 258 a.C.), non è possibile un’assegnazione ben defi nita di alcune anfore al gruppo VI, poiché queste presentano alcune peculia-rità della forma che richiamano il tipo V195. Lo stu-dioso ha quindi proposto di attribuirle ad un gruppo che denomina V/VI, indicativo della derivazione del tipo VI dal tipo V196. Tra gli orli di via Ciantro, abbiamo preferito attribuire al gruppo V/V-VI del Vandermersch197, 67-6867-68 (tav. VII), ancora infl uenzati dalla tradizione del tipo V.Importanti centri di produzione di queste anfore
171 Empereur-Hesnard 1987, p. 29. 172 Cui adde inv. 16020 in condizioni di conservazione non buone.173 Vandermersch 1994, pp. 76-80.174 Manacorda 1981, pp. 22-24; Manacorda 1986, p. 582.175 Lyding Will 1982, pp. 341-344.176 Campagna 2000, pp. 450-452. Alcuni esemplari sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio, risultando di provenienza campana (gruppo chimico 2), cfr. Olcese 2004, pp. 176, 182.177 Pavia 2001, pp. 22, 36, catt. VM/46,VM /48, fi g. 15.178 Oppido Mamertina, p. 302, n. 574, fi g. 309.179 Lima 1995, pp. 243-247, fi g. 74.180 Barra Bagnasco 1989, p. 95, n. 25, tav. XXXVII.181 Corretti-Capelli 2003, pp. 326-327.182 Bechtold 2007, p. 62.183 Di Stefano 1993, fi g. 25, nn. 1-4; fi g. 26, nn. 5-6; Bechtold 1999, pp. 158-160, tavv. XXX-XXXII.184 Vandermersch 1994, p. 79; per Velia, Maggi 2004, p. 105.185 Vandermesch 1994, pp. 79-80.186 Olcese et alii 1996, p. 16.187 Olcese et alii 1996, p. 16.188 Olcese 2004, pp. 177-180. 189 Olcese 2005-2006, pp. 60, 65.190 Pasquinucci-Menchelli 1999, p. 27; Vandermersch 2001, p. 171. 191 Cavalier-Livadie 1985a, p. 70; Parker 1992, p. 302, n. 785; Olcese 2004, p. 181 (si ipotizza una produzione ischitana). La datazione tradizionale del relitto all’ultimo quarto del IV sec. a.C. ha trovato conferma nel confronto con anfore di piazza Gari-
baldi a Taranto (Campagna 2000, p. 450 con riferimenti), ma un’esemplare della necropoli di Portinenti a Lipari comparabile per forma e impasto con le anfore del Relitto di Panarea, è datato dal corredo al secondo quarto del III sec. a.C., lasciando ipotiz-zare che la produzione di anfore di questa forma sia stata molto più lunga nel tempo di quanto non si sia fi nora ritenuto.192 Cavalier-Livadie 1985b, pp. 88-89; Parker 1992, pp. 117-118, n. 234; Olcese 2004, p. 181.193 Cavalier-Livadie-Vandermersch 1985, pp. 53-64; Parker 1992, p. 396, n. 1065; Olcese 2004, p. 181; Morel 2004, pp. 81-87; Olcese 2005-2006, p. 66.194 Per una disamina completa dei problemi cronologici delle anfore di tipo V, cfr. Campagna 2000, pp. 450-452 con riferimenti.195 D’altro canto, il criterio comunemente adottato, secondo il quale ogni profi lo dell’orlo corrisponde ad un momento cronolo-gico non può considerarsi incondizionatamente valido, poiché spesso la distinzione tra una forma e l’altra non è netta, e soprat-tutto perché la documentazione restituita da scavi di impianti pro-duttivi, come per esempio l’offi cina di Nocera Torinese (Valenza
Mele 1991, pp. 100-103), ha dimostrato che in un stessa produ-zione possono essere presenti contemporaneamente orli diversi.196 Olcese 2004, p. 182.197 Vandermersch 1994, pp. 81-82, fi g. a con riferimenti. Le analisi archeometriche effettuate sui materiali della fornace di Santa Resti-tuta ad Ischia hanno dimostrato che l’isola era uno dei più impor-tanti centri di produzione di anfore di questa forma: cfr. Olcese et alii 1996, p. 21; Olcese Hiener 1999; Olcese 2004, pp. 175-179. Altri importanti luoghi di produzione dovevano essere a Napoli e nella Campania settentrionale: cfr. Olcese 2005-2006, p. 60.
214
sono stati individuati, grazie agli accertamenti in laboratorio, nell’area nella Baia di Napoli (Olcese et alii 1996, gruppo chimico 2198)199 e tra Lazio meridio-nale e Campania settentrionale, dove sono prodotte anche anfore di tipo VI e “di transizione” alle Dressel 1200. Impasti diversi lasciano presupporre l’esistenza di altre aree di produzione: in Sicilia, ad esempio, le caratteristiche di un impasto da noi distinto ad occhio nudo potrebbero individuare uno o più centri di produzione nell’area di Gela-Agrigento, in conti-nuità con le produzioni anforarie di età arcaica e classica già riconosciute da G. Spagnolo201. Il gruppo V-VI è attestato anche a Lipari, in sepolture della necropoli di Portinenti con corredi del secondo quarto del III sec. a.C. Il che confermerebbe una datazione del passaggio dal tipo V al tipo VI nei decenni intorno alla metà del III sec. a.C.202.D’altro canto, le anfore di tipo V/VI si trovano asso-ciate in diversi contesti, sia con il tipo V che con il tipo VI, essendo evidentemente la loro produzione almeno parzialmente contemporanea all’uno e all’altro gruppo. Anfore Vandermersch V e V-VI provengono dal re -litto A della Meloria datato, per la ceramica a v.n. rinvenuta in associazione (coppe di forma Lambo-glia 27 e 42B), alla metà-seconda metà del III sec. a.C.203. Anche i relitti di Tour Fondue204, Bon Capò205, Cabrera 2206, Cala Rossa207, Terrasini B208 e Sangui-naires A209 hanno restituito anfore di tipo V insieme
ad anfore V/VI, tutti in associazione con reperti della metà-seconda metà del III sec. a.C.
La forma triangolare dell’orlo, caratterizzato all’esterno da una forte inclinazione verso il basso, tipica del tipo VI, è facilmente riscontrabile sui framm. 69-8369-83 (tavv. VI-VII e tav. 13, n. 6), mentre l’orlo più stretto e meno pendente di 84-8584-85 (tav. VII) è indicativo del passaggio dalle greco-italiche alle Dressel 1a, cui, probabilmente210, possiamo assegnare anche 8686 (tav. VII e tav. 13, n. 5). Anfore di tipo Vandermersch VI sono ben attestate in Sicilia occidentale. Gli esemplari documentati a Segesta sono datati da dopo la metà del III fi no all’inizio del II sec. a.C.211. Nella stessa Segesta sembrano più ampiamente utilizzate nel corso del II sec. a.C.212, come risulta anche ad Entella213 e Lilibeo214. Nella Sicilia centrale, l’unico dato fi nora noto si riferisce ad un’anfora dalla tomba 1 della necropoli di piazza Armerina, datata dal Gentili al III sec. a.C.215. Lungo la costa tirrenica, sono atte-state ad Alesa associate con materiali del III sec. a.C.216, a Tindari in livelli della seconda metà del III sec. a.C.217 e nella stessa Milazzo, dove, oltre ai diciassette esemplari frammentari da C. Ciantro, conosciamo un’anfora appartenente al corredo di una tomba della necropoli orientale datata tra fi ne III e inizi II sec. a.C.218. A Lipari, un solo esemplare è documentato dalla necropoli di Portinenti219,
198 Olcese et alii 1996, p. 16.199 Olcese 2004, pp. 179-180.200 Hesnard et alii 1989; Arthur 1990; Olcese 2005-2006, p. 60, fi g. 7.201 Barone 2002; Barone et alii 2004a; Barone et alii 2004b. 202 Campagna 2000, p. 452.203 Bargagliotti-Cibecchini 1998, pp. 168-169, fi g. 3, n. 1; Olcese 2005-2006, p. 70.204 Joncheray 1989; Olcese 2004, p. 182; Olcese 2005-2006, p. 70.205 Asensio i Vilarò-Martin i Menéndez 1998.206 Asensio i Vilarò-Martin i Menéndez 1998, pp. 140-144 hanno applicato alle anfore dei relitti del Mediterraneo occidentale il criterio crono-tipologico basato sul calcolo del rapporto tra altezza totale e diametro di massima espansione: la sequenza cronologica stabilita (Bon Capò/Cabrera 2-Pech Maho-Tour d’Agnello-Grand Conglouè-el Portalò), coinvolge-rebbe non più di 15 anni, a riprova della crescita rapidissima dell’importanza della corrente commerciale verso Occidente avvenuta nella seconda metà o meglio nell’ultimo quarto del III sec. a.C.207 Liou 1975, p. 583.208 Purpura 1974, pp. 48-49, f. 4-6.209 Alfondi-Gandolfo 1997. Per tutti i relitti, cfr. Olcese 2005-2006, p. 70, fi g. 5, con riferimenti.
210 L’incertezza nasce dallo stato lacunoso delle nostre anfore, di cui non è possibile osservare la forma intera e i rapporti tra le varie parti. Per i criteri di distinzione tra greco-italiche tarde e Dressel 1a e per la relativa cronologia, cfr. Tchernia 1986, pp. 42-44, 309-312; Empereur-Hesnard 1987, pp. 29-30.211 Bechtold 2007, p. 62, nota 212 (area 15000 degli scavi della necropoli di Segesta).212 Bechtold 2007, p. 62 con riferimenti.213 Alla ricerca di Entella, pp. 256, fi g. 22, n. 4 (ma anche 3), pp. 278-280, fi g. 43, nn. 6-7; pp. 305-306, fi g. 66, n. 2; pp. 310-311, fi g. 71, nn. 1-2; Parra 1990, p. 496, 4, tav. CX, n. 2; Michelini 1994, pp. 268-269, 11, tav. LIII, n. 2. Vedi anche Bechtold 2007, p. 62.214 Bechtold 1999, p. 160, tipo AC3C, tav. XXXII, n. 281. Vedi anche Bechtold 2007, p. 62.215 In associazione con uno skyphos a v.n., una coppa e nume-rosi unguentari piriformi, cfr. Gentili 1969, p. 35, fi g. 42; Van-
dermersch 1994, p. 82.216 Carettoni 1959, p. 304, n. 16i; p. 308, n. 13, fi g. 16d; Van-
dermersch 1994, p. 82.217 Lamboglia 1952, pp. 156, 159, 162, fi g. 20; Vander-
mersch 1994, p. 82; Tramontana 2008, pp. 261-262.218 Ollà, in Tigano 2002, p. 115, t. 16 (Ciantro, Coop. Nuova Milazzo Uno).219 Campagna 2000, p. 453.
215
datato tra gli ultimi decenni del III e gli inizi del II sec. a.C.220.Il passaggio dalle anfore greco-italiche alle Dressel 1, nella fase fi nale del gruppo VI, non avviene in maniera netta: ne sono testimonianza, come già evidenziato da Firmati, le alternanti defi nizioni di “greco-italica tarda” e di Dressel 1a nella bibliogra-fi a relativa221.Già Lusuardi Sena nel pubblicare le anfore Dressel 1a di Luni222 aveva notato che alcuni degli orli meno pendenti potevano forse riferirsi alle anfore greco-italiche del III-II sec. a.C., osservando che “la lenta evoluzione di questi contenitori dai prototipi elleni-stici a quelli italici e la frammentarietà del materiale impedisce spesso una identifi cazione corretta”. Del resto, non di rado capita di imbattersi in diffi -coltà di attribuzione, spesso dovute, tra l’altro, allo stato frammentario dei materiali. In Sicilia, a Polizzi Generosa, nel palermitano, in un panorama vario di orli di anfore, molto simili a quelli documentati in contrada Ciantro, la Sarà, soprattutto per gli orli più alti e meno aggettanti, lascia aperta la possibi-lità che possa trattarsi di anfore greco-italiche tarde dei tipi D-E della Lyding Will o di anfore Dressel 1 o ancora di tipi intermedi223.L’incertezza, determinata in alcuni casi da lievi dif-ferenze morfologiche, è esemplifi cata anche nell’an-fora n. 3 dal relitto dell’isola Barthélémy il cui orlo è confrontabile con la nostra 8686 classifi cata come Dressel 1: l’anfora, nel commento, è defi nita una greco-italica “étirée en longueur”224. Ai tipi più tardi delle anfore greco-italiche (Lyding Will e, pp. 353-355), sono da riferire insieme a 84-8684-86 (tav. VII), anche le anfore dai relitti di Portopalo (SR)225, Cala Scirocco226, Punta Scaletta227, de La
Chretien ne228, Heliopolis 2229, recentemente datati tra il primo ed il secondo quarto del II sec. a.C.230.Nel complesso dunque in base ai confronti morfo-logici fi n qui stabiliti con contesti chiusi dalla cro-nologia specifi ca, le anfore di C. da Ciantro possono datarsi tra la seconda metà del IV ed il II sec. a.C.: la gran parte si colloca tra la seconda metà del III e il primo quarto del II sec. a.C.
Dati epigrafi ciPer quanto riguarda l’aspetto epigrafi co, soltanto due sono i frammenti di anse con bolli.Sull’ansa 8787 (tav. VIII e tav. 13, n. 7) il bollo, in greco, è impresso entro un cartiglio rettangolare con angoli a spigolo vivo. Nella prima parte del bollo, a sinistra, le lettere sono coperte da un’incrostazione di piombo che ne impedisce la leggibilità. Le lettere rimanenti non sono a rilievo marcato, ma sono leggibili -NTAL.Potrebbe trattarsi della forma abbreviata del nome greco Antallos di cui sono noti diversi esemplari da diversi siti231: su anfore da Lipari (necropoli di Por ti-nenti)232 prodotte in Campania233, su anfore di Era-clea Minoa234 ed Erice235, di Ischia ed Ensèrune236 e di Cartagine237. Vandermersch considera il nome originario della Sicilia238, ma le analisi di laboratorio condotte sugli esemplari bollati da Ischia, Ensèrune e Lipari ne hanno evidenziato la provenienza cam-pana239, anche se non possiamo escludere l’esistenza di casi di omonimia240.L’ansa 8888 (tav. VIII e tav. 13, n. 8) ha un bollo in latino. Il bollo si conserva per intero ed è iscritto entro un cartiglio rettangolare. Sulla scorta dell’ipotesi propo-sta per un timbro praticamente identico da Ischia241 riteniamo che la lettura possa essere M ANTERIO, anche se non si può escludere M ANTESTIO242, per
220 Cfr. le anfore dal relitto della Secca del Bagno a Lipari, in Albore Livadie 1985, p. 66, fi gg. 47-48; Parker 1992, p. 395.221 Firmati 1991, p. 80, commento a cat. n. 68.222 Lusuardi Sena 1977, p. 208.223 Termini 1997, pp. 159-161, catt. 7-38.224 Liou-Pomey 1985, p. 573, fi g. 22, n. 3.225 Basile 1997, p. 149, fi gg. 4-5: la datazione del relitto andreb- be a nostro avviso abbassata dalla fi ne del IV-inizi III alla seconda metà se non alla fi ne del III sec. a.C.226 Firmati 1997, pp. 68-70, fi gg. 10-14.227 Lamboglia 1964; Firmati 1992, p. 33.228 Empereur-Hesnard 1987, p. 27.229 Long 1992, pp. 39-40.230 Firmati 1997, p. 70.231 Olcese 2004, p. 177; Garozzo 2005, pp. 380-383, nn. IMGSgr5-6; Garozzo 2006, p. 720, A.1 e A.2.
232 Campagna 2000, p. 455. 233 Olcese 2004, p. 182.234 De Miro 1958, p. 281, n. 15.235 Pellegrini 1887, p. 273, nn. 569-579.236 Olcese 2004, pp. 177, 182.237 CIL VIII 22639.23.238 Vandermersch 1994, pp. 162. Sulle anfore di Eraclea Minoa, Erice e Cartagine con bollo “Antallos”, cfr. Olcese 2004, pp. 177, 182.239 Olcese 2004, pp. 177-179, 182.240 Olcese 2004, p. 182.241 Buchner-Rittman 1948, p. 58; Vandermesch 2001, pp. 162, 195, fi g. 2. Un altro bollo con lettura simile è attestato a Cartagine: CIL VIII-3, 22637,11; Vandermesch 2001, p. 195.242 Vandermersch 2001, p. 195; Garozzo 2005, pp. 479-480, n. IMGSlt4; Garozzo 2006, pp. 723-724.
216
via dell’incertezza dovuta alle due lettere comprese tra la E e la O, da interpretare, nel primo caso, come -RI-, con la I che, allungata verso l’alto, supera le altre lettere; nel secondo caso, la lettura del gruppo sarebbe invece -ST-.La bibliografi a nota assegna i bolli in latino all’Italia centrale tirrenica243 e li data genericamente dopo la metà del III sec. a.C. La ridotta porzione del fram-mento in questione non consente di riconoscere la tipologia precisa dell’anfora di appartenenza, ma l’osservazione diretta dell’impasto indicherebbe una provenienza da area campana. Allo stato attuale quindi, oltre all’ipotesi dell’origine campana dell’an-fora, non possiamo dire molto sulla cronologia del bollo, né sul personaggio che lo ha utilizzato.
Prime ipotesi sulla determinazione di origineAnalisi petrografi che e chimiche effettuate, al mo -mento, soltanto su pochi campioni per ciascun impasto hanno in un certo senso confermato quanto osservato ad occhio nudo, anche se i risultati non sono ancora da considerare defi nitivi. Sono state distinte petrografi camente tre fabrics rispettiva-mente riferibili, anche in base agli elementi chimici rintracciati, ad area “locale” e/o non defi nita e ad area campano-laziale244.Ben quindici anfore proverrebbero, in base all’osser-vazione ad occhio nudo, dall’area campano-laziale, il che troverebbe conferma, almeno per i campioni analizzati sino a questo momento, nei risultati delle analisi archeometriche245: soltanto un esemplare può assegnarsi al tipo V, gli altri sono tutti attribui-bili a greco-italiche tarde.Su gran parte delle anfore di questo gruppo si è osservata una certa grossolanità dell’impasto che, come già osservato dalla Lyding Will, distingue-rebbe le anfore greco-italiche più tarde dalle più antiche, con impasto più rosato e più fi ne246.
Tra i sei esemplari che autopticamente abbiamo rite-nuto di provenienza locale o non defi nita, soltanto un frammento di orlo di tipo V è stato prodotto local-mente, come hanno dimostrato i ri sultati delle inda-gini minero-petrografi che e geochimiche247.Approfondimenti chimici in corso su altri campioni da contrada Ciantro contribuiranno ad approfon-dire il panorama di provenienze delle anfore greco-italiche da Milazzo, tra gli ultimi decenni del IV e il II sec. a.C.
Anfore punicheAnfore punicheÈ attestata una sola anfora punica (8989, tav. VIII) sporadica. È caratterizzata da un orlo estrofl esso e ingrossato con estremità superiore esterna appena pendente e lieve rigonfi amento sotto, un breve collo a profi lo concavo.Nella tipologia delle anfore puniche elaborata da Ramon Torres il tipo è defi nito 7.6.1.1. ed è attribuito a produzione della Bizacena, forse anche della Tripo-litania248, con impasto tipico del gruppo “Carthago-Tunez”249. Il tipo è poco documentato. Un esemplare è noto dal 2° relitto del Gran Conglouè250, un altro dai fondali antistanti la Colonia di St. Jordi, lungo la costa del Marocco251, entrambi contesti chiusi con materiali di fi ne II-I sec. a.C.252. Altri esemplari253 sono noti da Uzita254, Mactar255, Sabratha256, El Maklouba257, nell’Africa Settentrionale, dai fondali di Le Grau du Roi, in Francia258 da scavi però privi di utili riferimenti cronologici.
Conclusioni
L’analisi sin qui condotta ha messo in evidenza la presenza a Milazzo di un buon numero di esemplari di ceramica a v.n. di produzione locale, soprattutto
243 I più antichi bolli latini sono di attribuzione incerta, in particolare il bollo Tr. Loisio assegnato ora alla Campania (Buchner-Rittman 1948, p. 58; Manacorda 1986, pp. 582-583) ora alla Sicilia (Tchernia 1986, p. 49; Empereur-Hesnard 1987, p. 26; Hesnard et alii 1989, p. 31) è stato defi nitivamente assegnato alla Campania grazie alle analisi archeometriche (Olcese 2004, p. 174).244 Cfr. Barone et alii, infra, pp. 295-296.245 Cfr. Barone et alii, infra, p. 293.246 Lyding Will 1982; Olcese 2004, p. 117.247 Cfr. Barone et alii, infra, p. 296.248 Ramon Torres 1995, pp. 217-218, 294.
249 Ramon Torres 1995, pp. 258-259.250 Benoît 1961, tav. III, n. 7; Ramon Torres 1995, p. 35.251 Guerriero 1986, fi g. 10, n. 2; Ramon Torres 1995, p. 64.252 Ramon Torres 1995, p. 295.253 Ramon Torres 1995, p. 639, mapa 91.254 Van der Werff 1977-1978, fi g. 3, n. 23/17, fi g. 6, nn. 071721, 3774, 033/81, 034/209; Ramon Torres 1995, p. 118.255 Bourgeois 1982, pp. 32-36; Ramon Torres 1995, p. 119.256 Kenrick 1986, fi g. 91, n. 25; Ramon Torres 1995, p. 121.257 Peacock et alii 1989, fi g. 20, n. 6; Ramon Torres 1995, p. 119.258 Granier 1965, fi g. 6, n. 1; Ramon Torres 1995, p. 34.
217
patere, cui si affi anca la ceramica a v.n. sovraddi-pinta, che, pur rientrando nell’ambito della koinè produttiva dell’area dello Stretto durante la prima metà del III sec. a.C. e oltre, risulta, al momento, di origine incerta. Indeterminato è anche il luogo di origine della Magenta Ware, prodotta nei decenni intorno alla metà/seconda metà del III sec. a.C., mentre altamente probabile è l’esistenza di una produzione in loco di unguentari.Dal punto di vista quantitativo maggiori risultano gli indici di presenza di ceramica fi ne del III sec. a.C., mentre pochissimi sono i vasi da mensa riferi-bili al II-I sec. a.C.Le anfore da trasporto più antiche di via Ciantro sono attestate in numero ridotto: due pseudo-chiote e un’anfora con orlo ad echino, le cui produ-zioni, generalmente riferibili a centri della Sicilia o dell’Italia meridionale, forse si sovrappongono nei decenni a cavallo della metà del IV sec. a.C. La gran parte dei contenitori da trasporto attestati a Milazzo sono invece riferibili alle anfore greco-itali-che: di queste, poche sono quelle antiche, decisa-mente più numerose quelle recenti. Un buon numero proviene dall’area campano-laziale, atte-stando l’esistenza di rapporti commerciali tra la Sicilia nord-orientale e la Campania a partire dalla seconda metà/fi ne del III sec. a.C.; poche sono invece riferibili ad un’area non defi nita; una sola può considerarsi di produzione locale.Nell’Occidente dell’isola, contatti commerciali con la Campania esistono già a partire dalle fi ne del IV sec. a.C., ma si tratta di contatti, in un certo senso, modesti, che coinvolgono esclusivamente importa-zioni dalla Campania di ceramiche fi ni (fi gurate e a v.n.)259, contatti assolutamente non paragonabili a quelli documentati a partire dalla seconda metà del III sec. a.C., quando il volume delle anfore da tra-sporto esportate dai centri campano-laziali aumenta in maniera vertiginosa260 fi no alla distruzione di Cartagine del 146 a.C.261. Nelle città di Segesta, Entella, Lipari sono attestate anfore greco-italiche di tipo VI e greco-italiche recenti di provenienza campano-laziale che testimoniano una certa prefe-renza per il vino campano, in associazione con ceramica a vernice nera campana A262.
La gran parte della documentazione anforaria di via Ciantro coincide con la fase di più ampia diffu-sione dei prodotti campani, il cui indicatore crono-logico corrisponde con il periodo di produzione delle anfore di tipo V, V/VI, VI e VI-Dressel 1a. Milazzo dunque è a tutti gli effetti inserita nei circu-iti commerciali ad ampio raggio che coinvolgono i centri di produzione di area campano-laziale, pur non avendo restituito, allo stato attuale della docu-mentazione, alcun esemplare di campana A. La Sicilia nord-orientale è coinvolta nei traffi ci com-merciali che dagli ultimi decenni del III sec. a.C. vedono l’emergere di prodotti campani in tutto il Mediterraneo Occidentale. Si tratta di osservazioni preliminari a una valuta-zione complessiva del fenomeno in questa parte orientale della Sicilia che attende i risultati di più ampie ricerche condotte su un maggior numero di rinvenimenti, anche nella stessa Milazzo.Resta da chiarire, infi ne, un dato quantitativo: il rapporto numerico tra ceramica fi ne e anfore da trasporto vede la prevalenza della prima fi no agli anni posteriori alla prima guerra punica e s’inverte dai decenni seguenti in poi, quando alle presenze di ceramica a v.n., limitate alla sola forma della patera, corrisponde un maggior numero di anfore. Il dato potrebbe essere dovuto ai limiti della ricerca sul campo, svolta in condizioni diffi cili, o a cambia-menti di esigenze, in seguito alla prima guerra punica, di chi frequentava la fattoria, ma non si può escludere che le datazioni fi nora proposte per alcune produzioni di ceramica a v.n., in particolare della ceramica a v.n. sovraddipinta e della Magenta Ware263 debbano essere riconsiderate e abbassate nei loro termini fi nali. In ogni caso, dunque, si può concludere che la fatto-ria di c.da Ciantro iniziò ad essere frequentata in un periodo compreso tra la seconda metà del IV e i primi decenni del III sec. a.C. ma fu più intensa-mente abitata durante tutto il III sec. a.C., forse fi no ai primi decenni del II sec. a.C. Esemplari sporadici di ceramica fi ne e un frammento di anfora punica di produzione nord-africana si rife-riscono invece alla più recente frequentazione dell’area che può datarsi alla fi ne del II-I sec. a.C.
259 Bechtold 2007, pp. 59-60.260 Bechtold 2007, p. 62.261 Bechtold 2007, pp. 54-58; 61-62.
262 Bechtold 2007, pp. 62-63.263 Così Higgins 1976, pp. 5-15.
218
Catalogo
Ceramica a Vernice Nera Ceramica a Vernice Nera
1. Orlo di coppa a parete concavo-convessa1. Orlo di coppa a parete concavo-convessaSporadico. Inv. 15853, tav. IArgilla di colore beige (10YR8/4), abbastanza depurata; v.n.1,3x2,8.O. appena estrofl esso.Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90.
2. Orlo di coppa a parete concavo-convessa2. Orlo di coppa a parete concavo-convessaVano 3, taglio 3. Inv. 14626, tav. I1 fr. di o. e parete.Argilla rosa (7.5YR7/4); v.n.-bluastra, non omogenea3x4.O. appena estrofl esso, parete a profi lo concavo-convesso.Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90.
3. Orlo e vasca di coppa a parete concavo-convessa3. Orlo e vasca di coppa a parete concavo-convessaVano 4, taglio 2. Inv. 16016, tav. IArgilla di colore nocciola (7.5YR6/4); vernice grigia, iridescente, in alcune parti evanida.4,3x2,8.O. estrofl esso, vasca concavo-convessa.Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90.
4. Coppa a parete concavo-convessa4. Coppa a parete concavo-convessaVano 4, taglio 1. Inv. 15993, tav. I1 fr. di ansa e porzione di parete della vasca.Argilla di colore arancio (5YR6/6), abbastanza depurata, con vacuoli; v.n.-grigia; bianco so -vraddipinto.3,1x3,2.O. estrofl esso, parte superiore della parete leg-germente curva; ansa ad anello verticale, a doppio bastoncello sormontato da un “nodo”. Nella zona immediatamente sottostante il lab-bro, all’est., traccia di bianco sovraddipinto (fi ore?) e di linea graffi ta (tralcio?).Morel, serie 3211/3131.Fine IV-prima metà del III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 249-250, 255, tavv. 87, 90.
5. Coppa a parete concavo-convessa5. Coppa a parete concavo-convessaVano 1, taglio 2. Inv. 15898, tav. I1 fr.Argilla di colore arancio-rosa (5YR7/6), abba-
stanza depurata; vernice marrone in parte eva-nida; bianco e rosso sovraddipinta.3,4x2,8.O. estrofl esso, parte superiore della parete leg-germente curva; ansa ad anello verticale, a doppio bastoncello; all’int., sotto l’o., una linea bianca evanida e un paonazza.Morel, serie 3211/3131.Fine IV-prima metà del III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 249-250, 255, tavv. 87, 90.
6. Orlo e ansa di coppa a parete concavo-convessa6. Orlo e ansa di coppa a parete concavo-convessaVano 3, taglio 2. Inv. 14693, tav. IArgilla di colore beige (2.5YR8/3), abbastanza depurata; v.n.-bruna con qualche iridescenza, in parte abrasa.3,5x2,7.O. estrofl esso, parte superiore della vasca leg-germente curva; ansa ad anello verticale con doppio bastoncello sormontata da un nodo.Morel, serie 3211/3131.Fine IV-prima metà del III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 249-250, 255, tavv. 87, 90.
7. Coppa a parete concavo-convessa7. Coppa a parete concavo-convessaSporadico. Inv. 15855, tav. I e tav. 12, n. 11 fr.Argilla color nocciola (7.5YR7/6), abbastanza depurata; v.n., iridescente e densa.3,7x5,1.O. appena estrofl esso, parte superiore della vasca quasi diritta, carenata sotto l’ansa; ansa ad anello verticale, a doppio bastoncello, “annodato”. Decorazione graffi ta sotto il lab-bro: tracce di tralci a sin. delimitati in basso da una linea orizzontale.Morel, serie 3211/3131.Fine IV-prima metà del III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 249-250, 255, tavv. 87, 90.
8. Coppa a parete concavo-convessa8. Coppa a parete concavo-convessaSporadico. Inv. 15856, tav. I e tav. 12, n. 23 frr. ricomposti di o., parte della vasca e un’ansa.Argilla di colore rosa (2.5YR7/6), micacea, vacuolata; v.n.-grigio, opaca e arancio.5,8x8,2.O. estrofl esso, vasca a profi lo concavo-con-vesso, decorata da due coppie di linee graffi te non esattamente parallele, ansa ad anello verti-cale, a doppio bastoncello, annodata. Morel, serie 3211/3131.Fine IV-prima metà del III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 249-250, 255, tavv. 87, 90.
9. Coppa a parete concavo-convessa 9. Coppa a parete concavo-convessa Vano 1, taglio 2. Inv. 15911, tav. I5 frr. ricomposti di o. e parete della vasca.Argilla di colore beige (10YR8/4), abbastanza
compatta; v.n.-marrone in qualche punto evanida.Alt. 5,1, diam. ric. 10. O. estrofl esso, vasca a parete concavo-convessa. All’est., linee graffi te distanziate (a gruppi di due quelle centrali).Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90.
10. Coppa concavo-convessa10. Coppa concavo-convessaVano 4, taglio 2. Inv. 16014, tav. I1 fr. di o. e parete superiore della vasca.Argilla di colore beige scuro (7.5YR7/6), abba-stanza compatta; v.n. in parte evanida.Alt. 4,5, diam. o. ric. 11.O. estrofl esso, parte superiore della vasca quasi diritta; linee graffi te distanziate.Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90.
11. Coppa a parete concavo-convessa11. Coppa a parete concavo-convessaVano 3, taglio 1. Inv. 14665, tav. I1 fr. di o. e parete superiore della vasca.Argilla di colore giallino (2.5YR8/3), abba-stanza compatta; v.n. completamente evanida.2,8x4,8, diam. ric. 12.O. estrofl esso, parte superiore della vasca; all’est., tre linee orizzontali graffi te.Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90.
12. Coppa a parete concavo-convessa12. Coppa a parete concavo-convessaVano 3, taglio 2. Inv. 14657, tav. I1 fr.Argilla rosa (7.5YR7/4); v.n.-bluastra, iride-scente in alcuni punti evanida; ritocchi bianchi e paonazzi in parte evanidi.3,5x4,3.O. appena estrofl esso, parete a profi lo concavo-convesso. All’int., sotto l’o., una linea bianca e una rossa sovraddipinte.Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90.
13. Coppa a parete concavo-convessa13. Coppa a parete concavo-convessaVano 2, taglio 2. Inv. 15962, tav. II1 fr. di o. e parte superiore della parete.Argilla di colore rosa-arancio (5YR7/6), con piccolissimi inclusi bianchi a frequenza media; v.n.-grigia, opaca in parte evanida; bianco sovraddipinto.Alt. 2, largh. 4,9, diam. ric. 13.O. estrofl esso, parte superiore della parete della vasca diritta; tra tre linee graffi te, due serie di foglioline in bianco sovraddipinto, oblique.
219
Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90.
14. Coppa a parete concavo-convessa14. Coppa a parete concavo-convessaVano 3, taglio 1. Inv. 14664, tav. II e tav. 12, n. 31 fr.Argilla di colore arancio (5YR7/8), abbastanza depurata; v.r.-arancio, in alcuni punti abrasa; viola sovraddipinto.Alt. 4,3, largh. 6,8, diam. ric. 11. O. estrofl esso, parete della vasca concavo-con-vessa; ansa con attacco bifi do ad anello verti-cale; nella zona tra le anse, su un lato, tralcio graffi to con foglie d’edera sovraddipinte in bianco; sull’altro lato, iscrizione dipinta “E”; sotto, linea graffi ta.Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90. Per altri esemplari con iscrizione dipinta, cfr. Bacci 2001, pp. 12, 44-45, cat. VM/86.
15. Piede di coppa a parete concavo-convessa15. Piede di coppa a parete concavo-convessaVano 4, taglio 2. Inv. 16006, tav. II2 frr. ricomposti di pd. e f. della vasca.Argilla di colore beige-rosa (7.5YR8/4), abba-stanza depurata; v.n. e arancio per ossidazione in cottura.Alt. 2,1, diam. max 6.Pd. tronco-conico, modanato all’est. Parte int. del pd. risparmiata con scoli di vernice.Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90.
16. Piede di coppa a parete concavo-convessa16. Piede di coppa a parete concavo-convessaVano 3, taglio 3. Inv. 14700, tav. IIArgilla di colore rosa-arancio (5YR7/6), molto micacea, con piccolissimi inclusi bianchi a fre-quenza ridotta, vacuoli; vernice arancio-mar-rone poco omogenea e in alcuni punti evanida.Alt. 2,5, diam. 5,5. F. di vasca di coppa con pd. modanato. Rispar-miata la parte est. della vasca. All’int., tondo d’impilamento.Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90.
17. Piede di coppa a parete concavo-convessa17. Piede di coppa a parete concavo-convessaVano 3, taglio 3. Inv. 14699, tav. IIArgilla di colore beige (2.5YR8/4), compatta; v.n. completamente abrasa.Diam. 5.8, alt. 1.9.F. di vasca di coppa con pd. conico modanato.Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90.
18. Piede di coppa a parete concavo-convessa18. Piede di coppa a parete concavo-convessaVano 4, taglio 3. Inv. 16037, tav. II e tav. 12, n. 41 fr. di pd. e f. della vasca.Argilla di colore rosa-arancio (7.5YR7/4), mica-cea; v.n., iridescente, in alcuni punti evanida.Alt. 23, diam. ric. 4,5. Pd. tronco-conico, modanato all’est. Parte infe-riore della vasca e parte superiore del pd. risparmiati.Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 250, tav. 90.
19. Ansa di coppa a parete concavo-convessa19. Ansa di coppa a parete concavo-convessaSporadico. Inv. 15851Argilla di colore rosa-beige (7.5YR8/3), ab bastanza depurata, micacea, v.n. in parte evanida.3,3x1,2.Ansa ad anello verticale, modanata all’est.Morel, serie 3211.Fine IV-prima metà III sec. a.C.Morel 1981a, p. 255, tav. 90.
20. Coppa con orlo rientrante20. Coppa con orlo rientranteVano 2, taglio 2. Inv. 15955, tav. II1 fr. di o. e vasca.Argilla rosa (7.5YR8/3), abbastanza depurata, v.n. in alcuni parti evanida.1,9x2,4.O. rientrante; vasca, poco profonda, a profi lo arrotondato.Morel, specie 2710.Fine IV-inizi III sec. a.C.Morel 1981a, p. 207, tavv. 66-67.
21. Coppa con orlo rientrante21. Coppa con orlo rientranteSporadico. Inv. 15831, tav. II1 fr. di o. e parte superiore della parete.Argilla rosa-arancio (2.5YR7/6), abbastanza depurata; v.n.-arancio.Alt. 1,7, diam. ric. 11.O. rientrante; parte superiore della vasca pro-fi lo arrotondato. Morel, specie 2710.Fine IV-inizi III sec. a.C.Morel 1981a, p. 207, tavv. 66-67.
22. Coppa con orlo rientrante22. Coppa con orlo rientranteSporadico. Inv. 15826, tav. IIArgilla di colore giallino (2.5YR8/2), abba-stanza depurata; v.n.-violacea, sottile, diluita in parte, non omogenea.Diam. ric. 9,2, alt. 1,6.O. rientrante; vasca a calotta emisferica. Probabilmente Morel, serie 2714.III sec. a.C.Morel 1981a, p. 209, tav. 67.
23. Coppa con orlo rientrante23. Coppa con orlo rientranteVano 1, taglio 2. Inv. 15901, tav. II1 fr. di o. e vasca.Argilla arancio (tra 2.5YR7/6 e 7/8), abba-stanza depurata; v.n. luminescente.3,1x4,2.O. rientrante; vasca a calotta emisferica.Probabilmente Morel, serie 2714.III sec. a.C.Morel 1981a, p. 209, tav. 67.
24. Coppa con orlo rientrante24. Coppa con orlo rientranteVano 1, taglio 2. Inv. 15910, tav. II4 frr. ric. di o. e vasca con attacco del pd.Argilla beige (10YR8/2) con pochi piccolissimi inclusi bianchi; v.n. e violacea, in buona parte evanida. La superfi cie est. della vasca è legger-mente deformata. La superfi cie è abbastanza consunta.Alt. 3,2, diam. ric. 9,6. O. rientrante; vasca a calotta emisferica; pd. ad anello.Probabilmente Morel, serie 2714.III sec. a.C.Morel 1981a, p. 209, tav. 67.
25. Coppa con orlo rientrante25. Coppa con orlo rientranteVano 3, taglio 3. Inv. 14711, tav. II1 fr.Mancante di buona parte dell’o. e della vasca.Argilla rosa (10R7/4), abbastanza depurata; v.n.Alt. 3,7, diam. 8,4. O. rientrante; vasca a calotta emisferica; pd. ad anello. F. della vasca lievemente ombelicato.Probabilmente Morel, serie 2714.III sec. a.C.Morel 1981a, p. 209, tav. 67.
26. Coppa con orlo rientrante26. Coppa con orlo rientranteVano 4, taglio 1. Inv. 15986, tav. II1 fr. di o. e parete della vasca.Argilla beige (7.5YR7/4), abbastanza depurata; vernice nero-grigia, luminescente.Alt. 3,5, diam. 10,5.O. appena rientrante, superiormente arro-tondato.Probabilmente Morel, serie 2714.III sec. a.C.Morel 1981a, p. 209, tav. 67.
27. Coppa con orlo rientrante27. Coppa con orlo rientranteVano 4, taglio 3. Inv. 16042, tav. II1 fr. di o. e parte superiore della vasca.Argilla rosa (10R7/6), abbastanza depurata; v.n.-marrone.1,7x2,3.O. rientrante, ispessito; vasca a profi lo arro-tondato.
220
Probabilmente Morel, serie 2714.III sec. a.C.Morel 1981a, p. 209, tav. 67.
28. Coppa con orlo rientrante28. Coppa con orlo rientranteVano 4, taglio 3. Inv. 16039, tav. II1 fr. di labbro e parte superiore della vasca.Argilla beige (7.5YR7/4), abbastanza depurata; v.n.-marrone.Alt. 2,5, diam. ric. 11,4. O. rientrante, ispessito; parte superiore di vasca emisferica.Morel, serie 2724.Ultimi decenni IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, pp. 211-212, tav. 67.
29. Coppa con orlo rientrante29. Coppa con orlo rientranteVano 2, taglio 2. Inv. 15956, tav. II1 fr. di o. e parete della vasca.Argilla grigia; v.n.-grigia, in qualche punto evanida.3,3x3,2.O. rientrante, ispessito; vasca emisferica.Forse Morel, serie 2724.Ultimi decenni IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, pp. 211-212, tav. 67.
30. Coppa con orlo rientrante30. Coppa con orlo rientranteVano 3, sotto fondazioni strutture murarie. Inv. 15875, tav. II1 fr. di o. e parte superiore della vasca.Argilla di colore rosa (10R7/6); v.n.-arancio in parte evanida.2,8x2,5.O. rientrante, ispessito; vasca a calotta emi-sferica.Forse Morel, serie 2724.Ultimi decenni IV-prima metà III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, pp. 211-212, tav. 67.
31. Coppa con orlo rientrante31. Coppa con orlo rientranteVano 4, taglio 1. Inv. 15989, tav. II1 fr. comprendente parte dell’o., della vasca e del pd. con il f.Argilla rosa (7.5YR7/6), micacea, v.n. quasi completamente evanida.O. rientrante ispessito; vasca a calotta emisfe-rica; pd. ad anello.Morel, serie 2725.Ultimi decenni IV- prima metà III sec. a.C.Morel 1981a, p. 212, tav. 67.
32. 32. SkyphosSkyphosVano 2, taglio 1. Inv. 159521 fr.Argilla di colore rosa-arancio (5Yr7/6); v.n.
5,9x4,6.O. arrotondato, appena ingrossato, parete di -ritta.Morel, specie 4370.Seconda metà IV-prima metà III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 311-313, tavv. 131-132.
33. Piede di 33. Piede di skyphosskyphosVano 3, taglio1. Inv. 16011, tav. V1 fr.Argilla di colore rosa (2.5YR7/6); v.n.Pd. a disco, con doppia scanalatura all’attacco con la vasca stretta, cilindrica.Morel, serie 4375.Fine IV sec. a.C.Morel 1981a, pp. 311-312, tav. 132.
34. Orlo di 34. Orlo di skyphosskyphosSporadico. Inv. 14635, tav. VArgilla di colore beige-rosa (2.5YR7/5); v.n.4,8x3,8.O. arrotondato; parete diritta.Forse Morel, serie 4375.Fine IV sec. a.C.Morel 1981a, pp. 311-312, tav. 132.
35. 35. SkyphosSkyphosVano 2, taglio 2. Inv. 15970, tav. V1 fr.Argilla rosa (2.5Yr7/6); vernice nero-grigio.3,3x4,3.O. diritto, superiormente arrotondato; parete della vasca diritta.Forse Morel, serie 4375.Fine IV sec. a.C.Morel 1981a, pp. 311-312, tav. 132.
36. S36. SkyphoskyphosVano 2, taglio 1. Inv. 15908, tav. V1 fr.Argilla di colore rosa (2.5Yr7/6), abbastanza depurata; v.n.Alt. 6,4, diam. 21,0. O. arrotondato, parete diritta.Forse Morel, serie 4375.Fine IV sec. a.C.Morel 1981a, pp. 311-312, tav. 132.
37. Patera37. PateraSporadico. Inv. 15836, tav. III e tav. 12, n. 61 fr. di o. e parete della vasca.Argilla di colore rosa-arancio (2.5YR6/8); v.n., all’int. arancio, scistosa, in parte evanida.Alt. 3,1, diam. o. ric. 28,6.Labbro estrofl esso, ricurvo e pendente, legato alla vasca da una scanalatura all’int. e una pro-nunciata carenatura all’est. Est. risparmiato, ad eccezione di qualche punto sparso.Morel, serie 1534.
Fine IV-III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 120-121.
38. Orlo di patera38. Orlo di pateraVano 3, taglio 2. Invv. 14659-14680, tav. III e tav. 12, n. 72 frr. ricomposti di o. e parete della vasca sino all’attacco con il f.Argilla di colore arancio (2.5YR6/8) con picco-lissimi inclusi bianchi, ad alta frequenza; v.n.-marrone, diluita, sottile, in parte evanida con scoli all’est. della vasca.Alt. 4,4, diam. 21,4. Labbo estrofl esso, convesso, pendente, legato alla parete della vasca, profonda, da una care-natura all’int. e all’est.Morel, serie 1534.Fine IV-III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 120-121.
39. Orlo di patera39. Orlo di pateraVano 4, taglio 2. Inv. 16022, tav. III2 frr. ricomposti di o. e parete della vasca.Argilla di colore rosso-arancio (5YR7/6), mica-cea, con inclusi bianchi piccolissimi, ad alta frequenza; v.n.-marrone, diluita, scistosa.Alt. 6,7, diam. ric. 25,4. Labbro estrofl esso, convesso, pendente, legato alla parete della vasca da una carenatura all’int. e all’est. Serie Morel, serie 1534.Fine IV-III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 120-121.
40. Orlo di patera40. Orlo di pateraVano 2, taglio 1. Inv. 15944, tav. III2 frr. ricomposti di o. e parete della vasca.Argilla di colore arancio (5YR6/6), micacea, con inclusi bianchi e neri, piccoli, ad alta fre-quenza; v.n.-bluastra, iridescente, scistosa.Alt. 3,2, diam. 24,8. Labbro estrofl esso, bombato e pendente verso l’est., mancante del margine; parte della vasca con carenatura all’int. e all’est., all’attacco con il labbro. Morel, serie 1534.Fine IV-III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 120-121.
41. Orlo di patera41. Orlo di pateraSporadico. Inv. 15837, tav. III2 frr. ricomposti di o. e parete della vasca.Argilla di colore rosa-arancio (2.5YR6/8) con piccoli inclusi bianchi a frequenza media e cha-motte; v.n.-bluastra, opaca, in parte evanida.Alt. 3,9, diam. 23. Labbro estrofl esso, ricurvo e pendente, legger-mente ingrossato alle estremità; legato alla parete della vasca con una scanalatura all’int. e all’est. Est. risparmiato con scoli di vernice.
221
Morel, serie 1534.Fine IV-III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 120-121, tav. 21-22.
42. Orlo di patera42. Orlo di pateraVano 3, taglio 1. Inv. 14667, tav. IV1 fr. di labbro e vasca.Argilla di colore rosa-arancio (2.5YR6/8), con pochi inclusi bianchi piccolissimi; vernice aran-cio-marrone, sottile, opaca, in parte evanida.Alt. 4,1, diam. 28.Labbro estrofl esso a profi lo curvo, pendente, la parete della vasca poco profonda, all’int. si piega verso l’alto all’attacco con il labbro. Morel, serie 1534.Fine IV-III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 120-121, tavv. 21-22.
43. Patera43. PateraVano 1, taglio 2. Inv. 15909, tav. IV e tav. 12, n. 55 frr. ricomposti di o. e parete della vasca.Argilla di colore marrone (7.5YR6/3), micacea, con frequenti inclusi bianchi e neri; vernice violacea, opaca e diluita.Alt. 5, diam. ric. 13,3. Labbro estrofl esso appena ricurvo, largo, le -gato alla parete tessa della vasca, profonda, con una carenatura sia all’int. che all’est. Est. risparmiato con sgocciolature sulla parete della vasca.Morel, serie 1531.IV-III sec. a.C.Morel 1981a, p. 120, tav. 78.
44. Patera44. PateraVano 2, taglio 3. Inv. 15967, tav. IV1 fr. di labbro e piccola porzione della vasca.Argilla di colore beige (2.5Y8/2), lievemente granulosa; v.n. completamente evanida.5,4x7,6.Labbro estrofl esso, appena curvo, legato alla vasca poco profonda da una carenatura netta sia all’int. che all’int.III sec. a.C.
45. Patera45. PateraVano 4, taglio 1. Inv. 15984, tav. IV1 fr.Argilla di colore beige (10YR8/3), micacea e poco compatta con piccoli inclusi bianchi e neri a frequenza media; v.n.-marrone, opaca, in alcuni punti evanida.Alt. 2,3, diam. ric. 26. Labbro estrofl esso, appena ricurvo, largo, legato alla parete della vasca da una moderata carenatura all’int.Forse Morel, serie 1315.III sec. a.C.Morel 1981a, p. 104, tav. 13.
46. Patera 46. Patera Vano 4, taglio 1. Inv. 15985, tav. IVArgilla di colore rosa (5YR7/4), lievemente granulosa; v.n.-violacea, opaca, in alcuni punti evanida.5,1x2,3.Labbro estrofl esso, ricurvo, pendente, legato alla parete della vasca da una carenatura; all’int., in corrispondenza della carenatura, un cerchiello dipinto a v.n. Morel, serie 1534.Fine IV-III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 120-121, tavv. 21-22.
47. Patera47. PateraVano 2, taglio 1; vano 1, taglio 2. Inv. 15939, tav. IV3 frr. ricomposti di o. e parete della vasca.Argilla di colore arancio (5YR7/6), con picco-lissimi inclusi bianchi a frequenza media; v.n.-marrone e arancio per ossidazione in cottura, iridescente, in qualche punto abrasa. Alt. 1,6, diam. 13,6. Labbro stretto, estrofl esso, poco incurvato, con una scanalatura nella faccia superiore, vicino all’attacco con la parete della vasca, poco profonda.Morel, serie 1335.Fine II sec. a.C. Morel 1981a, p. 108, tav. 15.
48. Coperchio di pisside 48. Coperchio di pisside Sporadico. Inv. 17521Fr. di spalla e pomello.Argilla di colore beige-rosa (10YR8/3); vernice marrone-arancio.2,7x5,7.Porzione di saliente e pomello tronco-conico.Morel, tipo 2856c1.III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 233.
49. Coperchio di pisside49. Coperchio di pissideVano 3, taglio 1. Inv. 14671Argilla di colore beige (10YR8/3), v.n.; bianco e paonazzo sovraddipinto in parte evanidi.Diam. max ric. 9.All’int., battente per la posa.Morel, tipo 2856c1.III sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 233.
50. Ansa di forma chiusa50. Ansa di forma chiusaVano 4, taglio 2. Inv. 16002Argilla rosa-arancio, micacea; v.r.-arancio in parte evanida.Ansa verticale, a sezione ovoidale con attacco dell’o.IV-III sec. a.C.
51. Ansa di forma chiusa51. Ansa di forma chiusaVano 4, taglio 3. Inv. 16048Argilla di colore beige, con piccolissimi inclusi bianchi.Ansa a nastro verticale.IV-III sec. a.C.
52. Ansa di forma chiusa52. Ansa di forma chiusaVano 4, taglio 3. Inv. 16044Argilla arancio chiaro, micacea; v.n. iridescente, in alcuni punti evanida.Ansa a sezione quasi ovoidale con lieve sca -nalatura.IV-III sec. a.C.
53. Orlo di forma chiusa53. Orlo di forma chiusaVano 1, taglio 3. Inv. 15924Argilla di colore beige, con piccolissimi inclusi bianchi e neri; v.n., in parte evanida.Ansa a nastro verticale, modanata all’est.IV-III sec. a.C.
54. Orlo di forma chiusa54. Orlo di forma chiusaVano 4, taglio 3. Inv. 15928Argilla di colore rosa-arancio, v.n. in parte evanida.Imboccatura a estremità superiore ingrossata e appiattita con appendice pendula.IV-III sec. a.C.
55. Orlo di forma chiusa55. Orlo di forma chiusaVano 4, taglio 3. Inv. 16040Argilla di colore arancio chiaro, micacea; v.n. iridescente, in alcuni punti evanida.O. ad imbuto appena estrofl esso.IV-III sec. a.C.
56. 56. LekythosLekythos aryballica aryballicaVano 2, taglio 1. Inv. 15943Argilla rosa (2.5YR/76); vernice marrone-arancio.2,9x2,7.Corpo biconico a profi lo angoloso, pd. ad anello. Parte inferiore del corpo e pd. risparmiati.Morel, specie 5450.III sec. a.C.Morel 1981a, pp. 364 sgg.
Ceramica a Pasta GrigiaCeramica a Pasta Grigia
57. Piatto57. PiattoSporadico. Inv. 16021, tav. V7 frr. ricomposti di parete della vasca e pd.Argilla grigia, compatta, a frattura netta. V.n.-bluastra, opaca, densa e aderente.Alt. 2,1; largh. 11,5.
222
Pd. basso con f. della vasca decorato, all’int., da tre gruppi di sottili cerchi concentrici incisi.II-I sec. a.C.Per le produzioni a pasta grigia in generale, cfr. Morel 1978, p. 163; Morel 1980, pp. 104-105. Per le caratteristiche della Campana C, pasta grigia della regione di Siracusa, cfr. Morel 1963, p. 17; Morel 1981a, p. 47. per Lipari, cfr. Campagna 1998, pp. 394-395.
Ceramica Campana B o B-oideCeramica Campana B o B-oide
58. Coppa58. CoppaSporadico. Inv. 15831, tav. VArgilla di colore nocciola, molto compatta, dura, depurata; v.n.-bluastra, densa e aderente.Alt. 4,6; diam. pd. 10,3; diam. o. 13,3.L’o. è leggermente ingrossato, la vasca piega verso l’alto con una carenatura nella parte bassa della parete, all’altezza del fondo, il pd. è alto, molto obliquo.Morel serie 2311.Fine II-I sec. a.C.Per la forma, cfr. Morel 1981a, p. 163, tav. 46. Per i problemi relativi all’identifi cazione della campana B o B-ioide cfr. Morel 1981b, pp. 95 ss. Per altri esemplari da Lipari, cfr. Campagna 1998, pp. 392-394.
Magenta WareMagenta Ware
59. Vaso plastico59. Vaso plasticoVano 4, taglio 1. Inv. 16062, tav. 13, n. 14 frr. ricomposti.Argilla beige-rosata (10YR7/4); vernice aran-cio-marrone, non omogenea, in alcuni punti evanida.Porzione di raffi gurazione di lotta tra un leone e un toro: di questo rimangono due zoccoli contrapposti, mentre del leone, il cui corpo è caratterizzato dall’indicazione del pelo con linee sinuose incise, resta una parte della pan-cia, una coscia ed una zampa anteriore. All’estremità des. del fr. un tratto sovraddi-pinto in bianco. L’attacco tra la cornice di b. e la parte plastica del vaso è evidenziato con una scanalatura irregolare.III sec. a.C.Cfr. Sguaitamatti 1991, pp. 117-146. Per altri esemplari di Magenta Ware a Milazzo, cfr. Tigano 1993-1994, pp. 1059-1085.
60. Vaso plastico60. Vaso plasticoVano 4, taglio 1. Inv. 16063, tav. 13, n. 23 frr. ricomposti.
Argilla beige-rosa (10YR7/4); vernice arancio-giallo; bianco sovraddipinto.Porzione di vaso con decorazione illeggibile che comprende, sopra lo zoccolo di b., due rigonfi amenti di cui uno, quello inferiore, maggiore rispetto all’altro. Quest’ultimo, sulla sin., presenta due tratti obliqui sovraddipinti in bianco. Sul lato, due tratti incisi e congiunti. La cornice di b. che è decorata da due linee dipinte e due risparmiate, ha l’attacco con la parte plastica del vaso evidenziato da una sca-nalatura irregolare.III sec. a.C.Cfr. Sguaitamatti 1991, pp. 117-146. Per altri esemplari di Magenta Ware a Milazzo, cfr. Tigano 1993-1994, pp. 1059-1085.
61. Vaso plastico61. Vaso plasticoVano 4, taglio 1. Inv. 16064, tav. 13, n. 3Argilla beige-rosa (10YR7/4); v.r.Porzione di rappresentazione con due corna affi ancate (?), ingrossate nella parte superiore.III sec. a.C.Cfr. Sguaitamatti 1991, pp. 117-146. Per altri esemplari di Magenta Ware da Milazzo, cfr. Tigano 1993-1994, pp. 1059-1085.
UnguentariUnguentari
62. Unguentario62. UnguentarioVano 1. alt. 21.8. Inv. 16055, tav. VAlt. 21,7, diam. max 6,2, diam. o. 1,9, diam. pd. 3,2.Argilla beige (10YR7/4); vernice bruna sull’o. e sul collo.O. a sezione triangolare distinto dal collo ci -lindri co; corpo fusiforme con curvatura costan- te; basso stelo con pd. tronco-conico e b. di -stinta a disco.Camilli 1999, p. 25, forma B, serie 32. Cfr. Ti gano 2002, pp. 108 ss. della metà del III sec. a.C.
Anfora Pseudo-ChioteAnfora Pseudo-Chiote
63. Orlo di anfora pseudo-chiota63. Orlo di anfora pseudo-chiotaVano 4, taglio 3. Inv. 16053, tav. VI e tav. 13, n. 4Argilla rosa chiaro (M7.5YR7/4) con molti inclusi bianchi piccoli e medi. Ingubbiatura trasparente.7,1x9,3.O. a sezione amigdaloide allungato, sottoline-ato da una lieve gola all’attacco col collo.Seconda metà del IV sec. Per il tipo, cfr. Vandermesch 1994, p. 67 (MGS II).
Anfora con Orlo a Quarto di Anfora con Orlo a Quarto di
CerchioCerchio
64. Orlo di anfora con orlo a quarto di cerchio64. Orlo di anfora con orlo a quarto di cerchioSporadico. Inv. 17191Argilla rosa (2.5YR7/6) abbastanza compatta, depurata con piccoli inclusi bianchi e mica. Ingubbiatura biancastra.2,4x9,1.O. superiormente orizzontale, con parte infe-riore “ad echino”.Tipo IIIFine IV-inizi III sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermersch 1994, pp. 69-73.
Anfore Greco-ItalicheAnfore Greco-Italiche
65. Orlo di ansa greco-italica65. Orlo di ansa greco-italicaVano 3, taglio 3. Inv. 14623, tav. VIArgilla rosa (10R7/6) con piccolissimi inclusi bianchi e scuri; ingubbiatura biancastra.4,7x12,9, diam. ric. 12,3.O. a sezione triangolare con estremità superio re e margine est. arrotondato; attacco del collo cilindrico.Tipo V.Ultimi decenni IV-metà III sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermersch 1994, pp. 76-80.
66. Orlo di anfora greco-italica66. Orlo di anfora greco-italicaSporadico. Inv. 17528, tav. VIArgilla arancio (10R6/8) con fi tti, piccolissimi inclusi bianchi e più radi grigi, bianchi e rossi. 4,2x14,1, diam. o. ric. 14,6.O. a sezione triangolare, inclinato verso il basso con margine superiore ed est. arrotondato; attacco del collo.Tipo V.Ultimi decenni IV-metà III sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermersch 1994, pp. 76-80.
67. Orlo di anfora greco-italica67. Orlo di anfora greco-italicaVano 3, taglio 3. Inv. 14622, tav. VIIArgilla rosa (7.5YR7/3), ricca di piccolissimi inclusi scuri, alcuni rossi di dimensioni medie; ingubbiatura giallina.6,1x10,2.O. a sezione triangolare inclinato verso il basso con margine est. arrotondato; attacco del collo cilindrico.Tipo V-VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermesch 1994, pp. 81-83.
68. Orlo di anfora greco-italica68. Orlo di anfora greco-italicaVano 4, taglio 2. Inv. 16010, tav. VII
223
Argilla rosa-beige (2.5Y8/1) con molti piccolis-simi e medi inclusi neri. Ingubbiatura grigia.2,8x10,5.O. a sezione triangolare con margini arroton-dati, inclinati verso il basso; all’attacco con il collo cilindrico, scanalatura.Tipo V-VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermesch 1994, pp. 81-83.
69. Orlo di anfora greco-italica69. Orlo di anfora greco-italicaVano 4, taglio 2. Inv. 16009, tav. VII1 fr. di o. con attacco del collo. Argilla rosa (2.5YR7/6) con inclusi di piccolissime e medie dimensioni, fi tti, neri, più radi bianchi, qual-cuno rosso; ingubbiatura giallina.3,3x10,5.O. a sezione triangolare, inclinato verso il basso, con margini arrotondati; all’attacco del collo cilindrico, lieve scanalatura.Tipo V-VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermesch 1994, pp. 81-83.
70. Orlo di anfora greco-italica70. Orlo di anfora greco-italicaSporadico. Inv. 17529Argilla rosa (2.5YR7/4) con fi tti, piccolissimi inclusi grigi, più radi bianchi, micacea; ingub-biatura biancastra.2,9x10,4, diam. ric. 13,8.O. a sezione triangolare, breve, con attacco del collo.Tipo VISeconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermesch 1994, pp. 81-83.
71. Orlo di anfora greco-italica71. Orlo di anfora greco-italicaVano 3, taglio 3. Inv. 15871Argilla rosa-arancio (2.5YR6/6) con inclusi piccolissimi bianchi e medi neri. Ingubbiatura giallina anche all’int.5,9x5,1.O. a sezione triangolare, inclinato verso il basso; attacco del collo cilindrico.Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermesch 1994, pp. 81-83.
72. Orlo di anfora greco-italica72. Orlo di anfora greco-italicaVano 2, taglio 2. Inv. 159721 fr. di o. (con margine est. abbastanza lacu-noso) e di collo con attacco di ansa a sezione ovoidale. Argilla rosa-arancio (2.5YR6/6) con inclusi piccolissimi neri e medi bianchi; ingub-biatura giallina anche all’int.10,2x7,4.O. a sezione triangolare, inclinato verso il basso; collo cilindrico e attacco d’ansa ovoidale.
Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermesch 1994, pp. 81-83.
73. Orlo di anfora greco-italica73. Orlo di anfora greco-italicaVano 3, taglio 3; vano 2, taglio 1. Invv. 14697-15932, tav. VIIArgilla rosa (10R7/6) con piccolissimi inclusi bianchi, micacea. Ingubbiatura biancastra.Alt. 16,8, diam. 15,3. O. a sezione triangolare inclinato verso l’est. con gradino all’attacco con il collo pseudo-cilin-drico. Attacchi superiori delle anse ovoidali.Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermesch 1994, pp. 81-83.
74. Orlo di anfora greco-italica74. Orlo di anfora greco-italicaSporadico. Inv. 17526, tav. VIIArgilla rosa-arancio (5YR7/8) con inclusi medi e piccoli bianchi e grossi litici; densa ingubbia-tura bianca.Alt. 4,3x 6,8.O. a sezione triangolare inclinato verso il basso, attacco del collo cilindrico segnato da una ner-vatura. Spessa ingubbiatura bianca all’est.Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermesch 1994, pp. 81-83.
75. Orlo di anfora greco-italica75. Orlo di anfora greco-italicaVano 4, taglio 2. Inv. 1600, tav. VII1 fr. di o. con piccola porzione di o.Argilla di colore rosso-arancio scuro (10R6/6) ricca d’inclusi bianchi, rossi e neri; ingubbia-tura giallina. 8x4,8.O. a sezione triangolare inclinato verso il basso, attacco del collo cilindrico. Piccola porzione d’iscrizione lacunosa illeggibile sul collo (due tratti graffi ti ad angolo retto).Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermesch 1994, pp. 81-83.
76. Orlo di anfora greco-italica76. Orlo di anfora greco-italicaVano 1, taglio 1. Inv. 15886, tav. VIIArgilla rosa chiaro (7.5YR8/4) con pochi, pic-colissimi inclusi neri, rossi e bianchi; ingubbia-tura giallina.8,2x10,2.O. a sezione triangolare, inclinato verso il basso con margini arrotondati; collo cilindrico; ansa a sezione ovoidale.Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermersch 1994, pp. 81-83.
77. Orlo di anfora greco-italica77. Orlo di anfora greco-italicaSporadico. Inv. 17527, tav. VI1 fr. comprendente parte dell’o., dell’attacco del collo e di un’ansa. Argilla rosa (7.5YR8/3) con inclusi grigi piccolissimi e fi tti e rossastri più grossi e radi; ingubbiatura biancastra. 6,9x 11,7, diam. o. ric. 14.O. a sezione triangolare, inclinato verso il basso con margine superiore ed est. arrotondato; scanalatura irregolare all’attacco con il collo cilindrico; attacco d’ansa a sezione ovoidale.Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermersch 1994, pp. 81-83.
78. Orlo di anfora greco-italica78. Orlo di anfora greco-italicaSporadico. Inv. 17530, tav. 13, n. 6Argilla rosa (7.5YR8/4), grigia al nucleo con inclusi di piccole e medie dimensioni di colore scuro; ingubbiatura biancastra.4,5x12,1, diam. o. ric. 13,7. O. a sezione triangolare inclinato verso il basso con margine est. arrotondato; attacco del collo cilindrico.Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermersch 1994, pp. 81-83. Oppido Mamertina, pp. 302-303, n. 576, fi g. 310.
79. Collo di anfora greco-italica79. Collo di anfora greco-italicaVano 3. Inv. 14608, tav. VIArgilla rosa (7.5YR7/6) ricca di inclusi bianchi piccolissimi e alcuni medi anche rossi, cha-motte; ingubbiatura biancastra.Alt. 15,8, diam. 13.O. a sezione triangolare inclinato verso il basso, con margine est. arrotondato; collo cilindrico con lieve rientranza all’int. in corrispondenza con l’attacco superiore delle anse; attacco d’ansa a sezione ovoidale.Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermersch 1994, pp. 81-83. Oppido Mamertina, pp. 302-303, n. 576, fi g. 310.
80. Orlo di ansa greco-italica80. Orlo di ansa greco-italicaVano 2, taglio 2. Inv. 15974, tav. VIIFrammento di o. e attacco del collo. Argilla rosa-arancio (2.5YR7/6) con fi tti piccolissimi inclusi neri, più radi bianchi, chamotte. Ingub-biatura biancastra. 3,5x8,6. O. a sezione triangolare, inclinato verso il basso, con margini arrotondati; attacco del collo cilindrico.Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermersch 1994, pp. 81-83.
224
81. Orlo di ansa greco-italica81. Orlo di ansa greco-italicaVano 1, taglio 1. Inv. 15885, tav. VI1 fr. di o. con attacco del collo e piccola por-zione dell’attacco dell’ansa. Argilla rosa chiaro (7.5YR7/4) con piccolissimi, fi ttissimi inclusi neri, più radi bianchi. Ingubbiatura giallina3,5x8,6. O. a sezione triangolare, inclinato verso il basso, con margini arrotondati; attacco del collo cilindrico.Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermersch 1994, pp. 81-83.
82. Orlo di anfora greco-italica82. Orlo di anfora greco-italicaVano 4, taglio 2. Inv. 15998, tav. VIArgilla rosa-arancio (2.5YR6/6) con fi tti, picco-lissimi inclusi scuri, più radi bianchi; chamote. Ingubbiatura biancastra.7,5x15,3, diam. ric. 13,1.O. a sezione triangolare, inclinato verso il basso con estremità superiore e margine sterno arro-tondati; collo cilindrico.Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermersch 1994, pp. 81-83.
83. Orlo di anfora greco-italica83. Orlo di anfora greco-italicaVano 3, taglio 3. Inv. 14707Argilla rosa (5YR7/6) con pochi, piccolissimi inclusi bianchi. Ingubbiatura biancastra. 2,8x5,8.O. a sezione triangolare inclinato verso il basso; attacco del collo cilindrico.Tipo VI.Seconda metà III-inizi II sec. a.C.Cfr., per il tipo, Vandermersch 1994, pp. 81-83.
84. Orlo di anfora greco-italica84. Orlo di anfora greco-italicaVano 3, taglio 2. Inv. 14677, tav. VII1 fr. di o. e collo.Argilla rosa-arancio (5YR7/6) con frequenti inclusi bianchi e neri; ingubbiatura biancastra.
7,2x9,5.O. a sezione triangolare con profi lo est. obli-quo. Porzione di collo cilindrico.Tipo VI-Dressel 1.260-190.Per la transizione dal tipo VI alle Dressel 1, cfr. Empereur-Hesnard 1987, p. 29.
85. Orlo di anfora greco-italica85. Orlo di anfora greco-italicaVano 3, taglio 2. Inv. 14678, tav. VIIArgilla rosa-arancio (5YR7/6) con inclusi pic-colissimi bianchi e neri; sottile ingubbiatura giallina anche all’int..8,8x8,5.O. a sezione triangolare con profi lo est. obliquo e estremità inferiore pendente; lieve scanala-tura all’attacco tra l’o. ed il collo cilindrico, di cui resta una porzione.Tipo VI-Dressel 1.260-190.Per la transizione dal tipo VI alle Dressel 1, cfr. Empereur-Hesnard 1987, p. 29.
86. Orlo di anfora greco-italica86. Orlo di anfora greco-italicaVano 4, taglio 3.Vano 3, taglio 2. Inv. 14676-16025, tav. VII e tav. 13, n. 52 frr. ricompongono una porzione di o., collo e parte superiore di un’ansa.Argilla rosso-arancio (10R6/6) con piccolissimi inclusi bianchi e neri; ingubbiatura spessa bianca. Alt. 10,8, diam. o. ric. 12,4.O. a sezione triangolare con profi lo est. obli-quo. Collo cilindrico. Ansa a sezione ovoidale.Tipo VI-Dressel 1.260-190.Per la transizione dal tipo VI alle Dressel 1, cfr. Empereur-Hesnard 1987, p. 29.
87. Ansa di anfora greco-italica87. Ansa di anfora greco-italicaVano 1, taglio 3. Inv. 15914, tav. VIII e tav. 13, n. 71 fr. di ansa con incrostazione (piombo?) in parte del cartiglio. Argilla di colore rosa (2.5YR7/6)
con piccolissimi inclusi bianchi; ingubbiatura di colore biancastro.6,5x4,7.Ansa verticale a sezione ovoidale con bollo, parzialmente leggibile, impresso entro cartiglio rettangolare: [-]ntal
Molto probabilmente [À]ntavl.Cfr. Olcese 2004, p. 177; Garozzo 2005, 380-383, nn. IMGSgr5-6; Garozzo 2006, p. 720, A.1 e A.2.
88. Ansa di anfora greco-italica88. Ansa di anfora greco-italicaSporadico. Inv. 17523, tav. VIII e tav. 13, n. 8Argilla rosso-violacea (10R6/4) con inclusi pic-coli e medi bianchi e neri, più chiara al nucleo; ingubbiatura sottile biancastra.3x6,9.Parte superiore di un’ansa a sezione ovoidale con piccola porzione di collo. Sull’ansa, bollo in lingua latina impresso entro cartiglio rettango-lare: m anterio o m antestio?.Cfr. Vandermersch 2001, p. 162, 195, fi g. 2; Garozzo 2005, pp. 479-480, n. IMGSlt4; Ga -
rozzo 2006, pp. 723-724.
Anfora PunicaAnfora Punica
89. Anfora punica89. Anfora punicaSporadico. Inv. 16035, tav. VIIIO. e porzione di collo ricomposti con due frr.Argilla di colore rosa-arancio (5YR7/6), a frat-tura irregolare, dura con frequenti inclusi bian-chi, neri e grigi piccoli e medi. Superfi cie di colore biancastro.Alt. 6,6, diam. o. 13,4.O. estrofl esso e ingrossato, con estremità supe-riore esterna appena pendente e lieve rigonfi a-mento sotto; breve collo a profi lo concavo.Ramon Torres, tipo 7.6.6.1.Fine II-I sec. a.C.Cfr. Ramon Torres 1995, pp. 258-259.
225
Tav. I – Contrada Ciantro. Fattoria. Ceramica a vernice nera (disegni ed elaborazione grafi ca di Caterina Persiani).
226
Tav. II – Contrada Ciantro. Fattoria. Ceramica a vernice nera e a vernice nera sovraddipinta (disegni ed elaborazione grafi ca di Caterina Persiani).
227
Tav. III – Contrada Ciantro. Fattoria. Ceramica a vernice nera (disegni ed elaborazione grafi ca di Caterina Persiani).
228
Tav. IV – Contrada Ciantro. Fattoria. Ceramica a vernice nera (disegni ed elaborazione grafi ca di Caterina Persiani).
229
Tav. V – Contrada Ciantro. Fattoria. Ceramica a vernice nera, ceramica a pasta grigia, ceramica campana B o B-oide, unguentario (disegni ed elaborazione grafi ca di Caterina Persiani).
230
Tav. VI – Contrada Ciantro. Fattoria. Anfora pseudo-chiota, anfore greco-italiche (disegni ed elaborazione grafi ca di Caterina Persiani).
231
Tav. VII – Contrada Ciantro. Fattoria. Anfore greco-italiche (disegni ed elaborazione grafi ca di Caterina Persiani).