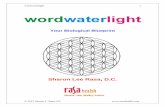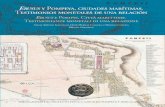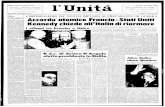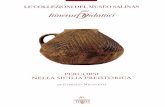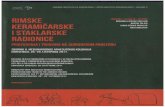Anfore in Sicilia (VIII-XII sec. D.C.)
Transcript of Anfore in Sicilia (VIII-XII sec. D.C.)
FABIOLA ARDIZZONE LO BUEAnfore in Sicilia (VIII -XII sec. d.C.)
© Copyright 2012 Torri del Vento Edizioni di Terra di Vento s.r.l.
Riproduzione vietata.
TORRI DEL VENTO EDIZIONI di Terra di Vento s.r.l.
www.torridelventoedizioni.it - [email protected]
Impaginazione - arch. GIUSEPPE NISI
Stampa - Fotograf
ISBN - 978-88-97373-29-2
Al mio adorabile “mostro” e ai miei cuccioli
INDICE GENERALE
BIBLIOGRAFIA ED ABBREVIAZIONI p. 5
PREMESSA p. 31
CAPITOLO I
LE ANFORE D’IMPORTAZIONE NELLA SICILIA OCCIDENTALE (VIII-XII SEC.) p. 37
1.1 ANFORE D'IMPORTAZIONE DI VIII SECOLO “ 391.2 ANFORE D'IMPORTAZIONE DI X-XII SECOLO “ 501.3 ANFORE D'IMPORTAZIONE NON CLASSIFICATE “ 631.4 GRAFFITI “ 701.5 RUOLO MEDITERRANEO DELLA SICILIA TRA L'VIII E IL IX SECOLO.
EPIGONI DEL MONDO BIZANTINO “ 721.6 LA SICILIA E IL MONDO ISLAMICO. LA RINASCITA DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE “ 75
CAPITOLO II
LE ANFORE DI PRODUZIONE LOCALE (X-XI SECOLO) p. 83
2.1 LA PRODUZIONE PALERMITANA “ 832.2 LE ANFORE DI X SECOLO “ 872.3 LE ANFORE TRA LA FINE DEL X E L'XI SECOLO “ 892.4 LE ANFORE DI XII SECOLO “ 1082.5 LE ANFORE DI PRODUZIONE PALERMITANA E LA CERAMICA
DIPINTA MEDIEVALE “ 1222.6 ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA FUNZIONE DELLE FORME INDIVIDUATE “ 129
CAPITOLO III
I CONTESTI DI RINVENIMENTO DELLE ANFORE ALTOMEDIEVALI DELLA SICILIA OCCIDENTALE p. 135
3.1 MARETTIMO “ 1353.2 CEFALÙ “ 1383.3 CARINI “ 1413.4 PALERMO “ 1443.5 RINVENIMENTI SOTTOMARINI “ 1493.6 I RELITTI DI MARSALA E DI SAN VITO LO CAPO “ 149
PREMESSA CATALOGO p. 151
CATALOGO DELLE ANFORE p. 152
MARETTIMO p. 152PALERMO - PALAZZO GALLETTI “ 157CEFALÙ “ 157MAZARA DEL VALLO “ 160PALERMO PALAZZO ROSTAGNO “ 167CARINI, CONTRADA S. NICOLA “ 168PALERMO, VIA TORREMUZZA “ 175PALERMO, EDIFICI NORMANNI “ 181PALERMO, CHIESA DI S. M. DELL'AMMIRAGLIO E MONASTERO ANNESSO “ 189PALERMO, PALAZZO DELLA ZISA “ 195
CONCLUSIONI p. 219
ABADIE REYNAL 1989
ABADIE 1989
ABULAFIA 1991
AGNELLO 1877
Agrigento 1995
Agrigento 2007
ALAIMO et alii 1995
AMARI BAS
AMARI Storia
AMIGUES - CRUSELLESGONZALES VILLAZSCUSALERMA 1995
AMPOLO 1971
Archeologia e territorio
C. ABADIE REYNAL, Céramique et commerce dans le bassin égéendu IVe au VIIe siècle, in Hommes et richesses dans l’Empire byzantin IVe- VIIe siècle, I, Paris 1989, pp. 143-159.
C. ABADIE, Amphores protobyzantines d’Argos (IVe-VIe siécles) in Re-cherches sur la céramique byzantine, Actes du Colloque (Athénes 8-10 avril1987), Athénes 1989, pp. 47-56.
D. ABULAFIA, Le due Italie. Relazioni economiche fra il regno nor-manno di Sicilia e i comuni settentrionali, Napoli 1991, Traduzioneitaliana del volume The Two Italies. Economic relations between theNorman Kingdom of Sicily and the Northern communes, Cambridge 1977.
AGNELLO, Riduzione di tutte le misure consuetudinarie di Sicilia,Palermo 1877.
AA. VV., in R. M. BONACASA CARRA (a cura di), Agrigento. La necropoli paleocristiana sub divo, (Studi e Materiali, Istituto di Archeologia, Università di Palermo, 10), Roma 1995.
AA. VV., in R.M. BONACASA CARRA – F. ARDIZZONE (a cura di), Agrigento. La necropoli paleocristiana sub divo, Todi 2007.
R. ALAIMO - L. DI FRANCO - R. GIARRUSSO - G. MONTANA,Analisi mineralogiche e petrografiche, in Agrigento 1995, pp. 365-429.
M. AMARI, Biblioteca Arabo - Sicula, I-II, Torino e Roma 1880-1881(rist. an. Catania 1982).
M. AMARI, Storia dei Musulmani di Sicilia, I-III, 2 edizione a cura di C. A. Nallino, Catania 1933-39.
F. AMIGUES - E. CRUSELLES - R. GONZALES VILLASCUSA - J.V.LERMA, Los envase ceràmicos de Paterna / Manises y el comercio baio me-dieval, in Actes du 5ème Colloque sur la Céramique Médiévale en Méditer-ranée Occidentale, Rabat 11-17 novembre 1991, Rabat 1995, pp. 346-363.
C. AMPOLO, Appendice V. Lo scarico di fornace arabo - normannarinvenuto nel peristilio della villa, in C. AMPOLO - A. CARANDI-NI - G. PUCCI - P. PENSABENE, La villa del Casale a Piazza Arme-rina, problemi, saggi stratigrafici ed altre ricerche, in MEFRA, LXXXIII,1971, pp. 261-272.
Archeologia e territorio AA.VV., Archeologia e territorio, Palermo 1997.
5
B I B L I O G R A F I A
6
ARCIFA et alii 1985-87
ARCIFA 1991
ARCIFA 1996
ARCIFA 1997
ARCIFA 1998 a
ARCIFA 1998 b
ARCIFA – BAGNERA NEF 2012
ARDIZZONE 1991
ARDIZZONE 1997-98
ARDIZZONE 1998
ARDIZZONE 1999
ARDIZZONE 2000
L. ARCIFA - C. A. DI STEFANO - M. H. DE FLORIS - J. M. PE-SEZ, Lo scavo archeologico di Castello San Pietro a Palermo, in B. C. A.Sicilia, VI-VII,2, 1985-87, pp. 30-41.
L. ARCIFA, I materiali, in V. LA ROSA - L. ARCIFA, Per il casaledi Milocca: ceramiche medievali dalla contrada Amorella, in L’età diFederico II, pp. 201-206.
L. ARCIFA, Palermo: scarti di fornace dall’ex Monastero dei Benedetti-ni Bianchi. Primi dati su alcune produzioni ceramiche palermitane del-la prima età normanna, MEFRM 108, 1996, 2, pp. 451-477.
L. ARCIFA, Dal X al XII secolo, in L. ARCIFA - E. LESNES, Primidati sulle produzioni palermitane dal X al XV secolo, in G. DÉMIANSD’ARCHIMBAUD (a cura di ), La céramique médiévale en Méditer-ranée, Actes du VIe congrès de l’AIECM2 (Aix en Provence 13-18 novem-bre 1995), Aix en Provence 1997, pp. 405-412.
L. ARCIFA, Contributo allo studio della ceramica comune medievalein Sicilia (sec. X-XII): problemi di classificazione e temi di ricerca, in Levillage médiéval et son environnement, Études offertes à Jean Marie Pesez, Paris 1998, pp. 273-289.
L. ARCIFA, Ceramiche città e commercio in Sicilia: il caso di Palermo, inS. GELICHI (a cura di), Ceramiche, città e commerci nell’Italia tardo-me-dievale, Atti del Convegno Ravello 3-4/5/1993, Mantova 1998, pp. 89-107.
L. ARCIFA – A. BAGNERA – A. NEF, Archeologia della Sicilia isla-mica: nuove proposte di riflessione, in Ph. SÉNAC (a cura di), Histoireet archéologie de l’Occident musulman (VIIe – XVe siècles). Al – Anda-lus, Maghreb, Sicile, Toulouse 2012, pp. 241-274.
F. ARDIZZONE, La ceramica, in R.M. BONACASA CARRA - F.ARDIZZONE - R. MACALUSO, Due nuove fornaci medievali adAgrigento, in L’età di Federico II, pp. 220-222.
F. ARDIZZONE, Le anfore dipinte a bande, in GRECO, C. - GARO-FANO, I. - ARDIZZONE, F. Nuove indagini archeologiche nel territoriodi Carini, Kokalos 43-44, II.2, 668-677.
F. ARDIZZONE, Le anfore, in Marettimo, pp. 407-411.
F. ARDIZZONE, Le anfore recuperate sopra le volte del Palazzo dellaZisa e la produzione di ceramica comune a Palermo tra la fine dell’XI edil XII secolo, in MEFRM 111, 1, pp. 7 - 45.
F. ARDIZZONE – R. DI LIBERTO, L’insediamento cristiano di “Ca-se Romane” nell’isola di Marettimo dal periodo protobizantino alla rifon-dazione d’età normanna, in M.C. SOMMA (a cura di), Cantieri e mae-stranze nell’Italia medievale, Atti del Convegno di Studio (Chieti – SanSalvo 16-18 maggio 2008) De re monastica II, Spoleto 2010, pp. 412-447.
7
ARDIZZONE 2010
ARCIFA - ARDIZZONE 1995
ARCIFA - ARDIZZONE 2009
ARIAS – BERTI TONGIORGI 1975
ARTHUR 1986 a
ARTHUR 1986 b
ARTHUR 1989
ARTHUR 1991
ARTHUR 1992
ARTHUR et alii 1992
ARTHUR 1993
ARTHUR 1994
ARTHUR 1995
F. ARDIZZONE, Nuove ipotesi a partire dalla rilettura dei dati archeo-logici: la Sicilia occidentale, in NEF A. - PRIGENT V. eds., La Sicilede Byzance à l’Islam, Paris 2010, pp. 51-76.
L. ARCIFA - F. ARDIZZONE, Saggi archeologici nell’area della Nuo-va Pretura di Palermo, in Federico e la Sicilia, 1995, pp. 293-299.
L. ARCIFA - F. ARDIZZONE, La ceramica dipinta in rosso in Sici-lia tra altomedioevo ed età normanna, in DE MINICIS E. ed., Le cerami-che di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. vol. VI, VI Conve-gno di studi (Segni 6-7 maggio 2004), Roma 2009, Kappa, 170-186.
C. ARIAS – G. BERTI – L. TONGIORGI, Caratteristiche tecniche dialcuni tipi di ceramica (XI – XVI secolo). Ingobbiatura e fenomeni dischiarimento degli impasti, in Atti dell’VIII Convegno Internazionaledella Ceramica (Albisola, 30 maggio – 2 giugno 1975), pp. 137-150.
P. ARTHUR, Appunti sulla circolazione della ceramica medievale aNapoli, in La ceramica nel Mediterraneo occidentale (Siena - Faenza,1984), Firenze 1986, pp. 545-553.
P. ARTHUR, Amphorae and the Byzantine World, in Recherches surles amphores grecques, Actes du Colloque International (Athèénes, 10-12Septembre 1984), Athénes 1986, pp. 655-659.
P. ARTHUR, Aspects of Byzantine Economy: an Evaluation of Ampho-ra Evidence from Italy, in Recherches sur la céramique byzantine, actesdu Colloque (Athénes 8-10 avril 1987), in BCH Supp. XVIII, Athénes1989, pp. 79-93.
P. ARTHUR, Naples: a case of urban survival in the early middle ages?,in MEFRM 103.2, 1991, pp. 759-784.
P. ARTHUR, Amphorae for Bulk Transport, in Otranto, Galatina (LE)1992, pp.199-217.
P. ARTHUR, Fornaci altomedievali ad Otranto. Nota preliminare, in“Archeologia Medievale” XIX (1992), pp. 91-122.
P. ARTHUR, Early Medieval Amphorae, the Duchy of Naples and theFood Supply of Rome, in PBSR LVIII (1993), pp. 231-244.
P. ARTHUR, Ceramica comune tardo-antica ed alto-medievale, in P.ARTHUR (a cura di), Il complesso archeologico di Carminiello ai Man-nesi, Napoli (Scavi 1983-1984), Galatina (LE) 1994, pp. 181-220.
P. ARTHUR, Il particolarismo napoletano altomedievale: una letturabasata sui dati archeologici, in MEFRM 107, 1, 1995, pp. 17-30.
8
ARTHUR 1998
ARTHUR- PATTERSON 1994
ARTHUR - PATTERSON 1998
ARTHUR - WHITEHOUSE 1982
Atlante I
AURIEMMA 1996
BACCI 1980-1981
BAKIRTZIS 1989
BAKIRTZIS 2009
BARELLO - CARDOSA 1991
BASILE 1987
BASILE 1994
P. ARTHUR, Eastern Mediterranean amphorae between 500 and 700:a view from Italy, in L. SAGUÌ (a cura di) Ceramica in Italia: VI-VIIsecolo, Atti del Convegno in onore di John W. Hayes Roma, 11-13 mag-gio 1995, I, Firenze 1998, pp. 157-183.
P. ARTHUR - H. PATTERSON, Ceramics and Early Medieval Centraland Southern Italy: “a potted History”, in La Storia dell’AltomedioevoItaliano, 1994, pp. 409-441.
P. ARTHUR - H. PATTERSON, Local pottery in southern Puglia inthe sixth and seventh centuries, in L. SAGUÌ (a cura di) Ceramica in Italia:VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di John W. Hayes Roma, 11-13 maggio 1995, I, Firenze 1998, pp. 511-530.
P. ARTHUR - D. WHITEHOUSE, La ceramica dell’Italia meridio-nale: produzione e mercato tra V e X secolo, in “Archeologia Medievale”,IX, 1982, pp. 39-46.
Atlante delle forme ceramiche, I. Ceramica fine romana nel bacino me-diterraneo (medio e tardo impero), EAA, Roma 1981.
R. AURIEMMA, Per la carta archeologica del Salento, in Atti del Con-vegno Nazionale di Archeologia Subacquea, Anzio 30 maggio - 1 giugno1996, Bari 1997, pp. 225-239.
BACCI, Ricerche a Taormina negli anni 1977-1980, in Kokalos XXVI-XXVII, II.1, pp. 737-748.
Ch. BAKIRTZIS, «Byzantine amphorae», in Recherches sur la cérami-que byzantine, actes du Colloque (Athénes 8-10 avril 1987), in BCH Supp.XVIII, Athénes 1989, pp. 73-77.
CH. BAKIRTZIS, Ceramiques en comblement des voutes a Sainte Sophiede Thessalonique, in J. ZOZAYA – M. RETUERCE – M.A. HER-VAS – A. DE JUAN (a cura di), Actas del VIII Congreso Internacionalde Ceramica Medieval. (Ciudad Real 27/2 – 3/3 2006), II, Madrid 2009,pp. 697-702.
F. BARELLO - M. CARDOSA, Casignana Palazzi, in MEFRM 103.2,1991, pp. 669-687.
B. BASILE, Recenti prospezioni subacquee nell’arco costiero fra Messinae Giardini Naxos, in Lo Stretto crocevia di culture, Atti del Ventiseiesi-mo Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto – Reggio Calabria,9-14 ottobre 1986), Taranto 1987, pp.361-395.
B. BASILE, Ricognizioni subacquee lungo la costa siracusana nell’ulti-mo quinquennio, in VI Rassegna di archeologia subacquea (GiardiniNaxos 25-27 ottobre 1991), Villa San Giovanni 1994, pp. 11-29.
9
BASS 1982
BAZZANA 1981
BELLAFIORE 1978
BELVEDERE 1988 a
BELVEDERE 1988 b
BELVEDERE 1993
BELVEDERE 1995
BELVEDERE 1997
BENENTE 1996
BERNABÒ BREA 1988
BERTI 1993
BERTI - MENCHELLI 1998
BERTI - TONGIORGI 1981
BIERMAN 1989
G. F. BASS, The Pottery, in G.F. BASS - F.H. VAN DOORNINCK,Yassi Ada, I. A Seventh Century Byzantine Shipwreck, Texas A&M University Press 1982, pp. 155-188.
A. BAZZANA, Essai de typologie des ollas valenciannes, in II ColoquioCeramica Medieval del Mediterraneo Occidental, Toledo 1981, pp. 93-98.
G. BELLAFIORE, La Zisa di Palermo, Palermo 1978.
O. BELVEDERE, Topografia storica, in AA. VV. Himera III, Roma1988, pp. 191-225.
O. BELVEDERE, Opere pubbliche ed edifici per lo spettacolo nella Si-cilia di età imperiale, in ANRW II.11.1, Berlin 1988, pp. 346-413.
O. BELVEDERE, Dalla città romana alla città medievale, in O. BEL-VEDERE - A. BURGIO - R. MACALUSO - M. S. RIZZO, TerminiImerese. Ricerche di topografia e di archeologia urbana, Palermo 1993,pp. 283-289.
O. BELVEDERE, Land Tenure and Settlement in Roman Sicily, in Ac-ta Hyperborea 6, Ancient Sicily, T. FISCHER HANSEN(a cura di), 1995, pp. 195-208.
O. BELVEDERE, Organizzazione fondiaria e insediamenti nella Sici-lia di età imperiale, in XLIII Corso di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina, (Ravenna 22-26 marzo 1997), Ravenna 1997, pp. 33-59.
F. BENENTE, Ceramiche d’importazione islamiche e bizantine, inAA.VV., Lo scavo della contrada di S. Domenico al Priamàr (Savona)relazioni preliminari sulle campagne di scavo 1989-1995, in “Archeolo-gia Medievale” XXIII, 1996, pp.347-351.
L. BERNABÒ BREA, Le isole Eolie dal tardo antico ai Normanni, Ravenna 1988.
G. BERTI, Pisa: dalle importazioni islamiche alle produzioni locali diceramiche con rivestimenti vetrificati (2° m- X- 1° m. XVII s.), in S. BRU-NI (a cura di ), Pisa. Piazza Dante uno spaccato di storia pisana. La cam-pagna di scavo 1991, Pisa 1993, pp. 119-143.
G. BERTI - S. MENCHELLI, Pisa. Ceramiche da cucina, da dispensa, da tra-sporto, dei secoli X-XV, in “Archeologia Medievale” XXV, 1998, pp. 307-333.
G. BERTI - L. TONGIORGI, I bacini ceramici medievali delle chiesedi Pisa, Roma 1981.
I. A. BIERMAN, The Art of the Pubblic Text: Medieval Islamic Rule,in I. LAVIN (a cura di), World Art. Themes of Unity in Diversity, Actsof the XXVIth International Congress of the History of Art, II,Pennsylvania U.P.1989, pp.283-290.
10
BISI 1969
BISI 1971
BJELAJAC 1989
BLAKE 1997
BONACASA CARRA 1987
BONACASA CARRA 1989
BONACASA CARRA 1992 a
BONACASA CARRA 1992 b
BONACASA CARRA 1996
BONACASA CARRA et alii 1991
BOWSHER 1986
BRESC 1980
BRESC 1983
A. M. BISI, XII. Favignana e Marettimo (Isole Egadi). Ricognizione ar-cheologica, “Notizie degli Scavi” XXIII (1969), pp. 316-340.
A. M. BISI, Marettimo (Sicilia, Trapani). 2842, “Fasti Archeologici” XXII,p. 198.
L. BJELAJAC, Byzantine Amphorae in the Serbian Danubian Area in
the 11th - 12th Centuries, in Recherches, pp. 109-118.
H. BLAKE, Sizes and Measures of Later Medieval Pottery in North -Central Italy, in Material Culture in Medieval Europe. Papers of the“Medieval Europe Brugge 1997” Conference volume 7, a cura di G. DeBoe - F. Verhaeghe, Zellik 1997, pp. 221-250.
R. M. BONACASA CARRA, Brevi note sul Cristianesimo ad Agri-gento e nel territorio agrigentino, in R.M. BONACASA CARRA(a cura di), Agrigento Paleocristiana, Palermo 1987, pp. 9-12.
R.M. BONACASA CARRA, Il materiale antico reimpiegato e rilavo-rato in età normanna, in AA.VV., La basilica cattedrale di Cefalù. Ma-teriali per la conoscenza storica ed il restauro. La ricerca archeologica.Preesistenze e materiali reimpiegati, 3 Palermo 1989, pp. 115-144.
R. M. BONACASA CARRA, Insediamenti e spazio cristiano in Sici-lia, in R.M. BONACASA CARRA, Quattro note di archeologia cri-stiana in Sicilia, Palermo 1992, pp. 1-25.
R. M. BONACASA CARRA, Due nuove fornaci medievali ad Agri-gento, in R.M. BONACASA CARRA, Quattro note di archeologia cri-stiana in Sicilia, Palermo 1992, pp. 81-95.
R. M. BONACASA CARRA, Agrigento paleocristiana nuove scoperte,in “Kokalos” XLII, 1996, pp. 59-74.
R. M. BONACASA CARRA - F. ARDIZZONE - R. MACALUSO,Due nuove fornaci medievali ad Agrigento, in L’età di Federico II, pp. 217-228.
J. M. C. BOWSHER, Excavations of the Western Exterior, in AA. VV.The Jerash North Theatre: Architecture and Archaeology 1982-1983, inFAWAZI ZAYADINE (a cura di), Jerash Archaelogical Project 1981-1983,I, Amman 1986, pp. 241-251.BRESC 1976 G.- H. BRESC, Cuci-na e tavola a Palermo nel tre e quattrocento, in Atti del IX Convegno In-ternazionale della Ceramica, (Albisola 28-31 Maggio 1976), pp. 21-35.
H. BRESC, La casa rurale nella Sicilia medievale: massaria, casale e “terra”, in Archeologia Medievale, VIII, 1980, pp. 375-381.
H. BRESC, Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450, Palermo 1983.
11
BRESC 1993
BRESC 1994
Brucato
BRUNAZZI 1989
BRUNO 2004
BRUSIC 1976
BURGARELLA 1989
BYLINSKI 1993
CADENAT 1977-79
CACCIAGUERRA 2009
CAMERATA SCOVAZZO 1977
CANGOVA 1959
CARACAUSI 1983
H. BRESC, Le marchand, le marché et le palais dans la sicile des Xe-XIIesiécles, in Mercati e mercanti nell’alto medioevo: l’area euroasiatica e l’a-rea mediterranea, XL Settimana di Studio del Centro Italiano di studi sul-l’Alto Medioevo, (Spoleto 23-29 aprile 1992), Spoleto 1993, pp. 285-321.
H. BRESC, Les Normands, constructeurs de chateaux, in P. BOUET -P. NEVEAUX (a cura di), Les Normands en Méditerranée dans le silla-ge des Tancrède, Caen 1994, pp. 63-75.
J. M. PESEZ (a cura di), Brucato. Histoire et archéologie d’un habitatmédiéval en Sicile, I, (Collection de l’École Française de Rome, 78),Rome 1984.
V. BRUNAZZI, La Catterdale di Cefalù tra programma, progetto e rea-lizzazione. Sulle problematiche di un progetto nel Medioevo, in AA.VV.,La basilica cattedrale di Cefalù. Materiali per la conoscenza storica ed ilrestauro.1, Palermo 1989, pp. 341-387.
B. BRUNO, L’arcipelago maltese in età romana e bizantina, Bari 2004.
Z. BRUSIC, Byzantine Amphorae (9th to 12th century) from Eastern Adria-tic Underwater Sites, in Archaeologia Jugoslavica XVII, 1976, pp. 37-49.
F. BURGARELLA, Le Terre bizantine, (Calabria, Basilicata e Puglia),in AA.VV., Storia del Mezzogiorno, II.2, Napoli 1989, pp. 415-517.
J. BYLINSKI, Marks and Signatures of artisans on Medieval Islamic Pot-tery from Kom el Dikka in Alexandria, in Société Archéologique d’A-lexandrie, 45, 1993, pp. 55- 68. Cacciaguerra G. (2009)
P. CADENAT, Recherches à Tihert - Tagdempt (1958-1959), in Bulletin d’Archeologie Algerienne, VII, I, 1977-1979, pp. 393-461.
G. CACCIAGUERRA, La ceramica a vetrina pesante altomedievalein Sicilia: nuovi dati e prospettive di ricerca, in Archeologia Medievale,36, pp. 285-300.
R. CAMERATA SCOVAZZO, I mosaici pavimentali di Carini. Tra-dizione pittorica ellenistico - romana su alcuni tessellati siciliani del IVsecolo, in Archeologia Classica XXIX, 1, 1977, pp. 134-159.
J. CANGOVA, Amphores du Moyen Age en Bulgarie, in “Bulletin del’Institut Archéologique”, Sofia Académie des Sciences de Bulgarie, XXII,1959, pp. 243-262.
G. CARACAUSI, Arabismi medievali di Sicilia, (Centro di Studi Filo-logici e Linguistici Siciliani. Supplementi al Bollettino, 5), Palermo 1983.
12
CARIGNANI - PACETTI 1989
Carini 1997-98
CARONIA 1982
Carthage I,2
CASTELLANA 1992
Castellana di Pianella 1994
CAYOL 1973
CECI 1992
CIABATTI 1978
CIPRIANO et alii
CIRELLI 2002
COLLURA 1962
COLUMBA 1906
CORRETTI 1995
A. CARIGNANI - F. PACETTI, Le importazioni di anfore bizantinea Roma fra IV e V secolo: le evidenze di alcuni contesti urbani, in Recher-ches, pp. 5-16.
C. GRECO – I. GAROFANO – F. ARDIZZONE, Nuove indaginiarcheologiche nel territorio di Carini, in Kokalos 43-44, II.2, pp. 668-677.
G. CARONIA, La Zisa di Palermo. Storia e restauro, Bari 1982.
M. G. FULFORD - D. P. S. PEACOCK a cura di, Excavations at Cartha-ge: the British Mission, I,2, The Avenue du President Habib Bourguiba, Sa-lambo. The Pottery and other Ceramic Objects from the Site, Sheffield 1984.
G. CASTELLANA, Il casale di Caliata presso Montevago, in Montevago,Agrigento 1992, pp. 35-49.
D. PETRONE - E. SIENA - D. TROIANO - V. VERROCCHIO,Una fornace bizantina a Castellana di Pianella (PE), in “Archeologia Me-dievale” XXI, 1994, pp. 269-286.
J. C. CAYOL, Note sur une amphore découverte à Cassis, in Cahiersd’Archeologie Subaquatique, II, 1973, pp. 181-182.
M. CECI, Note sulla circolazione delle lucerne a Roma nell’VIII secolo: i con-testi della Crypta Balbi, in “Archeologia Medievale” XIX, 1992, pp. 749-764.
E. CIABATTI, Relitto dell’età del bronzo rinvenuto nell’isola di Lipa-ri: Relazione sulla prima e seconda campagna di scavi, in “Sicilia Archeo-logica” 36, XI, 1978, pp. 7-35.
M. T. CIPRIANO - L. PAROLI - H. PATTERSON - L.SAGUÍ - D.WHITEHOUSE, La documentazione ceramica dell’Italia centro - me-ridionale nell’alto medioevo: quadri regionali e contesti campione, in Aceramica medieval no Mediterraneo ocidental, (Lisboa, 16-22 novembre1987), Mertola 1991, pp. 99-122.
E. CIRELLI, La circolazione di giare gerbine nel Mediterraneo occiden-tale: continuità e discontinuità nel commercio di derrate alimentari afri-cane in età tardoromana e islamica, in L’Africa Romana XIV (Sassari2000), Roma 2002, pp. 437-450
P. COLLURA, Le più antiche carte dell’archivio capitolare di Agrigento(1092-1282), Palermo 1962.
G. M. COLUMBA, I porti della Sicilia, Roma 1906.
A. CORRETTI, Entella, in Federico e la Sicilia, 1995, pp. 93-109.
13
Couleurs de Tunisie
CRACCO RUGGINI 1980
CRINÒ 1906
CUSA 1868-1882
D’ALESSANDRO 1978-79
D’ALESSANDRO 1994
D’ANGELA 1988
D’ANGELO 1972
D’ANGELO 1976
D’ANGELO 1982
D’ANGELO 1984
D’ANGELO 1986
D’ANGELO 1989
D’ANGELO 1992
AA. VV., Couleurs de Tunisie. 25 siècles de céramique, (Paris Institut dumonde arabe 13 décembre 1994 – 26 mars 1995 - Toulouse Musée des Augustin 24 avril - 31 juillet 1995), Paris 1994.
L. CRACCO RUGGINI, La Sicilia fra Roma e Bisanzio, in Storia dellaSicilia Antica, vol. III, Napoli 1980, pp. 3-96.
S. CRINÒ, Portolani inediti in lingua volgare e spagnuola. Il portola-no di Alfonso Ventimiglia, in “Atti della Regia Accademia Peloritana”XXI, 1, pp. 3-72.
S. CUSA, I diplomi greci e arabi di Sicilia, 2 voll., Palermo 1868-1882.
V. D’ALESSANDRO, Per una storia delle campagne siciliane nell’altomedioevo, in ASSO 5, 1978-79, pp. 7-24.
V. D’ALESSANDRO, Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale,Palermo 1994.
C. D’ANGELA, La ceramica altomedievale, in C. D’ANGELA (a cu-ra di ), Gli scavi del 1953 nel Piano di Carpino (Foggia). Le terme e la ne-cropoli altomedievale della villa romana di Avicenna, Mediterraneo tar-doantico e medievale. Scavi e Ricerche. 5, Martina Franca (TA), 1988,pp. 121-128.
F. D’ANGELO, Influenze straniere nella ceramica medievale di Paler-mo (1290-1425), in Atti del IV Convegno Internazionale della Ceramica,(Albisola 28 maggio - 3 giugno 1971), Albisola 1972, pp. 395-406.
F. D’ANGELO, Ceramica d’uso domestico della Sicilia medievale pro-veniente dalla Zisa (Palermo XII secolo), in Atti del IX Congresso Inter-nazionale della Ceramica, (Albisola 28-31 maggio 1976), Albisola 1976,pp. 53-61.
F. D’ANGELO, Monete, in AA.VV., Materiali per la conoscenza stori-ca e il restauro di una Cattedrale. Mostra di documenti e testimonianze fi-gurative della Basilica ruggeriana di Cefalù, Palermo 1982, pp. 66-67.
F. D’ANGELO, Aspetti della vita materiale in epoca normanna in Si-cilia, Palermo 1984.
F. D’ANGELO, Scarti di produzione di ceramiche siciliane dell’XI se-colo, in La ceramica medievale nel Mediterraneo Occidentale, (Siena -Faenza 8-13 ottobre 1984), Firenze 1986, pp. 587-594.
F. D’ANGELO, Malta per tegole, in “Sicilia Archeologica”, 22, 69-70,1989, pp. 55-59.
F. D’ANGELO, Stato delle ricerche sulle ceramiche medievali (secoli XI-XIII), in Montevago, Agrigento 1992, pp. 154-155.
14
D’ANGELO 1997
D’ANGELO 2005
D’ANGELO -GAROFANO 1997
D’ANGELO - GIOIA 2007
DELOGU 1993
DELOGU 1994
DENARO 1997
DE ROSSI 2005
DE SIMONE 1978
DE SIMONE 1996
DI COSMO - PANARELLO 1998
DI GANGI -LEBOLE DI GANGI 1998 a
F. D’ANGELO, Deux noveaux fours médiévaux à Agrigente, in Le vert& le brun. De Kairouan à Avignon, ceramiques du Xe au XVe siècle,Marsiglia 1997, p. 33.
F. D’ANGELO, Lo scarico di fornaci di ceramiche della fine dell’XI se-colo – inizi del XII nel Palazzo Lungarini di Palermo, in ArcheologiaMedievale, 32, pp. 389-400.
F. D’ANGELO - I. GAROFANO, Lo scavo ed i reperti, in C.A. DISTEFANO - F. TOMASELLI - F.- D’ANGELO - I. GAROFANO,Palermo. Ricerche archeologiche nel convento della SS. Trinità (Magio-ne), in “Archeologia Medievale”, XXIV, 1997, pp. 296-310.
F. D’ANGELO - GIOIA C. (2007) Analisi minero – petrografiche suireperti dello scarico di fornaci di Palazzo Lungarini a Palermo (fine XI-inizio XII secolo), in Archeologia Medeivale, 34, pp. 337-343.
P. DELOGU, La storia economica di Roma nell’alto medioevo. Introduzio-ne al seminario, in La storia economica di Roma, Firenze 1993, pp. 11-29.
P. DELOGU, La fine del mondo antico e l’inizio del medioevo: nuovidati per un vecchio problema, in La Storia dell’Alto Medioevo Italiano,Firenze 1994, pp. 7-24.
M. DENARO, La montagnola di Marineo. La ceramica medievale, inArcheologia e Territorio, Palermo 1997, pp. 209-219.
G. DE ROSSI, Indicatori archeologici della produzione e diffusione delvino della Baia di Napoli in età altomedievale, in G. VOLPE – M. TUR-CHIANO (a cura di), Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridio-nale tra tardo antico e altomedioevo, Bari 2005, pp. 541-549.
A. DE SIMONE, Palermo nei geografi e viaggiatori arabi del medioe-vo, in Studi Magrebini, II, 1978, pp. 129-189.
A. DE SIMONE, Splendori e misteri di Sicilia in un’opera di Ibn Qalaqis, Messina 1996.
L. DI COSMO - A. PANARELLO, Le ceramiche medievali di Capuaconservate nel Museo Provinciale campano, Marina di Minturno (LT) 1998.
G. DI GANGI - C.M. LEBOLE DI GANGI, Dal Tardoantico al Bas-somedioevo: inquadramento storico, dati di scavo e materiali del sito ur-bano di Tropea, in S. PATITUCCI UGGERI (a cura di), Scavi medie-vali in Italia 1994-1995, Atti della prima conferenza italiana di Archeo-logia medievale, Cassino, 14-16 dicembre 1995, Q.A.M. Suppl. 1, Roma- Freiburg - Wien 1998, pp. 93-122.
15
DI GANGI -LEBOLE DI GANGI 1998 b
DI GIOVANNI 1889-1890
DI LIBERTO 1996
DI STEFANO - KRÖNIG 1979
DI STEFANO 1988
DI STEFANO 1989
DI STEFANO 1994
DJELLID 2011
FACCENNA 1993
FACCENNA 2006
FALCANDO
Federico e la Sicilia
FERRONI -MEUCCI 1995-1996
G. DI GANGI - C.M. LEBOLE DI GANGI, Anfore Keay LII ed al-tri materiali ceramici da contesti di scavo della Calabria centro-meridio-nale (V-VIII secolo), in L. SAGUÌ (a cura di) Ceramica in Italia: VI-VIIsecolo, Atti del Convegno in onore di John W. Hayes Roma, 11-13 mag-gio 1995, I, Firenze 1998, pp. 761-768.
V. DI GIOVANNI, La topografia antica di Palermo dal secolo X al XVsecolo, Voll. 2, Palermo 1889-1890.
R. DI LIBERTO, La chiesa normanna di S. Cataldo a Palermo, in Pal-ladio, IX, 17, 1996, pp. 17-32.
G. DI STEFANO - W. KRÖNIG, Monumenti della Sicilia normanna,Palermo 1979.
C. A. DI STEFANO, Il relitto arabo-normanno di Marsala. Comini-cazione di aggiornamento, in G. D’ANGELO (a cura di), Dalla batta-glia delle Egadi per un’archeologia del Mediterraneo, Atti del II Conve-gno Internazionale di Archeologia Subacquea del Mediterraneo, Favigna-na 28-5-1985, Trapani 1988, pp. 36-39.
G. DI STEFANO, Antichi relitti nella Baia di Camarina, in Atti del-la IV Rassegna di Archeologia Subacquea, IV premio Franco Papò, Giar-dini Naxos 13-15 ottobre 1989, 1989, pp. 127-134.
C. A. DI STEFANO, Il chiostro di S. Domenico a Palermo e le nuo-ve ricerche archeologiche nell’area del trans-Papireto, in ASS, XX,1994, pp. 95-114.
A. DJELLID, La céramique islamique du haut moyen âge en Algérie (IXe-Xe siècles) les problemes de son étude, in P. CRESSIER – E. FENTRESS(a cura di), La céramique maghrébine du haut moyen âge (VIIIe – Xe sié-cle). État des recherches, problèmes et perspectives, Rome 2011, pp. 147-158.
F. FACCENNA, Un relitto del XII secolo a San Vito Lo Capo (Trapani),in Archeologia Subacquea I, Roma 1993, pp. 185-187.
F. FACCENNA, Il relitto di San Vito Lo Capo, Bari 2006.
U. FALCANDO, Historia o Liber de Regno Sicilie, Epistula ad PetrumPanormitane Ecclesia Thesaurarium, a cura di G.B. Siragusa, in Fontiper la Storia dell’Italia dell’Istituto storico italiano, Roma 1897.
C.A. DI STEFANO - A. CADEI (a cura di), Federico e la Sicilia dallaterra alla corona. Archeologia ed architettura, Palermo 1995.
A. M. FERRONI - C. MEUCCI , I due relitti arabo-normanni di Mar-sala, Bollettino di Archeologia Subacquea, 2-3, pp. 283-350.
16
FERRUZZAALEO NERO 1997
FIORILLA 1990
FIORILLA 1991
FIORILLA 1995 a
FIORILLA 1995 b
FOUILLARD - FRASCA PELAGATTI 1994-1995
GABRIELI 1985
GARCEA 1987
GARUFI 1899
GARZYA 1994
GAUTHIER DALCHÉ 1995
GAYRAUD 1997
M. L. FERRUZZA - C. ALEO NERO, La collezione archeologica delmarchese Antonio De Gregorio, in Archeologia e Territorio, Palermo1997, pp. 417-479.
S. FIORILLA, Schede, in S. SCUTO, Fornaci, Castelli & Pozzi dell’etàdi mezzo. Primi contributi di archeologia medievale nella Sicilia centro-meridionale, Catalogo della Mostra (Museo di Gela 9 giugno-31 dicem-bre 1990), Agrigento 1990.
S. FIORILLA, Considerazione sulle ceramiche medievali della Siciliacentro-meridionale, in L’età di Federico II , pp. 115-169.
S. FIORILLA, Ceramiche medievali della Sicilia centromeridionale, inRabat, 1995, pp. 205-215.
S. FIORILLA, Piazza Armerina (Enna): villa romaine del Casale, in Levert & le brun de Kairouan à Avignon, céramiques du Xe au XVe siècle,Marseille 1995, pp. 33-34.
F. FOUILLARD - M. FRASCA - P. PELAGATTI, Monte Casasia(Ragusa). Campagne di scavo 1966, 1972-73 nella necropoli indigena, in“Notizie degli Scavi” V-VI, 1994-1995, pp. 323-583.
F. GABRIELI, La Sicilia arabo - normanna in Ibn Giubair (versione diC. Schiaparelli), in F. GABRIELI - U. SCERRATO Gli Arabi in Ita-lia, Milano 1985, pp.738-747.
F. GARCEA, Appunti sulla produzione e circolazione delle lucerne nelnapoletano tra VII ed VIII secolo, in “Archeologia Medievale” XIV, 1987,pp. 537-544.
C. A. GARUFI, I documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia, Palermo 1899.
A. GARZYA, L’eau dans la littérature médicale de l’Antiquité tardive,in L’eau, la santé et la maladie dans le monde grec, (Actes du Colloque du25 -27 Novembre 1992, Paris), Paris 1994, pp. 109-119.
P. GAUTHIER DALCHÉ, Carte marine et portulan au XIIe siècle. Le“Liber de existencia riveriarum et forma maris nostri Mediterranei” [Lon-dra, British Library, ms Cotton Domitianus, A. XIII.), Coll. d’Écolefrançaise de Rome, n. 203, Rome 1995.
R.P. GAYRAUD, Les céramiques égyptiennes à glaçure, IXe-XIIe siè-cles, in La céramique médiévale en Méditerranée, Actes du VIe congrèsde l’AIECM2 (Aix en Provence 13-18 novembre 1995), Aix en Proven-ce 1997, pp. 261-270.
17
GELICHI – NEGRELLI 2009
GENTILI 1950
GIBBINS-PARKER 1986
GIL 1995
GIUSTOLISI 1971
GIUSTOLISI 1973
GOITEIN 1967
GOITEIN 1971 a
GOITEIN 1971b
GOITEIN 1983
GOLVIN 1980
GÓMEZ MARTINEZ s.d.
S. GELICHI – C. NEGRELLI, Ceramica e circolazione delle merci nel-l’Adriatico tra VII e X secolo, in J. ZOZAYA – M.RETUERCE – M.A.HERVAS – A. DE JUAN (a cura di), Actas del VIII Congreso Interna-cional de Ceramica Medieval. (Ciudad Real 27/2 – 3/3 2006), I, Madrid2009, pp. 49-61.
G. V. GENTILI, Piazza Armerina - Grandiosa villa romana in contrada“Casale”, in Notizie degli Scavi 1950, pp. 291-335.
D.J.L. GIBBINS - A.J. PARKER, The Roman wreck of c. AD 200 atPlemmirio, near Siracusa (Sicily): Interim Report, in IJNA 15.4, 1986,pp. 267-304.
M. GIL, Sicily 827-1072, in light of the Geniza documents and parallelsources, in Italia Judaica. Gli Ebrei in Sicilia sino all’espulsione del 1492,Atti del V convegno internazionale (Palermo, 15-19 giugno 1992), 1995,pp. 96-171.
V. GIUSTOLISI, Alla ricerca dell’antica Hykkara, in “Kokalos” XVI,1971, pp. 105-123.
V. GIUSTOLISI, Hykkara. Sicilia che scompare, 2, Palermo 1973.
S. D. GOITEIN, A Mediterranean Society. The Jewish Communities ofthe Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, vol.I. Economic Foundations, Berkeley - Los Angeles - London 1967.
S. D. GOITEIN, A Mediterranean Society. The Jewish Communities of theArab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, vol. II,The Community, Berkeley - Los Angeles - London 1971.
S. D. GOITEIN, Sicily and Southern Italy in the Cairo Geniza documents,in ASSO LXVII, 1971, pp. 9-33.
S. D. GOITEIN, A Mediterranean Society. The Jewish communities ofthe arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, vol.IV, Daily Life, Berkeley - Los Angeles- London, 1983.
L. GOLVIN, Les céramiques émaillées de période hammâdide Qal’a desBanû Hammâd (Algerie), in La céramique médiévale en Méditerranée oc-cidentale X - XV siècles, Actes des Colloques Internationaux du CentreNational de la recherche scientifique, n. 584, (Valbonne 11-14 septembre1978), Paris 1980, pp. 203-217.
S. GÓMEZ MARTÍNEZ, A cerâmica no Gharb al-Ândalus, in AA. VV.Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo, Lisboa s.d., pp. 121-131.
18
GRAGUEB – TRÉGLIACAPELLI – WAKSMAN 2011
GRECO–MAMMINA–DI SALVO 1993
GREGORIO 1873
GUILLOU 1977
GUILLOU 1978
GUILLOU 1980
GÜNSENIN 1989
HAYES 1980
HAYES 1992
HODGES-PATTERSON 1984
HUILLAERD BREHOLLES1852-1861
IDRIS 1961
S. GRAGUEB – J. C. TRÉGLIA – C. CAPELLI – Y. WAKSMAN,Jarres et amphores de Sabra al Mansuriya (Kairouan, Tunisie), in P. Cres-sier – E. Fentress (eds.), La céramique maghrébine du haut moyen âge(VIIIe-Xe siècle). Ètat des recherches, problèmmes et perspective,Rome 2011, pp. 197-220.
C. GRECO – G. MAMMINA – S. DI SALVO, Necropoli tardoroma-na in contrada S. Agata (Piana degli albanesi), in Di Terra in Terra. Nuo-ve scoperte archeologiche nella provincia di Palermo, Palermo 1993, pp.160-184.
R. GREGORIO, Considerazioni sopra la storia dai tempi normanni si-no ai presenti, VI, II ed. Palermo 1873 (I ed. 1806-1816), ris. anast. Palermo 1977.
A. GUILLOU, La Sicile byzantine etat de recherches, in “ByzantinischeForschungen”, 5, 1977, pp. 95-145.
A. GUILLOU, Città e campagna nell’Italia meridionale bizantina (VI-XI secolo). Dalle collettività rurali alla collettività urbana, in Habitat -Strutture – Territorio, in Atti del III Convegno Internazionale di Studiosulla Civiltà rupestre medioevale nel mezzogiorno d’Italia, (Taranto Grot-taglie, 24-27 settembre 1975), Galatina 1978, pp. 27-40.
A. GUILLOU, L’Italia bizantina dall’invasione longobarda alla cadu-ta di Roma, in P. DELOGU - A. GIULLOU - G. ORTALLI, Longo-bardi e bizantini, in Storia d’Italia, I, Torino 1980, pp. 219-338.
N. GÜNSENIN, Recherches sur les amphores byzantines dans les Mu-sées turcs, in Recherches sur la céramique byzantine, actes du Colloque(Athénes 8-10 avril 1987), in BCH Supplément XVIII, Athénes 1989,pp. 267-276.
J.W. HAYES, Problèmes de la céramique des VIIème - IX ème siècles aSalamine et a Chypre, in Salamine de Chypre. Histoire et archéologie,État des recherches, (Lyon 13-17 mars 1978), Paris 1980, pp. 375-380.
J.W. HAYES, Excavations at Saraçhane in Istanbul, II. The Pottery,Princeton 1992, pp. 61-79.
R. HODGES - H. PATTERSON, San Vincenzo al Volturno and theOrigins of the Medieval Pottery Industry in Italy, in La ceramica nel Me-diterraneo Occidentale (Siena - Faenza 1984), pp. 13-26.
J. L. A. HUILLAERD BREHOLLES, Historia diplomatica Fridericisecundi, Paris 1852 - 1861.
H. R. IDRIS, Commerce maritime et Kirad en Bérberie orientale d’aprèsun recueil inédit de Fatwas médiévales, in Journal of Economic andSocial History of the Orient, IV, 1961, pp. 225-239.
-. .
19
ISLER 1984
ISLER 1990
ISLER 1995
JAKOBSON 1951
JOHNS 1978
JOHNS 1985
JOHNS 1987
KENNET - SJOSTROMVALENTE 1989
LA MANTIA 1905
LASSUS 1956
La storia economica di Roma
LEBOLE DI GANGI 1991
LEBOLE DI GANGI 1994
LEFORT - MARTIN 1992
LESNES 1993
H. P. ISLER, La ceramica proveniente dall’insediamento medievale:cenni e osservazioni preliminari, in Studia Ietina II, Zurich 1984, pp.117-161.
H. P. ISLER, Monte Iato: la ventesima campagna di scavo, in “SiciliaArcheologica” XXIII, 74, 1990, pp. 7-27.
H. P. ISLER, Monte Iato, in Federico e la Sicilia, 1995, pp. 121-150.
A.L. JAKOBSON, Srednevekovye Amphory Severnogo prichernomorya,in Sovetsakaj Arkeologij, XV, 1951, pp. 325-344.
J. JONHS, Nota sugli insediamenti rupestri musulmani nel territoriodi Santa Maria di Monreale nel dodicesimo secolo, in Sicilia Rupestre,Galatina 1978, pp. 227-235.
J. JOHNS, The Monreale survey: Indigenes and Invaders in MedievalWest Sicily, in C. MALON - S. STODDART (a cura di) Papers in Ita-lian Archaeology IV, the Cambridge Conference Part IV Clas “Sicilia Ar-cheologica” l and Medieval Archaeology, BAR Int. Series 246, Oxford1985, pp. 215-301.
J. JONHS, Malik Ifriqiya: The Norman Kingdom of Africa and theFatimids, in “Lybian Studies” 18, 1987, pp. 89-101.
D. KENNET - I. SJOSTROM - I. VALENTE, Uno scavo urbano a VicoInfermeria, Marsala, in “Archeologia Medievale”, XVI, 1989, pp. 613-636.
F. LA MANTIA, Capitoli inediti della città di Sciacca del XV secolo,Sciacca 1905.
J. LASSUS, Fouilles à Mila. Campagne préliminaire (Juin-Juillet 1957),in Libyca Arch. Epigr. IV, 1956, pp. 216-231.
L. PAROLI - P. DELOGU (a cura di), La storia economica di Romanell’alto medioevo alla luce dei recenti scavi archeologici. Atti del semi-nario, Roma 2-3 aprile 1992, Firenze 1993.
M.C. LEBOLE DI GANGI, Saggi nell’abitato altomedievale di Palea-poli, in MEFRM 103.2, 1991, pp. 575-598
M. C. LEBOLE DI GANGI, Anforacei a bande rosse (broad e narrowline), in AA. VV., Scavi medievali in Calabria: Tropea 1, rapporto pre-liminare, in “Archeologia Medievale” XXI, 1994, pp. 351-374.
J. LEFORT - J. M. MARTIN, L’organisation de l’espace rural: Macédoineet Italie du Sud (Xe – XIIIe siècle), in Homme et richesses dans l’Empirebyzantin. VIIIe - XVe siècle, 2, Paris 1992, pp. 11-26.
E. LESNES, La céramique médiévale du cloître de San Domenico àPalerme, in MEFRM, 105, 1993,2, pp. 549-603
20
LESNES 1994
LESNES 1997
LESNES 1998
L’età di Federico II
LEWICKI 1978
LEWIS 1951
LEWIS 1978
LIOU 1987
LOVECCHIO 1989
LUGLI 1957
MAETZKE 1984
MAMMINA 1998
MANACORDA 1987
E. LESNES, L’indagine archeologica, in F. MAURICI - E. LESNES,Il Castello di Terra di Trapani: note storiche ed archeologiche, in “Ar-cheologia Medievale” XXI, 1994, pp. 386-400.
E. LESNES, La recente ricerca archeologica nel Museo, in Quaderni delMuseo Archeologico Regionale “Antonio Salinas”, 3, 1997, pp. 17-69.
E. LESNES, La ceramica medievale rinvenuta durante lo scavo dellacorsia est del Chiostro di San Domenico a Palermo, in S. GELICHI (a cura di), Ceramiche, città e commerci nell’Italia tardo-medievale, Atti del Convegno Ravello 3-4/5/1993, Mantova 1998, pp. 109-125.
S. SCUTO (a cura di), L’età di Federico II nella Sicilia Centro – Meri-dionale città, Monumenti, Reperti. Atti delle Giornate di Studio (Gela 8-9 dicembre 1990), Agrigento 1991.
T. LEWICKI, Les voies maritimes de la Méditerranée dans le haut MoyenAge d’après les sources arabes, in La navigazione mediterranea nell’altomedioevo, XXV Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Al-to Medioevo, (Spoleto 14-20 aprile 1977), II, Spoleto 1978, pp. 439-469.
A. LEWIS, Naval Power and Trade in the Mediterranean A.D. 500-1100,Princeton Un. Press, 1951.
A. LEWIS, Mediterranea Maritime Commerce: A.D. 300-1100 Shippingand Trade, in La navigazione mediterranea nell’alto medioevo, XXVSettimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 14-20 aprile 1977), Spoleto 1978, pp. 481-501.
B. LIOU, Inscriptions peintes sur amphores: Fos (suite). Marseille, Tou-lon, Port-la-Nautique, Arles, Sant-Blaise, Saint-Martin-de-Crau, Macon,Calvi, in Archeonautica 7, 1987, pp. 55-139.
M.M. LOVECCHIO, Commercio e ceramica bizantina in Italia, in V.DEROCHE - J.M. SPIESER (a cura di) Recherches sur la ceramiquebyzantine, Paris 1989, pp. 95-107.
G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 1957.
G. MAETZKE, Quadrato EEE19, in Caputaquis Medievale, II, Ricer-che 1974-1980, Pubblicazioni dell’Università degli Studi di Salerno,Sezione di Studi di Filologia, Letteratura, Storia e Archeologia delMondo classico, 1, Napoli 1984, pp.144-145.
G. MAMMINA, Appendice Numismatica, in Marettimo, p. 418.
D. MANACORDA, Il vino dell’Etruria Romana, in El vi a l’antigui-tat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental, Actes I Col-loqui d’Arqueologia Romana (Monografies Badalonines, 9), Badalona1987, pp. 43-48.
21
MARAZZI 1991
MARAZZI 1993
Marettimo
MAURICI 1995
MAURICI 1998
MC CONNEL 1991
Mc CORMICK 2008
MEGAW 1972
MENCHELLI 1993
MESSINA 1979
MILANESE 1996
MILELLA 1989
MILLER 1916
F. MARAZZI, Il conflitto tra Leone III Isaurico e il papato fra il 725 eil 733, e il “definitivo” inizio del medioevo a Roma: un’ipotesi in discus-sione, in PBSR LIX, 1991, pp. 231-257.
F. MARAZZI, Roma, il Lazio, il Mediterraneo: relazioni fra economiae politica dal VII al IX secolo, in La storia economica di Roma, Firenze1993, pp. 267-285.
F. ARDIZZONE - R. DI LIBERTO - E. PEZZINI - G. MAMMINA,Il complesso monumentale in contrada “Case Romane” a Marettimo (Tra-pani). La fase medievale: note preliminari, in S. PATITUCCI UGGE-RI (a cura di), Scavi medievali in Italia 1994-1995, Atti della prima con-ferenza italiana di Archeologia medievale, Cassino, 14-16 dicembre 1995,Q.A.M. Suppl. 1, Roma - Freiburg - Wien 1998, pp. 387-424.
F. MAURICI, L’Insediamento medievale in Sicilia: problemi e prospet-tive di ricerca, in “Archeologia Medievale” XXII, 1995, pp. 487-500.
F. MAURICI, L’insediamento medievale nel territorio della provinciadi Palermo. Inventario preliminare degli abitati attestati dalle fonti d’ar-chivio (secoli XI-XVI), Agrigento 1998.
B. E. MC CONNELL, L’insediamento medievale alla Muculufa (Bute-ra, CL), in S. SCUTO (a cura di), L’età di Federico II nella Sicilia Cen-tro - Meridionale città, Monumenti, Reperti, Atti delle giornate di studio(Gela 8-9 dicembre 1990), Agrigento 1991, pp. 229-233.
M. Mc CORMICK, Le origini dell’economia europea. Comunicazionie commercio 300-900 d.C., Milano 2008.
MEGAW, Supplementary Excavations on a Castell site at Paphos, Cy-prus, in DOP 26, 1970-71 (1972), pp. 322-343.
S. MENCHELLI, Vasellame privo di rivestimento per usi vari. Formechiuse (MAC), in S. BRUNI (a cura di), Pisa. Piazza Dante, uno spaccatodella storia pisana. La campagna di scavo 1991, Pisa 1993, pp. 573-524.
A. MESSINA, Le chiese rupestri del siracusano, Palermo 1979.
M. MILANESE, Contenitori da trasporto, in AA. VV., Il villaggio me-dievale di Geridu (Sorso, SS). Campagne di scavo 1995/1996: relazionepreliminare, in “Archeologia Medievale”, XXIII, 1996, pp. 518-519.
M. MILELLA, Ceramica e vie di comunicazione nell’Italia bizantina,in MEFRM 101.2, 1989, pp. 533-557.
MILLER, Itineraria romana, Stuttgart 1916.
22
Montevago
MOLINARI 1994 a
MOLINARI 1994 b
MOLINARI 1995 a
MOLINARI 1995 b
MOLINARI 1997 a
MOLINARI 1997 b
MOLINARI VALENTE 1995
MURIALDO 1988
MURIALDO 1995a
MURIALDO 1995b
MURIALDO 2001
ORTON - TYERSVINCE 1993
G. CASTELLANA (a cura di) Atti del Convegno Nazionale, Dagli sca-vi di Montevago e di Rocca d’Entella un contributo di conoscenze per laStoria dei Musulmani della Valle del Belice dal X al XIII secolo (Montevago, 27-28 ottobre 1990), Agrigento 1992.
A. MOLINARI, Il popolamento rurale in Sicilia tra V e XIII secolo: al-cuni spunti di riflessione, in La Storia dell’Alto Medioevo Italiano, Firenze 1994, pp. 361-377.
A. MOLINARI, La produzione ed il commercio in Sicilia tra X ed ilXIII secolo: il contributo delle fonti archeologiche, in “Archeologia Me-dievale” XXI, 1994, pp. 99-119.
A. MOLINARI, Le campagne siciliane tra il periodo bizantino e quel-lo arabo, in Acculturazione e mutamenti. Prospettive nell’archeologiamedievale del Mediterraneo, VI ciclo di lezioni sulla ricerca applicata al-l’archeologia, Certosa di Pontignano (SI), Museo di Montelupo 1-5 mar-zo 1993, Firenze 1995, pp. 223-239.
A. MOLINARI, La produzione e la circolazione delle ceramiche sicilia-ne nei secoli X-XIII, in Rabat, pp. 191-204.
A. MOLINARI, Momenti di cambiamento nelle produzioni ceramichesiciliane, in G. DÉMIANS D’ARCHIMBAUD (a cura di ), La cérami-que médiévale en Méditerranée, Actes du VIe congrès de l’AIECM2 (Aixen Provence 13-18 novembre 1995), Aix en Provence 1997, pp. 375-382.
A. MOLINARI, Segesta II. Il castello e la moschea (scavi 1989-1995), Pa-lermo 1997.
A. MOLINARI - I. VALENTE, La ceramica medievale provenientedall’area di Casale Nuovo (Mazara del Vallo) (seconda metà X/XI secolo),in Rabat, 1995, pp. 416-420.
G. MURIALDO, Contenitori da trasporto, in AA.VV., Il “Castrum”tardo-antico di S.Antonino di Perti, Finale Ligure (Savona): fasi strati-grafiche e reperti dell’area D. Seconde notizie preliminari sulle campagnedi scavo 1982-1987, in “Archeologia Medievale”, XV, 1988, pp. 352-371.
G. MURIALDO, Alcune considerazioni sulle anfore africane di VII se-colo dal “Castrum” di S. Antonino nel Finale, in “Archeologia Medieva-le”, XXII, 1995, pp. 433-453.
G. MURIALDO, Anfore tardoantiche nel Finale (VI-VII secolo), in “Ri-vista di Studi Liguri”, LIX-LX, 1993-1994, (1995), pp. 213-246.
G. MURIALDO, Anfore tardoantiche nel Finale (VI-VII secolo), in “Ri-vista di Studi Liguri”, LIX-LX, 1993-1994, (1995), pp. 213-246.
C. ORTON - P. TYERS - A. VINCE, Pottery in Archaeology, Cambridge 1993.
23
Otranto
PACE 1949
PACETTI 1986
PALERMO 1816
PANELLA 1989
PANELLA 1993
PANVINI 1990
PARKER 1976-77
PAROLI 1992a
PAROLI 1992b
PAROLI 1993
PAROLI 1996
PATITUCCI UGGERI 1977
AA.VV., Excavations at Otranto, II. The Finds, Galatina (LE) 1992.
B. PACE, Arte e civiltà della Sicilia antica, IV, Città di Castello 1949.
F. PACETTI, La distribuzione delle anfore orientali fra IV e VII secolod.C., in Società romana ed impero tardoantico. Le merci, gli insediamen-ti, 3, Roma 1986, pp. 278-284.
G. PALERMO, Guida istruttiva per potersi conoscere con facilità tan-to dal siciliano che dal forestiere tutte le magnificenze e gli oggetti degnidi osservazione della città di Palermo, I, Palermo 1816.
C. PANELLA, Gli scambi nel Mediterraneo occidentale dal IV al VIIsecolo dal punto di vista di alcune merci, in Hommes et richesses dansl’empire byzantin. IVe-VIIe siècle, 1, Paris 1989, pp. 129-141.
C. PANELLA, Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico, in A. CA-RANDINI - L. CRACCO RUGGINI - A. GIARDINA (a cura di),Storia di Roma, III.2, I luoghi e le culture, Torino 1993, pp. 613-697.
R. PANVINI, Presenze archeologiche di età arabo - normanna e sveva nelterritorio di Caltabellotta, in Montevago, Agrigento 1992, pp. 163-178.
A.J. PARKER, Sicilia e Malta nel commercio marittimo dell’antichità,in “Kokalos” XXII-XXIII, 2.1, 1976-77, pp. 622-631.
L. PAROLI, La ceramica invetriata tardoantica ed altomedievale nel-l’Italia centro-meridionale, in La ceramica invetriata tardoantica ed al-tomedievale in Italia, (Atti della Certosa di Pontignano (Siena), 23-24febbraio 1990), Firenze 1992, pp. 33-61.
L. PAROLI, Ceramiche invetriate da un contesto della Crypta Balbi -Roma, in La ceramica invetriata tardoantica e altomedievale in Italia,(Atti della Certosa di Pontignano (Siena), 23-24 febbraio 1990), Firenze1992, pp. 351-377.
L. PAROLI, Porto (Fiumicino). Area II-2000, in AA.VV., Produzionee circolazione di ceramiche tardoantiche ed altomedievali ad Ostia e Por-to, in La storia economica di Roma, pp. 231-243.
L. PAROLI, Aspetti archeologici degli scambi commerciali nel Mar Tir-reno tra VIII e IX secolo, in C. CITTER - L. PAROLI - C. PELLE-CUER - J.M. PÉNE, Commerci nel Mediterraneo occidentale nell’altomedioevo, in G.P. BROGIOLO (a cura di), Early Medieval Towns inthe Western Mediterranean (Ravello 22-24 settembre 1994), Mantova1996, pp. 121-125.
S. PATITUCCI UGGERI, La ceramica medievale pugliese alla luce degliscavi di Mesagne, Mesagne 1977.
24
PATRICOLO 1877
PATRICOLO 1883
PATTERSON 1993
PATTERSON 1995
PATTERSONWHITEHOUSE 1992
PEDUTO 1986
PEDUTO 1994
PELLECUER – PÉNE 1996
PERI 1962
PERI 1990
PESEZ 1995
PEZZINI 1998
PICCOLPASSO
G. PATRICOLO, La chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio in Paler-mo e le sue antiche adiacenze, in “Archivio Storico Siciliano”, N.S. II,1877, p. 21.
G. PATRICOLO, Il monumento arabo scoverto in febbraio 1882 e lacontigua chiesa di S. Giovanni degli Eremiti in Palermo, in “ArchivioStorico Siciliano” VIII, 1883, pp. 170-183.
H. PATTERSON, Pianabella (Ostia antica). La ceramica altomedievale,in AA. VV., Produzione e circolazione di ceramiche tardoantiche ed alto-medievali ad Ostia e Porto, in La storia economica di Roma, pp. 219-231.
H. PATTERSON, Analisi mineralogiche sulle ceramiche medievali dialcuni siti della Sicilia occidentale, in G. DÉMIANS D’ARCHIM-BAUD (a cura di ), La céramique médiévale en Méditerranée, Actes duVIe congrès de l’AIECM2 (Aix en Provence 13-18 novembre 1995), Aixen Provence 1997, pp. 218-223.
H. PATTERSON - D. WHITEHOUSE, The Medieval Domestic Pot-tery, in Otranto, Galatina (LE) 1992, pp. 89-195.
P. PEDUTO, Modalità e tipologia del quotidiano dallo studio della ce-ramica campana nell’alto Medioevo, in La ceramica medievale nel Me-diterraneo Occidentale, (Siena-Faenza 8-13 ottobre 1984), Firenze 1986,pp. 555-571.
P. PEDUTO, La ceramica, in I Normanni popolo d’Europa 1030-1200,(Roma, Palazzo Venezia 28 gennaio - 30 aprile 1994), Venezia 1994, pp.295-297.
C. PELLECUER – J.M. PÉNE, Les importations d’origine méditer-ranée en Languedoc aux VIIe et VIIIe siècles: l’exemple de San Peyre (LeBouquet-Gard/France), in C. CITTER - L. PAROLI - C. PELLECUER- J.M. PÉNE, Commerci nel Mediterraneo occidentale nell’alto medioe-vo, in G.P. BROGIOLO (a cura di) Early Medieval Towns in the We-stern Mediterranean (Ravello 22-24 settembre 1994), Mantova 1996, pp.126-132.
I. PERI, Per la storia della vita cittadina e del commercio nel Medio Evo:Girgenti porto del sale e del grano, in Studi in onore di Amintore Fanfa-ni, I Antichità e Alto Medioevo, Milano 1962, pp. 531-616.
I. PERI, Uomini città e campagne in Sicilia dall’XI al XIII secolo, Bari 1990.
J. M. PESEZ, Castello San Pietro, in Federico e la Sicilia, 1995, pp. 313-324.
E. PEZZINI, Un tratto della cinta muraria della città di Palermo. ME-FRM 110, 1998.2, pp. 719-771.
C. PICCOLPASSO, Li tre libri dell’arte del vasaio, a cura di G. Con-ti, Firenze 1976.
25
PIÉRART - THALMANN 1980
PIEROBON 1986
PRIGENT 2004
PRINGLE 1977
PUGLISI - SARDELLA 1998
PURPURA 1977
PURPURA 1985
PURPURA 1986
PURPURA 1989
PURPURA 1993
Rabat
RAGONA 1979
REBUFFAT 1965
Recherches
M. PIÉRART - J.P. THALMANN, Céramique romaine et médiévale(Fouilles de l’Agora), in BCH suppl. VI, Ètudes Argiennes, Athénes 1980,pp. 459-482.
PIEROBON 1986 R. PIEROBON, 2. The area of the kilns, in AA. VV.,The Italian Activity within the Jerash Project 1982-1983, in FAWAZIZAYADINE (a cura di), Jerash Archaelogical Project 1981-1983, I, Amman 1986, pp. 184-187.
V. PRIGENT, Les empereurs isauriens et la confiscation des patrimoi-nes pontificaux d’Italie du Sud, MEFRM, 116-2, 2004, p. 557-594.
D. PRINGLE, Ceramica medievale, in La ceramica dell’area Sud delConvento di San Silvestro a Genova, in “Archeologia Medievale” IV,1977, pp. 105-160.
M. PUGLISI - A. SARDELLA, Ceramica locale in Sicilia tra il VI e ilVII secolo d.C. Situazione attuale e prospettive future della ricerca, in L.SAGUÌ (a cura di), Ceramica in Italia. Atti del Convegno in onore diJohn W. Hayes (Roma, 11-13 maggio 1995), Firenze 1998, pp.777-785.
G. PURPURA, Nuove anfore nell’Antiquarium di Terrasini, in “Sici-lia Archeologica” 35, 1977, pp. 54-71.
G. PURPURA, Un relitto di età normanna a Marsala, in “Archeologiasubacquea” 2, Supplemento BdA 29, 1985, pp. 129-136.
G. PURPURA, Rinvenimenti sottomarini nella Sicilia occidentale, in “Ar-cheologia Subacquea” 3, Suppl. ai nn. 37-38 del BdA, 1986, pp. 139-160.
G. PURPURA, Nuovi rinvenimenti sottomarini nella Sicilia Occidentale(quadriennio 1986-89), in Atti della IV Rassegna di Archeologia Subacquea, IVpremio Franco Papò, Giardini Naxos 13-15 ottobre 1989, 1989, pp. 135-146.
G. PURPURA, Rinvenimenti sottomarini nella Sicilia occidentale (1986-1989), Archeologia subacquea, in Studi ricerche e documenti, I, Roma1993, pp. 163-171.
Actes du 5ème colloque sur la céramique médiévale en Méditerranéeoccidentale, (Rabat 11-17 novembre 1991), Rabat 1995.
A. RAGONA, La ceramica siculo - musulmana, in F. GABRIELI - U. SCERRATO, Gli Arabi in Italia, Milano 1979, pp. 599-609.
R. REBUFFAT, Le bâtiment à bossages et les premiers temps de l’occu-pation romaine, in Thamusida. Fouilles du service des antiquités du Maroc, vol. 1, Paris 1965, pp. 113-134.
Recherches sur la céramique byzantine. V. DÉROCHE - J.M. SPIESER(a cura di), Actes du Colloque (Athènes 8-10 avril 1987),in BCH SupplXVIII, Athènes 1989.
26
REYNOLDS 1995
RILEY 1979
RILEY 1982
RIZZITANO 1980
RIZZITANO 1994
RIZZO 1992
RIZZO 2004
RUGOLO 1984
RUSSO PEREZ 1954
SACHAU 1910
SAGUÌ 1991
SAGUÌ 1992
SAGUÌ 1998
P. REYNOLDS, Trade in the Western Mediterranean AD 400-700: Theceramic evidence, BAR International Series 604, Oxford 1995.
J.A. RILEY, The coarse pottery from Berenice, in Excavations at SidiKhrebish, Benghazi (Berenice). Supplements to Libya Antiqua, V, volu-me II, Tripoli 1979, pp. 91-467.
J.A. RILEY, New Light on Relations between the Eastern Mediterranean andCarthage in the Vandal and Byzantine Periods: the Evidences from the Uni-versity of Michigan Excavations, in CEDAC Dossier 1, 1982, pp. 111-122
U. RIZZITANO, La conquista musulmana, in Storia della Sicilia An-tica, vol. III, Napoli 1980, pp. 99-176.
Idrisi, Il libro di Ruggero, tradotto e annotato da U. RIZZITANO, Palermo, s.d. (1966), ed. Palermo 1994.
M. S. RIZZO, Distribuzione degli insediamenti di età arabo normannada Agrigento al Belice, in Montevago, Agrigento 1992, pp. 179-187.
M. S. RIZZO, L’Insediamento medievale nella Valle del Platani, Roma 2004.
C. M. RUGOLO, Maestri bottai in Sicilia nel secolo XV, in I mestieri.Organizzazione. Tecniche Linguaggi, Quaderni del Circolo SemiologicoSiciliano 17-18, Atti del II Congresso Internazionale di Studi Antropolo-gici Siciliani, (Palermo 26-29 marzo 1980), Palermo 1984, pp. 109-120.
G. RUSSO PEREZ, Catalogo ragionato della raccolta Russo - Perez dimaioliche siciliane di proprietà della Regione Siciliana, Palermo 1954.
E. SACHAU, Sicilien. Nach dem Tuerkischen Geographen Piri Reïs, inScritti per il centenario della nascita di Michele Amari, vol. II, Palermo1910 rist. an. Palermo 1990, pp. 1-10.
L. SAGUÌ, Ceramica acroma depurata, dipinta in rosso e invetriata, inAA.VV. La documentazione ceramica dell’Italia centro-meridionale nel-l’alto medioevo: quadri regionali e contesti campione, in A cerâmica me-dieval no Mediterrâneo Ocidental, (Lisboa 16-22 novembro 1987), Mer-tola 1991, pp. 105-111.
L. SAGUÌ, Produzioni vetrarie a Roma tra tardo-antico e alto medioe-vo, in La storia economica di Roma, 1992, pp. 113-136.A. SALINAS, Iscrizioni arabiche di gesso, in Rassegna archeologica sici-liana, n. 3, 1871, ripubblicato in A. Salinas, Scritti scelti, I, Palermo1976, pp. 203-206.
L. SAGUÌ, Il deposito della Crypta Balbi: una testimonianza impreve-dibile sulla Roma del VII secolo?, in L. SAGUÌ (a cura di) Ceramica inItalia: VI_VII secolo, Atti del Convegno in onore di John W. Hayes Ro-ma, 11-13 maggio 1995, I, Firenze 1998, pp. 305-330.
27
SALINAS 1871
SALINAS 1872
SALINAS 1899
SCERRATO 1968
SCERRATO 1979
Segesta 1995
SFERLAZZA 1998
SIENA - TROIANO - VERROCCHIO 1998
SILVESTRI 1879
SIMONSOHN 1997
SODINI - VILLENEUVE 1992
SOKOLOVA 1965
SPATAFORA 1992
SPATAFORA 2005
A. SALINAS, iscrizioni arabiche di gesso, in Rassegna archeologica sici-liana, n. 3, 1871, ripubblicato in A, Salinas, Scritti scelti; I, Palermo1976, pp. 203-206.
A. SALINAS, Ristauri nella chiesa dell’Ammiraglio, detta La Martora-na, in Palermo, in Rassegna archeologica siciliana, n. 4, 1872, ripubbli-cato in A. Salinas, Scritti scelti, I, Palermo 1976, pp. 209-212.
A. SALINAS, Carini. Scoperta di catacombe romane, in NSc 1899, pp.362-367.
U. SCERRATO, Ceramiche di tradizione islamica a Napoli, in “StudiMaghrebini” II, 1968, pp. 191-199.
U. SCERRATO, La Ceramica, in F. GABRIELI - U. SCERRATO,Gli Arabi in Italia, Milano 1979, pp. 399-445.
A. MOLINARI - M. DE CESARE, Ceramica per la conservazione de-gli alimenti, in AA.VV. Segesta nell’età sveva, in Federico e la Sicilia,1995, pp. 224-226.
P. SFERLAZZA, La produzione ceramica ad Agrigento dall’alto me-dioevo ai nostri giorni, Tesi per il Diploma di Operatore dei Beni Cul-turali, Università degli Studi di Palermo - sede di Agrigento, relatoriprof.ssa R. M. Bonacasa Carra e prof. R. Alaimo, A. A. 1997-98.
E. SIENA - D. TROIANO - V. VERROCCHIO, Ceramiche dallaVal Pescara, in L. SAGUÌ (a cura di), Ceramica in Italia: VI-VII seco-lo, Atti del Convegno in onore di John W. Hayes, Roma, 11-13 maggio1995, Firenze 1998, pp. 665-704.
G. SILVESTRI, I capibrevi di Giovanni Luca Barbieri, I, I feudi dellaVal di Noto, Palermo 1879.
S. SIMONSOHN, The Jews in Sicily, I, 383-1300, Studia post - biblica,48,3, Leiden - New York – Koln 1997.
J.P. SODINI - E. VILLENEUVE, Le passage de la céramique byzanti-ne à la céramique omeyyade du Nord, en Palestine et en Transjordane,in La Syrie de Byzance à l’Islam VIIe - VIIIe siècles, Actes du Colloque In-ternational, (Lyon - Paris 11-15 septembre 1990) a cura di P. Canivet -J.P. Rey –Coquais, Damas 1992, pp. 195-218.
I.V. SOKOLOVA, Les monnaies siciliennes du IXe siècle des fouilles deChersonèse, in Atti del Convegno Internazionale di Numismatica 1961,Roma 1965, pp. 565-570.
F. SPATAFORA, Testimonianze medievali a Monte Maranfusa, in Montevago, pp. 127-140.
F. SPATAFORA, Da Panormus a Balarm, Palermo 2005.
28
SPATRISANO 1982
STILLMAN 1973
Studio Idrologico1993
Tabulario della Magione
TODARO 1988
TORELLI 1980
TRASSELLI 1968
TRASSELLI 1969
TRÉGLIA et alii
TRONCHET BONAVENTURA 1994
TULLIO 1982
TULLIO 1984
TULLIO 1989
G. SPATRISANO, La Zisa e lo Scibene di Palermo, Palermo 1982.
N. A. STILLMAN, The Eleventh Century Merchant House of Ibn ‘Awkal.(A Geniza Study), in Journal of the Economic and Social History ofthe Orient, XVI, Leiden 1973, pp. 15-88.
G. CUSIMANO - A. DI CARA - P. MARESCALCHI, Studio idro-logico dell’isola di Marettimo (Isole Egadi Trapani), in “Rivista Minera-ria Siciliana”, 4 (166) Luglio-Agosto 1993, pp. 25-36 con Carta Idro-logica scala (:10.000).
E. LO CASCIO, Il Tabulario della Magione di Palermo (1116-1643). Re-pertorio, Pubblicazioni degli Archivi di Stato Fonti XLVIII, Roma 2011.
P. TODARO, Il sottosuolo di Palermo, Palermo 1988.
M. TORELLI, Innovazioni nelle tecniche edilizie romane tra il I sec. a.C.e il I sec. d.C., in Tecnologia, economia e società nel mondo romano, (Attidel Convegno di Como 27-29 settembre 1979), Como 1980, pp. 139-159.
C. TRASSELLI, Ocra e ossidiana nel neolitico siciliano, in “Sicilia Ar-cheologica”, I, 3, 1968, p. 24.
C. TRASSELLI, Appunti di metrologia e numismatica siciliana, per laScuola di Paleografia dell’Archivio di Stato di Palermo. Lezioni tenutenegli anni 1968 - 69, Palermo 1969.
J.C. TRÉGLIA – C. RICHARTÉ – C. CAPELLI – Y. WAKSMAN,Importations d’amphores médiévales dans le Sud est de la France (Xe –XIIe S.). Premierès donnèes archaéologiques et archéometriques, in S. GE-LICHI (a cura di) Atti del IX Congresso Internazionale sulla ceramicaMedievale nel Mediterraneo (Venezia 23-27 novembre 2009), Firenze2012, pp. 205-208..
E. TRONCHET BONAVENTURA, Scoperte nelle acque di Taormi-na, in Dioniso ed il Mare, VI Rassegna di Archeologia Subacquea, (Giardi-ni Naxos 25-27 ottobre 1991),Villa San Giovanni (RC) 1994, pp. 149-157.
A. TULLIO, I risultati della ricerca archeologica, in AA.VV., Materia-li per la conoscenza storica e il restauro di una cattedrale. Mostra di do-cumenti e testimonianze figurative della Basilica ruggeriana di Cefalù,Palermo 1982, pp. 45-58.
TULLIO, Cefalù antica, Palermo 1984.
A. TULLIO, I saggi di scavo, in AA.VV. La basilica cattedrale di Ce-falù. Materiali per la conoscenza storica ed il restauro. La ricerca archeo-logica. Preesistenze e materiali reimpiegati, 3, Palermo 1989, pp. 13-114.
29
TULLIO 1994
TULLIO 1995a
TULLIO 1995b
TULLIO 1997
TUSA 1976
UDOVITCH 1978
UDOVITCH 1993
UGGERI 1970
UGGERI 1984
VALENTI 1939
VAN DOORNINCK 1989
VAN DOORNINCKMAYER 1993
VASSALLO 1988
VASSALLO VENTRONE 1974
A. TULLIO, Esperienze di archeologia medievale a Cefalù, in A.M. RO-MANINI - A. CADEI (a cura di), L’Architettura medievale in Sicilia:la cattedrale di Palermo, Roma 1994, pp. 299-321.
A. TULLIO, Le torri del Duomo di Cefalù. Esplorazione archeologica1985-1986, in “Sicilia Archeologica”, 87/88/89, 1995, pp. 143-189.
A. TULLIO, Indagini archeologiche sulla Rocca di Cefalù, in A. TUL-LIO (a cura di), La Rocca di Cefalù. Recupero architettonico ed indagi-ni archeologiche (Atti dell’Incontro di Studio, Cefalù 15.5.1993), Cefalù1995, pp. 16-60.
A. TULLIO, Strumenti per la lavorazione dello zucchero a Maredolce(Palermo), in Archeologia e Territorio, Palermo 1997, pp. 471-479.
V. TUSA, Sull’archeologia medievale, in Atti del Colloquio Internazio-nale di Archeologia Medievale, (Palermo-Erice, 20-22 settembre 1974),Palermo 1976, pp. 104-109.
A. L. UDOVITCH, Time, sea and society: duration of commercial voya-ges on the southern sheres of the mediterranean durin the high middle ages,in La navigazione mediterranea nell’alto medioevo, XXV Settimana diStudio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 14-20aprile 1977), Spoleto 1978, pp. 503-546.
A. L. UDOVITCH, New Materials for the History of Islamic Sicily, in Delnuovo sulla Sicilia musulmana, Roma 1993, Roma 1995, pp. 183-210.
G. UGGERI, Sull’Itinerarium per Maritima Loca da Agrigento a Si-racusa, in “Atene e Roma”, XIV, 1970, pp. 107-117.
UGGERI, La viabilità romana in Sicilia con particolare riferimento alIII-IV secolo, in “Kokalos” XXVIII-XXIX, (1982-83), 1984, pp. 424-460.
F. VALENTI, R. Soprintendenza all’arte medievale e moderna della Si-cilia, Palermo: R. Cappella Palatina, in “Le Arti” I, III 1939, pp. 210-11.
F.H. VAN DOORNINCK, The Cargo Amphoras on the 7th CenturyYassi Ada and 11th Century Serçe Limani Shipwrecks: two Examples ofthe reuse of Byzantine Amphoras as Transport Jars, in Recherches, pp.247-257.F.H. VAN DOORNINCK - F.R. MAYER, Giving Good Weight inthe Eleventh - Century Byzantium: the Metrology of the Glass WreckAmphoras, in INA Quaterly 1993, pp. 8-12.
S. VASSALLO, I siti, in AA.VV. Himera III, Roma 1988, pp. 55-188.
G. VASSALLO VENTRONE, La problematica della ceramica islami-ca del Nord Africa, in Atti del VII Convegno Internazionale sulla Cera-mica, (Albisola 31 maggio-3 giugno 1974), Albisola 1974, pp. 85-102.
30
VERROCCHIO 1994
VINDRY 1980
WHITEHOUSE 1978
WHITEHOUSE 1980
WICKHAM 1988
WICKHAM 2005
WILLIAMS 1980
WILSON 1990
ZANINI 1998
ZORIC’ 1989
V. VERROCCHIO, La produzione di anfore, in AA.VV., Una forna-ce bizantina a Castellana Pianella (PE), in “Archeologia Medievale” XXI,1994, pp. 276-280.
G. VINDRY, Présentation de l’épave arabe du Batéguier (Baie de Cannes,Provence Orientale), in La céramique médiévale en Méditerranée occidenta-le X - XV siècles, Actes des Colloques Internationaux du Centre Nationalde la recherche scientifique, n. 584, (Valbonne 11-14 septembre 1978), Paris 1980, pp. 221-226.
D. WHITEHOUSE, Medieval Pottery of Rome, in H. Mc K. BLAKE– T. W. POTTER – D. B. WHITEHOUSE, Papers in Itlian ArchaeologyI: the Lancaster Seminar. Recent Research in Phreistoric, Classical andMedieval Archaeology, BAR Suppl. Series 41, 1978, pp. 475-493.
D. WHITEHOUSE, Medieval Pottery in Italy. The Present State ofReaserch, in La céramique médiévale en Méditerranée occidentale Xe - XVe siècles, (Valbonne 11-14 septembre 1978), Paris 1980, pp. 65-82.
C. WICKHAM, L’Italia e l’alto medioevo, in “Archeologia Medieva-le”, XV, 1988, pp. 105-124.
C. WICKHAM, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Medi-terranean 400-800, Oxford 2005.
D.F. WILLIAMS, The Petrology of certain Byzantine Amphorae: SomeSuggestions as to Origins, in CEDAC Dossier, I, 1980, pp. 99-110.
R.J.A. WILSON, Sicily under the Roman Empire, Warminster 1990.
E. ZANINI, Le Italie bizantine. Territorio, insediamenti ed economianella provincia bizantina d’Italia (VI-VIII secolo), Bari 1998.
ZORIC’, Il cantiere della Cattedrale di Cefalù ed i suoi costruttori, inAA.VV., La basilica cattedrale di Cefalù. Materiali per la conoscenza sto-rica ed il restauro,1, Palermo 1989, pp. 94-340.
31
P R E M E S S A
Nel panorama generale dei commerci nel Mediterraneo occidentale durante l’altomedioevo un ruolo costantemente di primo piano è stato giocato dalla Sicilia, siaper la produzione delle derrate alimentari, soprattutto grano, sia per l’importan-
za dei suoi grandi porti nello smistamento e stoccaggio delle merci provenienti da tutte le par-ti del bacino del Mediterraneo, e ciò malgrado l’avvicendarsi nell’isola di diverse dominazio-ni. L’aspetto archeologico di questo vasto e complesso argomento è principalmente legato al-lo studio dei reperti ceramici oggetto di questi scambi: i contenitori da trasporto per le der-rate alimentari e la ceramica di lusso. Questo lavoro si propone di studiare la produzione lo-cale e la circolazione delle anfore da trasporto nella Sicilia occidentale dagli inizi dell’VIII se-colo fino alla dominazione normanna dell’isola, sia attraverso la rilettura dei pochi manufat-ti editi, ma soprattutto grazie all’analisi di consistenti gruppi di materiali inediti.
Limiti intrinseci al nostro lavoro sono stati la restrizione geografica alla parte occidenta-le della Sicilia, la sola area per la quale ci è stata data la possibilità di accedere ai materiali re-cuperati nel corso di recenti scavi stratigrafici, per lo più ancora inediti; e la frammentarietàe discontinuità della documentazione archeologica che rende inevitabilmente congetturale ilquadro storico-economico che si andrà a delineare.
Per quel che riguarda la definizione dei limiti cronologici abbiamo scelto un arco di tem-po denso di rivolgimenti politici e culturali particolarmente significativi per la storia dell’i-sola nei secoli dell’alto medioevo.
L’VIII secolo, inizio del periodo della nostra indagine, è considerato in ambito mediterraneouno spartiacque tra il mondo tardo antico e quello medievale. In particolare gli anni trenta e qua-ranta di questo secolo, per dirla con Wickham, segnerebbero la fine del grande commercio ro-mano, legato alla raccolta dell’Annona, e di fatto, l’inizio del medioevo per molte delle regioniche si affacciano nel bacino del Mediterraneo. Per la Sicilia in particolare la scelta di questo seco-lo, come punto di partenza della nostra analisi, è motivata dalla esigenza di esplorare, quantoquesti rivolgimenti possano avere influito sull’economia dell’isola e che tipo di informazioni intale direzione si possano ricavare dall’esame delle tipologie dei contenitori attestati.
Nel corso del IX secolo, con la conquista islamica, la Sicilia esce dalla sfera d’influenza oc-cidentale per entrare nel mondo musulmano nord-africano al quale resterà strettamente lega-ta almeno dal punto di vista commerciale anche oltre l’arrivo dei Normanni sul finire dell’XIsecolo. Termine ultimo per la nostra ricerca è il XII secolo, che vede il consolidarsi della con-quista normanna nell’isola ed il ritorno della Sicilia alla sfera d’influenza dell’Occidente. Que-sto sconfinamento nel XII secolo trova la sua ragion d’essere nel carattere unitario della cul-tura materiale siciliana a cavallo tra la dominazione islamica e quella normanna. La presenzadi popolazione musulmana, soprattutto artigiani, spiega la continuità di produzione tra i dueperiodi che rende difficoltoso distinguere chiaramente i prodotti riferibili alla dominazioneislamica da quelli più propriamente normanni. Sarebbe quindi arbitrario stabilire il limitecronologico ultimo della nostra ricerca senza includere nell’analisi i manufatti dell’intero ar-co dell’età normanna.
Il periodo storico in esame, che ha visto l’avvicendarsi delle dominazioni bizantina ed isla-mica, è uno dei meno conosciuti della storia della Sicilia. Al lacunoso apporto delle fonti scrit-te fa riscontro una documentazione archeologica quanto mai carente: sono pochi i siti inda-gati secondo un rigoroso metodo stratigrafico e pubblicati, che restituiscano fasi di vita data-bili a questa epoca. In tale panorama, le evidenze ceramiche costituiscono quasi le uniche te-stimonianze delle attività economiche dell’isola legate alla produzione ed al commercio del-le derrate alimentari.
Il quadro generale delle ricerche sui contenitori da trasporto prodotti e circolanti in Sici-lia nei secoli dell’alto medioevo non è confortante. Si tratta di un campo di studi poco esplo-rato sul quale non si dispone né di organiche trattazioni d’insieme, nè di pubblicazioni siste-matiche dei materiali rinvenuti.
Per l’VIII secolo si hanno poche attestazioni provenienti da scavi sistematici riguardantiimportazioni di contenitori da trasporto e queste di fatto sono relative esclusivamente ai con-testi di Cefalù e, recentemente, a quelli di Marettimo (Trapani). A questi si aggiungono se-gnalazioni di rinvenimenti sporadici, occasionalmente pubblicati, riguardanti principalmen-te alcuni siti della Sicilia orientale: a Capo Plemmirio, nei pressi di Siracusa, è stata rinvenu-ta un’anfora datata al VII-VIII secolo, probabilmente d’importazione orientale; un frammen-to di anfora bizantina di VIII secolo è stata recuperata a Lipari. Senz’altro dovuta ad un ma-linteso è la datazione all’VIII secolo, cui fa riferimento P. Arthur, per la fornace ritrovata adAgrigento, la cui cronologia va collocata nell’ambito dell’XI secolo. Da quanto detto possia-mo concludere che per questo periodo non si conoscono produzioni locali di anfore destina-te sia al trasporto delle derrate che alla conservazione dei prodotti alimentari.
Dopo il tracollo del grande commercio delle derrate alimentari intorno alla seconda metàdel VII secolo, sopravvivono, soltanto in alcune aree, dei circuiti più circoscritti, tra cuiuno dei meglio noti è quello documentato dalla carta di distribuzione delle anfore globula-ri o subcilindriche prodotte in Campania. Uno degli interrogativi di ordine storico solle-vato dalla critica recente ha interessato l’esistenza nell’VIII secolo di un circuito sovrarre-gionale tirrenico destinato al rifornimento alimentare di Roma che aveva nella Sicilia unodei principali centri produttori. Infatti, allo stato attuale degli studi sia storici che archeo-logici è molto difficile valutare l’entità e la natura di questi commerci che andrebbe verifi-cata attraverso la presenza nei contesti isolani delle anfore globulari o subcilindriche carat-teristiche della fine del VII-VIII secolo.
Solo da pochi anni si cominciano a riconoscere le anfore da trasporto prodotte nell’Italiacentro meridionale tra la fine del VII ed gli inizi del IX secolo. Tuttavia, il dibattito su que-sti contenitori è ancora agli inizi ed i repertori tipologici a tutt’oggi disponibili non sono an-cora sufficienti ad esaurire il variegato panorama delle produzioni. A rendere più problema-tico il riconoscimento delle aree di provenienza dei manufatti interviene la mancanza totaledi standardizzazione nelle produzioni, come si evince dagli studi più recenti sulle anfore datrasporto diffuse nel bacino del Mediterraneo tra la fine del VII ed il IX secolo. Si verifica, in-fatti, che contenitori appartenenti ad uno stesso tipo possano essere dissimili tra di loro e pre-sentare un numero considerevole di varianti, per contro è rilevabile una certa uniformità ne-gli elementi caratterizzanti comuni a tutte le produzioni di anfore fino ad ora individuate an-che se di provenienza molto diversa. Per dirla con L. Paroli, le forme di questi recipienti pre-suppongono «un quadro di rapporti molto ampio con l’area mediterranea, in particolare con
32
33
Costantinopoli, ma di origine preminentemente culturale», una koinè mediterranea quindi,che si interromperà soltanto con l’età carolingia. Le difficoltà sopra evidenziate non consen-tono, dunque, ad oggi di delineare per questo periodo un quadro esaustivo delle importazio-ni stante la difficoltà di attribuire con certezza i contenitori da trasporto a singole aree di pro-duzione agricola.
Anche per l’arco cronologico compreso tra il X e l’XI secolo, durante il quale è documen-tata una rinascita dei commerci in anfora almeno nelle regioni orientali del Mediterraneo, lenostre conoscenze sui contenitori da trasporto rimangono molto carenti. Fanno eccezionealcuni manufatti attestati in area istrico-pontica e balcanica e lungo le coste turche, oggettodi indagine da parte di alcuni studiosi che ne hanno tentato una prima classificazione. In que-sto panorama mediterraneo manca una classificazione delle forme destinate al trasporto pro-dotte nel Nord Africa delle quali per contro si desume l’esistenza dalle fonti scritte ed in par-ticolare dalle lettere della Geniza del Cairo.
Per quanto riguarda la Sicilia la documentazione sulle anfore si arricchisce notevolmente ri-spetto ai secoli precedenti a partire dalla seconda metà del X, ma soprattutto nel corso dell’XIsecolo, al passaggio tra la dominazione musulmana e quella normanna. Se, infatti, sono a tutt’og-gi sconosciuti i prodotti delle officine ceramiche siciliane ascrivibili alla prima età islamica (IX- prima metà X secolo), per il periodo successivo il tentativo di seriazione cronologica delle for-me della invetriata ha permesso, in alcuni siti scavati stratigraficamente, di attribuire alla stessaepoca ceramiche comuni riferibili per le caratteristiche degli impasti a produzioni locali.
All’XI secolo vanno attribuite due fornaci di ceramica acroma scoperte ad Agrigento nel-la Valle dei Templi. Le fornaci producevano, tra l’altro, anche anfore i cui numerosi tipi co-stituiscono un ampio repertorio morfologico di sicura produzione locale e quindi un’affida-bile base di partenza per la conoscenza delle manifatture siciliane coeve. Allo stesso torno ditempo vanno riferiti alcuni materiali di produzione palermitana recentemente scoperti incontesti urbani ed extraurbani.
Dopo i pionieristici studi di F. D’angelo sulla ceramica comune palermitana di età nor-manna, recentemente questa classe di materiali è stata oggetto di studio da parte di A. Moli-nari e soprattutto di L. Arcifa che, alla luce dei risultati dello scavo palermitano di CastelloSan Pietro, ha riconosciuto delle produzioni locali ascrivibili al periodo di transizione fra idue momenti storici. Ciò nonostante, a tutt’oggi mancano di fatto delle classificazioni piùampie della ceramica acroma a cui ancorare i reperti delle manifatture locali dell’area paler-mitana, la cui produzione si manifesta almeno a partire dal X secolo e continua ininterrottafino alla seconda metà del XII.
Infine, restano ancora poco note, almeno dal punto di vista delle attestazioni archeologi-che, le importazioni di anfore in contrasto con quanto si evince dalle fonti scritte.
Alla luce di quanto detto, esigenza primaria di questo lavoro è la sistematizzazione di tut-ti i dati disponibili e la classificazione delle anfore riferibili a questo periodo, senza tuttaviaperdere di vista alcuni interrogativi relativi al quadro storico.
Questa ricerca aspira quindi all’elaborazione di una tipologia delle forme anforiche atte-state nei contesti siciliani databili entro l’arco di tempo preso in esame attraverso la schedatu-ra, il rilievo grafico e la documentazione fotografica di ogni forma individuata, nonché, laddo-ve possibile, utilizzando gli esiti delle analisi mineralogico petrografiche degli impasti, impre-scindibili da un punto di vista metodologico al fine di definire la provenienza dei contenitori.
Le informazioni così ricavate possono permetterci di raggiungere uno degli obiettivi fonda-mentali di questa ricerca: il riconoscimento delle produzioni locali e l’esplorazione del rap-porto di continuità o discontinuità con la tradizione morfologica precedente.
Particolare attenzione meritano, inoltre, le problematiche relative all’interpretazione deigraffiti presenti sul corpo ceramico di numerosi contenitori.
Siamo naturalmente ben consapevoli che lo studio delle anfore non è da solo sufficiente aricostruire l’economia ed i commerci di una regione in un determinato periodo, basti consi-derare che, durante i secoli dell’alto medioevo, l’uso di contenitori di terracotta nei traspor-ti diminuisce vistosamente rispetto ai periodi precedenti, a vantaggio di otri di pelle o di bot-ti di legno che non lasciano tracce archeologicamente riscontrabili. Perché il quadro storicodelineato dai contenitori da trasporto abbia un senso più ampio e veridico, abbiamo ritenu-to quindi utile integrare i dati desumibili dall’esame del materiale disponibile con quelli chesi possono ricavare dall’analisi delle pur scarse fonti note. In sintesi, ci si è chiesti se, nel si-lenzio totale degli studi sui contenitori da trasporto prodotti e circolanti nell’isola nell’altomedioevo, dall’esame di tali manufatti possano scaturire nuovi elementi che consentano dicomporre, almeno in parte, l’apparente contrasto tra il panorama storico disegnato dalle fon-ti documentarie e letterarie e quello che emerge dagli studi archeologici.
34
37
CAPITOLO I
Le anfore d’importazione nella Sicilia occidentale (VIII-XII secolo)
Le conoscenze attuali sulle anfore d’importazione nella Sicilia occidentale, nel periodocompreso tra la dominazione bizantina e quella islamica, sono quanto mai limitate enon soltanto perché è noto un numero estremamente esiguo di rinvenimenti di con-
tenitori allogeni, ma più in generale per l’incompletezza dello stato degli studi sulla culturamateriale del periodo, che rende difficile l’identificazione dei contesti archeologici in cui ta-li contenitori potrebbero trovarsi. A ciò si aggiunge il fatto che i pochi contesti noti riferibi-li a questo ambito cronologico, sono stati pubblicati solo parzialmente. Infatti, le nostre co-noscenze sulle ceramiche circolanti nell’isola si fermano al VII secolo per riprendere alla fi-ne del X - XII secolo con l’ultima fase della dominazione islamica e l’arrivo dei Normanni.
Sono soltanto due i siti indagati e pubblicati che presentino fasi di vita databili agli ultimicentocinquant’anni della dominazione bizantina (VIII - prima metà del IX secolo), ovvero alperiodo che precedette l’arrivo degli “Arabi”. Si tratta dell’edificio romano recentemente sco-perto nell’isola di Marettimo, nell’arcipelago delle Egadi1, e del Duomo di Cefalù dove è statamessa in luce all’interno della struttura ruggeriana la fase alto medievale di VIII secolo. En-trambi i siti, come vedremo, hanno restituito anfore d’importazione databili all’VIII secolo2 esi sono rivelati particolarmente interessanti ai fini del nostro studio per le implicazioni stori-che ed economiche che la presenza di questi contenitori comporta.
Non si conoscono altri rinvenimenti, neanche occasionali, riferibili a questo arco di tem-po, fatta eccezione per un frammento di anfora riferibile alle stesse tipologie dei contenitorirecuperati a Marettimo e Cefalù rinvenuta fuori contesto a Palermo3 e Agrigento4 e per letracce di frequentazione rilevate in seguito ad alcune prospezioni archeologiche lungo il cor-so settentrionale del fiume Himera, che hanno messo in evidenza la presenza di alcuni siti le-gati allo sfruttamento agricolo del territorio5.
1 L’edificio venne riusato nel medioevo come cenobio per una piccola comunità eremitica, rifugiatasi nell’isola.Cfr. Marettimo, per una sintesi dello scavo cfr. infra, Capitolo III, pp. 129-132.
2 Cfr. TULLIO 1989, per una sintesi dello scavo cfr. infra, Capitolo III, pp. 132-135.3 Di tratta dell’anfora di produzione dell’Italia centro-meridionale isolata a Palermo Piazza Marina durante i lavori
di restauro di Palazzo Galletti. Cfr. infra, p. 53, fig. 6, PPG 1.4 Cfr. Agrigento 2007, p. 184, fig.35, 99-35 Si tratta di una necropoli in località Passo Grande nei pressi della quale sono stati trovati alcuni frammenti di ceramica da
cucina databili all’VIII secolo, cfr. VASSALLO 1988, p. 106-109 sito n. 18 e di una fattoria greca con continuità di vita fino almedioevo, identificata nel Vallone di Sant’Antonio, che ha restituito tra l’altro materiali databili all’VIII secolo, cfr. VASSAL-LO 1988, pp. 117-119, fig. 101. Per un inquadramento generale su entrambi i siti cfr. BELVEDERE 1988a, pp. 216-220.
La pressoché totale assenza di anfore di importazione sembra riguardare anche il periododella dominazione islamica nell’isola (metà IX-XI secolo) ed in misura minore l’età norman-na, quando è documentato il rifiorire delle produzioni6, ciò malgrado in questi ultimi annisiano venute alla luce sia nelle città, soprattutto a Palermo, che nei siti rurali della Sicilia oc-cidentale, tracce sempre più numerose di insediamenti con livelli di frequentazione riferibilia questi periodi. Questo dato appare in netta contraddizione con il ruolo di fulcro commer-ciale del Mediterraneo islamico giocato dalla Sicilia occidentale così come emerge dalla lettu-ra delle fonti scritte coeve. La disamina delle fonti e l’interpretazione di questo dato verran-no proposte più avanti nell’ambito di questo stesso capitolo7.
Procedendo secondo l’ordine cronologico delle tipologie individuate analizzeremo in pri-mo luogo i due piccoli gruppi di anfore rinvenuti nei contesti di scavo di VIII secolo di Ma-rettimo e di Cefalù. Questi recipienti, come avremo modo di vedere in dettaglio, presentanostrette analogie sia dal punto di vista delle forme che delle aree di provenienza.
Nello stesso paragrafo tratteremo anche di alcuni contenitori da trasporto, ascrivibi-li alla stessa epoca e provenienti da rinvenimenti sottomarini occasionali effettuati lun-go la costa NO dell’isola, a San Vito Lo Capo e nel Canale di Sicilia8. I dati desumibilidallo studio di contenitori di provenienza incerta, inficiati dalle modalità stesse del recu-pero e dalla mancanza di informazioni precise sul luogo di rinvenimento, sono tuttaviainteressanti per due ragioni: la prima riguarda lo stato di conservazione delle anfore, dalmomento che si tratta sempre di vasi integri o parzialmente integri che ci permettonouna lettura completa della morfologia dei recipienti, la seconda riguarda le informazioniche si possono ricavare sulle rotte commerciali che passavano nei pressi delle coste sici-liane. Per potere comunque utilizzare a tal fine nel modo più opportuno i dati relativi airitrovamenti sottomarini occorrerebbe correlarli statisticamente, cosa che al momentonon è possibile data l’occasionalità e la sporadicità di tali rinvenimenti. Inoltre, la desti-nazione finale delle merci è di fatto sconosciuta dal momento che il naufragio delle im-barcazioni o la perdita del loro carico è avvenuta durante la navigazione. Anche la loca-lità di provenienza è di difficile identificazione data la consuetudine di imbarcare mercinei differenti porti di sosta lungo le rotte.
Un secondo paragrafo sarà dedicato alle anfore di X-XII secolo; queste sono rappresenta-te oltre che da una serie di contenitori recuperati nelle acque di Mazara, anche da quattroesemplari, provenienti dai restauri di alcuni edifici normanni di Palermo, riutilizzati comescarti d’uso nel riempimento leggero delle volte insieme a scarti di fornace di produzione lo-cale. Per questi ultimi reperti, databili per il contesto di rinvenimento al XII secolo, va co-munque tenuto conto che l’uso in architettura rappresenta l’ultimo impiego dei manufatti,e che gli stessi sono stati fabbricati in un’epoca precedente. Questi contenitori sono le unicheanfore da trasporto di importazione di questo periodo recuperate nella città di Palermo fat-ta eccezione per un frammento di anfora nord africana isolato nei contesti di X secolo del rio-ne Castello San Pietro9.
6 Cfr. infra, Capitolo II.7 Cfr. infra, paragrafo 1.5 Ruolo mediterraneo della Sicilia tra l’VIII ed il IX secolo. Epigoni del mondo bizantino, p. 69 e ss.8 Questi ultimi recuperi fortuiti sono posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Mazara del Vallo.9 Cfr. infra p. 63, fig. 20,9.
38
1.1 ANFORE D’ IMPORTAZIONE DI VIII SECOLO
Per l’VIII secolo, come abbiamo già anticipato, le sole informazioni sugli scambi commer-ciali e sulle importazioni nell’isola di derrate alimentari che provengano da contesti archeolo-gici attendibili, sono deducibili dai due piccoli gruppi di contenitori rinvenuti a Marettimo eda Cefalù10. Le altre anfore da trasporto non siciliane riferibili alla stessa epoca, sono quelle re-cuperate fortuitamente a Palermo durante i lavori di restauro di palazzo Galletti, nel Canaledi Sicilia e nell’area del relitto recentemente individuato nei pressi di Capo San Vito (TP)11.
Nell’isola di Marettimo i contenitori da trasporto, recuperati negli strati di riempimento di al-cune fosse isolate nei saggi B e G dell’edificio romano12 (figg. 1-2), appaiono abbastanza omogeneisia dal punto di vista morfologico che cronologico13. La presenza in questi stessi strati ed in quel-li riferibili alle fasi successive di vita del monumento di frammenti residuali databili tra il IV ed ilVII14 secolo, ci fa certi che il sito fu frequentato ininterrottamente dal periodo tardo antico alme-no fino al IX secolo, come attesta il rinvenimento di un follis di rame di Michele III (842-866)15.
Riferibili allo stesso periodo ed alle stesse forme sono alcuni contenitori da trasporto rinve-nuti a Cefalù all’interno del Duomo (fig. 3), negli strati II e III del saggio 2, in un contesto data-to agli inizi dell’VIII secolo e solo in parte pubblicato da A. Tullio nel 198916. L’analisi di buo-na parte dei reperti provenienti da questa fase di frequentazione del sito, condotta ai fini dellanostra ricerca, ci ha permesso di confermare la datazione all’VIII secolo, già suggerita da A. Tul-lio per l’associazione in strato con il sigillo plumbeo attribuito al patrizio (diochete) Antioco(inizi VIII secolo). Il contesto ha restituito, infatti, alcuni materiali la cui cronologia è stata direcente puntualizzata: alcune lucerne “a scarpa”17, un frammento di lampada di vetro a stelo ca-vo18, un coppo con larghe striature19 ed alcuni frammenti di ceramiche da cucina (fig. 4) la cuimorfologia rimanda agli esemplari alto medievali, noti dai contesti della Crypta Balbi20.
10 Sulla cultura materiale in Sicilia nell’alto medioevo, cfr. da ultimo MOLINARI 1994b.11 FACCENNA cds, tav. 8.12 Per la descrizione dell’area di scavo cfr. infra Capitolo III, pp. 130 e ss. 13 Le anfore recuperate a Marettimo sono riportate alle figg. 5 e 7, mentre i graffiti sono alla fig. 27.14 Per le anfore proto-bizantine recuperate a Marettimo cfr. ARDIZZONE 1998, p. 407 e s. 15 MAMMINA 1998, p. 418, nr. 1, fig. 16.16 TULLIO 1989, in questa sede l’A. ne ha dato solo notizia preliminare. Per le anfore recuperate in questo sito vedi fig. 6.17 Per una recente puntualizzazione sulla diffusione e sulla cronologia di questi manufatti cfr. per Roma CECI 1992; PA-
ROLI 1992b; per Napoli cfr. GARCEA 1987. A Cefalù sono stati individuati otto esemplari cinque dei quali provenientidallo strato II individuato dal Tullio, mentre gli altri tre esemplari vengono da quello immediatamente successivo; il III stra-to è stato messo in relazione con l’impianto del muro bizantino, cfr. TULLIO 1989, pp. 94-97, nrr. 196-200; 208-210.
18 TULLIO 1989, p. 95, nr. 203, fig. 127. Si tratta di una lampada da sospensione all’interno di anelli metallici o lignei (poly-candela). Questo tipo di manufatto, che sembra fare la sua prima apparizione nel VI secolo, perdura a lungo sia in Occiden-te che in Oriente. A Roma è molto comune in contesti datati a partire dal VI secolo, ma con una maggiore percentuale ne-gli strati della fine del VII-IX secolo. Per gli esemplari romani è stata ipotizzata un’importazione da Torcello la cui officinaera già attiva intorno alla metà del VII secolo, cfr. SAGUÌ 1992, p. 129 e s. nota 51, fig. 9, nrr. 84-85. L’attestazione più tar-da è documentata a San Vincenzo al Volturno in contesti del IX secolo, cfr. STEVENSON 1988, p. 208, fig. 4, 1; 4-5.
19 TULLIO 1989, p. 96, nr. 206.20 La casseruola K80/94,2b (fig. 4) con orlo ingrossato rientrante, ansa a presa triangolare e parete con andamento
tronco-conico, è confrontabile con una casseruola recuperata a Roma in un contesto della Crypta Balbi degli inizi del-l’VIII secolo (PAROLI 1992b, p. 366, Tav. 5,19), mentre le pentole K80/92,2a e K80/94,2b (fig. 4) sono molto similiad alcuni frammenti di ceramica da fuoco recuperati durante la prospezione archeologica effettuata dall’Istituto di Ar-cheologia dell’Università di Palermo nella parte settentrionale della valle del fiume Himera, a pochi Km ad Ovest diCefalù, nel sito altomedievale di Passo Grande (K80/92,2a trova confronto con VASSALLO 1988, fig. 83,5, p. 107
39
40
Fig. 1 - Isola di Marettimo (Egadi). Planimetria del complesso in contrada “Case Romane” (rilievo ed elaborazione grafica arch. R. Di Liberto).
Fig. 2 - Pianta dell’edificio romano con indicazione dei vani e dei piani pavimentali messi in luce nei saggi B e G.(rilievo ed elaborazione grafica arch. R. Di Liberto).
Le anfore di Marettimo e di Cefalù, raramente ricostruibili per intero e per lo più attesta-te da singoli frammenti per ogni tipo di recipiente, rientrano tutte nella tipologia delle “anfo-re globulari altomedievali” o sub cilindriche21. Si tratta cioè di contenitori di medie dimen-sioni, con stretta imboccatura, corpo più o meno ovoidale, fondo convesso, anse a sezione el-littica che si dipartono immediatamente al di sotto dell’orlo con andamento orizzontale perpiegare ad angolo retto e connettersi alla spalla. Sono prive di decorazioni ed alcune hannodei graffiti sulla spalla o sotto l’ansa22. Differiscono tra loro nella forma dell’orlo più o menoarrotondato ed estroflesso e nello sviluppo in altezza del collo.
Le caratteristiche del corpo ceramico, simili in tutti gli esemplari qui censiti, denotano unagrande accuratezza e perizia tecnica evidente soprattutto nell’uso di argille ben depurate e raf-finate. Tutti i nostri contenitori presentano un impasto di colore variabile dal rosaceo all’a-rancio, molto depurato, con inclusi calcarei di piccole dimensioni, nero rossiccio di naturavulcanica a bassa frequenza, e con tracce di mica.
ed il frammento K80/94,2b è confrontabile solo per la parete carenata con VASSALLO 1988, fig. 83,2-4). Infine, la cas-seruola K80/108a (fig. 4) è identica a quella ritrovata a Marettimo considerata residuale perché rinvenuta sopra un bat-tuto di età normanna (PEZZINI 1998, fig. 13.6, p. 413). Benché sia molto probabile che si tratti di materiale importa-to, i confronti con la ceramica da fuoco recuperata nei contesti dello stesso periodo, ubicati nelle vicinanze di Cefalù,ci fanno ipotizzare la circolazione anche nell’entroterra di questi manufatti.
21 Così viene definito questo tipo di contenitore cfr. PAROLI 1993, p. 235, MURIALDO 1995a, p. 444 - 446 con bi-bliografia precedente e PAROLI 1996, pp. 122-23 con carta di distribuzione di questi recipienti fig. 1.
22 Cfr. infra, pp. 64 e ss.
42
Fig. 4 - Ceramica da fuoco proveniente dagli scavi nel Duomo di Cefalù.
La maggior parte di questi recipienti trova confronto con le anfore prodotte nell’Italia me-ridionale tra la fine del VII e l’VIII secolo23. In particolare appartengono alle tipologie dei con-tenitori campani le anfore MRT15 e MRT61 recuperate a Marettimo (fig. 5)24, tutte quelle rin-venute a Cefalù25 e l’orlo ritrovato a Palermo durante i lavori di restauro a Palazzo Galletti(fig. 6)26. La provenienza dei contenitori siciliani dall’Italia centro meridionale viene confer-mata dalle analisi mineralogico petrografiche che hanno dimostrato la pertinenza di questifabrics ad un centro di produzione ubicato per l’appunto nell’Italia centro meridionale, pro-babilmente nell’entroterra campano per la presenza sporadica degli inclusi vulcanici, anchese non si può escludere l’area pugliese27.
Anche le anfore MRT57 e MRT68 (fig. 7)28 che in un primo momento erano state confronta-te con contenitori orientali datati tra l’VIII e gli inizi del IX secolo29, trovano, alla luce delle inda-gini mineralogico-petrografiche che ne hanno rivelato la provenienza dall’Italia centro-meridio-nale, un confronto più attendibile con un frammento di orlo recuperato nei contesti di VIII seco-lo della Crypta Balbi30. Pertanto questo confronto conferma la datazione all’VIII secolo delle anfo-re MRT57 ed MRT68 fino ad ora proposta soltanto sulla base del contesto di rinvenimento.
Si distaccano dal gruppo il fondo MRT 104 (fig. 7) e l’anfora MRT 103 (fig. 5) che per le carat-teristiche composizionali degli impasti potrebbero essere originarie del Mediterraneo orientale31.
Sono rapportabili alle tipologie documentate a Marettimo ed a Cefalù anche gli esempla-ri integri, MBA 36032 (fig. 8) ed MBA 1933 (fig. 9), recuperati nel braccio di mare nei pressi di
23 In particolare i nostri contenitori trovano confronto dal punto di vista morfologico, come si vedrà poco oltre, congli esemplari campani pubblicati da ARTHUR 1993, fig. 2.
24 La prima è confrontabile con un esemplare recuperato fuori contesto a Pozzuoli negli scavi del Rione Terra, vediARTHUR 1993, fig. 2,1, mentre la seconda con un recipiente rinvenuto a Napoli nello scavo a Santa Patrizia in uncontesto datato tra la fine del VII e l’VIII secolo, vedi ARTHUR 1993 fig. 2,3 p. 243.
25 (K80/115; K80/103.1; K80/94.1; K80/96.1; K80/108a). L’esemplare K80/115 è l’unico pubblicato, cfr. da ultimoTULLIO 1989, p. 94 n. 195 figg. 123-124. Nel 1992 L. Paroli confrontava l’anfora cefaludese K80/115 con le anforeprodotte in Campania (ARTHUR 1989, p. 88, fig.7) e con quelle della Crypta di Santa Prisca e di Capo Miseno data-bili all’VIII secolo, (cfr. PAROLI 1992b, p. 363).
26 Vagamente ricorda l’anfora ritrovata a Napoli (Santa Patrizia) ARTHUR 1993, fig. 2.3 senza la decorazione dipin-ta e con l’orlo più arrotondato, datata al VII-IX secolo.
27 Le analisi mineralogico-petrografiche effettuate su campioni prelevati da questi recipienti hanno escluso la prove-nienza da località ubicate lungo le coste nei dintorni di Napoli per la presenza sporadica di inclusi vulcanici. Per i no-stri contenitori risulta verosimile la provenienza dall’hinterland campano. Non è escluso pertanto che possano essercistati più centri produttori dello stesso tipo di contenitore alcuni dei quali ubicati verso l’interno del paese, cosa chesembra trovare conferma nella grande varietà delle anfore romane e portuensi messa in relazione da L. Paroli con “un’a-rea di rifornimento più ampia della sola zona di Napoli” (cfr. PAROLI 1996, p. 122). Per le analisi mineralogico-pe-trografiche cfr. infra Appendice 3, p. 326 e ss.
28 I campioni MRT 57 e MRT 59 presentano caratteristiche composizionali assolutamente identiche tra loro, tantoda rendere verosimile la loro appartenenza al medesimo contenitore.
29 ARDIZZONE 1998, pp. 408-411, confrontate con il tipo Hayes 44 (HAYES 1992, p. 73, fig. 58,17) ritrovato a Sa-raçhane e datata tra la fine dell’VIII ed il IX secolo.
30 PAROLI 1992b, Tav. 3, 10, p. 360.31 Per le analisi mineralogico-petrografiche cfr. infra Appendice 3, pp. 328-329; p. 332. 32 Confrontabile con l’anfora recuperata a Napoli nel convento di Santa Patrizia, probabilmente importata, databi-
le all’VIII secolo, cfr. ARTHUR 1993, fig. 3. 13 e fig. 5. Il nostro esemplare presenta il fondo umbonato.33 Questa anfora è confrontabile per la forma dell’orlo con alcuni recipienti recuperati a Porto e datati all’VIII seco-
lo, cfr. PAROLI 1993, fig. 4, 3-4, mentre per la morfologia del corpo del vaso sembra assolutamente pertinente alleanfore prodotte dalle fornaci di Otranto, cfr. ARTHUR et alii 1992, fig. 10, p. 105 datate al VII secolo. Allo stesso ti-po di recipiente fa rimando l’anfora priva dell’orlo MBA 12 con la stessa provenienza.
43
Mazara del Vallo, l’anfora MBA 362 priva dell’orlo (fig. 10), nonché il frammento rinvenu-to nell’area del relitto medievale di San Vito Lo Capo (fig. 7 )34. La provenienza dall’Italia cen-tro-meridionale di questi ultimi contenitori, ipotizzabile al momento solo sulla base della for-ma dei recipienti e delle caratteristiche macroscopiche degli impasti, potrà essere conferma-ta soltanto in seguito alle analisi mineralogico-petrografiche35.
Tutte queste forme appartengono ad una tipologia di recipienti da trasporto che, come haosservato L. Paroli, è perfettamente inserita nel solco della tradizione morfologica dei conte-nitori tardo antichi prodotti nelle regioni orientali dell’impero ed in uso nel mondo bizanti-no. Per queste anfore sono state proposte come prototipo non solo le anfore globulari ma an-che una derivazione della LRA136. Forme simili a queste continuano ad essere prodotte inOriente tra l’VIII ed il IX-X secolo, come dimostrato chiaramente dai rinvenimenti di Sa-raçhane ad Istanbul, recentemente pubblicati37. Rispetto ai recipienti più antichi si modificail rapporto tra l’altezza e la larghezza del vaso privilegiando quest’ultima rispetto alla prima.
La produzione di contenitori da trasporto con corpo ovoidale o globulare e fondo conves-so tra la fine del VII ed il IX secolo, è documentata oltre che nel Mediterraneo orientale an-che nell’Italia centro-meridionale dalla recente scoperta di fornaci ad Otranto, in Campanianel castrum di Miseno, ad Ischia38, nonché in Calabria dove la presenza di centri di produ-zione è stata ipotizzata sulla base delle analisi mineralogico-petrografiche effettuate su cam-pioni di anfore colà rinvenuti39. I manufatti prodotti in Campania sono diffusi principal-mente nell’Italia centrale e meridionale, come attestato dai ritrovamenti in contesti di VIIIsecolo a Roma - nella Crypta Balbi, a Santa Prisca e nel protiro di S. Maria in Cosmedin -,a Porto, nonché a Miseno ed a Napoli40; contenitori da trasporto riferibili a queste produ-zioni sono stati riconosciuti anche in Calabria tra il materiale di Tropea41 e di Paleapoli42,nell’Adriatico43 e nella Francia meridionale44. La circolazione delle produzioni di Otrantosembra al contrario essere limitata al Salento, alla Locride ed alla Albania; il rinvenimento
34 Rep. 247, FACCENNA 2006, fig 40, 2; un frammento di un'anfora simile a questa proviene dal dragaggio del por-to di Pignataro a Lipari. Quest'ultimo esemplare (inv. N. 12238) presenta le pareti percorse da cordonature. Cfr. CIA-BATTI 1978, p. 24, fig.12 senza indicazione sulla datazione.
35 Gli impasti di questi contenitori si presentano di colore beige rosato (5YR 7/6) con piccoli inclusi neri ad alta fre-quenza nell'anfora MBA 362, e di colore arancio chiaro (5YR 6/6), con rari inclusi bianchi e con inclusi di piccole emedie dimensioni di colore grigio chiaro più rari grigio scuro e con tracce di mica nell'anfora MBA 19. Dal momentoche si tratta di esemplari integri non è stato possibile effettuare le campionature necessarie per le analisi.
36 L. Paroli ha proposto per queste anfore, di chiara produzione dell'Italia centro-meridionale, la matrice culturaletardo antica di tradizione orientale, (cfr. PAROLI 1992b, p. 362, nota 41 e le ha messe in relazione con l'anfora LRA1).Per una messa a fuoco delle problematiche relative a questa produzione cfr. VILLA 1994, p. 352.
37 Per le anfore recuperate a Saraçhane cfr. HAYES 1992; per tutti i contenitori orientali confrontabili con questa ti-pologia di anfore, cfr. da ultimo PAROLI 1992b, p. 363, nota 42.
38 ARTHUR et alii 1992; ARTHUR 1989, p. 87, DE ROSSI 200539 DI GANGI - LEBOLE DI GANGI 1998b, pp. 756-766. Alcune di queste anfore hanno presentato alle analisi mi-
neralogico-petrografiche una compatibilità con le argille locali fermo restando che, come osserva l'A., le stesse argillesono caratteristiche della Sicilia Nord orientale e pertanto, in assenza di attestazioni di impianti produttivi nell'area,non si può essere certi dell'esistenza di produzioni calabresi.
40 PAROLI 1992b, p. 363, DE ROSSI 2005 41 DI GANGI-LEBOLE DI GANGI 1998a, fig. 6, p.110.42 LEBOLE DI GANGI 1991, fig. 1043 Cfr. da ultimo GELICHI 2009, p. 51 e ss figg. 3-4.44 PAROLI 1996, p. 122 e PELLECUER - J.M. PÉNE 1996, fig. 6, pp. 129-131.
44
di esemplari simili nel relitto di Ugento fa ipotizzare la diffusione via mare di questi manu-fatti a media e lunga distanza45. La presenza nell’VIII secolo di contenitori prodotti nell’Ita-lia centro-meridionale nell’isola non sorprende dal momento che la Campania, la Calabria ela Sicilia sarebbero state la fonte primaria dell’approvvigionamento romano delle derrate ali-mentari nell’alto medioevo e pertanto dovevano essere inserite negli stessi circuiti commer-ciali46. La consistenza di questi rinvenimenti, d’altra parte ci fa certi che questi collegamenti,fino ad ora soltanto ipotizzati sulla base delle fonti e di qualche rara attestazione, non dovet-tero essere sporadici e occasionali, ma costanti.
45 Da ultimo VILLA 1994, p. 352.46 PAROLI 1996; DELOGU 1994; VILLA 1994 p. 356; per la continuità dei rapporti commerciali della Sicilia
con la Campania anche dopo la conquista islamica dell’isola cfr. infra, paragrafo 1.6 La Sicilia ed il mondo islamico.La rinascita del commercio internazionale, p. 74 e s.
45
Fig. 5 - Marettimo, edificio romano. Anfore altomedievali (da Marettimo).
47
Fig. 7 - Marettimo, edificio romano. Anfore altomedievali (da Marettimo).
Fig. 8 - Anfora MBA 360 rinvenuta nel Canale di Sicilia.
1.2 ANFORE D’ IMPORTAZIONE DI X-XII SECOLO
Le anfore di importazione databili tra il X ed il XII secolo sono quasi del tutto assenti daicontesti archeologici noti della Sicilia occidentale. La maggior parte delle attestazioni nell’i-sola riguardano rinvenimenti decontestualizzati o occasionali. Esemplari riferibili a questaepoca provengono infatti, da recuperi sottomarini fortuiti nelle acque intorno a Mazara delVallo47 e dalle volte di alcuni edifici normanni palermitani48. Sempre a Palermo l’unico fram-mento proveniente da contesti archeologici databili al X secolo è stato rinvenuto nello scavodel Rione Castello San Pietro.
Inizieremo la nostra descrizione dalle anfore recuperate in mare, procedendo secondo l’or-dine cronologico delle tipologie individuate.
Tra i contenitori da trasporto custoditi nel Museo Civico di Mazara del Vallo segnaliamo lapresenza di un recipiente del tipo I della classificazione elaborata da N. Günsenin databile all’XIsecolo49 (fig. 11). Si tratta di un’anfora (MV 364) di piccole dimensioni con collo a svasare atro-fizzato, anse massicce impostate direttamente sull’orlo ed attestate sulla spalla del recipiente, cor-po cuoriforme, fondo convesso. L’impasto corrisponde alla descrizione sommaria che ne dà N.Günsenin: di colore arancio (7.5R 5/6), con minuscoli inclusi bianchi e con rara mica bianca dipiccolissime dimensioni50. Era composto da anfore di questo tipo il carico del relitto fatimida diSerçe Limani, naufragato nel primo quarto dell’XI secolo51. Questi contenitori sono molto co-muni lungo le coste della Turchia e del Mar Nero52, e sembrano prodotti nella regione di Ganossul litorale tracico nel mar di Marmara53. Probabilmente trasportavano vino, come dimostranole tracce di resina visibili all’interno di alcune anfore conservate nei musei turchi54.
Ad una tipologia ricorrente tra il materiale documentato lungo la costa orientale delmar Adriatico, appartengono i contenitori da trasporto MBA21 (fig. 12) e MBA18 (fig. 13)recuperati nelle acque intorno a Mazara del Vallo. Si tratta di due recipienti di medie di-mensioni, circa cm 54 di altezza, realizzati con un impasto di colore beige rosato (5YR7/6) depurato, con inclusi scuri di medie dimensioni e scaglie di mica di colore giallo55.
47 MV23; MV10; MV21; MV 364.4, cfr. infra, Appendice 1, Catalogo. 48 Si tratta delle anfore PPA 87, PPA 40, PPA 165B, PPA164 bis, PM50 recuperate sopra le volte di alcuni edifici nor-
manni di XII della città durante i lavori di restauro. Eccetto che per il contenitore PM50 non si hanno più notizie sul-la loro esatta provenienza, per i contesti di rinvenimento cfr. infra, Capitolo III, pp. 182-188, per i dettagli sulle anfo-re cfr. infra, Appendice 1, Catalogo.
49 GÜNSENIN 1989, Type I, fig. 2, pp. 269-270; VAN DOORNINCK 1989, fig.4.50 Sulla spalla del nostro esemplare è graffita la lettera H seguita da un pallino in negativo, fig. 11. Un graffito simile
ma con una serie di 4 pallini sopra la lettera H è visibile su un’anfora dello stesso tipo facente parte del carico del relit-to fatimida di Serçe Limani, cfr. VAN DOORNINCK 1989, fig. 3, n. 15.
51 VAN DOORNINCK 1986; VAN DOORNINCK 1989. Il relitto di Serçe Limani proveniva probabilmente dal-la Siria fatimida ed era diretto verso un centro di fabbricazione del vetro sito lungo la costa bizantina.
52 Cfr. Carta di distribuzione in GÜNSENIN 1989, fig. 1. Le percentuali di presenza di questo tipo di recipiente au-mentano in prossimità di Istanbul dimostrando come la destinazione finale di molti di questi contenitori fosse proprioCostantinopoli. Anfore di questo tipo sono state recuperate in Bulgaria, Romania ed in Russia.
53 GÜNSENIN 1989, p. 271.54 Cfr. BAKIRTZIS 2009, p. 698 fig. 2.55 Cfr. infra, Appendice 1, Catalogo, le misure dell’anfora MBA 21 sono: h. cm 54; Ø interno orlo cm 9.6; larghez-
za massima cm 44. Questo esemplare è privo dell’orlo e si presenta di dimensioni leggermente più grandi rispettoall’altro; la sua capacità è stata calcolata in l 44.68.
50
Presentano il corpo globulare percorso da cannelures, l’orlo verticale a larga fascia, brevecollo leggermente rigonfio, anse a sezione ellittica lievemente sormontanti, fondo convesso56.Entrambi questi contenitori sono simili per morfologia e per dimensioni ad un’anfora prove-niente dall’isola di Hvar, lungo la costa jugoslava, per la quale è stata proposta una datazionetra il X ed il XII secolo57.
Un discorso a parte meritano i contenitori da trasporto di importazione riusati come scartid’uso nel riempimento leggero delle volte di alcuni tra i più importanti edifici normanni dellacittà di Palermo e recuperati durante i restauri eseguiti tra la fine del secolo scorso e gli inizi del‘90058. Si tratta di oggetti decontestualizzati e ormai privi di una provenienza certa e del suppor-to del deposito archeologico; dopo il recupero sono stati infatti conservati tutti insieme senzaalcuna indicazione del luogo di rinvenimento. Dal momento che si tratta di scarti d’uso, ado-perati per un periodo indeterminato prima di essere usati in architettura anche la datazione nonpuò essere definita con precisione, l’unico dato in nostro possesso è la certezza che questi reci-pienti provengano da edifici la cui cronologia si colloca nell’ambito del XII secolo.
Iniziamo la nostra descrizione dall’anfora PPA87 (fig. 14)59 con collo tronco-conico, anse asezione ellittica leggermente sormontanti, corpo ovoidale allungato e fondo convesso, che tro-va confronti puntuali con due contenitori provenienti da Reggio Calabria e dal territorio diMetaponto, simili alle produzioni di Otranto e databili tra il X e l’XI secolo60. Come ha osser-vato P. Arthur potrebbero essere delle produzioni dell’Italia meridionale bizantina o norman-na destinate all’esportazione del vino o dell’olio per i mercati extra regionali. Le relazioni com-merciali della Sicilia con l’Italia meridionale durante la dominazione normanna sono note enon sorprende di trovare manufatti provenienti da quelle aree nel principale porto dell’isola61.
Nelle volte della chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, è stata reimpiegata l’anfora PM50(fig. 15) con orlo estroflesso leggermente pendulo e segnato nella parte superiore da una ner-vatura a rilievo, collo cilindrico, spalla leggermente inclinata con inciso un motivo ad ondedisposto su due registri, anse apicate a sezione ellittica impostate sulla spalla leggermente in-clinata e convessa, corpo ovoidale percorso nella parte bassa da cannelures e fondo umbona-to62. Questo contenitore, chiaramente uno scarto d’uso, si presenta morfologicamente diffe-rente rispetto agli esemplari prodotti a Palermo e recuperati nello stesso contesto, ma la man-canza di confronti con altre produzioni e l’impossibilità di valutare esaustivamente l’impasto
56 Le dimensioni del recipiente MBA 18 sono: h. cm 53; Ø orlo cm 10.5; larghezza massima cm 44, la sua capacità èdi l 41.22, cfr. infra, Appendice 1, Catalogo.
57 BRUSIC 1976, pl. IV, fig. 4, p. 43, Gruppo Va.58 Per maggiori dettagli sui contesti di rinvenimento e sugli edifici da cui provengono questi manufatti, cfr. infra, Ca-
pitolo III, pp. 182-188.59 La descrizione macroscopica dell’impasto di questa anfora è la seguente: colore arancio (2YR 6/8), depurato con
mica gialla a bassa frequenza, mentre le misure di massima sono: H cm 58; Ø orlo cm 7.60 ARTHUR 1989, fig. 10, p. 88 e s.; differisce dai prodotti rinvenuti ad Otranto per le caratteristiche dell’impasto,
cfr. ARTHUR 1992, fig. 7:2, n. 818 e fig. 7:3, n. 324 appartenenti al tipo 1 di Otranto datato tra il X e la prima metàdell’XI secolo, p. 206.
61 Malgrado la cronologia degli esemplari dell’Italia meridionale non va oltre l’XI secolo, il nostro esemplare è statorecuperato in un contesto databile ad un periodo non anteriore agli inizi del XII secolo. Nella valutazione della crono-logia non possiamo dimenticare che si tratta comunque di uno scarto d’uso per il quale è difficile stabilire per quantotempo sia stato adoperato come contenitore da trasporto. I contatti della Sicilia con l’Italia meridionale d’altronde so-no stati garantiti da Amalfi anche nel periodo precedente l’arrivo dei Normanni, cfr. infra p. 79.
62 Le dimensioni di questo contenitore sono: Ø orlo interno cm 11; h. 49.7; Ø fondo cm 18.
54
55
Fig. 14 - Anfora PPA 87 adoperata come riempimento delle volte di uno degli edifici normanni di Palermo.
non ci consentono di precisare se si tratti di un prodotto importato o piuttosto di una pro-duzione locale. Le caratteristiche generali della forma rientrano comunque nella tipologia del-le anfore della fine dell’XI - inizi XII secolo, tipiche delle aree di influenza islamica, soprat-tutto per la presenza degli apici sulle anse. Con questa cronologia sembra d’altra parte con-cordare anche il contesto di rinvenimento63.
Possono essere messi in relazione invece con esemplari più tardi, databili nell’ambito delXII secolo, l’anfora PPA 165 bis (fig. 16), proveniente da Palermo dalle volte di un edificio dietà normanna, e l’esemplare MBA 23 recuperato nel Canale di Sicilia (fig. 17). Entrambi que-sti esemplari, assolutamente identici sia per forma e dimensioni che per le caratteristiche ma-croscopiche dell’impasto64, trovano confronto con le grandi giare gerbine. Si tratta di conteni-tori associati al commercio dell’olio la cui circolazione inizia tra il X e l’XI secolo e continuaper tutto il medioevo fino all’età moderna65. Gli esemplari recuperati a Palermo e nel Canaledi Sicilia rimandano al tipo Gerba IV della classificazione di Cirelli e sono datati nei primi se-coli dopo il Mille66. La presenza nelle volte della chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio di unodei due esemplari siciliani ci fa propendere per una datazione tra la fine dell’XI e i primi de-cenni del XII secolo. Va osservato che su entrambi i vasi sono state graffite dopo la cotturaiscrizioni in lettere arabe. U. Scerrato ha letto nell’epigrafe incisa sulle anse dell’anfora di Pa-lermo il nome del proprietario del contenitore Bu Sa’id67. Sulla spalla dell’anfora MBA 23 con-servata a Marsala, è visibile una parola araba che potrebbe fare riferimento all’unità di misuradel recipiente68. Le iscrizioni graffite dopo la cottura dei vasi poco ci dicono sul luogo di fab-bricazione dei recipienti dal momento che le iscrizioni potrebbero essere messe in relazionecon il riuso dei recipienti, presumibilmente in un paese di lingua araba69.
Allo stesso orizzonte cronologico può ascriversi l’anfora PPA 164bis (fig. 18) recuperataanch’essa durante i restauri di uno degli edifici normanni della città di Palermo70. Si trattadi un contenitore da trasporto con collo cilindrico, orlo a fascia con profilo concavo, ansecostolate a sezione ellittica, flesse, spalla inclinata, corpo tronco-conico decorato con serie
63 Dalle volte della chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (La Martorana), datata entro la prima metà del XII secolo,provengono le anfore con motivi epigrafici che per le caratteristiche della forma sembrano ricadere nelle tipologie pro-dotte a Palermo tra la fine dell’XI secolo e la prima metà del secolo successivo. Cfr. infra, Capitolo II, pp. 117-120.
64 PPA 165 bis completa dell’orlo misura: H m 1; L max cm 70.8; Ø orlo interno cm 20, est. cm 32, queste misure coinci-dono perfettamente con quelle dell’esemplare analogo privo dell’orlo MBA 23: H cm 96; L. max cm 70. Anche l’impastodi queste due anfore è molto simile: di colore arancio (2.5 YR 5/8 (PPA165 bis) e 10R 6/8 (MBA23), duro, compatto conqualche incluso bianco e nero di piccole dimensioni e con piccolissima mica. Cfr. infra Appendice 1, Catalogo.
65 Un contenitore simile proviene dal Chersoneso ed è pertinente al gruppo Vb della classificazione di Brusic, cfr. BRU-SIC 1976, pl. V, fig.1, p. 43, Gruppo Vb da Spalato e da Crkvina in Jugoslavia. Per questa anfora è stata proposta una crono-logia compresa tra il XII ed il XIII secolo. Un'altra anfora è stata recuperata tra il carico di un relitto rinvenuto nelle acquedella Costa Smeralda in Sardegna cfr. JAKOBSON 1951, fig. 11.37, p. 340 del XII secolo; infine, contenitori analoghi sonostati recuperati in Bulgaria e lungo le coste del mar Nero cfr. BJELAJAC 1989, fig. 3.3, p. 115 si tratta di contenitori diffusiin area serbo danubiana e databili tra il XII ed il XIII secolo; l'impasto di questo contenitore è depurato di colore marrone omarrone rossastro chiaro (2.5YR 5/4; 5YR 6/4) e sulla superficie esterna è presente un'ingobbiatura chiara (10YR 8/4).
66 CIRELLI 2002, figg. 4, 6-7, pp. 443 e ss.67 Cfr. SCERRATO 1985, fig. 190. Questa pratica è ben attestata su questo tipo di contenitore, cfr. le anfore gerbine
di Cipro dove ricorrono sulle anse i nomi dei proprietari cfr.: MIKAH∆IH∆∑ - M∏AKIPTZH∑ 2003, p. 135..68 Sulla spalla dell’anfora MBA 23 (fig. 17) G. Ventrone Vassallo e M.V. Fontana avrebbero letto la parola wahuqaq
che sarebbe il plurale dell’unità di misura di peso per aridi l’occa, cfr. infra, p. 65, nota nr. 92.69 Sul riuso dei contenitori da trasporto cfr. VAN DOORNINCK 1989, p. 256.70 Le misure di questo contenitore sono: H cm 58; Ø orlo cm 10, cfr. infra, Appendice 1, Catalogo.
57
58
Fig. 16 - Anfora PPA 165 bis adoperata come riempimento delle volte di uno degli edifici normanni di Palermo.
60
Fig. 18 - Anfora PPA 164 bis adoperata come riempimento delle volte di uno degli edifici normanni di Palermo.
di archetti disposti su più registri, incisi a pettine nell’argilla ancora cruda, fondo convesso.Per le sue caratteristiche morfologiche il vaso sembra trovare confronti con le anfore egizianeanche per l’impasto di colore giallo chiaro (5Y8/4) in superficie e rosa al nucleo (5YR 7/6),leggermente poroso e depurato, macroscopicamente simile agli impasti delle anfore provenien-ti da quella regione71.
Ancora dalle volte degli edifici normanni di Palermo proviene il contenitore da traspor-to di grandi dimensioni PPA 40 (fig. 19)72. L’anfora si presenta con orlo ingrossato, arroton-dato a sezione semicircolare con profilo concavo all’interno, collo a svasare segnato all’ester-no da una nervatura, anse a sezione ovale, leggermente costolate ed impostate immediatamen-te sotto l’orlo fino alla spalla, spalla inclinata segnata tra ansa ed ansa da una serie di piccolisolchi eseguiti al pettine, ventre cilindrico con la parte bassa tronco-conica, fondo piatto. Unesemplare molto simile è stato recuperato nelle acque intorno a Mazara del Vallo73. trova con-fronti con contenitori ritrovati a Cipro e provenienti dall’isola di Jerba74. Purtroppo non sitratta di esemplari datati ma il ritrovamento nelle volte di uno degli edifici normanni dellacittà ci spinge a datare la nostra anfora all’interno del XII secolo. Inoltre, La presenza del fon-do piatto in questo contenitore non ci consente di rialzarne ulteriormente la cronologia.
Infine L. Arcifa tra il materiale dello scavo di Castello San Pietro a Palermo ha riconosciutoun’anfora di probabile produzione africana databile alla prima metà del XII secolo (fig. 20, 9)75.
71 Devo questa informazione a R. P. Gayraud che cordialmente ringrazio. 72 Le dimensioni di massima di questo recipiente sono: h cm 90.4; Ø orlo cm 10.8, fondo cm 8.73 Oggi conservato nel Museo Civico di Mazara ed al momento non accessibile.74 MIKAH∆IH∆∑ - M∏AKIPTZH∑ 2003, p. 129 e s., fig. 10.75 ARCIFA 1998b, p. 95, tav. I, 9. La provenienza dal Nord Africa è stata ipotizzata dall'A. sulla base dell'analisi ma-croscopica dell'impasto e sulla non compatibilità con quelli attestati nei manufatti provenienti dall'area palermitana.
61
Fig. 19 - Anfora PPA 40 bis adoperata come riempimento delle volte di uno degli edifici normanni di Palermo.
62
Fig. 20 - Palermo, Castello San Pietro. Ceramica della prima metà del XII secolo (da ARCIFA 1998b).
1.3 ANFORE D’ IMPORTAZIONE NON CLASSIFICATE
Fanno parte di questo gruppo cinque recipienti provenienti da recuperi subacquei fortui-ti in prossimità di Mazara del Vallo, per i quali non è stato possibile stabilire dei confrontiche permettano di precisarne la cronologia. Tuttavia, l’eccezionale stato di conservazione edalcune caratteristiche generali della forma, che farebbero ipotizzare trattarsi di anfore data-bili nell’ambito cronologico interessato da questa ricerca, ci hanno persuaso ad inserire inquesta sede comunque questi contenitori.
Inizieremo la nostra descrizione con l’anfora globulare MBA 10 (fig. 21). L’orlo è vertica-le, leggermente arrotondato, indistinto; il collo tronco-conico e le anse a sezione ovale; la spal-la inclinata; il ventre globulare ed il fondo convesso con un piccolo umbone. Il corpo del re-cipiente è segnato dalla decorazione a pettine con motivi ad onde disposti su registri paralle-li; presenta le superfici lisciate ed ha un impasto di colore rosso (10R 5/6), abbastanza depu-rato con inclusi bianchi77. In mancanza di confronti puntuali, indicazioni utili per l’inquadra-mento cronologico di questo manufatto potrebbero dedursi sia dalla forma del corpo che dal-la decorazione sulle pareti, entrambe tipiche, dei contenitori da trasporto di tradizione orien-tale databili tra l’VIII ed il X secolo78.
Anche per la seconda anfora MBA 330 (fig. 22) di medie dimensioni, non è stato possibileistituire confronti. La forma ovoidale del corpo è più pronunciata rispetto al vaso precedente79,l’orlo è piatto superiormente, il collo svasato, la spalla inclinata, le anse ellittiche con solco me-diano, il corpo piriforme ed il fondo convesso. L’impasto di questo recipiente appare di colorerosso, macroscopicamente simile a quello documentato nei contenitori di origine africana80.
Un altro contenitore proveniente dal Canale di Sicilia MBA 25 (fig. 23) si è rivelato parti-colarmente difficile ai fini di un inquadramento tipologico81. Si tratta di un’anfora di grandidimensioni con orlo verticale arrotondato, segnato all’esterno da un solco; basso collo cilin-drico, anse a sezione ovale percorse da un solco mediano impostate nel punto di raccordo trail collo e la spalla; ventre ovoidale; fondo convesso; pareti cordonate82.
Meritano segnalazione due contenitori morfologicamente molto simili, anche se diffe-renti tra di loro per dimensioni e per le caratteristiche dell’impasto83. Si tratta della grandeanfora MBA 218 (fig. 24) e del contenitore notevolmente più piccolo MBA 1 (fig. 25)84, en-trambe sono di forma ovoidale con orlo verticale, ingrossato all’esterno; collo cilindrico, an-se a sezione ellittica che arrivano nel punto di raccordo tra la spalla leggermente inclinata ed
77 Le dimensioni del contenitore sono: h. 50; Ø orlo 6.5; circonferenza max cm 132, cfr. infra, Appendice 1, Catalogo.78 Si tratta delle anfore eredi delle LRA2; MILELLA 1989, p. 544.79 Le dimensioni del contenitore sono: H. 54.4; Ø orlo est. 10; int. 6.8, larghezza massima cm 30.1; cfr. infra,
Appendice 1, Catalogo.80 Rosso 2.5YR 5/6, depurato, leggermente poroso con rari inclusi neri di piccole dimensioni.81 L’impasto di questo recipiente presenta le seguenti caratteristiche: di colore rosso arancio (10YR 5/8), duro, com-
patto, molto depurato con inclusi bianchi di medie dimensioni a bassa frequenza di piccole dimensioni a media fre-quenza e con inclusi neri di piccole dimensioni a media frequenza.
82 H cm 82,4; larghezza max cm 53,6; diametro orlo esterno cm 12,8, interno cm 11,2; capienza lt. 103,33.83 L’impasto dell’anfora MBA 218 è di colore arancio chiaro (10R 6/8) più scuro al nucleo (10R 4/8), molto depurato, com-
patto con rara mica di piccole dimensioni, mentre l’impasto dell’anfora MBA1 è di colore beige chiaro (10YR 7/4) più gri-gio al nucleo (10YR 7/2), molto depurato con tracce di mica, piccolissimi inclusi grigio chiaro a media frequenza.
84 H cm 45,2; diametro orlo interno cm 9, esterno cm 9,8; fondo cm 7; Larghezza max cm 24,7; capienza lt. 10,94.
63
il ventre ovoidale, fondo umbonato85. Su una delle anse dell’anfora MBA 218 sono visibili 12tacche disposte su tre file: la prima di tre tacche, la seconda di quattro, la terza di cinque. Diffe-risce dalla precedente oltre che per l’impasto per le dimensioni notevolmente ridotte e per laforma delle anse con andamento più ad angolo retto impostate immediatamente sotto l’orlo.
Infine, il recipiente MV1137 (fig. 26) per la morfologia del corpo vagamente ricorda l’anfo-ra di produzione palermitana PPA 102 anche se le caratteristiche dell’impasto ci fanno esclu-dere che si tratti di un’anfora siciliana86. Tuttavia, la somiglianza con questo recipiente data-bile tra la seconda metà dell’XI secolo ed i primi decenni del XII ci spingono a ritenere que-sto contenitore dello stesso ambito cronologico.
85 Le misure dell’anfora MBA 218 sono: H. 76,6; Larghezza max cm 42; diametro orlo interno cm 10,8, esterno cm14; diametro fondo cm 6,8; capienza lt. 54,72.
86 L’impasto di questa anfora, infatti si presenta di colore rosaceo (10R 6/6), polveroso, depurato, con inclusi ferro-si, rari di grandi dimensioni e medi più frequenti. Le misure dell’anfora sono: H cm 36,6; diametro orlo interno 6.6;larghezza max cm 28, diametro fondo cm 6.4; circonferenza cm 93; capienza lt. 12,68.
64
Fig. 21 - Anfora MBA 10 recuperata sott’acqua nei pressi di Mazara del Vallo.
1.4 GRAFFITI
Parecchie delle anfore sopra descritte presentano sulla superficie esterna del contenitorealcuni segni graffiti di lettura non sempre facile. Talvolta si tratta di lettere greche isolate olegate con dei nessi, talaltra di parole arabe o ancora di segni analfabetici chiaramente inten-zionali, ma la cui interpretazione risulta piuttosto difficile (fig. 27).
Sul significato di queste iscrizioni verosimilmente in relazione con l’uso dei recipienti, mol-to si è discusso: in alcuni casi è stato ipotizzato che potessero indicare il loro contenuto, in altriche facciano riferimento al proprietario o al destinatario87, comunque sia non sembra diano infor-mazioni particolari sulla loro origine, e nel caso, molto frequente sui nostri recipienti, di letteresingole88 è stato ipotizzato che possano essere interpretate come cifre numeriche in relazione al-la capacità del contenitore. Come è noto tale problema resta comunque ancora aperto89.
Le anfore K 80/103.1 (fig. 6) e MBA 218 (fig. 24) recano rispettivamente la prima una Esulla spalla e la seconda una serie di 12 tacche disposte su tre file sull’ansa90. In entrambi i ca-si i segni sono incisi nell’argilla fresca prima della cottura del vaso nel forno e pertanto nonsembrerebbe esservi una relazione con le vicende legate all’uso del contenitore. È verosimileche tali segni si riferiscano piuttosto alla capacità del recipiente indicata al momento della ma-nifattura dello stesso. Recentemente è stata avanzata l’ipotesi che i segni praticati nell’argillafresca potessero essere dei marchi per l’identificazione del proprietario impiegati al fine diconsentire il riuso del contenitore da trasporto91. L’iscrizione graffita in lettere arabe presen-te sull’ansa dell’anfora PPA165bis con l’indicazione esplicita del proprietario del vaso potreb-be essere interpretata, quindi, in quest’ottica.
Un chiarimento sul significato dei segni analfabetici, attestati su alcune delle anfore da noiprese in considerazione, ci viene dalla lettura delle lettere della Geniza del Cairo nelle quali sifa esplicito riferimento ad alcuni segni (tagli) praticati dal mittente sul corpo ceramico dei con-tenitori da trasporto, al fine di renderli identificabili al destinatario finale92. La presenza delletacche incise dopo la cottura sulla spalla dell’anfora MBA 12 potrebbe spiegarsi in tal senso.
A giudicare dalle fonti a nostra disposizione, già a partire dal VII secolo, ma soprattutto neisecoli successivi, i trasporti delle merci avvenivano su convogli privati e solo raramente su quel-li del sistema pubblico. Questi armatori al fine di formare il carico necessario a giustificare il viag-gio, raccoglievano merci appartenenti a diversi proprietari anche con destinazioni differenti,
87 Cfr. infra nota nr. 88. 88 Si tratta delle anfore PPA 87 con sulla spalla una X, MV364.4 con una H ed un pallino, MRT 101 con le lettere
NO sulla spalla, e dell’anfora MRT 73 su cui è presente un segno di © capovolto. Lo stesso segno ricorre su un’anforacon fondo umbonato e corpo ovoidale datata tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo, cfr. PIÉRART - THALMANN1980, pl. V B4, p. 477.
89 Si veda in proposito le interessanti considerazioni di F.H.Van Doorninck sui graffiti delle anfore alto medievali emedievali e sul probabile riuso dei contenitori attestato dal moltiplicarsi delle iscrizioni. L’A. analizza nello specificole anfore dei relitti di Yassi Ada e di Serçe Limani (VAN DOORNINCK 1989, pp. 250-256).
90 Segni incisi nell’argilla fresca sono documentati anche sulle anfore del relitto di Serçe Limani datato agli inizi del-l’XI secolo, cfr. VAN DOORNINCK 1989, p. 256.
91 AMIGUES - CRUSELLES - GONZALES - VILLAZSCUSA - LERMA 1995, p. 349. 92 In una lettera del primo terzo dell’XI secolo si trova scritto: «Among the oil trere are 3 ziqqs (giare) which ha-
ve a cut on the nech (of the container). They contain green oil which is in greater demand.», SIMONSOHN 1997,doc. nr. 34, p. 33.
70
ovviamente lungo la rotta seguita dall’imbarcazione93. Era quindi necessario che fosse semprechiara sia la provenienza che la destinazione delle merci; le merci venivano così etichettatecome può evincersi dalle fonti islamiche, indipendentemente dal modo con cui venivano im-ballate: in sacchi, balle o anfore di terracotta. Nelle lettere della Geniza del Cairo si fa riferi-mento anche ad iscrizioni dipinte con il nome del destinatario: per analogia potrebbero esse-re interpretati in questo senso anche certi monogrammi dipinti o graffiti documentati su al-cune anfore bizantine altomedievali94. Inoltre per quel che riguarda la Sicilia islamica questapratica ha la sua spiegazione nella tassa sulle importazioni (ushr) che i musulmani imposeroagli ebrei durante il periodo della dominazione islamica dell’isola95.
Chiaro riferimento alla capacità del recipiente, viene fatto indicando l’unità di misura usa-ta per la merce da trasportare, nelle anfore MBA 130 e MBA 23. Sul primo di questi conteni-tori (fig. 46) si trova scritto in lettere arabe l’indicazione del peso 1 mudd, ovvero 1/2 staio,misura molto usata nel mondo islamico per pesare gli aridi, mentre sulla grande anfora MBA23(fig. 17) sembrerebbe trovarsi, espressa al plurale (wahuqaq), l’indicazione di un’altra unità dimisura del peso l’occa, usata anch’essa nel mondo islamico96.
93 Non sorprende, quindi, di trovare nei secoli dell’alto medioevo e poi del medioevo carichi molto vari per prove-nienza e per destinazione, basti citare ad esempio i relitti di Yassi Ada, ma soprattutto quello fatimida di Serçe Lima-ni, cfr. VAN DOORNINCK 1989. Nel mondo islamico questa pratica è attestata fin dal X secolo e per tutto il XIIsia dai pareri giuridici di Kairouan (IDRIS 1961) sia nelle lettere della Geniza del Cairo (cfr. GOITEIN 1967).
94 In una lettera della Geniza del Cairo del 1064 si dice:«A Moslem loaded 27 ziqq labelled with your name and mi-ne», cfr. SIMONSOHN 1997, doc. nr. 151, p. 335. In un’altra lettera del 1055 si trova scritto: «I also dispatched onour account on the same boat 3 jars kosher oil, large, sealed; and one, the largest, is for you and carries your name inred ochre.», cfr. SIMONSOHN 1997, doc. nr. 103, p. 205. In quest’ultimo caso è attestato anche per le anfore medie-vali un titulus pictus. Inoltre, nelle lettere della Geniza del Cairo è chiaro in più punti l’uso di etichettare con il no-me del proprietario le anfore o le merci trasportate (cfr. SIMONSOHN 1997, doc. nrr. 125 e 151, del 1059 e del1064), cfr. SIMONSOHN 1997, p. XIX.
95 Cfr. SIMONSOHN 1997, p. XIX.96 Il Mudd è nel mondo islamico una misura per aridi, il nome deriva dal latino modius. Dal mudd arabo deriva il
mondellus (misura per solidi) citato nei documenti medievali siciliani a partire dall’età normanna (attestato per la pri-ma volta in un documento del 1168 a Catania come misura della farina) cfr. CARACAUSI 1983, p. 296 e s.; la letturawahuqaq per l’iscrizione sull’anfora MBA23 è incerta. L’occa è una misura di peso assai adoperata nell’impero ottoma-no ed ancora oggi in uso in Turchia, Egitto e Siria. Devo la lettura delle iscrizioni islamiche a G. Ventrone Vassallo edM. V. Fontana che ringrazio entrambe.
71
Fig. 27 - Graffiti sulle anfore altomedievali di Marettimo.
1.5 RUOLO MEDITERRANEO DELLA SICILIA TRA L’VIII E IL IX SECOLO.EPIGONI DEL MONDO BIZANTINO.
I dati provenienti dai siti siciliani sembrano coerenti con la tendenza, riscontrata in tuttoil bacino del Mediterraneo, già a partire dalla seconda metà del VII secolo, verso una riduzio-ne drastica dei commerci su vasta scala ed un incremento degli scambi a medio e corto rag-gio, testimoniato indirettamente anche dalla «frantumazione dell’organizzazione produtti-va»97. Il flusso commerciale di questo periodo, infatti, ha ormai ben poco in comune con l’in-tenso traffico mediterraneo dei secoli precedenti e con l’economia mercantile romana98.
A questo panorama di forte crisi, fa contrasto il dinamismo economico delle regioni del-l’Italia centro-meridionale quali la Campania, la Puglia, la Calabria e forse la Sicilia orienta-le, regioni che avevano una ben radicata tradizione produttiva99 e che mantennero, almenofino alla fine dell’VIII secolo, anche se in forma ridotta rispetto al passato, il loro ruolo di pri-mo piano nell’approvvigionamento dei centri direzionali100. Una dimostrazione di questo fat-to sono le produzioni locali di anfore da trasporto, recentemente individuate nella baia di Na-poli a Capo Miseno ed a Ischia, ad Otranto ed in Calabria, strettamente collegate con la com-mercializzazione del surplus agricolo di queste aree.
L’incidenza prevalente negli unici due siti scavati della Sicilia occidentale - Marettimo e Cefalù- di anfore prodotte nell’Italia centro-meridionale durante l’VIII secolo, e solo occasionalmente dianfore orientali, nonché la totale assenza, almeno nei due contesti indagati, di produzioni sicilia-ne suggeriscono per questa regione la prevalenza dei legami commerciali con il Tirreno centro-meridionale e forniscono elementi di comprensione per lo studio delle relazioni commerciali, giàipotizzate da P. Arthur, tra la Sicilia e la Campania nell’ambito dell’VIII secolo101. La presenza di
97 L’evidenza archeologica per il territorio italiano mostra una progressiva contrazione nel corso del VII secolo dell’impor-tazione delle merci dall’Africa e dall’Oriente per effetto nel primo caso della conquista islamica e nel secondo della “margi-nalità progressivamente assunta per esportatori e vettori dal mercato romano, lontano ed in contrazione”, cfr. DELOGU1993, p. 20. A partire dall’VIII secolo le anfore presenti a Costantinopoli fanno capo ad aree geografiche diverse da quelle delperiodo precedente, dimostrando che è mutata “la geografia commerciale ed economica che rimanda ad un commercio diraggio limitato” che solo sporadicamente raggiunge l’Occidente, cfr. PANELLA 1993, pp. 662-663; 671-672; ZANINI 1998,p. 318-319. A questo panorama di commerci regionalizzati di piccolo cabotaggio, secondo Zanini, rimanderebbe tra gli altriil ben noto relitto di Yassi Ada che con la sua miriade di varianti dimensionali e formali suggerisce un carico composto daderrate provenienti da diversi centri produttori, cfr. ZANINI 1998, pp. 318-319; BASS 1982; VAN DOORNINCK 1989.Le diverse varianti dimensionali e formali possono anche essere spiegate con un sistema di produzione differente non rigi-damente standardizzato come per il periodo romano. Verso questa interpretazione sembrano diretti i dati provenienti dal-le manifatture di Otranto e di Agrigento che documentano, all’interno dello stesso centro di produzione una variegata edarticolata serie di varianti della stessa forma (per Otranto cfr. ARTHUR - PATTERSON 1998; per Agrigento cfr. infra, Ca-pitolo II, pp. 78-93). Per la problematica in generale cfr. PANELLA 1993, pp. 657-680.
98 PANELLA 1993, p. 670.99 A partire dalla fine del V ed per tutto il VI secolo la Sicilia ed alcune regioni dell’Italia suburbicaria come la Cam-
pania provvidero al fabbisogno dell’Urbe, cfr. PANELLA 1993, p. 636 e s. nota n. 88, p. 646 e s. Queste aree rivesto-no nell’ambito dell’Italia bizantina un ruolo di primo piano dal momento che erano indispensabili per il controllo po-litico e militare della penisola soprattutto per l’incalzare dei Longobardi, cfr. PANELLA 1993, p. 669.
100 La Sicilia fino alla fine dell’VIII secolo ha con molta probabilità rifornito la capitale d’Oriente, soprattutto dopola perdita dell’Egitto, della Siria e della Palestina, cfr. REYNOLDS 1995, p. 126. Tutti questi dati ovviamente vannovalutati in relazione con il panorama mediterraneo dei secoli precedenti, rispetto ai quali va comunque rilevata in ge-nerale una forte contrazione delle importazioni e dei flussi commerciali anche in grossi bacini di raccolta come era Ro-ma in quel periodo cfr. PAROLI 1992b.
101 Cfr. ARTHUR 1995.
72
73
contenitori da trasporto dell’Italia centro-meridionale, infatti, confermerebbe che la Sicilia oc-cidentale facesse parte fra il VII e l’VIII secolo della complessa rete commerciale, finalizzata al-l’approvvigionamento della Chiesa di Roma102. Questa interessava il Tirreno meridionale edaveva a Napoli uno dei principali centri di raccolta e di scambio delle derrate alimentari103.
Le navi del Papato che trasportavano il grano siciliano raccolto nei vasti possedimenti del-la Chiesa e che, come sappiamo dalle fonti, raggiungevano Roma costeggiando il litorale cam-pano, prima di fare ritorno in Sicilia imbarcavano vino ed altre mercanzie che poi commer-ciavano lungo le coste dell’isola104. Ciò spiegherebbe la diffusione di manufatti prodotti nel-l’Italia centro meridionale nei siti costieri siciliani o nei grandi porti di Palermo e di Cefalù,nonché a Marettimo, Statio lungo la rotta per il Mediterraneo meridionale105 (fig. 28). L’esi-stenza e la vitalità degli scambi commerciali via mare su questa rotta tra la fine del VII e gliinizi del IX secolo, prima cioè della conquista araba della Sicilia106, sembrerebbe ribadita dalrecupero di contenitori da trasporto riferibili a queste produzioni nello stesso braccio di ma-re107 e nell’isola di Malta108, nonché dalla presenza di manufatti siciliani sia in Campania chenella stessa Roma109. La circolazione nel territorio romano dei contenitori da trasporto pro-dotti nell’Italia centro-meridionale continua per tutto l’VIII secolo e sembra cessare nel cor-so del IX secolo, molto oltre il 730, anno della crisi tra l’imperatore Leone III Isaurico ed ilPapa con la presumibile conseguente perdita della disponibilità del Patrimonium Sancti Petrisia in Sicilia che in Calabria110. In realtà, nell’assenza totale di riscontri archeologici, è difficile
102 ARDIZZONE 2000. Nella seconda metà del VII secolo e nella prima metà dell’VIII gli stretti legami di Roma conla Sicilia sembrano suggeriti non solo dal persistere della proprietà fondiaria del patrimonio di San Pietro nell’isola, maanche dall’immigrazione di siciliani a Roma resa più evidente dal consistente numero di papi di origine siciliana, alme-no 5 nell’arco di tempo compreso tra il 678 ed il 767: Agatone (678-681); Leone II (682-683); Conone (686-687), SergioI (687-701) ed infine Stefano III (767-772), cfr. DELOGU 1993, p. 21.
103 MARAZZI 1992. A partire dal VI secolo, con il governo bizantino dell’isola, la Chiesa di Roma, che com’è notoaveva numerosi possedimenti fondiari in Calabria ed in Sicilia, riscuote l’annona per conto dell’imperatore, almeno fi-no alla rottura con l’Impero avvenuta sotto il regno di Leone III Isaurico nella prima metà dell’VIII secolo.
104 I rapporti con il Lazio e la Campania, documentati dal rinvenimento delle anfore, trovano conferma anche nelladiffusione in Sicilia di ceramica a vetrina pesante a Siracusa e Patti (ME) in contesti databili nei secoli VIII-IX mentrea Palermo, Brucato ed a Piana degli Albanesi (PA) in contesti del X-XI secolo. Cfr. PAROLI 1992a, pp. 39-41 e MO-LINARI 1994a, p. 369 e s.; gli esemplari più tardi sembrano di produzione salernitana. La continuità anche in età isla-mica dei rapporti con le città costiere della Campania è attestata anche dalle fonti, cfr. infra, p. 75 e s.
105 Quale si è rivelata l’isola a seguito della recente scoperta di un insediamento romano con continuità di vita fino almedioevo, cfr. Marettimo e da ultimo ARDIZZONE - DI LIBERTO 2010.
106 Una testimonianza indiretta dell’esistenza di questa rotta agli inizi dell’VIII secolo si evince dalle tappe del viag-gio che papa Costantino (708-715) fece in nave verso Costantinopoli. Egli partendo da Porto toccò gli scali di Gaeta,Napoli, la Sicilia e poi verso la Grecia quelli di Reggio, Gallipoli ed Otranto, cfr. Liber Pontificalis Ecclesiae Romanae,ediz. L. Duchesne, 3 voll. Paris 1886, 171 s., p. 389 e s. indicazione trovata in DELOGU 1993, p. 21. Questa rotta, èstato suggerito da P. Delogu, poteva essere stata percorsa in senso inverso da uomini e merci talvolta caricati negli sca-li intermedi: per esempio è noto che il papa riceveva il vino da Capri (Ph. Jaffé - P. Ewald, Regesta Pontificum Roma-norum, I, 1885, 2216 da P. Delogu, p. 21). Non è un caso quindi che le uniche anfore da trasporto ritrovate nei conte-sti di VIII secolo a Marettimo e a Cefalù siano prevalentemente di origine dell’Italia centro-meridionale.
107 Ci riferiamo in particolare ai recuperi fortuiti effettuati nel Canale di Sicilia presso Mazara del Vallo in pre-cedenza analizzati.
108 B. Bruno 2004. 109 Le importazioni siciliane in questi contesti sono documentate principalmente dalle lucerne cosiddette “siciliane” diffu-
se tra il VI ed il VII secolo, cfr. PANELLA 1989, p. 138; per i contesti romani della Crypta Balbi, cfr. CECI 1992; per Na-poli GARCEA 1987; inoltre monete siciliane di IX secolo sono attestate nel Chersoneso Tracico, cfr. SOKOLOVA 1965.
110 Cfr. da ultimo PRIGENT 2004.
valutare le esatte conseguenze del provvedimento imperiale sia sull’economia romana che suquella dell’isola111. D’altra parte, come vedremo nel paragrafo successivo, sappiamo dalle fon-ti che i rapporti commerciali tra la Sicilia e le città della costa campana continuarono ininter-rottamente nel corso del IX secolo, anche dopo la conquista islamica dell’isola, grazie ad unaserie di alleanze tra il Duca di Napoli e l’emiro di Palermo.
111 Sulla natura di questo provvedimento e quindi sulle possibili ripercussioni sia sull’economia romana che su quel-la dell’isola esistono due correnti di pensiero: la prima facente capo ad A. Guillou secondo la quale l’Imperatore si eralimitato a revocare al Papato il diritto di riscossione dei tributi per conto dell’Impero sulle terre del patrimonio eccle-siastico, privandolo di fatto della grande disponibilità in denaro che gli veniva da questo servigio (GUILLOU 1980);contro questa interpretazione sono F. Burgarella, P. Delogu e F. Marazzi secondo i quali l’analisi delle conseguenze,per certi versi spropositate, del provvedimento sulle vicende romane porterebbe ad affermare che non si era trattatosoltanto della detrazione della aliquota fiscale, piuttosto che la Chiesa venne privata di tutta la rendita. Ammesso pu-re che in un primo momento il provvedimento abbia interessato soltanto la rendita fiscale, secondo F. Burgarella, dopo po-chissimo tempo si giunse alla vera e propria confisca dei beni. Cfr. BURGARELLA 1989; DELOGU 1993; MARAZZI1991. Purtroppo, anche la datazione all’VIII secolo di questi contenitori da trasporto resta troppo vaga per dare delleindicazioni precise sulle conseguenze di questo provvedimento, dal momento che non è possibile, allo stato attuale del-le nostre conoscenze, distinguere i manufatti circolanti in queste aree nella prima metà dell’VIII secolo da quelli circo-lanti nella seconda metà. Da ultimo PRIGENT 2004.
74
Fig. 28 - Carta di distribuzione delle anfore di fine VII - inizio VIII sec. in Italia (da Paroli 1992).
75
1.6 LA SICILIA E IL MONDO ISLAMICO. LA RINASCITA DELCOMMERCIO INTERNAZIONALE.
Con l’inizio della dominazione islamica la Sicilia esce dall’orbita bizantina per entrare inquella del Maghreb, diventando uno dei principali fulcri commerciali del Mediterraneo mu-sulmano. Si riducono verosimilmente le importazioni di alcune derrate alimentari, in parti-colare quella del vino come possiamo inferire date le restrizioni coraniche sull’uso di questabevanda, mentre aumentano le produzioni locali e le esportazioni di anfore, come può desu-mersi dall’incidenza preponderante di contenitori da trasporto fabbricati in loco, nonché dal-la loro presenza al di fuori dell’ambito isolano112.
Per il periodo compreso tra il IX ed il XII secolo, come abbiamo visto, non sono note nell’iso-la attestazioni archeologiche di contenitori da trasporto allogeni, fatta eccezione per un frammen-to di anfora africana databile al XII secolo rinvenuta nel Rione Castello San Pietro di Palermo113, eciò malgrado siano stati pubblicati alcuni scavi archeologici relativi a contesti di fine X-XII seco-lo114. Gli unici reperti in nostro possesso sono così quelli provenienti da recuperi sottomarini checi consentono soltanto di fare qualche considerazione sulle rotte commerciali che transitavano adOvest dell’isola. Per il solo XII secolo, qualche dato ulteriore ci viene fornito dalle anfore recupe-rate durante i restauri di alcuni edifici normanni di Palermo. Per entrambi questi gruppi di mate-riali non è stato possibile, come si è visto, avanzare ipotesi concrete sulla loro provenienza115.
Le poche e frammentarie informazioni relative al periodo della conquista islamica dell’i-sola - IX secolo -, sono quelle ricavabili dalle fonti storiche116.
Dalle fonti cristiane contemporanee emerge la continuità dei rapporti commerciali conl’area tirrenica, anche dopo la conquista islamica dell’isola117. Infatti, nell’836 Palermo stipu-la un’alleanza con le città campane, in particolare con Napoli, basata essenzialmente sulla fi-ducia reciproca derivante dai lunghi anni di contatti commerciali118. Questa alleanza, che du-rerà per circa mezzo secolo, voluta sembrerebbe per fronteggiare le mire espansionistiche deiLongobardi, dovette di fatto determinare la continuità delle relazioni commerciali con la co-sta tirrenica, come ci suggerisce tra l’altro la presenza di frammenti di Forum Ware databilitra il IX e l’XI secolo in alcuni centri dell’isola119.
112 Cfr. infra, Capitolo II.113 Cfr. supra, p. 63, fig. 20,9.114 Ci riferiamo alle indagini degli abitati di Segesta, Entella, Monte Iato, Brucato, di numerosi piccoli centri dell’en-
troterra palermitano e trapanese, di Mazara del Vallo ed infine ad alcune indagini nel centro storico della città di Pa-lermo, anche se pubblicate solo in parte.
115 Come è noto, infatti la sola analisi delle affinità morfologiche non è sufficiente a fornire dati sicuri sulla provenienza di que-sti manufatti dal momento che la forma dei contenitori da trasporto, in questo periodo, viene ripetuta con poche varianti neidiversi centri di produzione. Bisognerà in tal modo attendere che vengano effettuate delle analisi mineralogico-petrografiche.
116 A tutt’oggi, infatti, non sono stati scavati siti archeologici che abbiano restituito fasi di vita relative a questo periodo.117 La dominazione araba non causò l’interruzione dei commerci e delle attività produttive delle zone conquistate,
cfr. VILLA 1994, p. 411.118 AMARI Storia, I, pp. 312 e ss.; LEWIS 1951, p. 132; RIZZITANO 1980, p. 128 e ss. Sembrerebbe, infatti che i
Campani si rivolsero agli Arabi di Sicilia per essere difesi contro i Longobardi di Benevento e che la loro alleanza du-rasse per mezzo secolo «fino al novecento, nonostanti le scomuniche dei papi, le minacce degli imperatori e la rapacitàe insolenza dei Musulmani» AMARI, Storia, I, p. 313. Questa alleanza venne sancita da alcune monete d’oro del duca-to di Napoli in cui il nome del duca era scritti in lettere arabe in caratteri cufici.
119 PAROLI 1992a, pp. 39-41; MOLINARI 1994a, p. 369 e s. Nei contesti di Palermo Castello San Pietro, Brucato,
Un episodio riportato dalle fonti cristiane della fine del IX secolo suggerisce l’intensità de-gli scambi commerciali che interessavano l’isola. Nelle cronache bizantine dell’880 si narrainfatti che, in occasione della grande vittoria della flotta bizantina sui Musulmani ottenutanei pressi di Milazzo vennero razziate alcune navi mercantili destinate alla Sicilia. Il bottinodi olio fu talmente ingente da determinarne il ribasso del prezzo a Costantinopoli120.
Relativamente al X ed all’XI secolo sembra esservi un evidente contrasto tra l’intensità deitraffici commerciali, chiaramente desumibile dalle fonti scritte, e quella che sembra una pres-soché totale assenza di attestazioni archeologiche di contenitori da trasporto allogeni, alme-no nei pochi siti siciliani noti dalla letteratura sull’argomento121.
Di contro il rinvenimento in contesti esterni all’isola di anfore e di ceramica fine da men-sa invetriata prodotte in Sicilia nello stesso periodo122 e l’elevata percentuale di rinvenimen-ti, lungo le coste occidentali dell’isola, di contenitori da trasporto prodotti localmente, se daun lato ribadisce la vitalità delle esportazioni123, dall’altro fornisce un motivo di perplessitàsu quanto siano significative le informazioni archeologiche in nostro possesso.
È possibile che la spiegazione di questa apparente incongruenza vada ricercata nello statodegli studi su questo tipo di manufatto, nella natura dei contesti archeologici che sono statifino ad oggi indagati, e, circostanza non trascurabile, nel tipo di prodotti importati; infatti:
• le anfore da trasporto, e più in generale la ceramica comune di produzione non locale,sono poco note e pertanto difficilmente identificabili allo stato frammentario. È molto diffi-cile distinguerle dalla ceramica residuale ed è invalsa la consuetudine, soprattutto nelle rela-zioni preliminari, di pubblicare soltanto il materiale riconosciuto;
• la carenza di questo tipo di manufatto potrebbe anche essere legata alle caratteristichedel sito indagato, nonché alla organizzazione delle aree destinate al commercio ed alle moda-lità degli scambi. È probabile invero che, in particolar modo nei grandi porti dell’isola, lemerci importate convergessero in centri di raccolta e che per la vendita al dettaglio venisse-ro utilizzati dei recipienti più piccoli fabbricati in loco. Inoltre, come abbiamo visto nel ca-so di alcuni tipi di iscrizioni presenti sul corpo dei vasi, i contenitori da trasporto spesso ri-manevano proprietà del mercante e venivano riusati;
• scorrendo la lista dei prodotti importati124, la grande maggioranza degli stessi non ne-cessita di contenitori di terracotta che sarebbero così stati utilizzati solo nel caso di ac-qua di canfora, olio d’oliva, miele, sapone, mercurio, di sostanze medicinali e di oro125 -
Siracusa databili a questo periodo sono stati rinvenuti frammenti di Forum Ware di probabile produzione salernitana.A Piana degli Albanesi in contrada Sant’Agata recentemente è stato recuperato un frammento di probabile produzio-ne laziale datato tra il IX ed il X secolo.
120 Teofane Continuato, Lib. V, cap. LXIV, pp. 304-305 come si legge in AMARI Storia, I, p. 415.121 Nei siti archeologici pubblicati che hanno restituito fasi di vita relative a questo periodo non sembrano essere presenti
contenitori da trasporto allogeni, con l’unica eccezione dello scavo di Castello San Pietro a Palermo più volte citato.122 G. Berti osservava la presenza a Pisa tra la seconda metà del X secolo ed il successivo di un consistente numero di ce-
ramiche invetriate prodotte nell’isola, acquistate direttamente dai pisani nel porto di Palermo, cfr. BERTI 1993, p. 125.123 Ci riferiamo in particolare ai relitti di Marsala e di San Vito Lo Capo, cfr. infra, Capitolo II.124 Cfr. infra, Capitolo II, p. 151 e s.; SIMONSHON 1997, p. XXIX. 125 Nelle lettere di XI secolo vengono citati diverse volte i contenitori da trasporto in terracotta soprattutto per l’im-
ballaggio di alcune merci. Si tratta in particolare dell’olio (SIMONSOHN 1997, doc. 60, p. 94; doc. 103, p. 205; doc.113, p. 237; doc. 127, p. 273; doc. 145, p. 316; doc. 149, p. 323; doc. 151, p. 335; doc. 160, p. 371), dell’acqua di canfora(SIMONSOHN 1997, doc. 125 e 123), del miele (SIMONSOHN 1997, doc. 79, p. 138; doc. 159, p. 370), di sostanzemedicinali quali la scamonea (SIMONSOHN 1997, doc. 77, p. 133), di sapone (SIMONSOHN 1997, doc. 79, p. 141;doc. 160, p. 371), di mercurio (SIMONSOHN 1997, doc. 159, p. 370), di oro (SIMONSOHN 1997, doc. 162, p. 378).
76
77
alcuni di questi beni venivano peraltro prodotti anche in Sicilia e l’olio d’oliva financoesportato126.
Vediamo in ogni modo di analizzare nel dettaglio le fonti storiche disponibili e di cerca-re, laddove sia possibile, i collegamenti con i limitati dati archeologici individuati nel corsodella nostra ricerca.
Le fonti principali delle nostre informazioni sui rapporti commerciali dell’isola durante il pe-riodo della dominazione islamica si devono essenzialmente all’eccezionale ritrovamento dellelettere private scritte dalle famiglie dei mercanti ebrei di Palermo, Mazara, Kairouan ed Alessan-dria conservate nella sinagoga della vecchia Cairo127 e delle Fatwas, i pareri giuridici espressi daidottori della legge di Kairouan dietro rogatorie della comunità malikite locale su varie questio-ni private alcune delle quali riguardanti il commercio con la Sicilia128. Entrambe queste raccolte,benché insufficienti, sono per noi di grande interesse dal momento che, come tutti i documentiprivati, sono di prima mano, appartenenti a due diverse comunità che praticavano commerci,contemporanee ai fatti e scevre da ogni condizionamento legato ad interessi politici e di parte.
H. Bresc, recentemente, ha messo a confronto i dati desumibili da queste due fonti, espres-sione di gruppi sociali ed etnici differenti. Ciascuna delle società rappresentate, condiziona-ta dalle proprie pratiche mercantili, espressioni del peculiare rilievo economico della comu-nità, nonché dal rispettivo bagaglio culturale e religioso, ha lasciato un’immagine della Sici-lia differente129. Nell’XI secolo coesistono due Sicilie: quella del grano e dello zucchero, atte-stata soprattutto dalle fatwas tunisine130, e quella del corallo, della seta, e delle merci di qua-lità documentata principalmente dalle lettere della Geniza; infatti, per i beni più preziosi: lespezie, le droghe, il lino e le altre mercanzie provenienti dall’Oriente e di cui la Sicilia eragrande consumatrice, la fonte principale di approvvigionamento era l’Egitto ed in particola-re il porto di Alessandria. Entrambe queste realtà, come ha osservato H. Bresc, presuppon-gono dei modelli di scambio totalmente differenti. La realtà economica siciliana che traspa-re dai pareri giuridici è contraddistinta essenzialmente da modesti mercanti musulmani che,sia in periodo di carestia che di abbondanza, trasportavano grano dai porti di Marsala e Ma-zara verso Capo Bon, Mahdiyya, Iqlîbiyya praticando su piccole imbarcazioni una naviga-zione di cabotaggio131. L’entità dei commerci che ci vengono descritti da questa fonte è abba-stanza modesta, ben lontana dal più complesso ed articolato mercato comunitario svolto dal-le comunità giudaiche. Dalle lettere della Geniza, infatti, traspare una realtà produttiva fattadi grandi centri artigianali collegati con le reti di commercializzazione e di scambio intessute
126 L’olio d’oliva veniva anche importato, forse per ragioni di prezzo, cfr. SIMONSOHN 1997, p. XXIX.127 Cfr. GOITEIN 1967; UDOVITCH 1993; GIL 1995; da ultimo SIMONSOHN 1997 con bibliografia precedente.128 IDRIS 1961.129 BRESC 1993, pp. 290-291.130 Per questa fonte la Sicilia è soprattutto terra d’esportazione del grano, vengono ignorate le importazioni dalla Tu-
nisia, eccetto quella del sommacco per l’industria tessile, molto fiorente nell’isola. Questo ruolo di granaio del mondomaghrebino, ancora attivo alla fine dell’XI secolo, non è documentato da altre fonti contemporanee. Infatti, le lette-re della Geniza del Cairo ignorano totalmente il commercio del grano, probabilmente in mano a mercanti musulma-ni. Il ruolo dell’isola come fonte principale di granaglie è ribadito ancora nel XII secolo dalle fonti d’archivio, soprat-tutto genovesi. Per queste problematiche cfr. BRESC 1993 ed ABULAFIA 1991. Il commercio dello zucchero, inveceè attestato occasionalmente nelle Fatwas in un documento del 944-45 in cui si ricorda una fornitura di questo alimen-to ai pasticceri di Kairouan, cfr. BRESC 1993, p. 295.
131 BRESC 1993, p. 293: Mahdiyya distava dalla costa siciliana 155 miglia, Iqlîbiyya 89 miglia, Pantelleria 62.
da mercanti ebrei ben organizzati che provvedevano alla domanda di prodotti agricoli dei merca-ti nord africani132. Essi si servivano della Sicilia quale base per il loro commercio internazionale133.
Tra il X ed il XII secolo le direttrici dell’economia mercantile siciliana attestate dalle fon-ti, sono quelle del commercio tradizionale: da una parte quello con l’Africa ed il Levante, dal-l’altra quello con la Spagna ed il Tirreno134. Le lettere della Geniza infatti, documentano col-legamenti giornalieri con i porti nord africani di Tripoli ed Alessandria e con la Palestina135.Molto prima della conquista normanna, l’isola in età islamica è il mercato della frutta e delvino della Campania e la moneta siciliana è considerata unità di misura per gli amalfitani. Perquanto riguarda la penisola italiana, le città ricordate nelle lettere della Geniza sono Amalfie talvolta Salerno, porti in cui i mercanti ebrei potevano passare l’inverno se i loro affari lorichiedevano136. Altri centri della costa orientale adriatica - Bari, Otranto ed Oria - anche sevengono citati nelle lettere della Geniza, non lo sono mai in riferimento a relazioni commer-ciali, tanto che trova conferma l’ipotesi che queste avessero rapporti diretti con la Grecia econ Bisanzio senza l’intermediazione dell’Egitto o della Tunisia137.
Nell’XI secolo, i principali porti dell’isola, così come si può dedurre dalle Lettere della Ge-niza, sono Palermo e Mazara. Mazara, infatti, è il punto di arrivo di molte delle merci pro-venienti dall’Egitto, da Mahdia o da altri porti della Tunisia ed è il porto che relaziona Ales-sandria ad Almeria; anche le mercanzie dirette in Oriente potevano transitare da questo sca-lo. Tuttavia, in questo periodo, il ruolo dominante nei commerci dell’isola sembra essere sta-to svolto dal porto di Palermo che era considerato il fulcro delle rotte mercantili del Medi-terraneo: le attività economiche vi prosperavano ed era luogo di scambio di merci e tappa peri viaggiatori provenienti da ogni parte del Mediterraneo138. Che i mercanti stranieri visitasse-ro l’isola si evince dalle lettere della Geniza, dove nel 1064 è attestata la presenza di commer-cianti bizantini nella città di Palermo139.
Le merci importate nell’isola citate nelle lettere della comunità ebraica erano soprattuttolino egiziano e nord africano, pepe ed altre spezie come la cannella, la mirra, il mirabolano(usato in conceria), aromi e profumi come l’aloe, la canfora, la gomma mastice. Inoltre veni-vano acquistate erbe medicinali, legni odorosi, sostanze chimiche ed una varietà di materialiusati per le manifatture ad esempio borace (usato per le saldature nell’industria metallurgica,
132 D. Abulafia, osservava che una simile organizzazione del mercato non destò l’interesse dei mercanti tirrenici, cheper lungo tempo si tennero lontani dalle coste siciliane.
133 ABULAFIA 1991, p. 92.134 Nelle Fatwas infatti, fin dal X secolo, sono documentate sia la rotta che dalla Sicilia portava alla Spagna che quella ver-
so Sousse e la costa tunisina. Cfr. IDRIS 1961, p. 237, n. XXX, dove si parla di un naviglio noleggiato per fare il viaggio dal-la Sicilia alla Spagna durante la buona stagione; IDRIS 1961, p. 237, nr. XXXIV; infine, cfr. IDRIS 1961, p. 234, dove citaun documento del 1141 in cui si narra di un mercante che affida dei soldi ad un marinaio per fare degli affari in Sicilia. Que-sti, infatti, era solito fare per mare il tragitto tra la costa africana e la Sicilia anche se era infestato dai pirati cristiani.
135 Una lettera ci informa che nell’XI secolo era più agevole partendo da Alessandria, raggiungere Tripoli facendo sca-lo a Palermo, dal momento che a quel tempo vi erano collegamenti giornalieri da questo porto verso la costa africana,cfr. GOITEIN 1971b, p. 16. Per le informazioni sulla Palestina cfr. SIMONSOHN 1997, p. XII.
136 GOITEIN 1971b, p. 12137 GOITEIN 1971b, p. 13138 GOITEIN 1967, p. 10. Palermo era chiamata durante il periodo della dominazione islamica, Siqilliyya ovvero Sici-
lia o Madinat Siqilliyya ovvero la città della Sicilia o più frequentemente al-Medina (città). Il nome Palermo diviene piùfrequente in età normanna. Le navi spagnole usavano questo scalo sulla rotta per l’Oriente. ABULAFIA 1991, p. 92.
139 SIMONSOHN 1997, pp. XX e XXIX.
78
79
nonché nell’industria del vetro e degli smalti), indaco, perle e perline, gioielli e pietre prezio-se e semipreziose; ancora si importavano olio d’oliva, zucchero, sapone e cera140.
Diversamente che per i mercanti ebrei, non abbiamo notizie sulle famiglie dei mercantimusulmani che certamente numerose dovettero abitare nella città di Palermo. Le cronachedel 947 fanno riferimento ad una famiglia patrizia molto potente di origine persiana, i Banûat Tabarî, attiva a Palermo141; di questa H. Bresc asserisce si trattasse di un gruppo familiaredi mercanti142. In realtà, le fonti in nostro possesso non ci informano sulle attività svolte daiBanû at Tabarî. L’unico indizio per ipotizzare che si sia trattato effettivamente di una fami-glia di mercanti riguarda la presenza di «consorti» in vari paesi, che farebbe pensare alle nu-merose sedi commerciali ed alle relazioni tra partners in analogia con il modello desumibiledai documenti della Geniza sui mercanti ebrei143. Questo tipo di organizzazione stava alla ba-se degli scambi mediterranei di quel periodo144.
Nella metà dell’XI secolo, in concomitanza con le guerre civili che tormentavano la Sici-lia e che determineranno, qualche decennio più tardi, l’arrivo dei Normanni, sono riportatidalle Lettere della Geniza grandi spostamenti di persone dalla Sicilia verso l’Egitto145. Ad Ales-sandria ed a Fustat durante il X secolo, ma soprattutto nell’XI, sono attestate grosse comu-nità, vere e proprie colonie, di ebrei siciliani, caratterizzate da una grande mobilità e che pren-dono parte ad una fitta rete di relazioni commerciali tra l’isola e la costa africana146.
Durante il XII secolo, con la dominazione normanna, la Sicilia e l’Italia meridionale ven-gono relegate ad un ruolo mercantile sempre più marginale. Le navi spagnole, francesi e del-l’Italia settentrionale cominciano ad avere rapporti diretti con i mercati egiziani, senza l’in-termediazione dei porti del Tirreno meridionale147. Gli scambi con l’Egitto ed il Nord Afri-ca, fiorenti nei due secoli precedenti, decrescono moltissimo anche se non cessano del tutto148.Una riprova della continuità di queste relazioni commerciali ci viene dall’anfora PPA 164 bisrecuperata in uno degli edifici normanni di Palermo, proveniente, come abbiamo visto, dal-l’Egitto e dalla giara gerbina PPA 165 bis.
140 SIMONSOHN 1997, p. XXIX; malgrado la Sicilia fosse da tempo immemorabile produttrice di olio in periodo isla-mico, a partire dal IX secolo fino al XII, importava olio dall’Africa, divenuta la fonte principale di questo bene. Oltre algià citato episodio dell’880 in cui i bizantini fecero grande bottino di olio, cfr. supra, pp. 70 e s., Amari nella sua Storiacita Al-Bakri per l’esportazione da Sfax di olio diretto in Sicilia nell’XI secolo o ancora un documento del 1134 in cui siparla di grano inviato dalla Sicilia all’Africa per ricavarne dell’olio ed altre derrate (AMARI, Storia, I, pp. 205-206).
141 AMARI Storia, II, pp. 240-247; AMARI BAS, I, pp. 416-419 e II, pp. 193-195. Di origine persiana, appartenentiagli ottimati della città «eran tra i primi della gamâ’ah», ovvero della società municipale (I, p. 416), sono ricordati dal-le fonti islamiche perché nel 947-48 furono a capo di una rivolta popolare contro l’emiro Ibn Attaf ed il suo successo-re Al Hasan Ibn Ali, mandato in Sicilia nello stesso anno dal califfo fatimida Al Mansur.
142 BRESC 1993, p. 291. l’A. non spiega l’origine della sua affermazione ed ipotizza che essi commerciassero inmerci preziose.
143 STILMANN 1973. Dove si analizza, attraverso la corrispondenza, il volume d’affari di una delle famiglie più im-portanti di mercanti ebrei di Fustat vissuta nell’XI secolo.
144 AMARI, BAS, I, p. 417. 145 GOITEIN 1967, p. 315; GOITEIN 1971b, p. 16: Durante l’estate di un anno non ben precisato della metà dell’XI
secolo, sono arrivate nel porto di Alessandria provenienti da Palermo 10 navi con a bordo ciascuna 500 passeggeri equesto afflusso era considerato normale.
146 Dalle lettere della Geniza si evince, infatti, che i membri di questa comunità viaggiano molto tra la costa africanae la Sicilia, trascorrendo anche lunghi periodi nelle altre sedi del loro commercio.
147 GOITEIN 1971b, p. 16.148 SIMONSOHN 1997, p. XLI.
83
CAPITOLO II
Le anfore di produzione locale(X-XI secolo)
Fino ad oggi sono del tutto sconosciute le produzioni locali siciliane dei primi secoli delmedioevo, mancano infatti tipologie ancorate a dati stratigrafici e non si conoscono icentri di produzione. Inoltre, fatta eccezione per Brucato, Monte Iato e Segesta, non
sono disponibili edizioni sistematiche di scavi siciliani che abbiano restituito fasi di vita me-dievali e per moltissimi siti si hanno soltanto segnalazioni di rinvenimenti di superficie diffi-cilmente classificabili per mancanza di dati quantitativi e qualitativi dei reperti.
In quest’ottica non può sfuggire l’importanza della scoperta ad Agrigento di un impiantoartigianale che produceva ceramica comune1, nonché del cospicuo gruppo di forme acrome,di sicura produzione locale, provenienti da recenti scavi sistematici e dalle volte di alcuni edi-fici normanni di Palermo. Questi ultimi recipienti, databili con certezza nell’arco del XII se-colo, sono oggi conservati nella Galleria Regionale di palazzo Abatellis.
2.1 LA PRODUZIONE PALERMITANA
I recenti scavi nella Sicilia occidentale in contesti archeologici sicuramente datati all’età isla-mica (X-XI secolo)2 e lo studio sistematico delle anfore di produzione locale recuperate a Paler-mo sopra le volte di alcuni edifici normanni3 ci hanno consentito di ampliare il repertorio forma-le e decorativo, già in parte noto, della ceramica dipinta prodotta a Palermo. Inoltre è stato pos-sibile proporre una prima classificazione di questa classe di materiali, nel tentativo di coglierne
1 Per quel che riguarda la produzione delle fornaci di Agrigento si fa riferimento al volume Agrigento II. Da ultimovedi ARDIZZONE 2010 con bibliografia precedente.
2 In particolare ci riferiamo a quelli effettuati a Palermo nel Rione Castello San Pietro, (cfr. ARCIFA et alii 1985-87; PE-SEZ 1995; ARCIFA 1997) e a Casale Nuovo nel territorio di Mazara del Vallo (MOLINARI - VALENTE 1995), mentreper gli scavi ancora inediti di Via Torremuzza e di palazzo Rostagno, particolarmente significativi ai fini della nostra ricer-ca, ed a quelli eseguiti fuori dalla città in Contrada San Nicola a Carini (PA), cfr. infra, Capitolo III, p. 175 e ss.; p. 182). Loscavo di quest’ultimo sito, ancora inedito, è stato condotto sotto la direzione della dott.ssa C. Greco della SoprintendenzaBB.CC.AA. di Palermo. Attualmente le anfore medievali provenienti da questo sito sono in corso di studio da parte di chiscrive su gentile incarico della dott.ssa Greco. Devo alla sua cortesia le informazioni relative alle indagini archeologiche.
3 Si tratta dei rinvenimenti avvenuti alla fine del secolo scorso durante i lavori di restauro delle chiese di San Giovan-ni degli Eremiti, S. Maria dell’Ammiraglio (La Martorana), la Cappella Palatina, San Cataldo, San Giacomo la Mari-na, il padiglione reale della Zisa ed il Monastero della Martorana, cfr. infra Capitolo III, pp. 182-188, per l’ubicazioneall’interno del perimetro urbano di questi edifici vedi fig. 130; le anfore ivi recuperate e conservate nella Loggia dellaGalleria Regionale di Palazzo Abatellis non sono state mai oggetto di studi sistematici ed una sommaria indicazione
84
l’evoluzione morfologica dal periodo della dominazione islamica dell’isola (inizi del X secolo)fino alla progressiva sparizione avvenuta nel corso della seconda metà del XII secolo4.
Benché in questo periodo le vicende storiche siciliane vedano il passaggio dalla domina-zione islamica a quella degli Altavilla, si registra tra i due periodi nelle produzioni ceramicheisolane una continuità ed una omogeneità, determinate dal sostanziale carattere islamico del-la cultura materiale in età normanna. Questa circostanza ci consente infatti di considerare laproduzione unitariamente nei due momenti storici e di seguirne lo sviluppo, verso la sempli-ficazione sia delle forme che dei motivi decorativi, in linea con la tendenza riscontrata nell’e-voluzione di tutta la produzione isolana di ceramica medievale5.
La ceramica dipinta costituisce una delle classi ceramiche maggiormente documentata neicontesti archeologici della Sicilia occidentale della fine del X - prima metà XII secolo; essacomprende soltanto forme chiuse, piccole brocche con filtro, bottiglie ed anfore di piccole emedie dimensioni, caratterizzate dalle pareti a cannelures, decorate con motivi dipinti inrosso/bruno o bianco a seconda del colore di fondo del vaso. Talvolta infatti, le superfici sipresentano schiarite da un sottile velo d’argilla, talaltra sono brunite per effetto della cottu-ra o ricoperte da un’ingobbio scuro.
La presenza sulle volte degli edifici normanni palermitani di scarti di lavorazione, come dimo-strano le evidenti malformazioni, le crepe e le bolle di cottura presenti sulla superficie dei vasi6, dasola ci fa certi dell’esistenza nel territorio palermitano di fornaci che producevano anfore e broc-che dipinte. Era infatti la vicinanza ai centri di produzione e la facilità di reperire in loco i manu-fatti fittili di scarto che ne rendeva particolarmente economico l’uso in architettura. Un’ulterio-re conferma indiretta della produzione locale di questi recipienti ci viene dall’analisi macroscopi-ca dell’impasto di tutte le anfore pertinenti per forma e decorazione a questa produzione che harivelato caratteristiche comuni: colore oscillante dall’arancio (2.5YR 6/6) al rosso (10R 5/8), do-vuto alla variabilità della temperatura all’interno del forno. L’impasto duro, compatto e depura-to presenta inclusi bianchi di piccole dimensioni ad alta frequenza, medi e grandi a bassa frequen-za, talora visibili anche sulla superficie esterna dei vasi, grigi di piccole dimensioni a media fre-quenza, grandi e rari di colore grigio; l’uso di calcinelli molto grandi avrebbe determinato inquesta produzione un’alta percentuale di oggetti mal riusciti, attestata d’altro verso dall’eleva-ta percentuale di scarti di fornace nelle volte normanne7. Le analisi mineralogiche petrografiche,
delle tipologie colà rinvenute sono state fornite attraverso le foto dei manufatti in varie circostanze: per citare soltan-to le più note cfr. D’ANGELO 1971, fig. 10 e SCERRATO 1979, figg. 186-190, pp. 420-421. Le anfore recuperate al-la Zisa nel 1972 sono state oggetto di studio, cfr. D’ANGELO 1976 che ne ha fornito una schematica tipologia attra-verso una documentazione fotografica e ARDIZZONE 1999.
4 Gli esemplari più tardi provengono dalle volte del Monastero della Martorana la cui fondazione si data al 1193,cfr. infra, Capitolo III, p. 186.
5 Sia A. Molinari che L. Arcifa, infatti, osservano questa tendenza nelle ceramiche invetriate siciliane di XII seco-lo, che raggiungerà l’acme nel periodo della dominazione sveva, quando si può osservare una netta semplificazionesia delle forme che dei motivi decorativi ed un impoverimento tecnico delle manifatture determinato dalla diasporadell’elemento musulmano della popolazione isolana, cfr. MOLINARI 1994b, pp. 105 e s. e ARCIFA 1998a, p. 277;ARDIZZONE - ACIFA 2009.
6 Tutte le deformazioni e le crepe presenti sulla superficie di queste anfore si sono verificate al momento della cottu-ra nel forno. Alcuni degli scarti di fornace, qui presi in esame, presentano la decorazione dipinta sulla superficie, poi-ché questa veniva eseguita prima della cottura. Devo questa informazione al prof. T. Mannoni.
7 Per le caratteristiche tecniche cfr. infra, Appendice 3, pp. 335-340; i grossi calcinelli, infatti determinavano al mo-mento della cottura le bolle o le grandi crepe visibili sulle superfici di molti degli esemplari presenti sulle volte.
85
effettuate su un campione di quattro frammenti recuperati sulle volte dalla Zisa e su un cam-pione di due forme chiuse più antiche - che come vedremo presentano caratteristiche morfo-logiche e decorative analoghe - provenienti da Carini, hanno anch’esse confermato l’originepalermitana di questi manufatti8. Negli impasti, infatti, sono presenti elementi litici riferibi-li alle formazioni rocciose affioranti nei dintorni di Palermo; in particolare i campioni ana-lizzati hanno caratteri compositivi simili a quelli delle “argille di Ficarazzi”, caratterizzatedalla presenza di abbondante fauna fossile. Questi depositi argillosi affiorano in diversi pun-ti della piana di Palermo ed in particolare vicino la costa nel tratto terminale del fiume Ore-to9 ed il loro sfruttamento è registrato nei documenti d’archivio almeno dal XIV secolo10. In-fine, la presenza di officine di ceramisti a Palermo è nota sia dalle fonti archivistiche sia da in-dagini archeologiche (fig. 29). Come ricordava il Di Giovanni, un documento del 1213 atte-stante la vendita di un casaleno «situm extra Cassarum Panormi in contrata quae dicitur hak-bitilfacha», dall’arabo aqabat al-fahhar ovvero salita della giara, ci informa che a Palermo nelXIII secolo esisteva un’intera contrada così denominata dove si produceva ceramica11. Il DiGiovanni, poi riferendosi allo stesso sitolo localizza tra Santa Maria La Grutta e la Sinagogadei Giudei12 in un’area ricca d’acqua perché interessata dal corso del fiume Kemonia, e lo iden-tifica quale sede già nell’XI secolo, di un centro artigianale dove si producevano vasi fittili,dal momento che in un documento del 1094 (anno ab origine mundi 6602)13 ricorre il toponi-mo arabo Phachaer «luogo dè forni e fabbriche di terre cotte» equivalente al siciliano stazzu-ni qual è il nome attuale di una strada nelle vicinanze14. Lo stesso luogo viene ricordato neidocumenti più tardi del XIII e del XIV secolo come Quartariorum dal termine Quartara,
8 I quattro campioni analizzati provenienti dalla Zisa sono pertinenti ai tipi A1 (Inv. 27216), A2 (Inv. 27233), E1 (Inv.27210), E2 (Inv. 27213), i due campioni rinvenuti a Carini sono frammenti di pareti con decorazione dipinta, senza unparticolare riferimento alla forma. Essi appartengono rispettivamente ad un recipiente con decorazione a fasce verticalialternate ad una linea sinusoidale continua, ritenuto dalla Arcifa come precipuo delle forme più antiche del X secolo (AR-CIFA 1998a, p. 279), ed al tipo con fasce verticali alternate a piccoli tratti obliqui documentato sui recipienti a partire dal-la fine del X secolo fino alla seconda metà del XII secolo. Ringrazio la dott. C. Greco per queste preziose informazioni.
9 Cfr. ALAIMO - GIARRUSSO in ARDIZZONE 1999. 10 D’ANGELO 1971, p. 396, nota 5: Archivio di Stato di Palermo (d’ora in avanti ASP), Notai Defunti, I stanza, Not.
Ruggero Citella, vol. 76, f. 51, 15 novembre 1326: Bartolomeo de Marci affitta al maestro Gualtero Rubeo celamidarius lasua vigna vicina al ponte dell’Ammiraglio «ad fodendum, capiendum, extraendum ad opus fundaci celamidarie» tutta lacreta che vuole per un anno. Il ponte dell’Ammiraglio si trova presso la foce del fiume Oreto. D’ANGELO 1971, p. 400:Nel 1418 il maestro Lencio Vulpi che ha la bottega all’Albergheria vicino al fiume (ASP, Notai defunti, not. Antonio Bru-no, vol. 553, 12 dicembre 1413), vende una carrozza a Chicco Tricotta in cambio di alga da Porta dei Greci e creta dal Pon-te dell’Ammiraglio e dalla foce del fiume Oreto (ASP, Notai Defunti, not. Giovanni Traverso, vol. 765, 22 marzo 1418).
11 DI GIOVANNI 1889-1890, II, p. 109; I, pp. 66-67, nota 1; RAGONA 1979, p. 601.12 Oggi compreso tra l’odierna Casa Professa e la chiesa di San Nicolò di Tolentino. Come ebbe a notare il Ragona
questo quartiere si trovava molto vicino alla chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (La Martorana) da cui provengo-no alcuni scarti di fornace che presentano lo stesso impasto delle anfore della Zisa. RAGONA 1979, p. 601.
13 Pubblicato con la data errata del 1183 da GARUFI 1899, p. 195-6, segnalazione della dott.ssa Elena Pezzini.14 DI GIOVANNI 1889-1890, p. 108 nota 1, poi ripreso da DE SIMONE 1968, p. 174, nota 196, da CARACAUSI
1983, p. 209, nota 228 che ubica la contrada nei pressi del fiume Papireto e infine da ARCIFA 1996, pp. 473-474, nota40 che, forte del riferimento contenuto nel documento del 1094 alla judeorum Synagoga, localizza correttamente la con-trada nel rione dell’Albergheria nelle vicinanze della chiesa di San Nicolò di Tolentino, cfr. DI GIOVANNI 1889-1890, II, p. 109. Ancora un’altra indicazione alla contrada detta Judayca è in D’ANGELO 1971, p. 395, nota 3: ASP,Notai defunti, Not. Adamo da Citella, f.1, 15 febbraio 1299: Jacopo e Leonardo celamidari, figli del fu Peregrino cela-midario, vendono un fondaco pro celamidario all’Albergheria, in contrada Judayca vicino al monastero della Chiesa diSanta Maria de Marturano.
86
ossia brocca o anfora15. Alla fine del XIV secolo le fornaci attestate dai documenti sono fuori lemura lungo le sponde del fiume Oreto16, presso le cave dove abbiamo visto veniva prelevata l’ar-gilla per l’attività ceramica.
Fin qui i dati desumibili dalle fonti documentarie; le attestazioni archeologiche sull’atti-vità di forni per la ceramica sono limitate a qualche rara e sporadica segnalazione: il rinveni-mento occasionale di scarti di produzione lungo la strada che costeggia il porto di Palermotutti databili alla prima metà dell’XI secolo, fanno supporre l’esistenza di una fornace neipressi dell’antico porto della città17, mentre recenti indagini archeologiche lungo il corso delfiume Kemonia, nell’area presso la Porta Mazara ancora nell’XI secolo extra moenia, hannorilevato la presenza di una fornace attiva tra l’XI ed il XII secolo che produceva ceramica in-vetriata ed acroma, tra cui vasi con filtro con decorazione sovraddipinta in bianco18.
15 In un documento del 1276 viene menzionato un certo Thomasuis de Mistrecta quartararius cfr. Tabulario della Ma-gione nr. 140, regesto in PEZZINI 1998b, p. 747 nota 116; D’ANGELO 1971, p. 399 cita due documenti uno del 1337ed uno del 1373 in cui si parla di botteghe di quartararii ubicate in quell’area della città. Nei documenti d’archivio del-la fine del secolo XIII e dei secoli successivi viene fatta una distinzione tra celamidarii ovvero fabbricatori di celamidesuna varietà di tegole e quartarari ovvero produttori sia di vasellame d’uso domestico sia di tegole D’ANGELO 1971, p.395. Mentre nei documenti normanni scritti in arabo i ceramisti vengono indicati con il nome al-garamade ossia “fab-bricatori di tegole” cfr. CUSA 1868-1892, p. 284, col.2; 16.320; 16.354 devo questa segnalazione alla dott.ssa A. Nef.
16 D’ANGELO 1971, p. 397, nota 9: Nel 1366 il maestro Manfredo celamidarius prende in affitto una calcaria nella con-trada Fluminis de Admirato, cfr. ASP Spezzoni Notarili, n. 99, not. Andrea Nubula, 17 maggio 1366, in particolare vicino lavigna di Giovanni Chiaramonte e paga in natura con 200 tegole. Ancora nel 1372 ricorre la stessa fornace di Porte Therma-rum ossia presso il ponte dell’Ammiraglio, ASP. Spezzoni Notarili, n. 100, not. Andrea Nubula, 18 dicembre del 1372.
17 Si tratta di forme aperte, scarti di prima cottura e di grumi d’argilla stracotti, D’ANGELO 1986.18 ARCIFA 1996.
Fig. 29 - Pianta di Palermo con l’ubicazione delle aree destinate alla lavorazione della ceramica citate dalle fontiarchivistiche o documentate da rinvenimenti archeologici.
87
2.2 LE ANFORE DI X SECOLO
Gli esemplari più antichi di ceramica dipinta di sicura produzione palermitana fino ad oranoti, sono stati recuperati a Palermo nello scavo del Rione Castello San Pietro in un conte-sto datato alla prima metà del X secolo (fig. 30, 6-9)19. Si tratta di anfore riconducibili a tre for-me20, caratterizzate dalle pareti percorse da cannelures, più larghe rispetto agli esemplari piùrecenti, e da una decorazione dipinta il cui ordito decorativo è costituito soltanto da fasce ver-ticali alternate a linee sinusoidali continue. Solo un esemplare tra quelli recuperati presentaun motivo dipinto a cerchi allacciati21, confrontato da L. Arcifa con motivi decorativi analo-ghi documentati sulle forme chiuse dell’Italia Meridionale e della Sicilia Orientale, ricorren-ti nei contesti dello stesso periodo22.
Diamo qui di seguito una breve descrizione di questi tre tipi di contenitori: - il primo presenta il collo di forma cilindrica con l’orlo ingrossato a mandorla e le anse a
sezione ovoidale (fig. 30,6); - il secondo ha il collo sempre di forma cilindrica anche se rispetto al precedente è meno
sviluppato in altezza e con un diametro maggiore, l’orlo è ingrossato, con un sottile solco sul-la parte superiore e sporge all’interno e le anse sono a sezione ovoidale (fig. 30,7);
- infine, il terzo mostra un collo di forma tronco-conica più o meno delle stesse dimensio-ni del precedente e presenta l’orlo ingrossato a sezione triangolare (fig. 30,8).
Le forme di queste anfore, poco leggibili nel complesso per la mancanza di esemplari interi,presentano come caratteristica peculiare i fondi umbonati con diametro maggiore rispetto alleanfore ovoidali attestate con più frequenza nei livelli di XI secolo (fig. 30,9). Pertanto è proba-bile che in questa fase ricorrano più facilmente le anfore di forma globulare simili al tipo PPA102 (fig. 37) attestato nello stesso sito nei livelli di fine X - prima metà XI secolo (fig. 30,10)23.Gli esemplari descritti mostrano stringenti somiglianze, con alcune delle forme prodotte dal-le fornaci di Agrigento, databili nell’ambito del X secolo24.
19 La provenienza palermitana di questi manufatti è stata confermata dalle analisi mineralogico petrografiche effet-tuate su campioni. Anche in questo caso infatti sono state adoperate le argille del fiume Oreto. Devo queste infor-mazioni alla cortesia della dott.ssa L. Arcifa. Le UUSS da cui provengono questi materiali sono datate alla prima metàdel X secolo per la mancanza di ceramica invetriata e la compresenza di un frammento di Forum Ware e di lucerne apiattello e serbatoio a cupola. Sulla ceramica invetriata cfr. ARCIFA - BAGNERA - NEF 2012.
20 Purtroppo non si conoscono le forme intere dal momento che sono stati recuperati soltanto frammenti di collo edi larghi fondi umbonati, cfr. ARCIFA 1998a, tav. I, a nrr. 6-9.
21 Anche in questo caso la produzione palermitana è stata confermata dalle analisi mineralogico petrografiche chehanno rivelato nella fabbricazione del pezzo l’impiego delle argille prelevate alla foce del fiume Oreto. Ringrazio perl’informazione la dott.ssa L. Arcifa.
22 ARCIFA 1998a, p. 279, nota 12, dà notizia della presenza di materiale analogo, cfr. ARCIFA - ARDIZZONE 2009.23 Cfr. infra, pp. 114-115; 143-144.24 Cfr. ARDIZZONE in Agrigento 2007, fig. 29 e fig. 31, 89-27; ARDIZZONE 2010.
89
2.3 LE ANFORE TRA LA FINE DEL X E L’XI SECOLO
Dalla fine del X e per tutto l’XI secolo, nella produzione ceramica palermitana è stato pos-sibile evidenziare una continuità nella tradizione morfologica. Dalla nostra analisi è emersa,all’interno di questo continuum, la tendenza evolutiva verso la progressiva semplificazionedei particolari e dei motivi decorativi, ancora più evidente nei prodotti normanni. Nel reper-torio già definito delle forme non si registrano cambiamenti di rilievo e l’unica eccezione sem-brerebbe essere l’anforetta con filtro e beccuccio/versatoio con la decorazione sovraddipin-ta in bianco su ingobbio rosso o bruno/nero, per la quale è stata avanzata l’ipotesi che la suaprima comparsa sia da mettere in relazione con l’inizio della produzione a Palermo della ce-ramica invetriata, verosimilmente introdotta sul finire del IX secolo da maestranze venutedirettamente dal Nord Africa25.
Partendo dall’esame dei campioni forma isolati tra il materiale dello scavo di Contrada SanNicola a Carini26, integrati con quelli recuperati durante le indagini archeologiche in Via Tor-remuzza a Palermo, si sono ampliate le nostre conoscenze sui tipi ricorrenti tra la fine del Xe l’XI secolo. Inoltre, si è tentato di istituire un parallelo con i tipi documentati in periodonormanno al fine di poterne cogliere l’evoluzione non solo dal punto di vista delle decora-zioni, ma soprattutto da quello delle forme. Sulla base di questa comparazione si è potuta giu-stificare la cronologia più alta di un gruppo di anfore provenienti dalle volte della chiesa diSanta Maria dell’Ammiraglio (La Martorana) a Palermo databili per il contesto ai primi de-cenni del XII secolo ed inserite in questo paragrafo.
Fatta questa premessa iniziamo la descrizione dei materiali recuperati a Carini integrandodi volta in volta i dati forniti con quelli desumibili dallo scavo di Via Torremuzza che ha re-stituito le stesse identiche forme attestate in Contrada San Nicola.
Come abbiamo già avuto modo di precisare, in questa sede abbiamo preso in considera-zione soltanto i materiali provenienti dal SAS II dal momento che solo in questo saggio so-no stati recuperati i livelli di frequentazione relativi alla fase islamica del sito. Occorre pun-tualizzare che di questi contenitori disponiamo unicamente degli orli, che tuttavia confron-tati con le anfore integre provenienti da altri contesti, ci hanno permesso nella maggior par-te dei casi di risalire alle forme intere.
La maggior parte dei contenitori da trasporto recuperati nel SAS II presentano impastiuguali al punto da permetterci di considerarli unitariamente e sono di produzione palermi-tana come hanno dimostrato le analisi mineralogico petrografiche effettuate su due campio-ni significativi. Le forme attestate trovano confronti precisi sia per la morfologia che per imotivi decorativi con il materiale fittile rinvenuto nei contesti noti della Sicilia occidentale
25 ARCIFA - BAGNERA - NEF 2012.26 Entrambi i gruppi di reperti sono ancorati ad una sequenza stratigrafica affidabile e sono databili all’ultimo secolo
della dominazione islamica. In contrada San Nicola a Villagrazia di Carini sono state rinvenute, sotto un crollo di te-gole e travi di legno ancora in situ, numerosi frammenti di anfore dipinte in associazione con materiale datante: dueframmenti di lucerne a piattello e serbatoio a cupola di cui una invetriata e numerosi frammenti di catini invetriati inprevalenza carenati con orli ingrossati confrontabili con le forme databili tra la fine del X e tutto l’XI (US 15). Cfr. in-fra, Capitolo III, p. 175 e ss. Tutte le informazioni sulla ceramica invetriata e sulle lucerne mi sono state gentilmentefornite dalla dott.ssa I. Garofano che sta studiando queste classi di materiali.
90
della seconda metà del X - XI secolo. Si distinguono per l’impasto solo due frammenti di or-lo: il Tipo CSN 127 ed il Tipo CSN 12 (fig. 32)28, per i quali non abbiamo elementi probantiper precisarne la provenienza.
Alla luce di quanto detto tratteremo qui di seguito le anfore di Carini unitariamente, rag-gruppandole secondo il criterio della funzione dei recipienti, ipotizzata essenzialmente sullabase delle dimensioni, della morfologia del collo e dei confronti con i tipi più tardi di cui siconosce la forma intera.
Gruppo I: si tratta di grandi contenitori (Tipi CSN 10; CSN 9; CSN 7 figg. 31), che pre-sentano come caratteristica la larga imboccatura (diametro cm 16 circa), collo non molto al-to, quasi cilindrico o leggermente tronco-conico, orlo ingrossato a mandorla segnato all’e-sterno da uno o più solchi. Forme siffatte erano destinate, con molta probabilità, a contene-re granaglie, frutta secca di una certa dimensione (carrube, fichi secchi, ecc.) o pesce salato29.Questo tipo di recipiente trova confronti puntuali con anfore di dimensioni leggermente piùgrandi recuperate nei livelli di XI secolo a Casale Nuovo (Mazara del Vallo)30, con i conteni-tori del tipo C del relitto normanno di San Vito Lo Capo (TP) (fig. 31)31, con un’anfora resi-duale ritrovata a Segesta32 e con un esemplare proveniente dallo scavo del Museo Archeolo-gico Regionale di Palermo33. Nel contesto carinese questo tipo di recipiente ricorre soltantonell’US 934. I nostri contenitori, come ci si può aspettare, presentano la stessa abbondanza diparticolari decorativi nella morfologia degli orli, quali le solcature sulla fascia esterna, carat-teristica, delle produzioni locali riferibili all’età islamica e databili nell’ambito dell’XI seco-lo. Questa ricchezza di particolari, nervature e solchi, si perde nei prodotti più tardi delle of-ficine normanne, dove come vedremo prevalgono le forme semplificate.
Gruppo II: comprende una serie di anfore con larga imboccatura (diametro circa cm 12)(Tipi CSN 21; CSN 18; CSN 2; CSN 8; CSN 12; CSN 14; CSN 15; CSN 24, figg. 31-32), do-cumentate a Carini soltanto nelle UUSS 15 e 16 databili tra la fine del X secolo e la prima metàdell’XI35. Si tratta di contenitori con orlo ingrossato a sezione triangolare, verticale, segnato al-l’esterno da uno o più solchi; collo atrofizzato collegato con la spalla attraverso una nervatura
27 Impasto di colore arancio granuloso, poco depurato. Si tratta di un recipiente dotato di larga imboccatura (diame-tro cm 22), con breve collo cilindrico, orlo ingrossato all’esterno a sezione semicircolare e parete percorsa da un fasciodi sottili linee ondulate incise prima della cottura.
28 L’impasto di questa anfora è di colore rosso violaceo, poco depurato, con inclusi bianchi calcarei di medie dimensio-ni ad alta frequenza. Le superfici esterne si presentano leggermente schiarite. Si tratta di un’anfora con collo atrofizzato,orlo a sezione leggermente triangolare con una grossa nervatura all’esterno. Il diametro dell’orlo è di cm 10.
29 L’esportazione dalla Sicilia di frutta secca soprattutto mandorle e pistacchi è attestata dalle fonti contemporanee (GOI-TEIN 1967, p. 121, nota 39; SIMONSOHN 1997, p. XXX). Per quel che riguarda in particolare il territorio di Carini, sap-piamo dalle fonti islamiche che era rinomato proprio per la produzione di mandorle, fichi secchi e carrubbe (cfr. Idrisi, inAMARI BAS I, p. 83; infra, Capitolo III). Questo dato rafforza l’ipotesi di siffatta destinazione per questi grandi contenitori.
30 MOLINARI-VALENTE 1995, p. 417, tav. III, 12.31 Cfr. FACCENNA 2006, fig. 41. Il tipo C comprende un gruppo di 13 anfore con il diametro orlo notevolmente
più ampio di quelle di Carini, compreso tra i cm 24 e 30. Alcuni esemplari presentano sul collo dei motivi ad onda in-cisi prima della cottura o delle decorazioni costituite da una doppia fila di piccoli tratti obliqui. Uno degli esemplari diSan Vito, molto più completo dei nostri, presenta le anse ad orecchia e la parete percorsa da cordonature.
32 MOLINARI 1997b, tipo II.3.1, pp. 127-129, fig. 172.33 LESNES 1997, p. 44, 4 con anse ad orecchia e pareti percorse da cordonature, il diametro dell’orlo è di cm 24.34 Cfr. CARINI 1997-98.35 I tipi A2 e A8 sono stati recuperati tra i materiali della US9, mentre il tipo A24 è attestato da un solo esemplare
rinvenuto nella US 13.
92
Fig. 32 - Carini (PA), c.da S. Nicola. Anfore della seconda metà X-XI secolo. Gruppo II.
a rilievo36. Il rinvenimento di una piccola anforetta nelle acque del Canale di Sicilia (MV350),oggi conservata nel Museo Civico di Mazara del Vallo (fig. 33), che presenta la stessa morfo-logia dell’orlo e della spalla testé descritti, ci permette di risalire alla forma intera del conte-nitore anche per i piccoli frammenti di Carini. Le pareti di questo recipiente, come le altrepertinenti alla stessa produzione, sono percorse da cordonature, ma sono prive di decorazio-ne dipinta; al contrario nei frammenti di Carini le superfici siano esse schiarite o scurite pereffetto della cottura sono decorate con motivi in rosso o in bruno37. Di questo tipo di reci-piente sono attestate diverse varianti dimensionali di cui l’esemplare recuperato nelle acqueintorno a Mazara rappresenta la più piccola. Campioni della stessa forma sono stati recupe-rati nell’US 65 di Via Torremuzza in associazione con frammenti di pareti dipinte con mo-tivi a zigzag (fig. 34 D-E)38. Per questo tipo di contenitore è possibile istituire un confronto,significativo ai fini della tradizione morfologica di riferimento, con le forme chiuse della cera-mica omayyade prodotte localmente a Gerasa, dove il passaggio tra il collo e la spalla è spesso
36 Un frammento pertinente alla stessa forma proviene dai livelli di XI secolo dello scavo di Casale Nuovo a Mazaradel Vallo, cfr. MOLINARI - VALENTE 1995, tav. III, 11.
37 Lo schiarimento di superficie si può ottenere lavorando l’argilla con acqua di mare o usando per l’impasto argillacontenente una certa quantità di carbonato di calcio che cuocendo i vasi in ambiente riducente cosa che conferisce unapatina biancastra all’esterno (cfr. ARIAS - BERTI - TONGIORGI 1975, p. 141 e l’intervento di T. Mannoni in ARIAS- BERTI - TONGIORGI 1975, p. 150), mentre le superfici scurite sottoponendo i contenitori a cottura in ambienteossidante. Talvolta alcuni di questi recipienti presentano un sottile velo di argilla più chiaro per uniformare il coloredella superficie.
38 Il motivo a zigzag vedremo essere attestato nella fase intermedia di passaggio dalla decorazione a linee sinusoidalie quella ancora più semplificata dei tratti obliqui, cfr. infra, p. 122-123.
94
segnato da una nervatura a rilievo39. Indicativo in tal senso è anche la presenza di un’analoganervatura negli esemplari più tardi della cosiddetta bag amphora da cui questa forma proba-bilmente discende40. Per la loro cronologia le anfore del gruppo II possono essere considera-te i prototipi del tipo D della Zisa (fig. 45): osserviamo che negli esemplari riconducibili a que-sto tipo si sono persi, coerentemente con la tendenza evolutiva verso la semplificazione, al-cuni dettagli decorativi caratterizzanti le forme più antiche quali i solchi sull’orlo all’esternoe la nervatura tra il collo e la spalla. In quest’ottica i grandi contenitori di forma analoga con-servati al Museo di Terrasini (fig. 35) nonché l’esemplare PPA125 di Palazzo Abatellis conl’orlo segnato da due solchi concentrici41 potrebbero essere considerati come un gradino in-termedio nell’evoluzione del tipo.
È probabile, che la funzione dei contenitori di questo gruppo fosse quella del trasporto diderrate alimentari42, i vasi più piccoli potevano trasportare merci pregiate quali ad esempio ilmiele43, mentre gli esemplari più grandi aridi o pesce salato “tonnina” che potevano essereagevolmente introdotti attraverso l’ampio collo.
Gruppo III: vi appartengono le anfore (CSN 13; CSN 22, fig. 36) con collo stretto, piùadatto per trasportare e contenere liquidi; orlo leggermente ingrossato, inclinato verso l’in-terno, indistinto all’esterno; collo leggermente rigonfio con la superficie esterna decorata conmotivi lineari dipinti. Esemplari di questo tipo di recipiente sono stati recuperati a Palermodurante lo scavo del Chiostro di San Domenico44. Questi contenitori somigliano per la for-ma dell’orlo e del collo che tende a stringere notevolmente nel punto di raccordo con la spal-la, ai vasi con filtro ed alle brocche monoansate delle fornaci di Agrigento destinati entram-bi all’uso domestico ed è pertanto probabile che si tratti di forme da dispensa o da tavola. Lapresenza, tra i frammenti recuperati negli stessi strati, di fondi piani e di un piede ad anellorelativi con molta probabilità a forme chiuse con analogo impasto e decorazione dipinta, sug-gerisce l’appartenenza di questi fondi alle forme testé descritte45.
Gruppo IV: fa parte di questo gruppo l’anfora di piccole dimensioni CSN 17 (fig. 36),la cui forma, non più documentata nei contesti siciliani di età normanna, si è rivelata tipi-ca dell’ultimo secolo della dominazione islamica46. Le caratteristiche del contenitore sonol’orlo verticale, ingrossato all’esterno, separato dalla parete da un solco e da una sottile ner-vatura; il collo rigonfio particolarmente ristretto nel punto di raccordo con la spalla piana;
39 PIEROBON 1986, p. 187, fig. 10.8. Anche in un’olla della stessa fase è presente questo dettaglio morfologico fig.10.6.40 Questo tipo di nervatura nella ceramica giordana di età omayyade continua la tradizione romana precedente tant’è
che dettagli simili sono presenti nelle anfore dei III-V secolo d. C. cfr. BOWSHER 1986, fig. 20. 8-9, p. 249.41 Fig. 45. Confrontabile con questo tipo di contenitore è l’esemplare di XI secolo ritrovato a Casale Nuovo (Maza-
ra), MOLINARI - VALENTE 1995, Tav. III, 13. Cfr. per i contenitori conservati nell’Antiquarium di Terrasini PUR-PURA 1977, fig. 23, Tav. III, m-n.
42 Un elemento in tal senso è costituito dal recupero nelle acque di Mazara del Vallo dell’anforetta MV350 (fig. 33).43 Anche questo bene era esportato dalla Sicilia come ci attestano le lettere della Geniza del Cairo, cfr. SIMONSOHN
1997, p. XXX.44 Cfr. fig. 40, 16 da LESNES 1998, tav. II, 16 con decorazione dipinta in bruno.45 È molto probabile che i fondi piani siano pertinenti a piccoli contenitori usati per la mensa o per la dispensa, co-
munque per uso domestico e non per il trasporto delle derrate alimentari. I contenitori da trasporto è probabile cheavessero i fondi umbonati.
46 Nel sito di Casale Nuovo, nei livelli di XI secolo sono attestate due varianti di questa forma, cfr. MOLINARI-VA-LENTE 1995, Tav. III 15.16; inoltre dallo scavo di Via Torremuzza a Palermo provengono alcuni frammenti di orloriferibili a questa forma (UUSS 81; 80; 73; 62, figg. 44 e 50).
97
Fig. 36 - Carini (PA), c.da S. Nicola. Anfore. Gruppo III e IV.
le anse costolate impostate a metà circa del collo e le pareti percorse da cordonature e deco-rate, limitatamente alla spalla, con un ordito di linee orizzontali collegate da sottili tratti ver-ticali. Questo tipo di decorazione, ad un esame comparativo con un esemplare integro riado-perato come scarto d’uso su una delle volte degli edifici palermitani di età normanna47 e conrecipienti analoghi recuperati nei livelli di XI secolo a Castello San Pietro48, si è rivelata pe-culiare di questa forma. Nelle UUSS 15 e 16 di Contrada San Nicola sono stati recuperati nu-merosi frammenti di pareti dipinte, pertinenti con molta probabilità a questo tipo di conte-nitore, per la presenza degli stessi motivi decorativi.
È possibile che anche questa forma fosse adoperata per il trasporto di derrate alimentari co-me sembrerebbe suggerire il recupero di contenitori simili nel relitto di San Vito Lo Capo49, nelGolfo di Mondello vicino Palermo50 e nel Canale di Sicilia51. Non può essere tuttavia escluso an-che un uso domestico come si evincerebbe dal ritrovamento a Palermo di esemplari analoghi,
47 Si tratta dell’anfora PPA 102 (fig. 37), oggi conservata a Palazzo Abatellis, la cui provenienza precisa è andata perduta.48 ARCIFA 1998a, tav. I,a. 10; nel riempimento di un pozzo individuato a Palermo nell’area dell’attuale Museo Ar-
cheologico Regionale è stata rinvenuta la metà superiore priva dell’orlo di un’anfora che per il caratteristico motivodecorativo sulla spalla può essere ricondotta a questo tipo, cfr. LESNES 1997, p. 44,3.
49 Dal momento che non si conoscono il numero esatto degli esemplari qui rinvenuti, non si può tuttavia escludereche si trattasse di vasellame di bordo, cfr. FACCENNA 2006.
50 Per l’informazione sul rinvenimento di un’anfora dello stesso tipo nel deposito sottomarino di Mondello ringra-zio il Dott. S. Tusa che gentilmente mi ha permesso di prendere visione di questi materiali.
51 Un esemplare molto simile a questi, privo dell’orlo, è stato recuperato nei fondali presso Mazara del Vallo(MV 344 fig. 38).
101
Fig. 40 - Palermo, Chiostro di San Domenico. Anfore e forme chiuse di produzione palermitana (da LESNES 1998).
102
Fig. 41 - Carini (PA), c.da San Nicola. Anfore. Gruppo VI.
52 Proviene anche dal riempimento di un pozzo l’anfora dello stesso tipo rinvenuta nell’area del Museo Archeologi-co Regionale di Palermo, cfr. supra nota n. 97. La presenza di anfore all’interno di un pozzo suggerisce che queste ven-nero usate nel quotidiano come contenitori per l’acqua.
recuperati negli scavi di Palazzo Rostagno e di Castello San Pietro, all’interno di pozzi la cuifrequentazione in entrambi i contesti viene datata tra la fine del X e la metà dell’XI secolo52.L’anfora di Palazzo Rostagno è particolarmente significativa perché presenta la decorazionea linee sinuose e fasce verticali, che, come vedremo, viene considerata da L. Arcifa specificadegli esemplari di X secolo. Se questa ipotesi di datazione risulterà confermata questo manu-fatto rappresenterebbe l’esempio più antico di questa forma noto in Sicilia.
Può essere considerata una variante della forma CSN 17 il tipo CSN 20 (fig. 36) di cui siconservano cinque frammenti di orlo pertinenti ad altrettanti recipienti, recuperati nello stra-to di accumulo (US 16) sottostante il crollo individuato nel SAS II di Carini. Questo vaso dif-ferisce dal contenitore CSN 17 solo per la forma dell’orlo leggermente più affusolato, men-tre presenta tracce di decorazione dipinta in bruno secondo lo stesso ordito decorativo docu-mentato per il tipo CSN 17.
103
53 Anfore con orlo simile a questo tipo, anch’esse acrome e con diametri confrontabili con i nostri, sono stati recu-perati nel contesti di XI secolo a Casale Nuovo (Mazara), cfr. MOLINARI-VALENTE 1995, Tav. III, 9-10, p. 417. Unframmento di orlo acromo è stato recuperato in Via Torremuzza a Palermo in un contesto dell’XI secolo (fig. 39, I).Frammenti analoghi provengono dal Chiostro di San Domenico a Palermo (fig. 40), cfr. LESNES 1998, Tav.II, 17.
54 Cfr. LESNES 1997, p. 43,2. Questo esemplare è privo del fondo.55 Fig. 43 cfr. infra, pp. 124-128. La scoperta di Carini ci permette di osservare come anche in questo caso la produzione ini-
zi prima del priodo normanno, già in età islamica, per continuare progressivamente semplificata fino al XIII secolo. 56 Oggi cinque di queste anfore sono esposte nel Museo di Arte Islamica della Zisa con l’indicazione della loro pro-
venienza, mentre le altre cinque si trovano nella Loggia della Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, prive di infor-mazioni sul contesto di rinvenimento. Per le anfore attualmente conservate a Palazzo Abatellis abbiamo preferito da-re, prima del numero, la sigla PPA, mentre per quelle conservate alla Zisa con l’indicazione della provenienza dallaMartorana abbiamo dato la sigla PM. La provenienza per tutti questi esemplari dalla chiesa della Martorana trovereb-be conferma nel riferimento di G. Patricolo alla presenza di lettere arabe su alcune delle anfore rinvenute sotto la pa-vimentazione del terrazzo attorno alla cupola della Martorana PATRICOLO 1877, p. 21 « (...) tra i quali alquanti contentativi d’iscrizioni arabiche.». Per notizie sul monumento cfr. infra, Capitolo III, p. 141.
Gruppo V: vi appartengono l’anfora tipo CSN 4 e la sua variante CSN 4.2 (fig. 31). I re-cipienti di questo gruppo sono privi di decorazione dipinta, caratterizzati da un alto orlo ver-ticale, arrotondato, indistinto, separato all’esterno dalla parete mediante un solco; collo ri-gonfio percorso da cordonature eseguite al tornio53. Non abbiamo elementi sufficienti per ri-condurre gli orli di cui disponiamo ad una forma precisa anche se il recente rinvenimento diun’anfora di piccole dimensioni con l’orlo identico a questi esemplari, collo cilindrico legger-mente più stretto in corrispondenza dell’attacco della spalla, anse a sezione ovale percorse daun solco, corpo ovoidale potrebbe dare l’idea della forma54. Il tipo di labbro ed il suo diame-tro hanno strettissime analogie con l’anfora normanna Tipo A della Zisa, molto comune nel-la Sicilia occidentale ancora nei contesti della fine del XII inizi del XIII secolo55. Per questeragioni, non dovremmo essere troppo lontani dal vero nel considerare questi contenitori ilprototipo di quelli normanni anche per lo sviluppo ovoidale del corpo. Per analogia con leanfore della Zisa Tipo A ipotizziamo per questa forma un uso domestico.
Gruppo VI: Comprende le forme CSN 16 e CSN 23 (fig. 41), documentate a Carini entram-be da un singolo frammento di orlo recuperati rispettivamente nelle UUSS 15 e 16. Si tratta dianfore particolarmente interessanti per la grande raffinatezza dell’esecuzione e la ricchezza di det-tagli morfologici. Questi particolari ancora abbastanza elaborati, in un’ottica di progressiva sem-plificazione e di impoverimento degli elementi decorativi, ci consentono di inserire questi esem-plari tra le anfore più antiche del nostro repertorio. Gli orli infatti sono articolati ed elaborati, co-stolati all’esterno ed evidenziati da una nervatura plastica appena sotto l’orlo. Il Tipo CSN 16 pre-senta l’attaccatura dell’ansa immediatamente sotto l’orlo e mostrano entrambi una decorazionedipinta in bruno all’esterno. Per questi due esemplari non abbiamo trovato confronti puntuali.
A Carini va infine segnalata la presenza, tra i materiali restituiti dall’US 16, di un frammentodi parete che non è stato possibile ricondurre ad alcuna delle forme testé descritte. Esso mostra lesuperfici decorate da una serie di archetti concentrici alternati a file di piccoli pois eseguiti con untratto sottile di pittura rossa. Anche per questo frammento si può ipotizzare la produzione paler-mitana dal momento che il suo impasto si è rivelato all’esame autoptico identico agli altri.
Come anticipato possono riferirsi ancora alle tipologie di XI secolo le dieci anfore condecorazione pseudo epigrafica provenienti verosimilmente dalle volte della chiesa norman-na di Santa Maria dell’Ammiraglio (La Martorana 1130-1140) (fig. 42)56; si può ritenere che
106
in quanto scarti di fornace siano tutte di produzione locale. I contenitori sono caratterizza-ti da una decorazione in bianco, disposta su più registri a partire dall’orlo e distesa sopraun’ingobbio grigio scuro presente sui tre quarti della superficie del vaso; la parte bassa delvaso ed il fondo sono generalmente risparmiati. Le forme articolate di questi recipienti, laricchezza di elaborati dettagli plastici, nonché la buona qualità pittorica delle fasce decora-tive e delle pseudo iscrizioni ci hanno indotto a considerarli di poco più antichi di quanto ilcontesto di rinvenimento non suggerisca57. È probabile infatti si tratti degli ultimi epigonidi una produzione, certamente di lusso, della fine dell’XI secolo non più attestata con lo stes-so livello qualitativo nel corso del XII secolo58 e destinata ad un uso domestico piuttosto cheal trasporto di derrate alimentari.
Iniziamo la nostra descrizione dalla grande anfora PM 157 (fig. 42). Si tratta di un granderecipiente di circa cm 71 di altezza, con orlo ingrossato a sezione semicircolare; collo cilin-drico caratterizzato dalla presenza all’interno nel punto di raccordo con la spalla di un gradi-no forse destinato ad accoglierne la chiusura, anse apicate, a sezione ovale, segnate da quattrosolcature; corpo globulare percorso nella metà inferiore da cannelures, fondo umbonato. Lametà superiore del vaso è interessata dalla presenza della decorazione dipinta in bianco: a fa-sce, nelle quali si ripetono le lettere arabe alif, lam e ha che formano nella stessa lingua il no-me di Dio (Allah), si alternano fasce decorate da racemi di foglie d’edera e da girali vegetaliresi con notevole senso pittorico. Nella parte bassa del vaso, chiude la decorazione una seriedi piccoli tratti trasversali. Sulla destinazione d’uso di questo contenitore ci sembra verosi-mile ipotizzare sulla base delle sue dimensioni (capienza lt 74,53) e della accuratezza della ma-nifattura e della decorazione, che servisse quale dispensatore d’acqua in un’abitazione o inuna moschea come era prassi frequente nei paesi islamici59.
Appartengono a questo insieme di contenitori dipinti con pseudo iscrizioni anche leanfore PM 158 e PM 115B (fig. 42), quest’ultima con filtro, caratterizzate dall’orlo indistin-to arrotondato, collo cilindrico segnato all’esterno da una serie di nervature a rilievo, anseapicate a sezione ovale percorse da tre solcature abbastanza regolari, corpo globulare leg-germente più ovalizzato rispetto all’anfora PM 157. In entrambi questi esemplari la super-ficie del vaso è percorsa da cannelures e presenta una decorazione in bianco molto simile alprecedente PM 157, solo che in questo caso le fasce a racemi sono sostituite con motivi atreccia stilizzata e a triangoli inscritti.
Dello stesso gruppo fa anche parte una piccola anfora con filtro (PM 108, fig. 42) che pre-senta il collo simile alla forma precedentemente descritta, anse con apici, fondo umbonato edil ventre ovoidale con decorazione dipinta su fondo scuro, che rispetto agli esemplari più tar-di di XII secolo, di cui si conserva un esemplare tra il materiale di Palazzo Abatellis (PPA 94,fig. 42) ove non sono più presenti le pseudo iscrizioni, si presenta molto più raffinata ed ela-borata: a tre linee sottili orizzontali sul collo seguono tre fasce parallele con motivi a treccia.
57 La chiesa della Martorana venne costruita da Giorgio di Antiochia, ammiraglio del regno di Ruggero II, tra il 1130ed il 1140.
58 Tutta la ceramica sovraddipinta in bianco documentata nei contesti di XII secolo dei siti noti della Sicilia occiden-tale presenta dei motivi decorativi molto semplici e rispetto a questi corsivi. Anche le pseudo iscrizioni non raggiun-geranno più quel livello di qualità e quella raffinatezza nel ductus.
59 Grandi contenitori di terracotta venivano utilizzati con quesata funzione nei contesti islamici del Portogallo cfr.GÓMEZ MARTINEZ s.d., p.126.
107
Chiude la decorazione nella parte intermedia del recipiente una pseudo iscrizione del tuttosimile alle altre. La particolarità di questa forma come di quella conservata a Palazzo Abatel-lis è che non ha beccuccio / versatoio, probabilmente quindi venivano usate per conservarel’acqua filtrata e non per servire a mensa. Sia per la forma globulare che per il tipo di decora-zioni non si conoscono esemplari confrontabili con questo recipiente, fatta eccezione per ilframmento di parete con lo stesso motivo pseudo epigrafico sovraddipinto in bianco recupa-rato nello scavo del Chiostro di San Domenico a Palermo60.
Infine, chiudono la descrizione di questo insieme di anfore dipinte due vasi (PM 142 e PPA146, fig. 42) di forma ovoidale, stretto ed alto collo cilindrico, anse a sezione ovoidale apica-te, in un caso percorse da due solchi; spalla inclinata e fondo umbonato. L’esemplare PM 142è privo dell’orlo mentre nell’anfora PPA 146 l’orlo è verticale, arrotondato con una nerva-tura plastica decorata ad impressioni di forma ovoidale realizzate con ditate nell’argilla fre-sca. Differiscono tra loro per gli apici: semplici a sezione triangolare nel tipo PPA 146, piùarticolati nel recipiente PM 142. Anche la decorazione dipinta attestata sui due esemplari dif-ferisce leggermente, ancora una volta nelle fasce interessate dai motivi fitomorfi: a foglie d’e-dera nell’anfora PPA 146 e a girali e volute nel vaso PM 142. Sono da riferire allo stesso tipodi contenitore altri tre esemplari provenienti con molta probabilità dalla Martorana PPA 117,PPA 96 e PPA 167. Infine, l’esemplare PPA 130 è confrontabile con queste anfore soltantoper la forma, mentre è privo dei motivi pseudo epigrafici.
Possono essere considerate una variante acroma della forma PPA 146, le anfore PPA 107; PPA115; PPA 105 (fig. 43)61, attestate tra il materiale di Palazzo Abatellis. Esse presentano le stesse ca-ratteristiche morfologiche del tipo A3 della Zisa (fig. 43) e si può avanzare l’ipotesi che ne sianogli antecedenti. Hanno il collo leggermente più alto rispetto agli esemplari di pieno XII secolo,cilindrico e segnato in prossimità dell’orlo da una nervatura plastica a rilievo decorata da im-pressioni di forma ovoidale realizzate nell’argilla fresca. Proprio la presenza di questa nervatu-ra, molto simile a quella documentata nell’anfora PPA 146 che, a differenza di quella del tipo A3,è resa con maggiore senso di plasticità, ci fanno ritenere questi esemplari più antichi rispettoa quelli della Zisa. Le differenze con gli esemplari più tardi testé descritte ci hanno indotto adindicare con il Tipo A7 questa forma.
Come abbiamo visto, tra i motivi decorativi di tutti questi recipienti predominano le fa-sce di derivazione epigrafica, costituite dalla reiterazione augurale o devozionale della paro-la Allah, formata da grafemi in caratteri cufici62. Sono infatti leggibili tre aste - un alif e duelam -, ed una lettera, particolarmente decorata, che costituisce il ha della parola Allah. Ben-ché sia abbastanza noto l’uso dei motivi pseudo epigrafici, ormai privi del significato origi-nario, nella composizione decorativa dell’arte islamica, nel caso delle formule augurali, comeosservava Scerrato, è difficile separare da queste parole la «coloritura magica per il valore di
60 LESNES 1998, Tav. III, 29, cfr. infra fig. 40, 29.61 Si tratta di tre esemplari tutti differenti tra di loro solo per le dimensioni: PPA105 è la più grande di tutte ha un’al-
tezza di cm 51; PPA 115 è alta cm 44, mentre PPA 107 è la più piccola e misura cm 38 di altezza.62 Il cufico, in uso fin dal periodo più antico dell’Islam, venne adoperato prevalentemente per i testi pubblici fatimi-
ti. Erano i caratteri privilegiati per copiare il Corano ed era quasi impossibile adoperarli per comunicazioni pubblichedal momento che in questo tipo di scrittura le 28 consonanti dell’alfabeto arabo sono rappresentate soltanto da 17 gra-femi. Questo avrebbe potuto determinare delle ambiguità e delle difficoltà di interpretazioni risolvibili soltanto se ilbrano scritto faceva riferimento ad un testo noto (per esempio una sura coranica), cfr. BIERMAN 1989, p. 284.
108
ideogramma carico di significato sacrale, che per il musulmano ha sempre il segno alfabeticospecialmente nella sua redazione cufica.»63. Questa interpretazione è ancora più vera per i no-stri esemplari se si considera che ancora alla fine dell’XI e nel corso del XII la maggior partedella popolazione isolana era arabofona e musulmana. Un confronto molto vicino da un pun-to di vista stilistico, per la composizione del disegno più complessa ed arricchita da volute egirali, ci viene offerto da un bacino proveniente dalla Chiesa di Sant’Andrea a Pisa64. La stes-sa parola, anche se più stilizzata, è documentata sul soffitto della Cappella Palatina65 e, anco-ra nel XII secolo, su alcuni frammenti di catini invetriati di probabile produzione locale, do-ve il ductus sempre più corsivo fa trasparire l’allontanamento dal modello epigrafico66.
Per concludere, dalla comparazione della produzione agrigentina di anfore databile all’etàislamica con quella palermitana dello stesso periodo emerge una somiglianza morfologica cheè legata evidentemente alla corrispondenza tra forma e funzione e ovvero all’uso a cui eranodestinati questi contenitori, identica nelle due realtà67. Esisteva, quindi, in epoca islamica inSicilia una sorta di “Koinè” morfologica che ha condizionato la produzione di questi manu-fatti siano essi opera delle officine palermitane che di quelle agrigentine, e che affondava lesue radici nella cultura musulmana nord africana come dimostrano soprattutto le forme pre-senti nel sito algerino di Tihert - Tagdempt ed in quello di Mila68. Purtroppo nella pubblica-zione di questi ultimi materiali manca un inquadramento cronologico preciso che possa per-mettere una proficua comparazione tra le due realtà.
2.4 LE ANFORE DI XII SECOLO
Per quanto riguarda le tipologie anforiche della produzione palermitana di XII secolo, par-tiremo nella nostra analisi dal consistente gruppo di recipienti provenienti dai restauri di al-cuni tra i più importanti edifici normanni della città. Questi contenitori, oggi conservati aPalazzo Abatellis ed alla Zisa, sono particolarmente significativi sia per il loro eccezionale sta-to di conservazione che per la grande varietà tipologica delle forme documentate, esemplifi-cative delle morfologie ricorrenti nei contesti di scavo riferibili al XII secolo. Significativo,per l’obiettivo finale della nostra analisi, è il fatto che gli edifici, dai quali questi contenitoriprovengono, coprono tutto l’arco cronologico del XII secolo consentendoci di seguire, sulla
63 SCERRATO 1979, p. 303.64 Cfr. BERTI - TONGIORGI 1981, tav. CXXI, n. 208, pp. 203-204: bacino di ceramica smaltata datato ai primi de-
cenni del XII secolo. Inoltre cfr. BERTI - TONGIORGI 1981, tav. LXXXII, n. 136, pp. 182-3: bacino di produzionemaghrebina e siciliana di ceramica invetriata policroma della fine dell’XI - primo quarto del XII secolo.
65 SCERRATO 1979, p. 303.66 Solo per dare alcuni esempi, FIORILLA 1990, p. 33 cat. nrr. 35-36, provenienti dalle fornaci medievali di Agrigento.67 Anche le forme delle olle prodotte dalle officine di Agrigento trovano ampio riscontro morfologico in oggetti si-
mili rinvenuti in altri siti isolani dello stesso periodo, cfr. VITALE in Agrigento 2007, ARCIFA 1998a, pp. 276-277.68 CADENAT 1977-79 e da ultimo DJELLID 2011, In questo sito sono state trovate forme aperte dai profili molto
simili a quelli agrigentini, lucerne a piattello e cupoletta, olle molto simili alle forme siciliane e quello che è ancora piùsorprendente sostegni del tutto analoghi ai nostri, forme chiuse con i fondi umbonati e profili degli orli confrontabi-li con quelli delle anfore agrigentine. Anche i motivi decorativi incisi con uno strumento a più punte ricordano da vi-cino quelli documentati sugli esemplari agrigentini sia per l’ordito decorativo con la prevalenza del motivo ad onde,sia per la tecnica usata; LASSUS 1956, pp. 216-230.
109
base dell’analisi morfologica dei tipi, dalla fine dell’XI per tutto il secolo successivo, l’evolu-zione delle forme all’interno di questa classe di materiali. Tra questi materiali sono anche at-testati scarti d’uso, anch’essi fabbricati in loco ed impiegati nelle volte dopo essere stati ado-perati per un periodo più o meno lungo; alcuni di questi oggetti sono particolarmente inte-ressanti poiché ascrivibili alle tipologie del secolo precedente.
Per il XII secolo sono state isolate 10 forme di riferimento con una serie di varianti, diffe-renti tra loro per forma e capacità, probabilmente in relazione al diverso uso per cui eranodestinate. Siamo partiti dai quattro tipi morfologici (A, B, C e D) individuati nel 1976 da F.D’angelo nell’ambito di una prima classificazione dei manufatti della Zisa69 e dalle varianti aqueste forme riconosciute dallo studioso70.
Un riesame delle anfore della Zisa ci ha portato ad arricchire questa classificazione con al-tre tre forme (E, F, G) e relative varianti, mentre dall’analisi dei contenitori custoditi nellaLoggia di Palazzo Abatellis sono emersi altri quattro tipi che abbiamo indicato con le lette-re H, I, L ed M. Infine, per completezza abbiamo aggiunto all’elenco la forma N relativa al-le anfore dei relitti normanni di Marsala e di San Vito Lo Capo71.
Partendo dalla tipologia così individuata si è cercato di volta in volta di seguire la diffu-sione di ogni tipo di contenitore riconosciuto al fine di elaborare la carta di distribuzionedi questi manufatti (fig. 48).
Tipo A (fig. 43): il primo della classificazione D’Angelo è di gran lunga il più documentato72.Ha forma ovoidale allungata e corpo percorso da cannelures eseguite al tornio; orlo vertica-le, indistinto ed arrotondato, alto cm 5 circa; lungo e stretto collo cilindrico rigonfio da cuisi dipartono due anse a sezione ovale; spalla leggermente inclinata e fondo umbonato; in al-cuni esemplari è stata rilevata la presenza di un sottile velo d’argilla sulle superfici esterne73.Di questo tipo sono state distinte da F. D’Angelo 4 varianti: Tipo A1: con alto collo che sirestringe in prossimità dell’orlo, corpo ovoidale, ha un’altezza di cm 55; Tipo A2: si distin-gue unicamente per le dimensioni più ridotte (h cm 45 circa); Tipo A3: (h cm 49 circa) con col-lo più corto ed orlo segnato all’esterno da un motivo plastico a treccia semplice; il corpo legger-mente più panciuto, è segnato sulla spalla da cordonature eseguite al tornio; il fondo è più largo;
Tipo A4: identico al precedente (h cm 42 circa), si distingue per la presenza su tutta la su-perficie di una decorazione dipinta in rosso o in bruno, eseguita con larghe pennellate diste-se seguendo un ordito di linee verticali ed orizzontali. La variante più antica di questa formasembrerebbe essere l’anfora con motivi pseudo epigrafici PPA146 e le sue varianti acromePPA105, PPA115, PPA107, considerate più antiche per la forma decisamente più plastica deldecoro sotto l’orlo. Bisogna osservare che l’altezza delle anfore riferibili alle varianti A1 e A2è molto variabile e va da un minimo di 44 cm ad un massimo di 55, mentre la larghezza delvaso, misurata nel punto di massima espansione, è più costante ed oscilla in tutti gli esemplari
69 D’ANGELO 1976.70 Purtroppo dalla verifica sono risultate mancanti le anfore del tipo D1.71 PURPURA 1985, FACCENNA 1993, FACCENNA 2006.72 Presente con 72 esemplari alla Zisa, 13 nel convento della Martorana, 15 tra le anfore della Loggia della Galleria
Regionale di Palazzo Abatellis.73 La presenza di una velatura di colore più chiaro rispetto al corpo ceramico è stata rilevata dalle analisi mineralogi-
co petrografiche eseguite su un campione prelevato dall’esemplare Inv. Nr. 27233 riferibile al tipo A2.
110
appartenenti alle due varianti tra i 18 ed i 21 cm. Pertanto, pur rispettando la tipologia pro-posta dal D’Angelo e avendo attribuito le anfore ai tipi A1 e A2 a seconda se i vasi avevanoun’altezza inferiore o superiore ai 50 cm, non riteniamo possano essere considerate significa-tive, ai fini della interpretazione di questo tipo di contenitore, le variazioni nelle dimensio-ni. A queste quattro forme vanno aggiunte altre due varianti: il Tipo A5 più sviluppato in al-tezza (cm 52 circa) e con orlo più basso (cm 2.5 circa)74, ed il Tipo A6 con collo cilindrico, ca-ratterizzato rispetto alle varianti A1 e A2 dalla presenza su tutti gli esemplari della decora-zione dipinta: resta pressoché inalterato il solito schema compositivo, mentre le larghe fasceverticali alternate alle serie di piccoli tratti obliqui vengono sostituite da due linee parallelepiù sottili. Questi ultimi manufatti, provenienti dalle volte del convento della Martorana da-tabile all’ultimo decennio del XII secolo75, tradiscono la loro recenziorità rispetto ai tipi pre-cedenti, proprio per l’ordito della decorazione dipinta, che mostra di essere coerente con latendenza verso il passaggio dalle “Broad Line” alle “Narrow Line”76.
Su uno degli esemplari della variante A2 è ben visibile un marchio a rilievo entro un car-tiglio, eseguito prima della cottura, costituito da un segno Z. Lo stesso contrassegno è pre-sente anche su alcuni blocchi della cattedrale ruggeriana di Cefalù ed è stato interpretato inquella sede come «numero arabico» corrispondente al numero 277. Se questa lettura è corret-ta, potrebbe essere un indizio eloquente delle origini etniche dei ceramisti palermitani. Qua-lunque sia il significato del segno, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non abbiamo ele-menti sufficienti per interpretarne il significato78.
Anfore con collo cilindrico e corpo più o meno ovoidale decorato da cordonature esegui-te al tornio, anse impostate nella parte bassa del collo e fondo umbonato, simili al nostro Ti-po A, sono state recuperate tra gli scarichi delle fornaci di Piazza Armerina datate al periodoantecedente il 1161, anno della distruzione violenta del sito79; a Sofiana80, a Carini (Tipo CSN4)nei contesti di XI secolo (fig. 31); nel casale di Caliata, datato all’XI secolo81; nel Castellazzo di
74 11 esemplari di questo tipo si trovano oggi nei magazzini della Cattedrale di Palermo e provengono con molta pro-babilità dal riempimento delle volte di questo edificio. Nella Loggia di palazzo Abatellis sono presenti nr. 2 esemplaririferibili a questa forma.
75 Si tratta di 13 esemplari conservati al Museo dell’Arte islamica della Zisa e di 7 anfore conservate a Palazzo Aba-tellis, la cui altezza media è di cm 45.
76 Solo per la decorazione cfr. ARCIFA 1998a, Tav. Ia, 12.77 In nessuna delle anfore da noi prese in esame relative alle produzioni palermitane sono presenti altri segni. Il marchio
sembra realizzato a crudo mediante la pressione di una matrice lignea o metallica di forma ellittica che produceva un’im-pronta a rilievo. Si tratta dell’esemplare proveniente dalla Zisa Inv. nr. 27222 conservato nel magazzino del Museo Archeo-logico Regionale di Palermo; per il marchio di Cefalù cfr. ZORIC´ 1989, p. 123: fa osservare che la presenza a Cefalù di se-gni numerici arabici costituisce una primizia epigrafica dal momento che compaiono con un’anticipazione di circa 70 annirispetto al Liber Abbaci del Fibonacci. Questi d’altra parte dichiara nella stessa prefazione al volume «di avere appreso l’usodi questa numerazione nella sua gioventù durante i soggiorni in Egitto, in Siria, in Grecia, in Sicilia e in Provenza».
78 Il problema del significato da attribuire ai bolli sulle anfore è ancora aperto. La loro funzione è con molta proba-bilità mutevole e va considerata non in assoluto, ma in relazione alla cronologia del recipiente ed alla particolare situa-zione dell’area di produzione (MANACORDA 1987, pp. 49-50). Marchi di produttori e atelier signs sono una vecchiatradizione dell’Egitto musulmano fin dal periodo tulunide (870-905). Per il XV secolo è documentato il segno Z dipin-to in nero sul fondo di una coppa di blue and white, cfr. BYLINSKI 1993, p. 60, pl. XI, 15.
79 AMPOLO 1971, p. 269, figg. 154-158.80 FIORILLA 1990, nr. 6, p. 159.81 CASTELLANA 1992, fig. 9, p. 41.
111
Delia, attribuite sulla base di confronti stilistici ad un periodo non posteriore al XII secolo82,nonché tra il materiale delle fornaci di Agrigento, scoperte dal Ragona, l’attività delle quali èstata messa in relazione con la presenza di maestranze musulmane in seguito deportate a Lu-cera tra il 1222 ed il 1246 da Federico II83. Fuori dall’ambito regionale un’anfora del tipo Asembra sia stata recuperata ad Alghero tra il vasellame di bordo di un relitto datato tra la finedel XII - inizi XIII secolo84. Infine, esemplari molto simili ai nostri, ma differenti per impastoe fattura meno accurata, provengono dai contesti della prima metà del XIII di Segesta85, di En-tella86 e di Iaitai87. Le anfore tipo CSN4 possono essere considerate tra le testimonianze più an-tiche riferibili a questa forma e ci inducono ad ipotizzare che il momento iniziale di questaproduzione possa essere fissato nell’ambito dell’XI secolo. La persistenza di questo tipo di con-tenitore anche in età sveva, come ha giustamente rilevato A. Molinari88, denota una «inerziamorfologica» giustificabile secondo noi con l’inalterata funzione a cui era destinato.
Tipo B (fig. 44): attestato da 4 anfore di piccole dimensioni (h cm 35 circa), caratterizzatedal collo cilindrico stretto ed alto con spesso orlo indistinto, ripiegato all’esterno e separatodal collo mediante un solco; anse a sezione ovale; spalla inclinata decorata da cordonature; fon-do umbonato e decorazione dipinta in rosso con motivi a linee verticali ed ondulate. Tra leanfore recuperate alla Zisa sono attestate 2 varianti. Il Tipo B1, già individuato dal D’Angelo,con orlo arrotondato ed ingrossato, segnato all’esterno da un solco piuttosto profondo e conil collo decorato da tre scanalature molto regolari. Il Tipo B2, non presente nella classificazio-ne precedente, con orlo meno pronunciato all’esterno, piatto superiormente e con il collo de-corato da 4 fasce dipinte di colore rosso. Un’altra variante solo per la forma dell’orlo ingros-sato a sezione semicircolare ed il collo più corto rispetto agli esemplari precedenti Tipo B3, èdocumentata da un unico esemplare conservato tra il materiale di Palazzo Abatellis (PPA 154).
Le tre varianti B1, B2 e B3, sono state distinte unicamente in base alle caratteristiche del-l’orlo, dal momento che questi recipienti sono assolutamente identici per morfologia, dimen-sione e tipo di decorazione dipinta. Analogamente, in tutti gli esemplari confrontabili per ledimensioni, la forma ovoidale, le anse ed i motivi decorativi si riscontra una grande varietà nel-la morfologia del collo e dell’orlo. Ci riferiamo in particolare a vasi coevi provenienti dallefornaci di Agrigento89, dal Casale di Milena90, dal relitto di Marsala e dai materiali della secca
82 FIORILLA 1991, pp. 120-122.83 FIORILLA 1990, p. 26 e s., n. 3 e forse 4.84 Devo questa informazione alla cortesia del dott. P.G. Spanu.85 MOLINARI 1997b, classe II.1 figg. 170-171, pp. 124-127. 86 CORRETTI 1995, A34, p. 100, ma con il fondo piano.87 Dove tra l’altro, sono stati recuperati numerosi frammenti di pareti con decorazione dipinta su fondo scuro con-
frontabili con il nostro Tipo F, cfr. ISLER 1995, A68, p. 135; per i frammenti con decorazione dipinta cfr. ISLER 1990,p. 16, fig. 27; ISLER 1984, p. 154, tav. 46, 125-27; tav. 47, 146.
88 MOLINARI 1994b, p. 110.89 Forme analoghe sono state recuperate sia nell’area delle fornaci di ceramica acroma recentemente scoperte nella
Valle dei Templi, sia tra il materiale recuperato nei pressi dei forni individuati dal Ragona in area urbana sotto la chie-sa di Santa Lucia, oggi distrutta: cfr. per le prime ARDIZZONE 1991, p. 222, attribuibile alla fase guglielmina di fre-quentazione del sito, perché trovata in associazione con monete di Guglielmo II e con ceramica solcata; per quelle in-dividuate dal Ragona cfr. da ultimo FIORILLA 1990, p. 28, 12.
90 ARCIFA 1991, tav. XVII, 12, p. 203.
112
di Mondello91. Fuori dall’ambito isolano anfore analoghe si ritrovano in Algeria nella Qal’adei Banû Hammâd in contesti di XI-XII secolo92.
Tipo C (fig. 45): si tratta di un’anfora di medie dimensioni (h. cm 45 circa) con collo lar-go e basso, orlo indistinto, arrotondato, segnato all’esterno da due solchi ben incisi; anse asezione ovoidale attaccate nella parte bassa del collo; corpo panciuto percorso da cordona-ture e decorato da linee verticali ed orizzontali dipinte in rosso; spesso sul collo compaionodei motivi dipinti “a virgole”93.
Una variante di questa forma Tipo C1 è rappresentata dall’anfora PPA 113, conservata aPalazzo Abatellis, differente dall’esemplare della Zisa soprattutto per l’orlo più ingrossato asezione semicircolare e per le dimensioni maggiori94. Fuori dal territorio urbano questo tipoè attestato soltanto a Brucato95.
Tipo D (fig. 45): Piccola anfora con largo e tozzo collo, spalla inclinata, ventre tronco-conico segnato da cordonature e da linee orizzontali e verticali dipinte in rosso; per cui ilD’Angelo ha individuato due varianti: il Tipo D1 alto cm 35 circa, è caratterizzato dall’or-lo a sezione triangolare, collo cilindrico segnato da un solco, anse a sezione ovoidale e fon-do umbonato96. Una variante di questa forma Tipo D1a con il fondo piatto e con la spallapiù sfuggente è attestato nei livelli di XII secolo a Castello San Pietro (fig. 30,13)97. Il TipoD2, di dimensioni maggiori, alto in media cm 55, presenta il collo atrofizzato, larga imboc-catura, orlo a sezione triangolare e spalla breve ed inclinata con due piccole anse ad anello.Tutti questi esemplari presentano le pareti percorse da cannelures e decorazioni dipinte inrosso o in bruno secondo il consueto schema decorativo: larghe fasce verticali alternate dauna fila di piccoli tratti obliqui.
Anche per questo contenitore sono documentate in Sicilia parecchie varianti che diffe-riscono tra loro solo per le dimensioni. Dagli altri edifici palermitani di XII secolo proven-gono due anfore del tipo D1, mentre dal Rione Castello San Pietro a Palermo da un conte-sto di scavo datato al XII secolo proviene un esemplare di questa variante con lo stesso mo-tivo decorativo dipinto in bruno, ma con le larghe fasce verticali sostituite da due linee piùsottili98. Sempre a Palermo sono stati recuperati alcuni esemplari in contesti di XII secoloin via Torremuzza ed un esemplare acromo da un pozzo individuato nell’area del Museo
91 Per i materiali recuperati a Mondello cfr. F. Faccenna, relazione al convegno “Scavi Medievali in Italia. 1994-1995”,Cassino 14-16 dicembre del 1995, mai pubblicata per la prematura scomparsa dell’autore.
92 GOLVIN 1980, p. 203-217. 93 Questa forma viene indicata nella classificazione D’Angelo come tipo C1, D’ANGELO 1976, p. 55, fig. 7. Si co-
noscono sei esemplari provenienti dalla Zisa.94 Gli esemplari pertinenti a questa forma conservati a Palazzo Abatellis sono 5.95 Cfr. Brucato, pl. 17,b; pl. 13,d.96 Purtroppo l’esemplare intero presentato dal D’ANGELO 1976, alla fig. 8 p. 60, non è più presente tra i conteni-
tori provenienti dalla Zisa, forse è andato disperso durante i ripetuti trasferimenti di questo materiale. Gli unici esem-plari attestati provengono dallo scavo dell’impianto termale annesso al palazzo. Per le indicazioni di scavo cfr. TUSA1976. Tra il materiale di palazzo Abatellis sono documentati due esemplari.
97 ARCIFA et alii 1985-1987, p. 40, fig. 9,b; ARCIFA 1998a, Tav. Ia.13.98 ARCIFA 1998a, Tav. Ia.12, il motivo decorativo documentato su questo contenitore è tipico degli esemplari più tardi.
113
Archeologico99, tre frammenti nell’area del vecchio porto “la Cala”100, mentre nel territoriocircostante la città frammenti di orlo sono stati isolati negli strati di XI - XII secolo tra il ma-teriale di Brucato101 e di Monte Iato102. Nella Sicilia sud occidentale frammenti di orlo ricon-ducibili a questo tipo di contenitore sono stati recuperati durante le prospezioni di superfi-cie a Monte Maranfusa nella media valle del Belice a pochi km a N-O di Roccamena103 e aMonte Castello sulla riva destra del fiume Platani104, mentre per quanto riguarda la Sicilia cen-tro orientale un frammento con la stessa forma di orlo e con decorazione dipinta sulla spal-la sembra sia stato trovato nella Villa del Casale a Piazza Armerina105.
L’anfora tipo D2 sembra, con molta probabilità, essere stata adoperata come contenitoreda trasporto per l’esportazione di derrate alimentari, come dimostra il rinvenimento di con-tenitori identici ai nostri a Salerno106, tra il carico del relitto di San Vito Lo Capo107 e nei fon-dali marini nei pressi di Terrasini ad Ovest di Palermo108.
Coerentemente con la tendenza evolutiva riscontrabile nella morfologia di questo contenito-re può desumersi che il prototipo del tipo D2 possa riconoscersi nell’esemplare PPA 125 conser-vato a palazzo Abatellis con l’orlo percorso da due solchi concentrici. Si tratta di uno scarto d’u-so, come si evince dall’usura del pezzo, la cui datazione sulla base dei caratteri stilistici si potreb-be collocare tra la seconda metà dell’XI secolo ed i primi decenni del successivo. Infatti, anfore si-mili sono state recuperate nei contesti successivi alla prima metà dell’XI secolo a Carini109.
Resta invariato nel corso del XII secolo l’uso di diverse varianti dimensionali evidentementecon funzioni differenti, come ci viene documentato nei livelli di XII secolo a Castello San Pietro110.
99 Durante lo scavo in via Torremuzza sono stati recuperati alcuni frammenti pertinenti a questa forma nella US 67in associazione con anse con solco mediano, cfr. infra, p. 182; per il Museo Archeologico cfr. LESNES 1997, p. 43, n.1, fig. 15 si tratta di un’anforetta del tipo D1, datata all’XI secolo.
100 D’ANGELO 1984, p. 31, n. 18, diametro orlo cm 15; n. 19 con le pareti dipinte; p. 32, n. 20. Tutti questi fram-menti vengono confrontati dall’autore con le anfore conservate a Palazzo Abatellis.
101 Brucato, p. 268, pl. 13.i; pl. 18.d.102 ISLER 1984, fig. 33 K3686; fig. 34 K 3683 con decorazione dipinta a linee parallele.103 SPATAFORA 1990, p. 135, fig. 11,54 dove vengono segnalati tra l’altro numerosi frammenti «di vasi di grosse dimen-
sioni caratterizzati da serie di solcature parallele, eseguite al tornio e a volte decorati con bande dipinte in rosso bruno».104 RIZZO 1990, fig. 10, p. 185.105 GENTILI 1950, fig. 32, p. 332, l’incertezza ci deriva sia dall’esiguità del frammento pubblicato, sia dalla forma
non chiaramente leggibile dalla foto.106 Ad Altavilla Silentina (SA), Località San Lorenzo, è stata recuperata una grande anfora a cannelures con decora-
zione dipinta a larghe fasce verticali, fondo umbonato datata al VII secolo che sembra molto simile al nostro esempla-re. Nello stesso sito, d’altra parte, sono stati recuperati da contesti di XII-XIII secolo anfore di questo tipo, cfr. PEDU-TO 1986, p. 560, fig.12 e PEDUTO 1994.
107 FACCENNA 1993, p. 186 cita alcune giare alte circa cm 60, con apertura molto larga, «anse ad orecchio» e pare-ti percorse da cannelures, paragonate con il tipo D2 della Zisa e con le anfore di Terrasini, cfr. nota seguente.
108 Nell’Antiquarium comunale di Terrasini, vicino Palermo, sono conservate due anfore molto simili al nostro esem-plare, con decorazione a bande rosso bruno sul corpo: cfr. PURPURA 1977, p. 66, fig. 23, Tav. III, m,n: una con ilfondo convesso (fig. 35) ed una con il fondo molto rastremato verso il basso, ma umbonato. Quest’ultima provienedai fondali limitrofi, mentre per l’esemplare B l’A. propone la provenienza dalle volte di un edificio forse San Catal-do, come recita la didascalia apposta sotto il pezzo nell’Antiquarium.
109 Rientra anche tra gli esemplari più antichi di questa forma il contenitore da trasporto con orlo percorso da due so-chi concentrici e con una nervatura a rilievo nel punto di raccordo tra la spalla ed il collo recuperato nello scavo delChiostro di San Domenico a Palermo, cfr. LESNES 1998, tav. II, 25 infra fig. 40, 25.
110 ARCIFA 1998a, tav. Ia, b.12, 13.
114
Tipo E (fig. 46): grande anfora con alto collo cilindrico, orlo segnato da un largo e profon-do solco, spalla inclinata, anse a sezione ovale con una scanalatura al centro, ventre tronco-conico percorso da cordonature eseguite al tornio, decorazione dipinta su un sottile strato diargilla diluita a linee verticali alternate a una serie di piccoli tratti obliqui e distesa su tutta lasuperficie del contenitore111, fondo presumibilmente umbonato. Sono attestate due varianti:il Tipo E1 di grandi dimensioni (h cm 67 circa), ed il Tipo E2 di dimensioni pressoché simi-li, ma con la spalla meno inclinata ed il corpo più panciuto.
Anfore analoghe al Tipo E per la forma e le decorazioni dipinte in bruno rossiccio sonostate recuperate ad Agrigento tra il materiale delle fornaci scoperte dal Ragona fuori dalla cin-ta muraria chiaramontana della città112. Inoltre, un’anfora priva del collo, ma che per la for-ma del corpo e per i motivi decorativi ricorda il nostro tipo E, è stata isolata nello scavo nelrione Castello San Pietro a Palermo ed è stata datata all’XI-XII secolo113. Fuori dalla Sicilia,un contenitore simile al nostro proviene dal relitto musulmano individuato nella baia di Can-nes, datato ipoteticamente al X secolo114.
Tipo F (fig. 44): è rappresentato dal frammento della parte superiore di un’anfora con or-lo arrotondato ingrossato all’esterno, stretto ed alto collo rigonfio e da due frammenti di spal-la con ansa a sezione ovoidale, palesemente differenti dalle anfore precedentemente presen-tate sia per il colore scuro delle superfici esterne, sia per le decorazioni sovraddipinte in bian-co realizzate con sottili pennellate. Il tipo di decorazione in bianco su fondo scuro è moltoricorrente su anfore, brocche e vasi con filtro di matrice islamica datati in Sicilia dalla fine delX secolo a tutto il XII115. La presenza, in uno dei nostri frammenti di motivi pseudo epigra-fici imitanti l’alfabeto arabo toglie ogni dubbio sulla appartenenza di questi manufatti all’a-rea culturale islamica. Decorazioni dipinte in bianco su fondo scuro sono presenti su conte-nitori in ceramica comune di periodo omayyade recuperati in Medio Oriente. Questo tipodi manufatto, frequente nei contesti medievali palermitani116 è presente fuori dall’ambito cit-tadino con alcuni frammenti in centri minori, quali Cefalù117, Brucato e Monte Iato118 e fuoridalla Sicilia in Calabria a Squillace e a Tropea119. D’altra parte la produzione palermitana dianforette e brocchette sovraddipinte in bianco, già suggerita dalla loro presenza nelle volte degliedifici normanni, è ulteriormente confermata dal rinvenimento di alcuni esemplari tra gli scartidi una fornace recentemente individuata nell’area sub urbana del trans Kemonia a Palermo120.
111 Le decorazioni in rosso bruno presenti sul corpo ceramico sono state realizzate con un’argilla ferrosa. 112 FIORILLA 1990, p. 27.3; FIORILLA 1991, p. 277, fig. 23. 4-5, p. 120.113 ARCIFA et alii 1985-87, fig. 9,a, p. 40.114 VINDRY 1980, pp. 221-226.115 Un frammento di vaso con filtro e beccuccio versatoio proveniene dallo scavo del Chiostro di San Domenico a
Palermo, cfr. LESNES 1998, tav. III, 27 (cfr. infra fig. 40, 27).116 Alcuni frammenti simili ai nostri per decorazione sono stati recuperati nel chiostro di San Domenico a Palermo
ed un frammento di vaso con filtro negli strati più antichi di Castello San Pietro, datati all’XI-XII secolo. Cfr. LESNES1993, p. 577, fig. 5, nn. 29-31 e LESNES 1998, Tav. III, 27; ARCIFA et alii 1985-87, p. 40, fig. 9d.
117 TULLIO 1995a, p. 149, fig. 13. 118 Brucato, p. 252, pl. 8,b,c,d,e,f; per Monte Iato cfr. ISLER 1984, K925, p. 121, tav. 39,6; pp. 138-40, tavv.45, 103-
114, p. 142, tavv. 46, 121-124, p. 146, tavv. 47,145.119 Devo l’informazione relativa a Squillace alla dott.ssa Chiara Raimondo; la presenza di frammenti di ceramica so-
vraddipinta in bianco a Tropea è stata segnalata da ARCIFA 1996, p. 469, nota 33.120 ARCIFA 1996, tav. I,4, pp. 469-70.
115
Tipo G (fig. 45): è caratterizzato dal collo tronco-conico largo e basso, orlo indistinto, ar-rotondato segnato all’esterno da un solco, corpo ovoidale, piccole anse ad anello, impostatesulla spalla percorsa da cordonature eseguite al tornio che riprendono in prossimità del fon-do umbonato del recipiente, superficie esterna decorata con i soliti motivi lineari dipinti inbruno. Due esemplari di questa forma sono stati recuperati rispettivamente sulle volte dellaZisa e della chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, mentre tra il materiale di palazzo Abatel-lis si segnala la presenza di un’anfora (PPA 122) che può essere considerata una variante Ti-po G1. Si tratta di uno scarto d’uso, con il fondo restaurato in antico con uno spesso tappodi malta, successivamente adoperato nel riempimento delle volte. Questa variante differiscerispetto al tipo G sia per la forma dell’orlo e del collo, leggermente più rigonfio e marcato al-l’esterno da un solco, che per la forma delle anse con evidenti costolature. Dettagli morfolo-gici di questo genere sono riscontrabili, come abbiamo visto, negli esemplari più antichi, an-che se il nostro recipiente presenta la superficie decorata da due fasce verticali parallele alter-nate ad una serie di piccoli tratti obliqui, secondo lo schema tipico degli esemplari più tardi.
Tipo H (fig. 45): abbiamo riferito a questa forma l’anfora PPA 121 con orlo ingrossato asezione semicircolare (diametro cm 8), leggermente concavo all’interno ed affusolato nellaparte terminale, e separato dalla parete esterna mediante un solco, alto collo tronco-conico,anse a sezione semicircolare percorse da due solchi, che si dipartono dalla parte inferiore delcollo fino al punto di massima espansione del recipiente; spalla sfuggente, corpo ovoidale efondo umbonato. La superficie del vaso, interamente percorsa da cannelures, è decorata se-condo il solito schema compositivo dipinto in rosso bruno con unica variante per la decora-zione sulla spalla che presenta due linee ondulate parallele comprese all’interno di due larghefasce orizzontali.
Tipo I (fig. 45): rappresentato dall’anfora PPA 109 di medie dimensioni (H cm 52) conorlo verticale, segnato all’esterno da una nervatura plastica decorata con un motivo a dita-te; collo leggermente tronco-conico percorso all’esterno da un solco con andamento sinu-soidale, spalla sfuggente, anse ad anello a sezione ovale leggermente schiacciate, percorse dacostolature poco evidenti; ventre ovoidale, fondo umbonato. La superficie esterna del re-cipiente è, anche in questo caso, interamente ricoperta da decorazioni dipinte secondo ilsolito schema compositivo.
Tipo L (fig. 46): appartiene a questa forma un grande contenitore (PPA 114 H cm 61) ca-ratterizzato dall’orlo ingrossato a sezione semicircolare piatto superiormente, collo cilindri-co, anse arcuate a sezione ovale percorse da un profondo solco mediano, impostate nella par-te bassa del collo fino al punto di massima espansione del vaso; spalla inclinata, corpo ovoi-dale, fondo umbonato. La superficie esterna del contenitore è interamente ricoperta da deco-razioni dipinte che ripetono gli stessi motivi riscontrati nelle anfore dello stesso periodo. Ri-feribile a questa tipologia sono le anfore del Tipo B isolate nel relitto di San Vito lo Capo121
121 Cfr. FACCENNA 2006, fig.39. Il tipo B comprende un gruppo di 25 anfore. Per le indicazioni sul relitto cfr. infra,Capitolo III, p. 190 e s.
120
Tab. 2. Anfore provenienti dal Convento della Martorana
quantità
ed il grande recipiente (MBA130) recuperato a Marsala tra il carico del relitto A122. Quest’ultimoesemplare rispetto al campione forma presenta delle fasce ad onda sul collo, mentre sulla spalla,dopo la cottura, è stata graffiata la parola araba 1 mudd. Il mudd è una delle unità di misura peraridi usata nel mondo islamico di quel periodo, corrispondente a mezzo staio e la sua presenzasulla spalla del recipiente è chiaramente in relazione al peso del contenuto dell’anfora123. Un esem-plare di questa forma è stato recuperato anche a Pisa nello scavo di Piazza Grande in un contestodatabile tra l’XI ed il XII secolo124. Proprio la presenza tra i carichi di alcuni relitti siciliani ed ilrinvenimento pisano ci fanno ipotizare che questo tipo di contenitore venisse utilizzato per l’e-sportazione delle derrate alimentari, probabilmente semi, granaglie o frutta secca.
Tipo M (fig. 44): con alto e stretto collo cilindrico, percorso all’esterno da una nervatura; or-lo ingrossato, a sezione semicircolare leggermente pendulo all’esterno; anse arcuate a sezioneovale con solco mediano, spalla inclinata, ventre ovoidale, fondo umbonato (PPA 95). Le pa-reti, percorse da cannelures, presentano le solite decorazioni dipinte in bruno. Una variantedimensionale di questa forma è l’anfora Tipo M1 proveniente dal Canale di Sicilia ed oggiconservata a Marsala (MBA 262).
I quantitativi dei reperti relativi alle anfore della Zisa, del Convento della Martorana e delgruppo di Palazzo Abatellis, divisi per forme, sono stati riassunti rispettivamente nelle tabel-le 1, 2 e 3 qui di seguito riportate:
Tab. 1. Anfore provenienti dalla Zisa
quantità
122 Per la descrizione dell’anfora cfr. infra, Appendice 1, Catalogo, p. 00, fig. 46; Per i relitti cfr. PURPURA 1984;DI STEFANO 1988.
123 Per informazioni su questa unità di misura si veda supra, Capitoli I, p. 69, nota n. 92.124 MENCHELLI 1993, p. 521.
tip
o
tip
o
121
125 Questo contenitore è stato classificato da F. Faccenna come Tipo A, cfr. FACCENNA 1993; FACCENNA 2006,fig. 30. Per i contesti di rinvenimento cfr. infra, Capitolo III, p. 190 e s.
126 Cfr. PATTERSON 1995.127 GRAGUEB - TRÈGLIA - CAPELLI - WAKSMAN 2011; TRÉGLIA et alii 2012.128 ARCIFA 1997, p. 408, fig.2a. 11.
Tab. 3. Anfore custodite a Palazzo Abatellisti
po
quantità
Tipo N (fig. 47): infine, per completezza, non possiamo non descrivere brevemente il con-tenitore da trasporto per eccellenza di questa produzione, che costituiva il carico dei relittidi Marsala (relitto A) e di Capo San Vito, datati entrambi al XII secolo125. Si tratta di un’anfo-ra acroma di piccole dimensioni per la quale, sulla base di analisi mineralogico petrografiche,è stata avanzata l’ipotesi di una produzione nella Sicilia occidentale126. Si presenta caratteriz-zata dal collo allungato cilindrico, orlo a mandorla di sezione triangolare al di sotto del qua-le è una fascia leggermente rientrante, anse a sezione ovale con solco mediano, corpo tronco-conico percorso da cannelures, fondo umbonato. Contenitori simili sono stati recuperati nel-lo scavo di Santa Patrizia a Napoli in contesti datati tra l’XI ed il XII secolo, documentandola circolazione nell’Italia centrale dei prodotti agricoli siciliani. Inoltre, anfore dello stesso ti-po sono state recuperate a Sabra al - Mansuriya in Tunisia e in Provenza, attestando un'am-pia circolazione di questi manufatti127.
Anche per l’anforetta con filtro e beccuccio/versatoio con la decorazione sovraddipintain bianco su ingobbio rosso o bruno/nero in uso ancora nel XII secolo, l’unico elemento perdistinguere le forme più antiche da quelle recenti, si potrebbe ricavare seguendo l’evoluzio-ne del motivo decorativo, sempre più corsivo, semplificato e meno accurato via via che ci av-viciniamo alla metà del XII secolo128.
122
In sintesi, dal confronto tra le anfore di periodo islamico rinvenute a Carini, la cui produ-zione palermitana abbiamo visto è stata confermata dalle analisi mineralogico petrografiche,e quelle recuperate sulle volte di alcuni edifici normanni palermitani anch’essi di sicura pro-venienza dalla stessa città, emerge una continuità sia nelle forme che nelle decorazioni ed èpossibile identificare una serie di caratteristiche morfologiche che consentono di distinguerele produzioni dei due periodi.
Questo continuum ci consente di affermare che la produzione palermitana di ceramica di-pinta è fiorente almeno a partire dalla seconda metà del X secolo e che perdura ininterrotta,evolvendosi verso forme sempre più semplificate, almeno fino alla seconda metà del XII se-colo, cioè in piena età normanna. La tendenza alla semplificazione dei dettagli morfologicidegli orli e delle anse, a nostro parere, risulta evidente dal confronto diretto dei manufattimusulmani di Carini con quelli normanni della Zisa. In particolare:
• le anse costolate, molto comuni tra le forme chiuse della ceramica dipinta ritrovate ne-gli strati islamici, presentano nella parte mediana un solco più profondo che può essere con-siderato in nuce il solco caratteristico delle anse delle anfore di età normanna129;
• gli orli modanati dei contenitori islamici tendono nel corso del XII secolo verso la sem-plificazione: ad esempio le anfore CSN 4 e CSN 4.2, che come abbiamo visto possono es-sere considerate i prototipi dell’anfora Tipo A della Zisa, presentano, rispetto agli esempla-ri più tardi, un dettaglio decorativo, quale il solco sulla parete esterna dell’alto orlo, nonpiù riscontrabile nelle forme simili di età normanna. Anche in altre forme con orlo ingros-sato a mandorla abbiamo notato la presenza di solcature non più attestate sui recipienti ana-loghi di età normanna;
• La nervatura in rilievo tra il collo e la spalla presente nelle forme con collo atrofizzato,indice evidente di una certa accuratezza nell’esecuzione del manufatto, non è più riscontra-bile negli esemplari riferibili a questi tipi, databili al XII secolo130;
• anche per quanto riguarda le decorazioni dipinte sul corpo dei contenitori può notarsi, comeverrà meglio precisato nel prossimo paragrafo, la tendenza verso la semplificazione dei motivi.
2.5 LE ANFORE DI PRODUZIONE PALERMITANA E LA CERAMICA DIPINTA MEDIEVALE
Come abbiamo avuto modo di osservare, le anfore prodotte a Palermo tra il X e la secondametà del XII secolo presentano motivi dipinti in rosso o in bruno. Per questo tipo di decorazio-ne L. Arcifa, sulla base dello studio dei materiali ascrivibili allo stesso arco di tempo recuperatinello scavo del Rione Castello San Pietro, ha riconosciuto una tendenza evolutiva verso la sem-plificazione ove in particolare le linee sinuose evolverebbero verso una serie di tratti obliqui131.
L’osservazione ben si accorda con quanto rilevato dall’esame dei reperti di Carini e di viaTorremuzza negli strati relativi alla piena età musulmana, dove il motivo a linee sinuose
129 Cfr. le anfore del gruppo II di Carini (figg. 31-32) con il tipo D più tardo della classificazione D’Angelo (fig. 45)ed all’interno dello stesso tipo D2 l'anfora recuperata alla Zisa databile al pieno XII secolo e l’esemplare PPA125 piùantico probabilmente della fine dell'XI - inizi del XII secolo.
130 Cfr. i tipi G, D e C della Zisa e l’anfora PPA 134 conservata a Palazzo Abatellis.131 ARCIFA 1997, p. 408; ARCIFA 1998a, p. 280, ARCIFA - ARDIZZONE 2009.
124
(alternate a fasce verticali parallele) è presente in concomitanza con una decorazione a se-rie di piccoli tratti obliqui (sempre alternati a fasce verticali). La compresenza dei duemotivi decorativi nel sito di contrada San Nicola datato tra la fine del X e gli inizi del-l’XI secolo ci induce a ritenere questo un periodo di transizione fino alla definitiva affer-mazione del motivo semplificato sulle anfore databili tra la fine dell’XI secolo ed il suc-cessivo. Ma vediamo di seguire attraverso i materiali in nostro possesso questo processoevolutivo: come abbiamo visto precedentemente negli esemplari più antichi ricorre, for-se già anteriormente al X secolo, una decorazione dipinta a cappi continui di matrice bi-zantina. Contemporaneamente si afferma, divenendo predominante durante la primametà del X secolo, uno schema decorativo a larghe fasce verticali parallele alternate a li-nee sinuose continue presenti senza variazioni di rilievo su tutta la superficie del vaso. Leforme chiuse con le pareti percorse da linee sinuose, prevalenti nei contesti della primametà del X secolo, continueranno ad essere presenti nella seconda metà del secolo, quan-do si registra una progressiva rarefazione fino alla totale scomparsa nei livelli di XI seco-lo. Questa tendenza è ribadita a nostro giudizio sia dall’incidenza sempre minore di que-sti manufatti nei livelli più tardi, sia dalla contemporanea presenza negli strati della se-conda metà del X secolo di esemplari in cui i motivi a linee sinuose coesistono con quel-li semplificati a piccoli tratti obliqui.
La transizione dal motivo a linee sinuose verso i tratti obliqui sarebbe confermata dal rin-venimento negli strati di fine X secolo a Carini ed in Via Torremuzza di alcuni frammenti dipareti in cui lunghi segmenti obliqui molto ravvicinati sono legati da nessi trasversali comese la linea sinuosa si fosse sclerotizzata ed irrigidita in una serie di pennellate trasverse. Que-sti motivi dipinti sono attestati soltanto nel momento di passaggio tra le due decorazioni (se-conda metà del X secolo) e tendono a scomparire nel secolo successivo.
Verso la fine del X secolo diventa predominate la decorazione costituita da larghe ban-de verticali parallele, alternate ad un serie di piccoli segni obliqui, che, abbiamo visto, ca-ratterizzerà tutta la ceramica dipinta di produzione locale fino alla seconda metà del XII se-colo. Come è stato osservato in precedenza per il motivo più antico, si tratta di decorazio-ni standardizzate ricorrenti senza notevoli differenze su tutte le forme vascolari di questaproduzione; fa eccezione la forma PPA 102 che presenta sulla spalla un tipo di decorazio-ne che sembra ricorrere soltanto su questo tipo di contenitore: le larghe fasce orizzontaliparallele sulla spalla sono collegate tra di loro da un fitto reticolato costituito da sottili li-nee verticali132. Nel corso del XII secolo l’ordito decorativo tende ancora verso un’ulterio-re semplificazione attestata sia sugli esemplari più tardi provenienti dalle volte del Conven-to della Martorana databile al 1193, sia dalle anfore di pieno XII secolo dello scavo di Rio-ne Castello San Pietro a Palermo133. In questi recipienti, infatti, come è stato osservato, iltratto si è fatto «più corsivo e affrettato, per le bande disposte in modo più spaziato che ten-dono a dividersi in due più sottili, parallele»134, seguendo la regola del passaggio dalle BroadLine alle Narrow line, osservata da D. Whitehouse.
132 Sia nel sito di Villagrazia di Carini sia in Via Torremuzza a Palermo abbiamo osservato che questo tipo di deco-razione non ricorre sulle altre forme di questa produzione. Cfr. anche ARCIFA 1997, fig. 2a.10.
133 ARCIFA 1997, fig. 2a.12.134 ARCIFA 1997, p. 408.
125
A questo proposito, ci sembra opportuno, fare qualche considerazione di carattere più ge-nerale sulle problematiche relative alla ceramica dipinta medievale diffusa nell’Italia meridio-nale, considerata dalla letteratura archeologica una classe ceramica a se stante.
Il problema più discusso dalla critica è quello relativo alla cronologia di questo tipo di ma-nufatti, messi tradizionalmente in relazione con la ceramica dipinta d’influenza bizantina checompare nel Mediterraneo orientale tra il VI ed il VII secolo d. C.135. Per questa classe di ma-teriali D. Whitehouse ha riconosciuto nella decorazione un’evoluzione dalle linee più larghe(Broad Line) a quelle più strette (Narrow Line) ed, alla luce delle recenti indagini archeologi-che nell’Italia meridionale, ha identificato un periodo di transizione durante il quale i due ti-pi di decorazione appaiono contemporaneamente e non è quindi sempre possibile attribuirela ceramica dipinta ad una o all’altra delle due classi136.
Quanti si sono occupati dell’argomento, hanno ritenuto di dovere comprendere all’inter-no della ceramica decorata a linee sottili (Narrow line) i manufatti recuperati a Palermo nel-le volte degli edifici di età normanna137. In realtà occorre precisare che i motivi decorativi ri-correnti sulle forme dell’Italia meridionale - serie di archetti, spirali, linee ondulate - sonomolto differenti da quelli più decisamente lineari documentati sulle nostre anfore. Sia D. Whi-tehouse che S. Patitucci Uggeri, che per primi hanno affrontato la questione, tendono a con-siderare diversi gli esemplari siciliani rispetto a quelli trovati nell’Italia meridionale che mo-strano una maggiore affinità con gli esemplari bizantini138. Questa differenza è ovvia dal mo-mento che si tratta di due differenti aree geografiche e culturali che fino alla fine dell’XI se-colo non hanno relazioni di tipo politico e scarse di tipo commerciale, essendo la Sicilia sot-to la sfera d’influenza islamica139.
Nei manufatti siciliani la decorazione dipinta non sembra strettamente legata ad una for-ma chiusa particolare, dal momento che è presente senza variazioni di rilievo su tutti i tipi dicontenitore individuati nei nostri contesti; inoltre, è presente spesso sui numerosi frammen-ti di pareti di forme chiuse recuperati nei contesti siciliani databili tra la fine del X ed il XIIsecolo (cfr. carta di distribuzione fig. 121)140.
135 PATITUCCI UGGERI 1977, pp. 66-67.136 PATTERSON - WHITEHOUSE 1992, p. 105 e s.137 PATITUCCI UGGERI 1977, pp. 84-86; WHITEHOUSE 1980, pp. 65-82; ARTHUR - WHITEHOUSE 1982,
pp. 44-45.138 WHITEHOUSE 1978; PATITUCCI UGGERI 1977, p. 85.139 Le forme chiuse con decorazione dipinta oggetto del nostro studio, come si è detto, sono di produzione locale co-
me confermato anche dalle analisi mineralogico petrografiche eseguite sui campioni prelevati dalle anfore del relitto diSan Vito lo Capo (TP) e di Marsala, contemporanei ai nostri recipienti e simili a questi per i motivi decorativi e lamorfologia: FACCENNA 1993, p. 185-187; MOLINARI 1994b, p. 109 indicano come area di produzione la Sicilia oc-cidentale. Per i relitti A e B di Marsala cfr. DI STEFANO 1988, PURPURA 1985, pp. 129-136. Anche per la cerami-ca dipinta dell’Italia meridionale recentemente è stata ipotizzata la presenza di più centri produttori locali sulla basedella grande diffusione di questo tipo di manufatto e sulla base di alcune analisi mineralogico petrografiche: cfr. DI CO-SMO - PANARELLO 1998, p. 15.
140 Brucato, tavv. 13-14, p. 268; nel territorio circostante Brucato lungo la valle del fiume Himera nei siti di contradaBurgitabis e di Cozzo San Nicola sono state recuperate anse con il solco mediano e pareti cordonate con decorazionedipinta in bruno, cfr. VASSALLO 1988, fig. 166, 2, 4, 23-24, 18 p. 170; Monte Iato, ISLER 1984, tav. 46, pp. 125-127;tavv. 47, 146; Milena, ARCIFA 1991, tav. XXVII, 12, p. 203; Marineo, DENARO 1997, p. 219, tav. II, 6; Sofiana, Bi-talemi, Caltanissetta, la pianura di Gela, FIORILLA 1990, Marsala, KENNET - SJOSTROM - VALENTE 1989, percitare soltanto i più noti.
126
Alla luce di quanto detto si può ravvisare nelle produzioni della Sicilia occidentale una li-nea evolutiva autonoma rispetto a quelle dell’Italia meridionale; sembra tuttavia prematurocercare di riconoscere le matrici culturali bizantine od islamiche, dato l’insoddisfacente sta-to degli studi sulla ceramica comune dei secoli VIII e IX. Recentemente alcuni studiosi han-no tentato di rintracciare, attraverso le produzioni ceramiche, due diverse matrici culturalinelle maestranze operanti in Sicilia tra il X e l’XI secolo: la prima sarebbe perfettamente in-serita nel solco della tradizione tardo romana peculiare delle manifatture siciliane prima del-la conquista musulmana, la seconda sarebbe legata all’arrivo nell’isola di ceramisti provenien-ti dal Nord Africa. In questa analisi la cultura materiale tardo antica viene usata come ante-cedente per ipotizzare la continuità nel medioevo di una produzione locale141. Nel parlare dicontinuità morfologica o di “influenze” culturali tardo romane o islamiche in contrapposi-zione tra loro nelle produzioni siciliane di ceramica acroma dal X al XII secolo, non bisognadimenticare che allo stato attuale delle ricerche sono del tutto sconosciute le produzioni lo-cali siciliane dell’VIII e del IX secolo142, che certamente dovettero esistere, e che sulla base del-le nostre conoscenze non è possibile cogliere una netta differenziazione morfologica tra lacultura materiale tardo antica nord africana e quella siciliana fino all’VIII-IX secolo d. C. Man-ca quindi l’anello di congiunzione che consentirebbe di stabilire come la tradizione morfo-logica tardo antica si sia evoluta nelle produzioni locali siciliane durante l’alto medioevo equanto abbia influito su questo processo, a partire dal IX secolo, l’apporto del conquistatoremusulmano nord africano. Non bisogna dimenticare, infatti, che, a giudicare almeno dalleforme più antiche dell’invetriata policroma prodotte a Raqqada nel IX secolo143, i prodotti lo-cali di ceramica fine da mensa delle officine africane, pur avendo accolto innovazioni tecno-logiche ed ispirazioni decorative provenienti dall’Oriente, continuano a mantenere inaltera-to il repertorio morfologico e decorativo della ceramica sigillata prodotta in precedenza inquelle aree geografiche. Infatti, soltanto a partire dal X secolo l’arte islamica nord africanasembra abbia sviluppato quei caratteri di matrice orientale che la distingueranno rispetto al-la tradizione tardo antica e protobizantina144. A quell’epoca la Sicilia occidentale era islamica
141 Mi riferisco in particolare all’ipotesi avanzata da A. Molinari sulla continuità di produzione in Sicilia fino al medioevodelle pentole plasmate a mano prodotte nell’isola di Pantelleria nel periodo tardo antico, cfr. MOLINARI 1994a, p. 363.
142 Per un elenco aggiornato dei rinvenimenti più significativi siciliani attribuibili a questo periodo cfr. ARCIFA1998a, p. 281, nota 16 a cui vanno aggiunti i livelli di VIII secolo del Duomo di Cefalù - che hanno restituito alcuniframmenti di anfore provenienti probabilmente dall’Italia centro meridionale e due lucerne cosiddette a scarpa che co-stituiscono a tutt’oggi gli unici fossili guida almeno per l’VIII secolo, cfr. TULLIO 1989, pp. 94-95 -, e gli strati di VIII-IX secolo dell’edificio romano nell’isola di Marettimo (TP), cfr. Marettimo, pp. 373-411. Per le notizie sul rinvenimen-to di frammenti di ceramica a vetrina pesante di probabile produzione laziale databili dall’VIII-IX fino al X-XI secolo,cfr. MOLINARI 1994a, p. 364, nota 33.
143 Couleurs de Tunisie, p. 116, schede nrr. 56-65.144 GAYRAUD 1997, p. 264. Infatti, è ancora molto evidente in queste regioni la continuità con il passato produtti-
vo tardo romano. Gli unici siti con continuità di vita dell’area islamica noti dalla letteratura archeologica sono quellidell’area siro - palestinese. In queste località Sodini, a riprova di quanto detto, ha osservato una chiara continuità conil passato bizantino nell’evoluzione delle forme alto medievali, almeno fino al IX-X secolo, quando vengono introdot-te nuove morfologie, cfr. SODINI - VILLENEUVE 1992, p. 211. La stessa continuità è stata riscontrata nella produ-zione anforica omayyade palestinese con la produzione almeno fino all’VIII secolo delle anfore a sacco ed in quella diKellia dove nello stesso periodo si ritrovano le forme classiche della produzione egizia tardoantica (tipi Egloff 173-175).Come hanno osservato J.P. Sodini e E. Villeneuve anche nel castello omayyade di Khirbet al-Mafiar presso Gerico laproduzione anforica tardoantica sembra proseguire fino all’età abbasside (SODINI - VILLENEUVE 1992, pp. 197-99).Da ultimo su queste problematiche cfr. VILLA 1994, p. 411.
127
da almeno un secolo e, per i repertori morfologici delle produzioni locali della secondametà del X, ma soprattutto dell’XI secolo, non sembra convincente l’ipotesi che le formedi tradizione tardo antica e quelle islamiche coesistano come fenomeni distinti145. Gli uni-ci apporti islamici identificabili con certezza nella produzione ceramica locale riguardanole tecniche di lavorazione e di decorazione della ceramica con l’introduzione dell’invetria-ta e dei forni a barre e di alcune forme ceramiche per le quali è accertato che non erano pre-senti nella cultura materiale isolana prima dell’arrivo dei Musulmani146. Nell’analisi di que-sti fenomeni non bisogna confondere gli apporti dovuti alle innovazioni tecnologiche e latradizione morfologica. Per quanto riguarda poi il repertorio decorativo, la storia della ce-ramica ci insegna che influssi di matrice orientale in una produzione non implicano neces-sariamente l’opera di artisti orientali.
Nella Sicilia normanna del XII secolo è ormai anacronistico fare riferimento genericamen-te ad "influssi" dall’area islamica, dal momento che sono ormai definiti i canoni stilistici e for-mali dell’arte normanna; anche la cultura materiale isolana ha dei caratteri autonomi matu-ri, che sono il prodotto della libera elaborazione di apporti di varia origine. Inoltre, l’isolamalgrado sia divenuta cristiana è perfettamente inserita nei circuiti culturali e commercialinord africani al punto che gli stessi “Arabi” la considerano ancora parte del Maghreb147.
Ciò premesso, tuttavia, si possono fare una serie di considerazioni sulla ceramica dipinta.Lo stato attuale degli studi sulle produzioni locali di questo periodo, ma soprattutto degli ul-timi secoli della dominazione bizantina dell’isola (fine VII-IX secolo), non ci consente di rin-tracciare la genesi di questo tipo di decorazione, anche se, almeno per quella con cappi con-tinui, pur con le dovute cautele, si potrebbe ipotizzare il perdurare della tradizione locale pre-cedente. A tal proposito merita secondo noi riflettere su alcuni dati in nostro possesso:
• l’evoluzione dei motivi dipinti attestati sulle forme più antiche di questa produzione ri-manda ai decori con andamento curvilineo a cappi continui che, abbiamo visto, sono tipicidella produzione bizantina ed il cui sviluppo sulla ceramica dipinta si può cogliere nelle pro-duzioni dell’Italia meridionale, ancora nell’avanzato medioevo;
• questa tradizione sembra perduri nella Sicilia orientale dove nei contesti alto medievaliricorrono le forme chiuse acrome con decorazioni a motivi curvilinei a cappi continui dipin-te sulla superficie esterna148;
145 Questa ipotesi è stata avanzata da A. Molinari relativamente al confronto istituito tra le produzioni di ceramichefini da mensa delle fornaci di Mazara del Vallo, per le quali la studiosa non ha dubbi nel considerarle «tipicamente “isla-miche”», e la produzione di ceramiche comuni e di anfore di Agrigento ritenuta al contrario appartenente ad un “am-bito tecnico-culturale” di matrice differente nel solco della tradizione locale. In questa valutazione va considerato inol-tre che le forme aperte acrome presenti ad Agrigento sono dal punto di vista morfologico assolutamente identiche aquelle documentate nelle forme più antiche delle invetriate, quelle per l’appunto che a detta della Molinari sarebberole prime testimonianze del cambiamento tecnico culturale. Cfr. MOLINARI 1997a, p. 375.
146 Mi riferisco alle lucerne a piattello e serbatoio a cupola e ai vasi con filtro. Bisogna ricordare che tali forme sem-brano ricollegarsi, ancora una volta a precedenti tardo antichi documentati in Nord Africa, cfr. Atlante I, tav. CIII, 5a-b, p. 206, forma XVI, e tav. XXIII, 10-11, p. 51. Per le lucerne cfr. ARCIFA 1997, p. 408
147 UDOVITCH 1993, p. 188. 148 Per uno studio riassuntivo delle problematiche e delle tipologie delle forme chiuse della ceramica comune siciliana
tra VI e VII secolo, da ultimo cfr. PUGLISI-SARDELLA 1998. Per la ceramica a bande rosse di questo periodo cfr. da ul-timo GRECO-MAMMINA-DI SALVO 1993, p. 167, fig. 10 e p. 177, cat. 324. La ceramica dipinta di questo periodo, co-me è stato osservato da L. Arcifa, risulta percentualmente inferiore rispetto alle forme acrome (ARCIFA 1998a, p. 281).
128
• il Nord Africa, di contro, non sembrerebbe avere una tradizione di ceramica dipinta diquesto genere ed i motivi dipinti omayyadi siriani e giordani, vagamente confrontabili con inostri, affondano le loro origini nella ceramica dipinta bizantina prodotta in quelle aree geo-grafiche prima della conquista musulmana149;
• la produzione di ceramica dipinta della Sicilia occidentale e centro meridionale, inoltre,al suo nascere è troppo articolata per essere una neo sperimentazione dell’elemento musul-mano della popolazione e la standardizzazione stessa dei motivi decorativi è il frutto di un’e-voluzione già matura;
• di contro sembrano invece appartenere alla tradizione islamica più matura i motivi pseu-do epigrafici e a racemi floreali presenti nella sovraddipinta in bianco che probabilmente, co-me ha sostenuto L. Arcifa, viene introdotta in Sicilia nella seconda metà del X secolo.
Questo dato, visto lo stato degli studi sull’argomento e la pressoché totale mancanza di materiali pubblicati relativi a que-ste fasi di vita isolane, non può essere indicativo della “povertà” delle produzioni dipinte della Sicilia bizantina. Inoltre, pro-prio nella parte orientale dell’isola durante i secoli dell’alto medioevo lo scavo del Foro di Taormina ha restituito numero-si frammenti di una grossolana ceramica acroma con decorazioni dipinte in rosso o in bruno per la quale si potrebbe ipo-tizzare una provenienza locale sulla base sia dell’abbondanza di questi materiali che della povertà dell’esecuzione (BACCI1980-81, p.744). Sempre dalla Sicilia orientale (Monte Casasia in provincia di Ragusa) proviene una forma chiusa con deco-razione a cappi allacciati dipinta in rosso cfr. FOUILLARD - FRASCA - PELAGATTI 1994-1995, pp. 572-573, fig. 199.
149 SODINI-VILLENEUVE 1992; Questo dato non sorprende per una regione come la Siria che abbiamo visto esse-re tra le aree conquistate dall’Islam quella col sostrato bizantino più consistente.
129
2.6 ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA FUNZIONE DELLE FORMEINDIVIDUATE
Dalle fonti documentarie medievali in nostro possesso risulta che per il trasporto dei prodottialimentari, malgrado la crisi del contenitore di terracotta, spesso venivano utilizzate le anfore150.Nella Sicilia araba e poi normanna i generi che venivano principalmente esportati anche in questotipo di recipiente sono: il pesce salato, le olive, i legumi, la frutta secca, il formaggio, il miele151 edin misura minore l’olio152; il vino era bene d’esportazione ma solo durante il periodo normanno.
Dallo studio sulla diffusione dei tipi di anfore prodotte nella Sicilia occidentale tra il X edil XII secolo è stato possibile identificare alcune forme usate prevalentemente per il trasportodi derrate alimentari nonché i contenitori, come per esempio il tipo A, che servivano per laconservazione di liquidi, in particolare di acqua e vino.
Fino al secondo dopoguerra quartare di terracotta153, di forma molto simile al nostrotipo A, erano usate in Sicilia per conservare l’acqua da bere fresca e pulita anche per qual-che giorno: infatti il liquido, assorbito dal corpo permeabile del vaso, trasuda alla super-ficie ed evaporando ne raffredda il contenuto. Anche i dati quantitativi degli esemplaridocumentati alla Zisa e tra il materiale di Palazzo Abatellis sembrerebbero confermarel’ipotesi che questa forma sia stata usata per fini domestici, infatti, le anfore tipo A1 e A2sono le più attestate154. Inoltre il tipo A, dalla caratteristica imboccatura stretta, adattaper i liquidi, non si ritrova al di fuori della Sicilia ed è presente con le sue varianti A1 eA2 soltanto a Palermo, mentre la variante A3, quasi senza alterazioni morfologiche di ri-lievo, è molto comune tra il vasellame di uso corrente nei siti rurali siciliani, la cui vita
150 Nell’XI secolo erano preferiti per il trasporto delle derrate alimentari le borse di pelle ed altri recipienti in mate-riale deperibile rispetto alle anfore e alle giare di terracotta usate a tal fine in misura minore, cfr. GOITEIN 1967 p.209 ss., p. 260, supra, Capitolo I, p. 77, nota n. 120. Per l’uso di contenitori di ceramica nel trasporto di alcune mercicfr. nota seguente. In generale sulla crisi dei contenitori di terracotta per i trasporti dei beni agricoli cfr. supra, Premes-sa, p. 46; Questi contenitori potevano essere riusati più volte anche per beni diversi come è attestato per le anfore bi-zantine dei relitti di Yassï Ada (VII secolo) e di Serçe Limanï (XI secolo). Cfr. VAN DOORNINCK 1989, pp. 247-257.
151 I mercanti avevano giarre, botti e carratelli per trasportare questo bene oggetto di scambio almeno dal XII secolocome ci attestano le lettere della Geniza del Cairo. BRESC 1976, p. 24 e per la commercializzazione del prodotto cfr.GOITEIN 1967, p. 219 e a p. 485, nota 8 l’A. riporta i nomi arabi per indicare i contenitori da trasporto di terracotta:zir, jarra, qulla usati essenzialmente per olio, sapone e aceto, mentre le brocche fuqqa’a erano usate per il miele ed ilmercurio; in una fonte musulmana del XII secolo si fa riferimento ai fiaschi per l’olio, ai barili per i grani grossi (caffè)e ai fakakih per il burro. Il termine fakakih è stato tradotto dalla De Simone, che ha curato la traduzione della fonte,con il termine “quartare”, cfr. DE SIMONE 1996, p. 69.
152 Si veda il diploma citato da AMARI Storia, vol. III, p. 783 nel quale si ricorda da parte del Monastero del San Salvatoredi Messina l’esportazione per l’Africa di 200 salme di frumento «ad emendum oleum et reliqua necessaria eis, quae inAfrica sunt». Che l’olio fosse prodotto essenzialmente in Tunisia è documentato anche nelle lettere della Geniza delCairo, cfr. GOITEIN 1967, p. 154, p. 330 cita una nave tunisina che portava olio ad Agrigento; GOITEIN 1971a, p.294 cita un mercante tunisino a Palermo che nel 1064 aveva un totale di 500 dinari in olio. Comunque, come osservalo stesso Amari, la coltura dell’ulivo, ricordata espressamente da Falcando, dovette essere accresciuta ma non impian-tata ex novo nella seconda metà del XII secolo, AMARI Storia., p. 783, nota 2. GOITEIN 1967, a p. 485, nota 8 ricor-da una lettera in cui si dice che tre grandi jirar con olio puro furono mandate dalla Sicilia all’Egitto.
153 Questo termine, ancora oggi in uso nel dialetto siciliano per indicare i contenitori di terracotta, veniva utilizzatofin dal XII secolo, sia per l’unità di misura per liquidi, sia per il recipiente di ceramica e più in generale i quartarii era-no coloro i quali fabbricavano vasi di terracotta.
154 Non sorprende che i contenitori da trasporto siano in quantità inferiore dal momento che i beni destinati all’e-sportazione costituivano una piccola parte dell’intera produzione. Per i dati quantitativi cfr. supra, Tabelle 1-3.
155 MOLINARI 1997b, pp. 78, 87, figg. 170-171, p. 127. Si tratta di un numero minimo di 42 esemplari, tutti dispo-sti sul pavimento lungo la parete orientale dell’ambiente 6. Il contenitore segestano confrontabile con il nostro è allaclasse II.1 della classificazione della Molinari.
156 Le fornaci furono attive tra la fine dell’XI secolo e la prima metà del XII, cfr. AMPOLO 1971, pp. 261-267; FIO-RILLA 1995b, pp. 33-34.
157 Nel sito della statio tardo romana sono state isolate tre fornaci: una relativa alla fase tardo antica e due databili tral’XI ed il XII secolo, il primo resoconto della scoperta si deve a D. Adamesteanu, di recente è stata proposta una rilet-tura dei dati, cfr. FIORILLA 1995b, p. 34 con bibliografia precedente.
158 Ancora fino a pochi decenni fa i contadini siciliani portavano l’acqua da bere in campagna dentro una piccola anfo-ra di forma ovoidale, dal collo stretto e lungo molto simile al nostro tipo A, denominata bummulu, per la somiglian-za morfologica tra il tipo A ed il bummulu, cfr. D’ANGELO 1976.
159 Come dimostrerebbe la presenza di materiale molto vario sia per tipologie che per cronologie recuperato nellostesso sito.
160 ARDIZZONE 1998, p. 397. 161 Cfr. ARDIZZONE 2010. 162 LEBOLE DI GANGI 1994, p. 364; da ultimo DI GANGI - LEBOLE DI GANGI 1998a, Fig. 6, p. 110.163 Un frammento di parete con cordonature e con la caratteristica decorazione a larghe bande di colore bruno e con
impasto che macroscopicamente somiglia a quello delle anfore palermitane è stato trovato ad Otranto, cfr. ARTHUR1992, p. 213, fig. 7.6, 865.
164 ARTHUR 1986a, fig. 4, p. 548 dallo scavo di Santa Patrizia in un contesto di XI secolo.165 PEDUTO 1986, p. 560, fig. 12, segnala il rinvenimento di un’anfora a cannelures del tipo D con nervatura a rilie-
vo tra il collo e la spalla dalla plebs baptesimalis del S. Lorenzo di Altavilla Silentina (SA); PEDUTO 1994, p. 296, incontesti di XII secolo; nella valle del medio Volturno, frammenti di ceramica dipinta «a fasce sottili, di origine islami-ca - araba» sono stati recuperati nelle ricognizioni effettuate sulla collina di S.Angelo d’Alife in provincia di Caserta.
166 Per il rinvenimento di pareti a cannelures con decorazione a bande brune alternate a tratti obliqui che presentanoun impasto molto simile alle anfore palermitane, cfr. MAETZKE 1984, p. 144 e s., tavv. 27, 14, 17.
167 MENCHELLI 1993, p. 521, nr.1, a Piazza Dante in contesti datati tra X e XIII secolo; recentemente la Menchel-li e la Berti hanno ripreso le problematiche relative alla presenza di anfore di produzione siciliana nei contesti pisanirilevandone l’attestazione già nelle fasi della seconda metà del X secolo ed un progressivo aumento nei contesti di fineX - XI secolo e poi di XII secolo, cfr. BERTI - MENCHELLI 1998, p. 327, tab.10, schema 12.
130
si protrae fino al XIII secolo. Significativo a tal proposito è il rinvenimento a Segesta dinumerose anfore riferibili a questa forma, immagazzinate e chiaramente usate come con-tenitori per la conservazione delle derrate in un ambiente databile tra il 1220 ed il 1250,per il quale è stata riconosciuta la funzione di magazzino - cucina del castello medieva-le155. Per questo tipo di anfore sono documentate anche produzioni locali in centri mino-ri ad economia agricola come Piazza Armerina156 e Sofiana157, che attesterebbero la fab-bricazione in loco per il fabbisogno delle popolazioni residenti nelle campagne158.
I tipi B, C, D, E, L, M ed N erano molto probabilmente destinati al trasporto di derra-te alimentari come confermerebbero i rinvenimenti di contenitori riferibili a queste formedi produzione palermitana in centri ubicati fuori dalla Sicilia ed I recuperi sottomarini.Anfore del Tipo B e del Tipo E sono presenti tra il materiale abbandonato da imbarca-zioni in difficoltà a Mondello, lungo la costa palermitana159, nel relitto di San Vito Lo Ca-po e nelle isole Egadi a Marettimo160, mentre un’anfora Tipo L con l’indicazione del pe-so del suo contenuto è stata isolata tra il materiale del relitto di Marsala.
Diverse anfore del Tipo N sono state recentemente recuperate in due relitti individuati aMarsala ed a San Vito Lo Capo (TP). Per questi contenitori, appartenenti al carico delle na-vi, è stata avanzata l’ipotesi che trasportassero zucchero161.
I rinvenimenti di anfore di produzione siciliana a Tropea162, Otranto163, Napoli164, Saler-no165, Capaccio Vecchia166, Pisa167, Genova168, Savona169 e a Geridu (SS) in Sardegna170 nonché
131
168 A San Silvestro (PRINGLE 1977, tav. IV, 4a, p. 108) è stato recuperato in contesti datati tra la fine dell’XI e gliinizi del XII un frammento di forma chiusa con decorazione dipinta in rosso.
169 Recentemente al Priamàr (Savona) sono stati isolati in contesti del XII secolo frammenti di pareti con cordonatu-re in associazione con l’invetriata verde di produzione siciliana (BENENTE 1996, p. 351). Sia nel caso di Genova chenel caso di Savona l’appartenenza ad anfore siciliane è incerta.
170 MILANESE 1996, p.518, fig. 30.12.171 TRÉGLIA et alii 2012; GRAGUEB - TRÉGLIA - CAPELLI - WAKSMAN 2011.172 Infatti nei documenti della Geniza le città di Amalfi, Salerno, Venezia e Lucca compaiono molto spesso mentre
bisognerà aspettare il XII secolo per incontrare anche i pisani ed i genovesi. 173 GOITEIN 1967, p. 211, p. 209 e ss. 174 PEDUTO 1994, p. 295; l’A. non specifica di quali documenti si tratta e di che periodo sono. L’A. riporta la deno-
minazione medievale di questi contenitori i “Cados”.175 BRESC 1983, pp. 266 e s. tabl. 39 e carte 20 cita una tonnara a Isola delle Femmine ad Ovest di Palermo attiva nel
1176 e una a Cefalù nel 1130-1140 e sempre nella Sicilia occidentale a Scibiliana vicino Mazara è attestata la più anticatonnara dell’isola attiva tra il 1093 e il 1144.
176 BRESC 1976, p. 24.
fuori dall’Italia in Provenza e in Nord Africa171 (fig. 48) sono un’ulteriore conferma dell’esistenzadel commercio di derrate alimentari dalla Sicilia normanna verso e tramite le città marinare atti-ve tra l’XI ed il XII secolo172. Che fossero principalmente le città marinare i vettori commercialidei prodotti siciliani nei mercati italiani e nell’Europa settentrionale si evince dai documenti del-la Geniza del Cairo nei quali si fa esplicito riferimento alla consuetudine di mercanti cristiani pro-venienti da queste città a recarsi nei mercati nord africani e siciliani per l’acquisto di merci173.
Infine, riguardo le grandi “giare” di forma D è stato ipotizzato, sempre sulla base di docu-menti d’archivio, che trasportassero tonno o più genericamente pesce sotto sale174, utilizza-zione che a nostro parere trova conferma nella morfologia del recipiente, dotato di larga im-boccatura. La produzione di tonno salato in Sicilia è d’altra parte documentata dalle fonti ar-chivistiche che registrano la presenza di tonnare attive lungo la costa palermitana nel XII se-colo175. Ancora nel XIV e XV secolo il commercio di questi beni è testimoniato dai documen-ti dove si fa menzione dell’uso esclusivo, da parte dei mercanti, di barili o di recipienti piùpiccoli come la bucticella e la terzarola per il trasporto di pesce sotto sale176.
Fig. 49a - Palermo edifici normanni, pentola. Fig. 49b - Palermo edifici normanni, vaso da zucchero.
135
CAPITOLO III
I contesti di rinvenimento delle anfore alto medievali della Sicilia occidentale
Al fine di completare le informazioni fornite dall’analisi del repertorio morfologicodelle anfore documentate nella Sicilia occidentale nei secoli dell’alto medioevo, e con-sentire il vaglio critico dei dati riportati, ci è sembrato necessario, sotto il profilo me-
todologico, contestualizzare i rinvenimenti, e fornire alcune informazioni sugli scavi dei sitipresi in considerazione, tenuto conto che si tratta per lo più di materiali che difettano anco-ra oggi di un inquadramento cronologico e tipologico preciso, nonché di contesti editi.
Prenderemo in considerazione un sistema complesso di dati che tenga conto delle crono-logie relative del deposito archeologico, delle associazioni in strato con altri reperti datanti e,qualora vi siano, dei confronti con altri contesti tenendo ben presente le differenze dovutealle diversità socio economiche dei siti confrontati. Infine, trattandosi di anfore per le qualinon è sempre facile distinguere la funzione, la natura del deposito archeologico potrà fornir-ci informazioni sull’uso di questi recipienti: se siano o meno state adoperate come conteni-tori da trasporto ovvero quali vasi per la conservazione delle derrate alimentari.
Fatta questa premessa proseguiremo analizzando la stratigrafia dei siti citati nel corso del-la nostra ricerca, che verranno esposti seguendo il criterio della cronologia dei contesti, par-tendo quindi dai più antichi fino ai più recenti.
3.1 MARETTIMO
Nell’isola di Marettimo, in contrada "Case Romane si conserva un complesso monumen-tale costituito da un edificio militare di età tardo repubblicana in opus quasi reticulatum, dauna piccola chiesa medievale di impianto basiliano e da una cisterna1 (fig. 1). Nella stessa area,nella zona immediatamente antistante l’ingresso dell’edificio romano, è stato inoltre messoin luce un insieme di strutture murarie e di canalizzazioni, che convogliavano le acque della
1 Per la bibliografia precedente e per le informazioni storiche sul sito cfr. ARDIZZONE - DI LIBERTO 2010.2 Studio idrogeologico 1993. Si tratta della più ricca sorgente di acqua dolce dell’Isola.3 Per il catalogo delle anfore e per la discussione sui tipi cfr. infra Capitolo I, p. 52-57 e Catalogo, pp. 146-150.
vicina sorgente di acqua dolce2, attribuibili al VI secolo d.C. Nel 1994 sono state condotte del-le indagini archeologiche, nell’ambito delle quali all’interno dell’edificio in opera reticolatasono stati identificati i livelli di frequentazione altomedievali che hanno restituito alcune anfo-re databili tra la fine del VII ed il IX secolo3 .
Il ruolo di Marettimo quale importante scalo lungo le rotte che collegavano la Sicilia nonsolo all’Africa, ma anche alla Sardegna è testimoniato fin dall’età romana dall’Itinerarium An-tonini dove, con il nome latino di Maritima, compare quale statio nella rotta che dalla Siciliaportava a Capo Bon4. L’importanza dell’isola lungo queste rotte è ribadita nel medioevo daipiù antichi portolani a noi noti: il Liber de Exsistencia riveriarum, redatto a Pisa nel XII seco-lo5 e il Conpasso de Navegare, della metà del XIII secolo6. Ancora nel XVI secolo, i Portolanicatalani fanno menzione dell’isola lungo la rotta che collegava la Sicilia a Capo Bon7.
La frammentarietà delle fonti storiche in nostro possesso non ci consente di delineare unquadro preciso della frequentazione dell’isola, tuttavia le stesse parrebbero concordi nel riba-dire l’assenza di un insediamento stabile. Pertanto, gli edifici in contrada "Case Romane" do-vettero rimanere per molti secoli in tutta l’isola le uniche strutture costruite in pietra. Le fon-ti medievali di XII secolo che indicavano Marettimo come disabitata8 trovano smentita nellacronologia stessa degli edifici9 e nei dati archeologici recuperati durante la campagna di scaviche attestano una frequentazione del sito in età normanna10. Tra queste fonti anche la più au-torevole, quella di Idrisi il geografo di Ruggero II, contraddittoria circa la presenza o menodi un porto nell’isola, fa ipotizzare che l’autore del Libro di Re Ruggero abbia utilizzato del-le fonti di seconda mano di cui non ha verificato l’attendibilità recandosi personalmente nel-l’isola11. Infine, l’abbandono seguito alla frequentazione medievale del sito, documentato dal-le indagini archeologiche trova conferma nelle fonti scritte relative ai secoli XIV- XV che cidescrivono l’isola ormai spopolata e dimenticata, ricetto sicuro per i pirati africani e turchi12.
136
4 MILLER 1916, p. LXVII, 492-493. 5 Cfr. GAUTIER DALCHÉ 1995, p.175. 6 MOTZO 1947, pp. 98-99; 107; 109-110; 112. 7 Alfonso Ventimiglia, nel Portolano del 1573, descrivendo l’isola di Marettimo significativamente scrive "Tiene abri-
gos y buena aqua" cfr. CRINO’ 1906, p. 22. Inoltre, una disanima sulle rotte che passavano per le isole Egadi è in CO-LUMBA 1906, pp. 247-248.
8 Ibn Giubàir che visita la Sicilia durante il regno di Guglielmo II (1183-1185), afferma che Marettimo non era popo-lata, cfr. Ibn Giubair (versione di C. Schiaparelli) in GABRIELI 1985 p. 744.
9 L’impianto della chiesetta è stato attribuito sulla base dei confronti stilistici con altre strutture analoghe al periododella contea cfr. DI LIBERTO 1998, p. 401.
10 Cfr. PEZZINI 1998a, p. 407. 11 Idrisi descrivendo l’Isola da indicazioni contraddittorie: "ad occidente dell’Isola si trova Marettimo situata di fron-
te a Tunisi e Cartagine e discosta trenta miglia da Favignana; essa manca di porti e la sua fauna comprende capre e gaz-zelle" e più avanti "adiacenti a Trapani si trovano Favignana Levanzo e Marettimo ognuna dotata di un porto, di bo-schi e pozzi da cui si ricava la legna". Idrisi a cura di RIZZITANO 1994, pp. 26, 43.
12 Un documento del 1240 cita Marettimo con altre isole siciliane tra i luoghi dove venivano catturati i falconi per Fe-derico II cfr. HUILLARD - BREHOLLES 1852-1861, V, p. 858; Nel 1399, al tempo di re Martino, le isole Egadi sonoconsiderate possedimenti demaniali cfr. G. L. Barbieri in SILVESTRI 1888, p. 22. Più avanti nella stessa pagina l’A. ciinforma che nel 1510 le isole risultavano alienate e concesse in feudo; ulteriori fonti relative ai secoli XIV e XV men-zionano l’isola esclusivamente per la presenza di pirati nelle sue acque, BRESC 1986, p. 339; nella seconda metà del XVsecolo secondo il Gregorio l’isola "già resa diserta" era "sicuro ricetto" per i Corsari dell’Asia e dell’Africa cfr. GRE-GORIO 1873, p. 519; Ancora nel 1521 un geografo turco Piri Reïs nel suo viaggio attraverso il Mediterraneo cita Ma-rettimo e ne dà la distanza da Favignana, cfr. SACHAU 1910, pp. 8-9.
L’edificio romano, in opus quasi reticulatum (fig. 1)13, unico per il suo impianto in Sicilia14,venne fondato con chiara matrice militare verosimilmente tra il 43 ed il 36 a.C. da Sesto Pom-peo in posizione strategica su una balza rocciosa da cui si dominano le isole di Favignana eLevanzo e la terraferma da Marsala fino al monte di Erice15. La cronologia alla seconda metàdel I a.C. ben si accorda con i dati archeologici relativi al momento della fondazione dellastruttura romana derivanti dall’indagine effettuata al suo interno e con la datazione dell’opusreticulatum nel resto della penisola16. Questa struttura fu usata quasi ininterrottamente finoagli anni ‘50 di questo secolo subendo vari rimaneggiamenti e trasformazioni.
All’interno della struttura romana le indagini archeologiche hanno individuato quattro fasidi vita: la prima ascrivibile all’impianto originario dell’edificio databile al I secolo a.C.17; la secon-da riferibile ad età tardo antica (V secolo), vede una risistemazione globale della struttura roma-na con l’elevazione del muro di divisione tra i vani II e V e con la costruzione su tutta la super-ficie dell’edificio di un battuto pavimentale in argilla18; la terza fase alto medievale dell’VIII seco-lo, è quella che ha restituito le anfore oggetto del nostro studio. Durante questo periodo il sitovenne frequentato e riadattato, come attestano alcuni rifacimenti del piano pavimentale tardoantico sul quale furono aperte tre fosse (UUSS 440; 438; 439; 122) colmate contemporaneamen-te e successivamente chiuse con uno spesso strato di argilla gialla19. Sia i riempimenti (UUSS 444,450, 456, 150) sia lo strato di argilla gialla (US 443) che sigillava le fosse hanno restituito nume-rosi frammenti di anfore databili, sulla base dei confronti, tra la fine del VII e l’VIII secolo e qual-che frammento di ceramica da fuoco dello stesso periodo20. La funzione di queste fosse all’in-terno della struttura non è chiara ed è stata avanzata l’ipotesi che quella scoperta all’angolodel vano III servisse per ospitare un recipiente per la conservazione di derrate alimentari21.
137
13 Questa tecnica muraria è documentata in Sicilia da rari esempi datati tra l’età augustea e gli inizi del II secolo d.C.;per gli altri edifici siciliani in cui è adoperato l’opus reticulatum cfr. ARDIZZONE 1998, p. 390.
14 Il suo impianto trova confronti precisi con le più tarde turres del limes africano, cfr. REBUFFAT 1965, pp. 113-134.15 Gli unici due avvenimenti storici che potrebbero avere determinato l’impianto di una piccola base militare a Maret-
timo sono il bellum navale di Gn. Pompeo contro i pirati cilici ed ancora quello tra Sesto Pompeo ed Ottaviano. A que-sto proposito Plutarco nella vita di Gn. Pompeo (24-26) ci narra che nel 67 a.C. Pompeo, dovendo combattere i pirati ci-lici suddivise il Mediterraneo in 13 settori, stabilendo per ognuno un certo numero di navi ed un comandante, e con ope-razioni di polizia costrinse i pirati ad abbandonare il mare libico ed il Tirreno e quelli intorno alla Corsica alla Sardegnae alla Sicilia. Qualche anno più tardi , tra il 43 ed il 36 a.C. Sesto Pompeo, dopo essersi impossessato della Sicilia la usòquale base militare per azioni di disturbo sui carghi romani provenienti dall’Africa. Il Torelli, nonostante ubichi erronea-mente l’edificio romano a Favignana, riferisce la costruzione dell’edificio alla riorganizzazione della Marina Militare daparte di Agrippa negli anni che seguirono la guerra contro Sesto Pompeo (TORELLI 1980, p. 152). Una conferma indi-retta di questa seconda ipotesi viene da un’epigrafe rinvenuta nell’Insula di Capo Boeo a Marsala, che ricorda il restaurodel porto di Lilibeo e la costruzione di torri lungo la costa ad opera di Sesto Pompeo, per l’epigrafe, cfr. SALINAS 1894.
16 Cfr. ARDIZZONE 1998, p. 390.17 Per tutte le indicazione sulla stratigrafia del sito cfr. PEZZINI 1998a, p. 402-407.18 Tale pavimentazione è documentata nei vani III, IV, V e tracce nel vano II. All’esterno dell’edificio romano è da
mettere in relazione con questa fase un recinto rettangolare lastricato che ingloba, sui due lati brevi, due vasche ellitti-che collegate alla sorgente mediante un sistema di canalette.
19 Le fosse sono state aperte nei vani III (Saggio B) e IV (Saggio G). La contemporaneità ed uniformità del riempimen-to è stata ipotizzata sulla base del rinvenimento negli strati di riempimento di due fosse differenti di due frammenti ri-componibili pertinenti alla stessa anfora, cfr. PEZZINI 1998a, p. 404.
20 Cfr. PEZZINI 1998a, p. 413, fig. 13.21 Analoga funzione è stata ipotizzata per un angolo chiuso da un muretto all’interno di una casa di Monte Iato del
XIII secolo PEZZINI 1998a, p. 404.
I dati di cui disponiamo non consentono comunque di determinare la natura e la consi-stenza dell’occupazione dell’area in questa epoca. La quarta ed ultima fase di vita dell’e-dificio romano ascrivibile ad età medievale (fine XI- prima metà XII secolo)22 vede la ri-sistemazione del piano pavimentale e la sequenza di tre sottili battuti, il più recente deiquali è databile all’età gugliemina23.
Tra la fase altomedievale e quella normanna, pertanto, sembrerebbe esserci uno hiatusdi circa tre secoli in cui mancano evidenze archeologiche sulla frequentazione dell’area,fatta eccezione per una moneta di Michele III (842-866), rinvenuta nel Saggio A, coniatadalla zecca di Siracusa24.
3.2 CEFALÙ
Un piccolo gruppo di anfore alto medievali di VIII secolo25, significativo sia per la prove-nienza che per l’associazione in strato con materiale datante, è stato recuperato nel 1980-81,durante gli scavi archeologici eseguiti all’interno ed all’esterno del Duomo di Cefalù, in oc-casione dei lavori di restauro dell’edificio26 (fig. 3). In quest’area è stata messa in luce una se-quenza di “livelli”, relativi alle varie fasi di vita del sito, databili dall’età ellenistica (IV secoloa.C.), quando la città di Kephaloidion venne fondata, al regno di Ruggero II sotto il quale sidiede avvio alla costruzione della chiesa (1131). A partire dal IV secolo a.C., l’intera zona do-ve sorge la cattedrale era urbanizzata come si ricava dalla presenza di due assi viari: uno data-bile al primo impianto della città in età ellenistica (metà IV a.C. - II a.C. (?) e l’altro riferibi-le al periodo romano (II a.C. (?) - terzo quarto del II d.C.)27.
Dal 175 d.C. circa la città conobbe un periodo di crisi e di contrazione dell’abitato docu-mentato archeologicamente dall’abbandono delle strade individuate, che vennero obliterateda un crollo di elementi architettonici. Solo nel VI secolo d.C. l’area antistante il Duomo ven-ne edificata con la costruzione di una struttura, forse una chiesa, di cui resta soltanto parte delmosaico pavimentale policromo con raffigurazioni di uccelli stilizzati ed elementi vegetali28.
138
22 I frammenti ceramici rinvenuti negli strati di abbandono sono databili in un arco cronologico compreso tra l’XI se-colo ed il XII, testimoniano una occupazione precoce dell’area da mettere in relazione con la chiesetta datata come ab-biamo visto per i caratteri stilistici al periodo della contea cfr. DI LIBERTO 1998, p. 401.
23 In questo strato è stato recuperato un follaro tosato di Guglielmo II (1166-1189), della Zecca di Messina, cfr. MAM-MINA 1998, p. 418, n.2.
24 MAMMINA 1998, p. 418, n.125 Per le anfore vedi supra, Capitolo I, pp. 50-57; infra, Catalogo, pp. 207-210. 26 I saggi di scavo sono stati condotti dal prof. A.Tullio che ringrazio per avermi permesso di studiare le anfore e la ce-
ramica da fuoco alto medievali contestualmente recuperate. Sia i saggi eseguiti nel Duomo di Cefalù che i materiali più si-gnificativi ivi rinvenuti sono stati pubblicati in due riprese: in occasione della Mostra realizzata in concomitanza con l’i-nizio dei restauri dell’edificio cfr. TULLIO 1982, pp. 45-58 e nella pubblicazione definitiva TULLIO 1989, pp. 13-114.
27 Nel saggio 3, aperto alle spalle del Duomo in prossimità del punto di raccordo all’esterno tra la piccola abside del-la protesis ed il muro NE del bema, sotto due livelli di sepolture il primo dei quali è da riferire all’età normanna, è sta-ta messa in luce una pavimentazione stradale a ciottoli con una canaletta di scolo al centro, riferibile all’impianto ur-banistico del IV secolo a.C. Questa strada sembra ortogonale al prolungamento verso NE dell’asse viario di età roma-na, messo in luce nel protiro della chiesa (saggio 1), cfr. TULLIO 1989.
28 La datazione viene proposta dal Tullio sulla base dei confronti stilistici del mosaico policromo, cfr. TULLIO 1989,pp. 48 e s.
L’edifico si presentava orientato diversamente rispetto alla maglia urbana preesistente, ormai evi-dentemente obliterata, e corrispondeva probabilmente ad una diversa destinazione d’uso dell’a-rea di cui, allo stato attuale delle nostre conoscenze, ci sfugge il rapporto con il resto della cittadi-na. Con questa struttura sarebbero stati messi in relazione tre frammenti marmorei di elementiarchitettonici decorati con tralci d’uva e melograni databili per confronti stilistici alla secondametà del VII secolo29. Né deve sorprenderci la presenza, nell’area dove oggi sorge il Duomo, di unedificio religioso bizantino di un certo pregio, a giudicare almeno dalla presenza del mosaico, dalmomento che a partire dal VII secolo Cefalù era annoverata tra le sedi vescovili siciliane30. L’im-portanza della comunità cristiana della cittadina ci viene, inoltre, suggerita dal mantenimento del-la dignità di chiesa metropolitana anche dopo che la città cadde nelle mani dei musulmani (857)31.
Particolarmente significativo ai fini del nostro studio sulle anfore alto medievali è il perio-do compreso tra la frequentazione medio bizantina dell’area (VII - VIII secolo) e la costruzio-ne normanna della basilica (1131). Di questa fase restano peraltro labili ed incerte tracce ar-cheologiche: solo il Saggio 2, tra quelli praticati nell’area del Duomo32, ha restituito materialidatabili agli inizi dell’VIII secolo tra cui alcune anfore. Purtroppo la stratigrafia in questo sag-gio sembra essere stata disturbata dall’impianto del grande muro che sostiene il colonnato esebbene i dati che ci vengono dallo studio dei materiali non possano essere ancorati ad unabuona sequenza stratigrafica, tuttavia, la coerenza cronologica degli oggetti recuperati nellostrato II tutti riferibili all’VIII secolo, rende plausibile l’affidabilità dello strato medesimo.
Come abbiamo in precedenza ricordato, la datazione alla media età bizantina è stata pro-posta da A. Tullio per la presenza, tra i materiali dello strato, di un sigillo plumbeo attribui-to al patrizio Antioco, datato alla prima metà dell’VIII secolo33. Apparterrebbe a questa fasedi vita del sito un muretto che ha lo stesso orientamento E-O della strada romana e che, se-condo A. Tullio, si inserirebbe «organicamente nel contesto dell’impianto urbanistico» pre-cedente34. Quest’ipotesi non trova, tuttavia, conferma nei dati emersi dal saggio 1, sulla basedei quali l’asse viario di età romana era stato abbandonato già dalla fine del II secolo d.C., enel diverso orientamento del pavimento a mosaico che, come abbiamo visto, si sovrappone-va alla maglia urbana precedente.
139
29 Si tratta di un frammento di lastra di marmo bianco con venature grigio azzurre (R17) e di due frammenti di stipi-ti dello stesso marmo (R18 ed R19) reimpiegati nella pavimentazione del bema della cattedrale normanna, cfr. BONA-CASA CARRA 1989, pp. 136-140, gli stipiti datati intorno alla metà del VII secolo, circa un secolo dopo la costruzio-ne del pavimento mosaicato ed anteriori alla fase di VIII documentata nel saggio 2, sono stati messi in relazione conuna fase di vita dell’edificio di culto intermedia e con «abbellimenti o ristrutturazioni compiuti in occasione dell’isti-tuzione del nuovo vescovato di Cefalù».
30 BONACASA CARRA 1992a, p. 3.31 Sappiamo dalle fonti che uno dei suoi vescovi, Niceta, nell’869-870 prese parte al IV Concilio Costantinopolitano
ZORIC 1989, p. 208, nota 4.32 Il saggio 2 è stato aperto all’interno della chiesa presso il sesto intercolunnio del colonnato meridionale.33 D’ANGELO 1982, p. 67, nr. 4-76; TULLIO 1989, p. 96 nr. 204, fig. 129. I Dioicheti erano degli amministratori;
altri sigilli con il nome di Antioco sono stati ricordati da S. BORSARI, in Rivista Storica Italiana, 66, 1954, n. 19, p.157, cfr. TULLIO 1989, p. 96, nota 121. Questa cronologia, come sopra anticipato, trova conferma negli altri materia-li qui recuperati quali: un frammento di lampada di vetro a stelo cavo, un coppo con larghe striature, alcuni frammen-ti di ceramiche da cucina, le anfore materia della nostra ricerca e soprattutto numerose lucerne del tipo definito da O.Mazzuccato “a ciabatta”. Per una descrizione più dettagliata sui materiali cfr. supra, Capitolo I, pp.
34 TULLIO 1989, p. 91. Il muro era lungo circa m 1.90 e formato da un doppio paramento di ciottoli sbozzati in fac-cia vista tenuti insieme da malta povera con un emplekton costituito da terra, ciottoli più piccoli e scaglie.
Il rinvenimento del muro nel saggio 2 ed i tipi di materiali recuperati, quasi tutti d’impor-tazione, farebbero ipotizzare la presenza di un insediamento di tipo urbano, del quale perònon siamo in grado di precisare la consistenza e la vocazione. Certo è che la superficie co-struita non doveva essere molto estesa dal momento che non sono stati isolati resti databilialla stessa epoca negli altri saggi aperti nell’area del Duomo35. Dalle fonti storiche contempo-ranee alla conquista araba si desume che nella media età bizantina l’abitato di Cefalù si era ri-tirato sul promontorio alle spalle della cittadina, la Rocca, e che le strutture a valle, in riva almare, furono parzialmente abbandonate al punto che, come ci viene ricordato dalla supplicadei canonici di Cefalù del 1170, Ruggero II dovette riedificare ex novo la città nel secondoquarto del XII secolo.
L’identificazione della Cefalù bizantina con l’abitato forte sulla Rocca, ci viene suggeritadalla descrizione del lungo assedio da parte dell’armata Musulmana nell’837-83836 e dalle mo-dalità della resa e della distruzione della «fortezza di Cefalù» ad opera di Al Abbas ibn al Fadldell’857-58 narrata da Ibn Idhari37. Con questa identificazione concorderebbe anche la descri-zione di poco precedente la conquista normanna: «Qalat Guflud (Rocca di Cefalù) la maggio-re è città forte di Sicilia, [fabbricata] sopra un alto monte in riva al mare»38.
140
35 Sulla questione problematica dell’individuazione di una fase di vita intermedia tra la frequentazione bizantina del-l’acrocoro e la costruzione del Duomo ruggeriano, sono stati espressi pareri discordi. All’esterno della struttura nor-manna, nella zona interessata dalla presenza del mosaico e della strada di età romana, il Tullio ha individuato una faseintermedia, datata dai risultati dello scavo archeologico genericamente in un arco di tempo che va dal VII secolo, pe-riodo in cui cade in disuso l’edificio con il mosaico, e la prima metà del XII, cioè al periodo immediatamente preceden-te, l’impianto ruggeriano del Duomo. A questa fase apparterrebbe nel saggio aperto nel protiro della basilica uno spes-so battuto bianco forse relativo al cantiere della chiesa normanna. Questo livello pavimentale è stato messo in relazio-ne dal Tullio con il muro a grandi blocchi visibili presso l’angolo SE del portico antistante l’ingresso alla chiesa, con-siderato dall’archeologo preesistente l’impianto ruggeriano. Di parere contrario sono gli architetti V. Zoric e V. Bru-nazzi, che attraverso il rilievo accurato del monumento e l’analisi delle murature e dei loro spessori, nonché attraver-so l’esame delle tecniche murarie impiegate nella costruzione del Duomo e dell’unitarietà del progetto, avvalorano l’i-potesi del riuso dei grandi blocchi, provenienti certamente dallo spoglio di edifici preesistenti, ma messi in opera con-testualmente alla costruzione della cattedrale normanna (ZORIC 1989, p. 226; BRUNAZZI 1989, pp. 375-376). Laspiegazione dell’uso di materiale per le sue dimensioni così scomodo da trasportare e lavorare, sta nel fatto che la chie-sa è stata concepita e realizzata come una fortezza e pertanto il lato più esposto atto a fronteggiare la città venne rea-lizzato a differenza degli altri meno esposti, in opera quadrata maggiormente resistente agli sfondamenti. La presenzadei grossi blocchi isodomi, quindi, nei due filari più bassi dell’ordito di questo muro costituiva una maggiore garanziadi difesa (ZORIC 1989, p. 226).
36 AMARI BAS I, Ibn al Atir, p. 372: «L’anno dugentoventitrè (3 dic. 837 - 22 nov. 838) vennero in Sicilia grosse for-ze navali dei Rum, mentre i Musulmani assediavano Cefalù da molto tempo.». Amari nella sua Storia infatti dice, aproposito del lungo assedio e della resa pattuita, che era difficile prendere la città per fame perché essendo troppo vici-na al mare poteva essere rifornita, cfr. AMARI, Storia, vol. I, p. 464.
37 AMARI BAS II, Ibn Idhari, p. 12:«L’anno 243 (30 apr. 857 - 18 apr. 858) fu combattuta la guerra sacra in Sicilia daAl Abbas ibn al Fadl... Quei della fortezza di Cefalù si arresero a patto di uscire [immuni] e che egli distruggesse la for-tezza: il che fu fatto ». Questo autore della fine del XIII secolo usò come fonte il Tabari compendiato con aggiunte daArib ibn Sad che, liberto presso gli Omayyadi di Cordoba, scrisse questo libro tra il 363-366 H (973-976). In questa fon-te sono riportate «le notizie più rare e più plausibili che abbiamo su le vicende dei Musulmani d’Occidente», AMARIBAS I, p. LIV.
38 Si tratta di un dizionario geografico, cfr. AMARI BAS I, Yaqut Mu ‘gam, p. 191: «Qalat Guflud (Rocca di Cefalù)la maggiore è città forte di Sicilia, [fabbricata] sopra un alto monte in riva al mare». L’autore del dizionario Yaqut, vis-suto a Baghdad alla fine del XII secolo, cita espressamente per questa notizia Al Hasan ibn Yahya autore della Tarih Si-qilliah (Storia di Sicilia) vissuto prima della conquista normanna della Sicilia, AMARI BAS I, p. XXX-XXXI. Dopo larifondazione normanna della città a valle, la Rocca conservava la sua funzione di difesa della città tanto che nel 1181 ilviaggiatore spagnolo Ibn Gubayr così descrive Cefalù: la città “marittima” prospera ed abbondante per produzioni
L’ubicazione sulla Rocca dell’abitato cefaludese medio bizantino è infine avvalorata dallapresenza sul promontorio roccioso di numerose strutture riferibili a questa fase e dal recupe-ro di alcuni frammenti di lucerne «a ciabatta» e di una mattonella a forma di squama di pe-sce39, in corrispondenza dei tratti della cinta muraria, attribuiti da A. Tullio alle fortificazio-ni di età bizantina40. Questi manufatti, come abbiamo visto, sono ricorrenti nelle fasi alto me-dievali della città e possono essere considerati anche per Cefalù dei fossili guida41.
Alla luce di quanto detto non è chiaro il rapporto esistente tra le strutture emerse a segui-to dello scavo nel Duomo databili agli inizi dell’VIII secolo e l’abitato alto medievale sullaRocca. Quest’ultimo, infatti, è stato fin dall’epoca della fondazione di Kephaloidion inscindi-bile dalla città bassa e dal suo porto, dal momento che ne garantiva la difesa. In età bizantina,forse nel corso dell’VIII secolo, l’abitato di Cefalù dovette ritirarsi sul promontorio roccio-so a causa dell’insicurezza delle coste, quando le incursioni dal mare dei pirati prima e delleflotte musulmane poi rendevano poco sicuro il porto ed il suo entroterra ed era necessarioquindi arroccarsi in un luogo forte e munito. A valle, nei pressi dell’approdo, dovettero ri-manere delle strutture legate all’attività marittima e commerciale della città, difese dalla cin-ta muraria antica che corre lungo la linea di costa ancora in uso in età bizantina, come dimo-strerebbero le numerose integrazioni ed i restauri visibili lungo il suo percorso42.
3.3 CARINI
Recenti indagini, condotte nel territorio di Carini (PA) in contrada San Nicola, lungo lacosta settentrionale dell’isola a pochi Km ad Ovest di Palermo, hanno messo in luce i resti diun probabile insediamento43. Il sito, ubicato nella piana alle falde dell’odierno paese di Cari-ni, presenta tracce di frequentazione dal periodo tardo antico fino all’inizio della dominazio-ne normanna, anche se va precisato che la continuità di vita è soltanto ipotizzabile dal mo-mento che mancano evidenze archeologiche, soprattutto per i secoli della tarda età bizanti-na, dalla fine del VII al IX secolo d.C.44 Nell’ambito di questa prima campagna di scavo, in-fatti, sono stati indagati soltanto i livelli riferibili alla fase islamica e normanna tralasciandoper il momento l’esplorazione dei livelli più antichi.
Gli strati relativi alla fase islamica di frequentazione hanno restituito numerosi frammen-ti di anfore e di forme chiuse di ceramica comune, pertinenti alle morfologie della ceramicaprodotta a Palermo tra la fine del X secolo ed il XII secolo, a cavallo cioè tra la dominazione
141
agrarie, provvista di mercati, è sovrastata da «una rupe vasta e rotonda; su la quale sorge una rocca che non se ne videmai altra più formidabile: e l’hanno munita ottimamente contro qualsivoglia armata navale che improvvisamente as-salisse venendo da parte de’ Musulmani» AMARI BAS I, Ibn Gubayr, p. 152.
39 Del tipo analogo a quella recuperata negli strati considerati alto medievali dei saggi archeologici nel Duomo, cfr.TULLIO 1989, p. 49, 35-37, fig. 43.
40 TULLIO 1995b, p. 20. Devo questa informazione alla cortesia del prof. A. Tullio.41 Cfr. supra, Capitolo I, p. 51 e s.42 TULLIO 1984, p. 51.43 Carini 1997-98.44 Tra il materiale residuale si segnala la presenza delle forme più tarde della sigillata africana quali la Hayes 105 ed alcu-
ni frammenti di pareti di anfore che per le caratteristiche dell’impasto piuttosto rosaceo e con inclusi micacei potrebbe-ro essere riferiti alle anfore tardo bizantine note in Sicilia nei siti di Cefalù, Palermo e Marettimo, cfr. infra, pp. 50-57.
islamica dell’isola ed il regno normanno. L’analisi di questi manufatti ci ha permesso, trami-te lo studio comparato con i contenitori meglio noti di età normanna, di seguire l’evoluzio-ne morfologica e decorativa di questa produzione e di cogliere i caratteri peculiari delle fasipiù antiche della manifattura.
La frequentazione tardo romana della zona è documentata sia dal grande mosaico pavi-mentale romano rinvenuto durante lavori agricoli alla fine dell’ottocento (1873)45, sia dal re-cupero, nell’ambito del recente scavo archeologico, di abbondante materiale residuale data-bile alla stessa epoca46. Tra questi significativa è la presenza di numerosi frammenti di lastredi marmi pregiati e di tessere musive, che segnalano la preesistenza di strutture monumenta-li nell’area. Tali strutture probabilmente erano relative ad un insediamento ubicato lungo lavia costiera ed in relazione con il porticciolo poco distante, attivo ancora in età medievale47,identificato dal Giustolisi in contrada Carbolangeli-Baglio Carini48, nonché con il complessocatacombale sito nelle vicinanze dell’area esplorata e databile probabilmente al V secolo d.C.
La fertilità del luogo e l’abbondanza di acque nei giardini, ancora oggi esistenti in tutta lacontrada, avrebbero giustificato la presenza di un insediamento legato allo sfruttamento agri-colo dell’area. Il territorio nel quale si trova il nostro sito dovette essere frequentato ancora nel-l’alto medioevo, tanto che in piena età islamica, nel 970 circa, al Muqqadasi annovera un abita-to con il nome arabizzato di Qarînas, nell’elenco che ci ha tramandato delle città di Sicilia.
La tradizione storiografica ha localizzato il sito islamico di Carini nell’area dell’odiernopaese, arroccato, con il suo castello medievale, su un promontorio che domina la valle e l’ap-prodo a mare. I resti archeologici scoperti recentemente che si trovano invece nella vallata ria-prono la questione circa l’identificazione dell’abitato islamico; tanto più che i recentissimi
142
45 Il recupero e la conservazione del mosaico si deve a G. De Spuches il quale lo acquistò e riadoperò in uno dei salo-ni della sua abitazione a Palazzo Galati in Palermo. Egli stesso ci riferisce che il mosaico venne recuperato in contradaSan Nicola a Villagrazia di Carini nel podere della signora Ferranti, cfr. DE SPUCHES 1892, p. 291 e ss. Si tratta delpavimento di una sala absidata, costituito da cinque mosaici a disegni geometrici tutti differenti tra di loro, databile alIV secolo d.C. Sulla funzione dell’edificio di cui il tessellato costituiva uno dei pavimenti, molto si è discusso; sia il DeSpuches che per primo ne diede notizia, che il Salinas ed il Pace hanno riferito questo mosaico ad una basilica paleo-cristiana basandosi sulla presenza dell’abside. Nel 1977 la Camerata Scovazzo (CAMERATA SCOVAZZO 1977) cheha ristudiato i mosaici, esclude che si possa trattare di un edificio di culto cristiano dal momento che la forma dellastanza non è in alcun modo raffrontabile con lo schema degli edifici a pianta basilicale e nell’ordito decorativo del tes-sellato non ci sono elementi chiaramente riferibili alla religione cristiana. La studiosa, invece ipotizza che si possa trat-tare dell’ambiente absidato di una villa del IV secolo d.C. confrontabile con gli esempi più noti siciliani (la Villa delCasale di Piazza Armerina, cfr. CAMERATA SCOVAZZO 1977, p. 150).
46 Tra il materiale dello scavo nei contesti medievali sono attestati frammenti di rosso antico, serpentino e di tesseremusive anche di pasta vitrea, nonché numerosi frammenti di terra sigillata D e di anfore africane databili a questo pe-riodo, cfr. Carini 1997-98.
47 Come ci viene tramandato dalle fonti normanne, cfr. Idrisi, in AMARI, BAS, I, p. 120. 48 Le prospezioni archeologiche effettuate da V. Giustolisi agli inizi degli anni’70 hanno portato al rinvenimento in
contrada Carboangeli - Baglio Carini di alcune strutture di notevoli dimensioni e di numerosi frammenti ceramici da-tabili tra il III a.C. e l’età normanna. Si segnalano in particolare alcuni frammenti di pareti percorse da cannelures edun frammento di ciotola di spiral ware, cfr. GIUSTOLISI 1971, p.112, tav. XL, fig. 1. La zona interessata dalla presen-za della torre medievale (Baglio Carini) potrebbe essere identificata con il caricatore dal momento che vi si trova unapiccola insenatura, l’unica lungo tutto il litorale roccioso, usata ancora oggi dai pescatori come approdo. All’internodella baia poco al di sotto del livello del mare affiora una sorgente di acqua dolce. I bassi fondali di questa piccola inse-natura permettono soltanto l’approdo di piccole imbarcazioni, mentre la zona del porto vero e proprio è stata identi-ficata da Giustolisi nella zona subito dopo l’Arco del Baglio. Nell’entroterra di questa contrada a circa 2 Km si trovail sito recentemente scavato di contrada San Nicola. Cfr. GIUSTOLISI 1971, p. 111; GIUSTOLISI 1973, pp. 10-14.
scavi archeologici nel Castello di Carini, volti a documentare eventuali preesistenze, hannodimostrato la fondazione normanna della cinta muraria del castrum ed escluso la presenza distrutture riferibili ad epoche precedenti49. La costruzione della fortezza è probabilmente inrelazione con l’infeudamento del territorio di Carini, voluto dalla contessa Adelasia alla finedell’XI secolo, nel periodo di reggenza prima dell’ascesa al trono del figlio Ruggero II50. Apartire da questa data, infatti, il sito di Carini è ricordato nei documenti medievali essenzial-mente per la presenza del castello51.
A conferma di quanto detto ci sovviene lo stesso Idrisi che nel 1150 così descrive Carini: «ter-ra graziosa, bella e abbondante, produce gran copia di frutte d’ogni maniera ed ha un vasto mer-cato e la più parte dé comodi che si trovano nelle grandi città, (come sarebbero) dè mercati (mi-nori), dè bagni e dè grandi palagi. Si esporta da Carini gran copia di mandorle, fichi secchi, car-rube: che se ne carica delle navi e delle barche per varii paesi. Copiose acque sgorgano d’ognicanto del territorio, la più parte dentro i giardini (stessi) del paese. Avvi una fortezza nuova,fabbricata sopra un colle che domina la terra. Il mare (si apre) a tramontana alla distanza d’unmiglio all’incirca.»52. Poco più avanti il geografo di Ruggero precisa che la cittadina è anche do-tata di porto53. Egli nella sua descrizione precisa che la fortezza è stata fabbricata di recente e sta-bilisce inequivocabilmente il suo rapporto di dominanza sulla “terra” sottostante, ubicata ve-rosimilmente nei pressi della zona dove sono state condotte le indagini archeologiche.
Il castello, quindi fu costruito in età normanna a difesa dell’abitato più antico, verosimil-mente aperto. Qualora, in seguito all’ampliamento delle indagini archeologiche, si riveleràcorretta l’identificazione dell’abitato citato da al Muqqadasi con il nostro sito, si potrà dimo-strare che l’insediamento arabo si trovava nella piana, come tra l’altro lascerebbero intende-re le fonti arabe in nostro possesso.
Per il momento gli esiti dello scavo in contrada San Nicola sono stati particolarmente avaridi strutture, mentre hanno restituito abbondante materiale ceramico, soprattutto contenitori datrasporto, la cui cronologia si può stabilire - sulla base della sequenza stratigrafica e delle associa-zioni in strato - tra la fine del X - inizi dell’XI secolo54. I manufatti databili a questa epoca pro-vengono essenzialmente dal Saggio II. Daremo qui di seguito qualche indicazione sulla stratigra-fia del SAS II al fine di contestualizzare il rinvenimento delle anfore oggetto del nostro studio.
Al di sopra di un piano di calpestio US 19 in relazione con un muro (US 20), ritro-vato in fondazione55, si è individuato uno spesso strato di accumulo (US 16), su cui è sta-to isolato il crollo del tetto (US 15)56. Entrambi gli strati UUSS 15 e 16 hanno restituito
143
49 Carini 1997-98.50 AMARI, Storia, III, p. 307.51 Il Pirri, II, p. 842 parla dell’ abitato fortificato. Ancora nel 1168 viene ricordata da Falcando per il suo castellum (p.
160) e in un diploma del 1182 pubblicato da Cusa per il centro abitato (p. 187). La terra ed il castello quindi ricorronoin molti documenti dal 1271-1282 fino al 1651. Per l’elenco completo dei riferimenti cfr. MAURICI 1998, p. 73.
52 AMARI, BAS I, p. 83.53 AMARI, BAS I, p. 120.54 Carini 1997-98.55 Il muro è costruito con pietrame grossolanamente sbozzato, legato con malta di terra, secondo una tecnica docu-
mentata nelle costruzioni databili al periodo islamico finora note, cfr. gli scavi di Castello San Pietro e della NuovaPretura di Palermo (ARCIFA et alii 1985-87; ARDIZZONE - ARCIFA 1995).
56 Il tetto era costituito da una struttura lignea coperta da tegole, come si evince dalla presenza sotto le tegole dei chio-di di carpenteria.
abbondante materiale ceramico, costituito soprattutto da anfore con decorazione dipin-ta, che per associazione con le lucerne a piattello e serbatoio a cupola57 e con ceramica in-vetriata58, può essere datato tra la fine del X - XI secolo. Questi dati cronologici sono pernoi particolarmente significativi dal momento che costituiscono, dal punto di vista stra-tigrafico, il terminus ante quem che ci permette di attribuire alla piena età islamica la fre-quentazione dell’insediamento.
Questa sequenza archeologica era coperta dagli strati UUSS 9 e 13, poco affidabili dal pun-to di vista stratigrafico poiché rimaneggiati dai lavori agricoli. Tra i materiali ivi recuperatisi segnalano alcune forme ascrivibili alle tipologie ricorrenti nei contesti databili al periodonormanno, che consentono di fissare la cronologia dell’ultima fase di frequentazione del si-to agli inizi del XII secolo.
3.4 PALERMO
I rinvenimenti di contenitori da trasporto nel territorio della città di Palermo sono statinumerosi anche se occasionali e riguardano sia le produzioni più antiche da noi prese in con-siderazione, ovvero le anfore di fine VII - inizi del IX secolo59, sia quelle relative alle manifat-ture locali di ceramica dipinta, databili tra il periodo della dominazione islamica e quella nor-manna60. Soprattutto per quest’ultima produzione abbiamo visto che i recuperi palermitanihanno permesso di ricostruire una tipologia abbastanza ampia il cui arco cronologico va dalX secolo fino ad età guglielmina (seconda metà XII) e di seguire l’evoluzione morfologica deiprodotti di questa manifattura.
Cominciamo la descrizione dei siti partendo da quello che ha restituito un frammento dianfora a corpo ovoidale e fondo ombelicato databile tra la fine del VII e gli inizi del IX seco-lo. Purtroppo, si tratta di un recupero occasionale, che non permette alcuna considerazionesul contesto: dalla terra di risulta di uno scasso in corrispondenza del muro E di Palazzo Gal-letti a Piazza Marina, nel quartiere della Kalsa61. Abbiamo comunque preferito inserire que-sto frammento dal momento che si tratta del primo rinvenimento nell’ambito della città diPalermo databile a quest’epoca.
Nella stessa piazza, poco più ad Oriente di palazzo Galletti, a Palazzo Rostagno nel 1998in occasione dei lavori di restauro sono stati effettuati degli scavi regolari62 che, malgradoabbiano interessato un’area disturbata in antiquo da un ampio sbancamento, hanno resti-tuito i livelli di frequentazione più antichi databili al IV secolo a.C. Questo elemento ci fa
144
57 La presenza costante di questo tipo di manufatto nei contesti di X - inizi XI secolo della Sicilia Occidentale, fa diquesta lucerna un fossile guida per il periodo islamico dell’isola, cfr. ARCIFA 1995.
58 GRECO-GAROFANO-ARDIZZONE 1997-98, cfr. MOLINARI 1995; ARCIFA 1997 e 1998 e ARCIFA - BA-GNERA - NEF 2012.
59 Cfr. supra, Capitolo I, p. 53; pp. 59-74.60 Cfr. supra, Capitolo II, p. 100 e ss.61 Devo questa segnalazione alla Dott.ssa E. Pezzini.62 Le indagini a Palazzo Rostagno sono state curate e dirette dal Prof. O. Belvedere e dal Dott. A. Burgio che sen-
titamente ringrazio per la disponibilità accordatami a prendere visione dei materiali ed ad usare questi dati ai fi-ni della ricerca.
ipotizzare per quest’area urbana continuità di vita fino ai nostri giorni, anche se mancano letestimonianze archeologiche relative alla facies bizantina della città. La vicinanza con Palaz-zo Galletti che si trova a poche decine di metri da questo sito e che ha restituito il frammen-to di anfora medio bizantina, avvalora l’ipotesi della frequentazione dell’area in questo pe-riodo in relazione con il porto. Per i secoli successivi ed in particolare per quelli relativi almomento della dominazione islamica è stato isolato un pozzo, il cui riempimento ha resti-tuito frammenti di forme chiuse databili tra il X e gli inizi del secolo successivo (fig. 48) perassociazione con un catino invetriato a parete carenata ed orlo ingrossato. Si tratta comun-que di dati preliminari dal momento che le indagini nell’area non sono a tutt’oggi terminatee che gli esiti di questo primo intervento sono ancora in corso di studio.
Nell’ambito dello stesso quartiere, in Via Torremuzza, nella zona in corrispondenza del-le mura della cittadella fatimida la al Halisah, nel 1997 è stato effettuato uno scavo d’emer-genza in relazione con i lavori per la metanizzazione della città, che ha messo in luce un trat-to della cinta muraria urbica di età normanna. Dai livelli più antichi di frequentazione del si-to sono stati recuperati, in associazione con ceramica datante di X - prima metà XI secolo63,numerosi frammenti relativi a contenitori da trasporto di produzione palermitana64. Questiesemplari, insieme a quelli recuperati negli strati di età islamica dell’insediamento di contra-da San Nicola a Carini, ci hanno permesso di individuare le forme più antiche ad oggi dellaceramica dipinta palermitana e di cogliere all’interno di questa produzione l’evoluzione rela-tiva sia alle morfologie dei recipienti che ai motivi decorativi dipinti.
Il nucleo più consistente di anfore, da noi preso in considerazione nell’ambito di questaricerca, tra l’altro in perfetto stato di conservazione, proviene come abbiamo più volte ricor-dato da recuperi di fortuna nell’ambito di lavori di restauro, risalenti in massima parte ai pri-mi del secolo, eseguiti sui principali edifici palermitani di committenza regia databili al pe-riodo della dominazione normanna dell’isola: San Giovanni degli Eremiti, Santa Maria del-l’Ammiraglio, la Cappella Palatina, la Cattedrale, San Cataldo, San Giacomo la Marina ed in-fine il palazzo della Zisa ed il Monastero della Martorana. In queste strutture, infatti, gli scar-ti di fornace o gli scarti d’uso furono impiegati in uso secondario, come riempimento legge-ro nei rinfianchi delle volte non prevedendo per le anfore una funzione strutturale, come in-vece era il caso delle cupole costruite con filari di tubi fittili innestati gli uni negli altri. I va-si mal cotti, in prevalenza forme chiuse, venivano posti in opera capovolti con l’imboccatu-ra verso il basso, affinché non si riempissero; spesso erano allettati nella malta, di cui conser-vano le tracce ed erano coperti da terra o sabbia.
Malgrado le anfore non siano state recuperate con metodo stratigrafico, possiamo ipotiz-zare, sulla base della storia delle trasformazioni degli edifici, che oggetti fittili e monumento
145
63 Cfr. PEZZINI 2004. Frammenti di lucerne a piattello e serbatoio a cupola e frammenti di catini carenati invetriatidelle forme databili tra la fine del X e la prima metà dell’XI secolo, cfr. MOLINARI 1997.
64 Si tratta di alcuni strati di riempimento (UUSS 83; 73; 65; 96; 80) costituiti da terra rossa argillosa il più antico deiquali (US80) sembrerebbe databile al X secolo per la presenza di una lucerna a piattello e cupoletta acroma e di paretidi anfore con linee ondulate alternate a fasce verticali. Sopra questi strati sono stati individuati alcuni battuti pavimen-tali (UUSS; 81; 84; 85; 90; 94; 67) databili tra la fine del X e la prima metà dell’XI secolo per la presenza in associazio-ne di ceramica invetriata policroma delle forme più antiche. L’ultimo di questi battuti la US 67 è databile al XII seco-lo per il tipo di contenitori ivi rinvenuti, ascrivibili ai tipi più recenti delle produzioni palermitane (Tipo D2 e fram-menti di anse con il solco mediano, cfr. supra Capitolo II, pp. 130-131).
abbiano la stessa cronologia, dato che i contenitori erano parte integrante della struttura archi-tettonica e che furono messi in opera all’atto della costruzione. È necessario comunque preci-sare che, la cronologia certa della struttura architettonica non basta comunque da sola a defini-re il momento d’inizio della produzione dei tipi ceramici né, tanto meno, la sua durata, quin-di, le indicazioni cronologiche suggerite dagli edifici normanni in cui sono stati recuperati que-sti esemplari, vanno integrate con i dati provenienti da scavi stratigrafici di altri contesti chepossano fornirci informazioni utili sulla cronologia e sulla diffusione di questi manufatti.
Fatta eccezione per i materiali provenienti dalla Zisa e dalla Martorana, conservati nel Mu-seo di Arte Islamica della Zisa con la specificazione della loro origine, le anfore recuperatenegli altri edifici palermitani giacciono nella Loggia della Galleria Regionale di Palazzo Aba-tellis, a tutt’oggi privi dell’indicazione di provenienza. Per questa ragione abbiamo preferitoanalizzarle nel loro insieme, segnalando la dizione generica dell’attuale luogo di conservazio-ne cioè Palazzo Abatellis e dare qui di seguito brevi informazioni sulla storia dei monumen-ti interessati dalla presenza di questi manufatti.
Poche notizie abbiamo circa l’edificio più antico da cui provengono le anfore conservatea Palazzo Abatellis, la chiesa di San Giacomo la Marina datata al periodo della contea di Rug-gero (1130) e distrutta nel 186465; sappiamo da M. Amari, che durante la demolizione dellachiesa vennero recuperati alcuni vasi che lo stesso studioso definì di produzione locale66.
Segue nel tempo la chiesa di San Giovanni degli Eremiti, restaurata nel 1882, la cui costru-zione risulta compresa tra il 1142, anno della morte del fondatore dell’Ordine degli Eremiti diMontevergini a cui l’edificio fu affidato, ed il 1148 data del diploma di donazione di Re Rugge-ro in cui si dice che la chiesa era già stata eretta «sumptibus propriis et laboribus»67. Accanto al-la struttura religiosa sono tuttora visibili i resti di un convento di poco posteriore alla costru-zione dell’edificio di culto e l’intero complesso si addossa alla cinta muraria della città databilealla prima metà del XII secolo68. Nell’area dove oggi sorge l’edificio di culto normanno la tra-dizione storiografica vuole che esistessero costruzioni anteriori: un tempio dedicato a Mercu-rio69, il monastero gregoriano di Sant’Ermete70, una moschea araba ai cui resti si appoggerebbe ilfianco meridionale della struttura normanna71 e nelle immediate vicinanze gli avanzi dell’antica
146
65 DI STEFANO - KRÖNIG 1979, p. XXV: la chiesa, ormai distrutta, è attribuita dalla tradizione al periodo dellaContea.
66 AMARI, Storia, III, p. 793: «Palermitani e senza alcun dubbio siciliani sono gli orci e le brocche di terra cotta, va-rii per la grandezza e la forma, grossolani di fattura (...), e la più parte sciupati al forno, dei quali si trovò, com’io ri-traggo, un piccol numero nel demolire la chiesa di San Giacomo la Marina in Palermo (1864)».
67 DI STEFANO - KRÖNIG 1979, pp. 40-41. 68 Sul problema della datazione delle mura medievali di Palermo da ultimo cfr. ARCIFA 1996, p. 476, con bibliogra-
fia precedente e PEZZINI 1998b.69 DI GIOVANNI 1889 - 1890, II, pp. 297-298., Il recupero di basi, capitelli e colonne definite dal Di Giovanni “ro-
mane o greche” nell’area dell’antico monastero, oggi giardino della chiesa, avrebbe dato adito all’ipotesi dello studio-so che il nome di S. Ermete, dato da S. Gregorio al monastero, ricalcasse il toponimo della zona risalente alla presen-za nell’area di un tempio dedicato a Mercurio. Le rovine di questo tempio pagano sarebbero state inglobate nella chie-setta trovata da San Gregorio nell’area del monastero.
70 Si tratta di uno dei monasteri fondati da Gregorio Magno sul finire del VI secolo d.C. alle porte di Palermo ed eragià in rovina quando Ruggero nel 1132 concedeva al B. Guglielmo le rovine per edificare la chiesa.
71 Sostenitore della tesi sulla preesistenza della moschea i cui resti sarebbero ancora visibili lungo il lato meridionaledell’odierna basilica, è stato G. Patricolo che ha curato il restauro della chiesa alla fine dell’Ottocento: PATRICOLO1883, pp. 170-183. Di parere contrario già lo stesso Di Giovanni (DI GIOVANNI 1889-1890, II, pp. 301-306).
chiesa di San Giorgio in Kemonia72. La reale presenza e ubicazione di queste preesistenze rispet-to alla basilica di San Giovanni degli Eremiti risulta a tutt’oggi piuttosto nebulosa, e solo inda-gini archeologiche eseguite nell’area potrebbero dare delle indicazioni più precise.
Un altro edificio più o meno contemporaneo a San Giovanni degli Eremiti, da cui pro-vengono alcune anfore è la Cappella di San Pietro a Palazzo Reale nota come Cappella Pala-tina, costruita attorno al 1131 per volontà di Ruggero II subito dopo la sua elezione a Re diSicilia (1130), e consacrata nel 1140. Durante i restauri del 1937 il Valenti recuperò «numero-se anfore vinarie disposte sistematicamente le une accanto alle altre»73 alcune delle quali si tro-vano oggi alla Galleria Regionale di Palazzo Abatellis confuse con le altre.
Analogamente nella coeva chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio costruita da Giorgiod’Antiochia, ammiraglio del Regno, sarebbero stati ritrovati numerosi vasi, scarti di forna-ce, messi in opera sotto il pavimento del terrazzo74. La chiesa subì vari rifacimenti tra il XVed il XVIII secolo: nel 1588-90 la facciata venne distrutta e l’edificio prolungato a discapitodell’atrio, nel 1683-87 al posto dell’abside venne costruito un cappellone quadrato, nel 1726a seguito di un terremoto venne distrutta la parte alta del campanile e nel 1870-73 il monu-mento fu finalmente restaurato dal Patricolo75. Dalla cronistoria degli interventi subiti dallachiesa risulta evidente che la zona della cupola e del suo terrazzo, tra l’altro ancora interessa-ti dalla presenza dei mosaici originari, non vennero toccate da rifacimenti e lavori, pertantoi materiali ivi recuperati dovrebbero essere stati messi in opera nei primi decenni del XII se-colo contemporaneamente alla costruzione della chiesa.
Nella seconda metà del XII secolo questa tecnica di alleggerimento mediante vasellame diterracotta è documenta ancora nelle volte del chiostro del monastero annesso alla chiesa diSanta Maria dell’Ammiraglio costruito nel 1193 riutilizzando il palazzo della contessa Ade-licia de Golisano, nipote di Ruggero II, presente in Sicilia tra il 1134 ed il 1161. Dopo questadata, sotto il regno di Guglielmo III il palazzo venne ceduto ad Aloisa de Marturana76 che nel1193 lo trasformò in un monastero benedettino femminile.
Altre anfore provengono dalla limitrofa chiesa di San Cataldo (1154-1176)77 e forse dallacattedrale di Palermo (1169-1190)78. Infatti, nelle sale annesse al Duomo sono conservate 11anfore ascrivibili al tipo A5 della nostra classificazione. Purtroppo non si hanno notizie pre-cise circa la loro provenienza. È probabile però che, dato il loro eccezionale stato di conser-vazione, provengano dalle volte, forse della stessa Cattedrale.
147
72 DI GIOVANNI 1889-1890, II, pp. 299-300. La chiesa preesisteva all’impianto del monastero gregoriano.73 VALENTI 1939, p. 211. 74 Oggi in parte conservati al Museo di Arte Islamica della Zisa di Palermo; SALINAS 1871, a p. 203 ci informa che
erano scarti di fornace; SALINAS 1872, p. 210; PATRICOLO 1877, p. 21 « (...) inoltre il restauro dell’antico terrazzocircoscritto alla cupola condusse al rinvenimento di un numero considerevole di vasi di terra cotta, tra i quali alquan-ti con tentativi d’iscrizioni arabiche. Questi vasi erano collocati sull’estradosso delle sottostanti volte a sostegno delterrazzo (...) ».
75 DI STEFANO - KRÖNIG 1979, p. 43.76 RUSSO PEREZ 1954, p. 46.77 DI LIBERTO 1996, pp. 17-32; sul rinvenimento dei vasi durante il restauro cfr. FIORILLA 1990, p. 158, nota 17;
Brucato didascalia alla fig. 112, p. 277.78 L’inizio della costruzione della cattedrale di età guglielmina, voluta dall’arcivescovo di Palermo Gualterio Offami-
lio (o proto familiarios secondo la lettura proposta da B. Rocco), è ricordato in una cronaca siciliana tarda nel 1184.Questa data sembra essere troppo vicina al momento della consacrazione per essere plausibile e quindi si propone ilperiodo compreso tra il 1169 ed il 1190, cfr. DI STEFANO - KRÖNIG 1979, pp. 74-82.
Nessuno di questi monumenti, quindi, sembra abbia subito grandi trasformazioni e re-stauri fino all’intervento degli architetti Patricolo e Valenti operanti tra la fine del secolo scor-so ed i primi decenni del nostro.
Infine, nel 1974, durante i lavori di restauro del palazzo della Zisa a Palermo, un monu-mento di età guglielmina (seconda metà del XII secolo), sotto i pavimenti del primo pianosono state rinvenute numerose anfore normanne ancora in situ79. Il palazzo della Zisa (dal-l’arabo al-Aziz = la splendida), sorgeva fuori dalle mura della città di Palermo, all’internodel parco reale normanno, il Genoard (dall’arabo Gennat al-arde ovvero paradiso sulla ter-ra) che si estendeva con splendidi padiglioni, rigogliosi giardini e bacini d’acqua da Altofon-te fino alle mura del palazzo reale. Le prime notizie sulla data d’inizio della costruzionedella Zisa al 1165, sotto il regno di Guglielmo I, ci sono state tramandate da Falcando nelLiber de Regno Sicilie80. Sappiamo infatti da questa fonte che nel 1166, anno della morte diGuglielmo I, la maggior parte del Palazzo era stata costruita «mira celeritate, non sine ma-gnis sumptibus» e che l’opera fu portata a termine dal suo successore Guglielmo II (1172-1184), subito dopo la sua maggiore età. L’appellativo Musta’izz riferito, secondo l’Amari, aGuglielmo II ricorre anche in un’iscrizione in caratteri naskhî nell’intradosso dell’arcata diaccesso alla Sala della Fontana81. Alla luce di queste fonti la maggior parte degli studiosi so-no concordi nel fissare al 1175 la data di completamento dei lavori del solatium reale82. Fi-no al XVII secolo il palatium non venne sostanzialmente modificato, come ci testimonia ladescrizione del 1526 fatta dal monaco bolognese Leandro Alberti che visitò la Zisa in quel-l’anno. Significativi interventi di restauro si ebbero negli anni 1635-36, quando Giovannide Sandoval acquistò la Zisa e la adattò alle nuove esigenze abitative83. In questa fase comun-que non sembra siano state interessate le volte dell’edificio.
148
79 D’ANGELO 1976; CARONIA 1982, pp. 95-162.80 FALCANDO, p. 87: «Cum ergo regnum ab extrinsecis tumultibus aliquando quievisset, rex autem interim otio
quietique vacaret, timens ne quevis occasio voluptuosum otium impediret, familiares suos promonuerat ut nichil eiquod mestitiam aut solicitudinem posset ingerere nunciaret, ac se totum deinceps voluptati devovens, cepit animo la-tius evagari, cogitans ut quia pater eius Favariam, Mineium aliaque delictabilia loca fecerat, ipse quoque palatium co-strueret, quod commodius ac diligentius compositum, vederetur universis patris operibus preminere, cuius parte maxi-ma, mira celeritate, non sine magnis sumptibus expedita, antequam supremam operi manum imponeret, dissenteriamincurrens cepit diuturno morbo dissolvi».
81 L’iscrizione in caratteri cufici, tuttora visibile nel muretto d’attico del palazzo è molto lacunosa e priva del nomedel re e della data. Infatti, venne tagliata ad intervalli regolari per ricavarne merli nel momento in cui il palazzo vennetrasformato in fortezza.
82 BELLAFIORE 1978, pp. 9-11; CARONIA 1982, p. 50.83 In occasione di questi lavori venne aggiunto un altro piano chiudendo il terrazzo e si costruì, nell’ala destra del pa-
lazzo, secondo la moda dei tempi, un grande scalone resecando i muri portanti e distruggendo le originarie scale di ac-cesso. Successivamente nel 1806 la Zisa passò alla famiglia dei Notarbartolo che effettuò diverse opere di consolidamen-to, quali il risarcimento di lesioni sui muri e l’incatenamento degli stessi per contenere le spinte delle volte. Venne tra-sformata la distribuzione degli ambienti mediante la costruzione di tramezzi, soppalchi, scalette interne e nel 1860 ven-ne ricoperta la volta del secondo piano per costruire il pavimento del padiglione ricavato sulla terrazza. Nel 1955 il pa-lazzo venne espropriato dallo Stato, ed i lavori di restauro, iniziati immediatamente, vennero poco dopo sospesi. Do-po un quindicennio di incuria nel 1971 l’ala destra, compromessa strutturalmente dai lavori del Sandoval e dagli inter-venti di restauro, crollò. In questa circostanza si poté osservare che gli spazi di risulta tra gli estradossi delle volte ed ipavimenti del piano superiore erano riempiti con numerose anfore capovolte (BELLAFIORE 1978, pp. 9-25; SPATRI-SANO 1982, pp. 105-106; CARONIA 1982, pp. 95-162).
3.5 RINVENIMENTI SOTTOMARINI
Nell’ambito della nostra analisi abbiamo preso in considerazione alcuni contenitori da tra-sporto, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Mazara del Vallo, provenienti da recuperi sot-tomarini effettuati dai pescatori nelle acque del Canale di Sicilia e databili all’interno dell’ar-co cronologico compreso tra l’VIII ed il XII secolo d.C84.
Malgrado, ovviamente, non si possano attribuire questi contenitori a contesti di rinve-nimento sicuri, si tratta comunque di materiale di una certa importanza dal punto di vitastorico dal momento che è costituito in prevalenza da anfore d’importazione. Questi reci-pienti ci forniscono informazioni di massima sulle rotte commerciali che interessavano que-sto tratto del Mediterraneo nei secoli di passaggio dalla “talassocrazia” romana e bizantinaall’arrivo degli “Arabi”. Per quanto riguarda poi i recipienti prodotti nella Sicilia occiden-tale tra il X ed il XII secolo e presenti con una piccola percentuale tra questo insieme di ma-teriali, i dati provenienti dallo studio di questi contenitori recuperati in mare, sicuramen-te adoperati per il trasporto delle derrate alimentari siciliane, integrati con quelli desumi-bili dagli scavi “terrestri” in cui sono state recuperate anfore analoghe, ci hanno aiutato aprecisare meglio la destinazione delle forme prodotte ed a distinguere quelle destinate al-l’esportazione delle derrate alimentari.
3.6 I RELITTI DI MARSALA E DI SAN VITO LO CAPO
Avendo preso in considerazione nel corso del nostro lavoro le produzioni palermitane da-tabili tra il X ed il XII secolo, non possiamo non accennare brevemente anche al recupero ec-cezionale di tre relitti normanni lungo la costa nord occidentale dell’Isola. Si tratta in parti-colare dei relitti A e B di Marsala e del relitto recentemente individuato ad Est del Capo SanVito che presentano interessanti analogie per il tipo di carico costituito da anfore acrome disicura produzione siciliana, riferibili al contenitore è stato inserito nella nostra classificazio-ne con la denominazione convenzionale di Tipo N. Analizziamo quindi un pò più nel detta-glio le informazioni in nostro possesso su questi due recuperi.
Nel 1983 venne alla luce a Marsala, presso il Lido Signorino, un relitto caratterizzatodalla presenza di numerosi contenitori da trasporto databile al XII secolo per l’associazio-ne con ceramica solcata dello stesso periodo, usata verosimilmente come vasellame di bor-do85. Nel 1985, poco distante da questo scafo venne alla luce un altro relitto di dimensio-ni più piccole che in un primo momento venne considerato contemporaneo al primo edi supporto durante la navigazione. Ad un’analisi più attenta dei materiali ivi recuperati,oggi esposti al Museo di Marsala, risulta evidente che questa seconda imbarcazione è più an-tica della prima di almeno cinquant’anni. Purtroppo, quest’ultimo rinvenimento è rimasto atutt’oggi praticamente inedito.
149
84 Queste anfore si trovano oggi conservate in massima parte nei magazzini del Museo Archeologico di Marsala, men-tre una piccola percentuale si trova nei depositi del Museo Civico di Mazara del Vallo.
85 Si tratta di un cospiguo gruppo di anfore pertinenti al tipo N della nostra cassificazione e di un esemplare deltipo L con iscritta la parola araba mudd graffita sulla spalla, fig. 46, cfr. supra, pp. 136-137. PURPURA 1985;D’ANGELO 1984 da ultimo FERRONI - MEUCCI 1998. Si tratta tra l’altro di ceramica solcata agrigentina lacui datazione si colloca nell’arco del XII secolo.
Anche del rinvenimento del relitto di San Vito Lo Capo si sa molto poco per la prematu-ra scomparsa del dott. Faccenna che ne curava lo studio86. Il carico di questa imbarcazione,come quello del relitto A di Marsala, era costituito essenzialmente dai 419 esemplari dell’anfo-retta del tipo N87, per le quali le analisi mineralogico petrografiche hanno confermato la pro-duzione siciliana88. Tra le anfore sono stati individuati due tipi di contenitore oltre quello pre-cedentemente citato: alcuni esemplari del tipo L e delle giare appartenenti al gruppo I di Ca-rini89. La ceramica di bordo, il cui studio ha permesso la datazione del carico, era costituitada alcune forme dell’invetriata policroma databili nell’arco del XII secolo90.
150
86 Una pubblicazione preliminare dello scavo è in FACCENNA 1993; FACCENNA 2006.87 Si tratta del tipo A di San Vito, cfr. FACCENNA 1993 e FACCENNA 2006 figg. 30 - 39. 88 PATTERSON 1995.89 Per le anfore del Tipo C della classificazione Faccenna riconducibili alle giare appartenenti al gruppo I di Carini
cfr. fig. 31; gli esemplari riferiti al tipo L della nostra classificazione sono stati indicati dal Faccenna come tipo B, cfr.FACCENNA 2006, fig. 41 e FACCENNA 2006, p. 44 e ss.
90 FACCENNA 1993.
151
P R E M E S S A C ATA LO G O
Solo per i campioni forma sono state redatte schede informatizzate molto sinteticheche tenessero conto essenzialmente della provenienza ed ubicazione attuale del ma-nufatto, della descrizione macroscopica degli impasti, delle misure, privilegiando quel-
le relative alla forma cioè diametro orlo e fondo, spessore parete, e nel caso di forme interel'altezza del manufatto e la sua larghezza, della descrizione della forma; della bibliografia del-l'oggetto e dei confronti. Infine è stata proposta la datazione del manufatto o sulla base delcontesto di scavo ovvero, quando questo non era affidabile o meglio ancora insistente sullabase dei confronti tipologici con altri materiali.
Per i materiali provenienti da contesti di scavo attendibili, laddove è stato possibile -Agri-gento, Carini e Palermo Via Torremuzza - la condizione di estrema frammentarietà dei re-perti si è proceduto alla quantificazione dei frammenti di anfore seguendo il sistema della va-lutazione della percentuale di vaso attestata considerano gli orli e, nel caso di esemplari indi-viduati sulla base della forma della parte terminale del recipiente, il fondo. Infatti, trattando-si di ceramica acroma con caratteristiche d'impasto nella stragrande maggioranza dei casi ana-loghe, poiché la maggior parte dei frammenti appartiene a forme prodotte dalle stesse forna-ci, ci sembrava che questa metodologia di conteggio fosse la più adatta. Per motivi logisticinon è stato possibile effettuare la valutazione del peso di gran lunga preferibile in queste cir-costanze1.
Ogni qual volta si fa rimando a confronti con il materiale recuperato nello scavo delle for-naci medievali della Valle dei Templi di Agrigento, questo è stato pubblicato in Agrigento2007.
Pe tutti quegli esemplari che macroscopicamente presentavano un impasto simile aquello delle anfore di Palermo abbiamo usato la dizione: tipo Zisa.
1 Sui sistemi di quantificazione dei reperti cfr. ORTON - TYERS - VINCE 1993, pp. 166-181.
marettimo
ALTO MEDIEVALI
Inv MRT 15 (Fig. 5)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 115.
Stato di conservazione Parzialmente ricomposto / collo ed anse.
Impasto Impasto arancio, depurato, polveroso, con piccoli inclusi neri e micacei ad alta frequenza. Superfici esterne scurite.
Descrizione Orlo ingrossato all’esterno a sezione triangolare, collo tronco-conico, anse ad angolo retto, a sezione ellittica, impostate immediatamente sotto l’orlo.
Bibliografia ARDIZZONE 1998, fig. 9, p. 408.
Confronti È confrontabile con un'anfora ritrovata a Pozzuoli (Rione Terra) e datata tra il VII e l'VIII secolo (ARTHUR 1993, Fig. 2,1).
Cronologia Fine VII – inizi VIII secolo.
Inv MRT 60 (Fig. 5)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 444.
Stato di conservazione Parzialmente ricomposto / metà superiore.
Impasto Impasto dal grigio arancio all’arancio chiaro (2.5YR 6/4 al 2.5YR 6/6), duro, granuloso, depurato con inclusi piccoli micacei e neri a media frequenza, rari bianchi di grandi dimensioni.
Descrizione Due frammenti ricomposti di collo cilindrico, spalla inclinata, anse a sezione ellittica impostate nella parte bassa del collo ed ad angolo retto, corpo ovoidale.
Bibliografia ARDIZZONE 1998, fig. 9, p. 408
Cronologia Fine VII – inizi VIII secolo.
Inv MRT 62 (Fig. 5)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 456.
Stato di conservazione Parzialmente ricomposto / metà superiore.
Impasto Impasto camoscio (5YR 7/6) duro, granuloso, depurato con inclusi piccoli micacei e neri a media frequenza, rari bianchi di grandi dimensioni.
Descrizione Tre frammenti ricomposti, priva dell'imboccatura e con lettere greche (?) graffite sulla spalla (Fig. 27). Collo tronco-conico, anse a sezione ellittica impostate a metà circa del collo, spalla poco inclinata, corpo globulare.
Bibliografia ARDIZZONE 1998, fig. 9, p. 409
Cronologia Fine VII – inizi VIII secolo.
152
Inv MRT 61 (Fig. 5)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 444/443/440.
Stato di conservazione Parzialmente ricomposto / collo ed anse.
Impasto Impasto colore arancio chiaro (10R 6/8), duro, compatto, con inclusi scuri piccoli e con mica a bassa frequenza.
Descrizione Sedici frammenti di cui alcuni ricomponibili, orlo arrotondato, ingrossato all’esterno, collo tronco-conico, anse a sezione ellittica impostate sotto, l’orlo, spalla inclinata.
Bibliografia ARDIZZONE 1998, fig. 9, p. 409
Confronti Vagamente richiama ARTHUR 1993, fig. 2,3 p. 243 che presenta però tracce di decorazione dipinta in rosso, da contesti datati alla fine del VII o all'VIII secolo.
Cronologia Fine VII – inizi VIII secolo.
Inv MRT 73
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US421.
Stato di conservazione Frammentario / spalla ed ansa.
Impasto Impasto rosso arancio, duro, compatto, depurato con piccoli inclusi bianchi e micacei ad alta frequenza. Ingobbiatura (?) giallastra.
Descrizione Tre frammenti ricomposti di spalla ed ansa con graffite sulla spalla le lettere !" (Fig. 27). La lettera " è scritta capovolta. Stessa forma di 60 e 61.
Bibliografia ARDIZZONE 1998, p. 409
Cronologia Fine VII – inizi VIII secolo.
Inv MRT 103 (Fig. 5)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 151.
Stato di conservazione Frammentario / parte superiore.
Impasto Impasto dall’arancio chiaro al rosso arancio (5YR 6/6 al 2.5YR 5/8), duro, compatto, depurato con grandi vacuoli irregolari a bassa frequenza e piccolissimi inclusi micacei a media frequenza.
Descrizione Orlo verticale arrotondato, ingrossato all’esterno, collo cilindrico, leggermente tronco-conico, anse a sezione ellittica impostate immediatamente sotto l’orlo ad angolo retto, spalla inclinata, corpo ovoidale. Tre frammenti ricomposti.
Bibliografia ARDIZZONE 1998, fig. 9, p. 409
Cronologia Fine VII – inizi VIII secolo.
153
Inv MRT 57 (Fig. 10)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 444/443.
Stato di conservazione Parzialmente ricomposto / metà superiore.
Impasto Impasto arancio chiaro (2.5YR 6/6), duro, granuloso, depurato, con rari inclusi bianchi di piccole dimensioni, chamotte, e grossi vacuoli circolari, mica di piccole dimensioni a media frequenza.
Descrizione Trentatré frammenti alcuni ricomposti. Graffito sulla spalla presso l'ansa, forse un'alfa (Fig. 27).
Bibliografia ARDIZZONE 1998, fig. 10, p. 409
Confronti Il profilo dell'orlo è molto simile ad una imboccatura recuperata alla Crypta Balbi (PAROLI 1992a, Tav. 3, 9-10, p. 360 da contesti di VIII secolo). Ricorda il tipo Hayes 44 p. 73 fig. 58,17 ritrovato a Saraçhane, datato tra la fine dell'VIII e il IX secolo, che differisce dal nostro esemplare per il collo, più basso e largo.
Cronologia Fine VII – inizi VIII secolo.
Inv MRT 59 (Fig. 10)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane
Dati di scavo US 444.
Stato di conservazione Frammentario / fondo
Impasto Impasto arancio chiaro (2.5YR 6/6), duro, granuloso, depurato, con rari inclusi bianchi di piccole dimensioni, chamotte, e grossi vacuoli circolari, mica di piccole dimensioni a media frequenza.
Descrizione Dieci frammenti ricomponibili del fondo convesso, corpo ovoidale. Forse è il fondo della 57.
Bibliografia ARDIZZONE 1998, fig. 11, p. 409
Cronologia Fine VII – inizi VIII secolo.
Inv MRT 104 (Fig. 10)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 444/443.
Stato di conservazione Frammentario / fondo
Impasto Impasto arancio rosato (2.5YR 6/8), compatto, depurato con inclusi piccoli bianchi a bassa frequenza, scuri a media frequenza e micacei.
Descrizione Nove frammenti non ricomponibili del fondo convesso di un'anfora con corpo ovoidale.
Bibliografia ARDIZZONE 1998, fig. 10, p. 409
Cronologia Fine VII – inizi VIII secolo.
154
Inv MRT 68
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 447
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Impasto arancio chiaro, granuloso, poco depurato con numerosi inclusi micacei.
Descrizione Piccolo frammento di orlo arrotondato separato dalla parete interna mediante un solco, ansa attaccata immediatamente sotto l'orlo.
Bibliografia ARDIZZONE 1998, p. 409
Confronti ARTHUR 1993, fig. 2,6 ritrovata durante gli scavi di S. Patrizia a Napoli in contesti di VIII o IX secolo.
Cronologia Fine VII – inizi VIII secolo.
Inv MRT 29
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 114.
Stato di conservazione Frammentario / parete
Impasto Impasto rosso arancio, depurato, duro, compatto, con piccolissimi inclusi bianchi e micacei a bassa frequenza.
Descrizione Graffito sulla spalla composto da linee che si intersecano. (Fig. 27).
Bibliografia ARDIZZONE 1998, p. 409
Inv MRT 1
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 102.
Stato di conservazione Frammentario / parete ed ansa
Impasto Impasto rosso arancio, duro, compatto, depurato con inclusi bianchi di medie dimensioni e a media frequenza. Ingobbiatura all'esterno e superficie a buccia d'arancia all'interno.
Descrizione Graffito sotto l'ansa composto da linee che si intersecano (Fig. 27).
Bibliografia ARDIZZONE 1998, p. 409
Inv MRT 101
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 135/136.
Stato di conservazione Frammentario / parete
Impasto Impasto rosso arancio, duro, compatto, depurato con inclusi bianchi di medie dimensioni e a media frequenza. Ingobbiatura all'esterno e superficie a buccia d'arancia all'interno.
Descrizione Due frammenti di parete tra cui uno con graffito (Fig. 27).
Bibliografia ARDIZZONE 1998, p. 409
155
MEDIEVALI (XI-XII SECOLO)
Inv MRT 3
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 102
Stato di conservazione Frammentario / parete
Impasto Impasto rosso mattone, depurato, con vacuoli a bassa frequenza. Superfici schiarite. Tipo Zisa ?
Descrizione Due frammenti di parete percorsa da cordonature e con decorazione dipinta in rosso bruno a motivi lineari.
Bibliografia ARDIZZONE 1998, p. 411
Confronti Per il tipo di decorazione e di impasto potrebbe essere riferito alle produzioni di ceramica dipinta palermitana.
Cronologia XI-XII secolo.
Inv MRT 28
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 102.
Stato di conservazione Frammentario / parete
Impasto Impasto rosso mattone, depurato, con vacuoli a bassa frequenza. Superfici schiarite. Tipo Zisa? Superficie interna ed esterna a buccia d'arancia.
Descrizione Più frammenti in parte ricomponibili di parete e collo percorso da cordonature e con decorazione dipinta in rosso bruno con motivi lineari ed ad onde.
Bibliografia ARDIZZONE 1998, p. 411
Confronti Per il tipo di decorazione e di impasto potrebbe essere riferito alle produzioni di ceramica dipinta palermitana.
Cronologia XI-XII secolo.
Inv MRT 14
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marettimo, Contrada Case Romane.
Dati di scavo US 105/115.
Stato di conservazione Frammentario / parete
Impasto Impasto rosso arancio, depurato con inclusi bianchi di piccole dimensioni a media frequenza. Superfici schiarite.
Descrizione Due frammenti ricomponibili di collo con decorazione ad onda poco incisa sotto l'orlo.
Bibliografia ARDIZZONE 1998, fig. 12, p. 411
Confronti Per il tipo di decorazione e di impasto potrebbe essere riferito alle produzioni di ceramica dipinta palermitana.
Cronologia XI-XII secolo.
156
palermo, palazzo galletti
Inv PPG 1
Ubicazione Palermo.
Provenienza Palermo, Piazza Marina, Palazzo Galletti
Dati di scavo Recupero durante i lavori di restauro del palazzo
Stato di conservazione Frammentario / ansa
Impasto Arancio chiaro (5YR 6/6), depurato con piccolissimi inclusi micacei gialli ad alta frequenza, rari inclusi grigi di piccole dim. e neri cristalliformi a media frequenza visibili sulla superficie esterna.
Misure Diametro orlo cm 7
Descrizione Orlo indistinto, arrotondato, inclinato verso l'esterno, collo a svasare, anse a sezione ovale ad angolo retto.
Confronti Vagamente ricorda ARTHUR 1993, fig. 2.3 senza la decorazione dipinta e con l'orlo più arrotondato.
Cronologia VII-IX secolo.
cefalù
ALTOMEDIEVALI
Inv. C. K80/115 (fig. 6)
Ubicazione Cefalù Magazzino
Provenienza Cefalù Duomo, Saggio 2
Dati di scavo m- 1.10
Stato di conservazione Priva dell'orlo e del fondo.
Impasto Arancio chiaro, rosato, con inclusi bianchi calcarei a media frequenza, neri rossicci (vulcanici?) a bassa frequenza e piccolissima mica bianca a media frequenza. Superfici schiarite.
Misure H cm 35; larghezza max cm 32; diametro collo cm 5,2.
Descrizione Sedici frammenti ricomposti. Collo leggermente tronco-conico, anse a sezione ovale ad angolo retto, spalla inclinata convessa, ventre globulare. Sulla spalla graffito A praticato dopo la cottura.
Bibliografia TULLIO 1985, p. 94, nr. 195, figg. 123 e 124; PAROLI 1992b p. 363.
Confronti ARTHUR 1993, fig. 2.1
Cronologia Inizi VIII secolo
Inv. C. K80/96,1 (fig. 6)
Ubicazione Cefalù Magazzino
Provenienza Cefalù Duomo, Saggio 2
Dati di scavo Taglio N fino a m- 1.20
Stato di conservazione Frammentario / collo
Impasto Arancio chiaro, mediamente depurato con inclusi rosso mattone a bassa frequenza, bianchi e grigi di medie dimensioni a media frequenza. Superfici schiarite.
Misure Diametro orlo interno cm 5 esterno cm 7.
157
Descrizione Orlo verticale, ingrossato, a sezione semicircolare, collo tronco-conico, anse ad angolo retto a sezione ovale impostate poco sotto l’orlo, spalla orizzontale convessa.
Confronti Vagamente richiama ARTHUR 1993, fig. 2.1.
Cronologia Inizi VIII secolo
Inv. C. K80/94,1 (fig. 6)
Ubicazione Cefalù Magazzino
Provenienza Cefalù Duomo, Saggio 2
Dati di scavo Taglio N fino da m- 1.20 a m- 1.60
Stato di conservazione Frammentario / collo
Impasto Arancio chiaro depurato, duro, con inclusi micacei e bianchi di piccolissime dimensioni ad alta frequenza, rarissimo inclusi neri (cristalli?), qualche raro incluso grigio di medie dimensioni.
Misure Diametro orlo interno cm 4,6, esterno cm 6,2
Descrizione Orlo verticale ingrossato, obliquo, collo tronco-conico con segni del tornio all'interno; anse ad angolo retto a sezione ovale impostate immediatamente sotto l’orlo.
Confronti ARTHUR 1993, fig. 2.8 o 5
Cronologia Inizi VII-VIII secolo.
Inv C. K80/108a (fig. 6) Ubicazione Cefalù Magazzino
Provenienza Cefalù Duomo, Saggio 2
Dati di scavo Allargamento a Nord da m- 1.00 a m- 1.75
Stato di conservazione Frammentario / collo
Impasto Rosso scuro, grigio in superficie, depurato, con inclusi bianchi di piccole e medie dim. a media frequenza, nero rossiccio opaco (vulcanici) di medie dimensioni ad alta frequenza, rari grigi (cristalli?) con ingobbio chiaro
Misure Diametro orlo interno cm 4, esterno cm 6.
Descrizione Orlo estroflesso obliquo, collo cilindrico con attacco dell'ansa a metà circa del collo.
Confronti ARTHUR 1993, fig. 2.4
Cronologia Inizi VIII-IX secolo.
Inv C. K80/103,1 (fig. 6)
Ubicazione Cefalù Magazzino
Provenienza Cefalù Duomo, Saggio 2
Dati di scavo Allargamento a Nord fino a m- 0.50
Stato di conservazione Frammentario / parte superiore
Impasto Arancio chiaro, depurato, con inclusi micacei e bianchi a media frequenza. Superfici chiare.
Misure Diametro orlo interno cm 5,6, esterno cm 7,3.
Descrizione Orlo leggermente estroflesso, ingrossato a sezione semicircolare, collo tronco-conico, anse a sezione ovale ad angolo retto impostate immediatamente poco sotto l’orlo, spalla inclinata convessa. Sulla spalla lettera E graffiata prima della cottura.
Confronti ARTHUR 1993, Fig. 2.2; PAROLI 1992b, Tav. 3.7
Cronologia VIII secolo.
158
Inv. C. K80/96
Ubicazione Cefalù Magazzino
Provenienza Cefalù Duomo, Saggio 1
Dati di scavo Taglio N fino a m- 1.20
Stato di conservazione Frammentario / ansa
Impasto Arancio chiaro depurato, con inclusi micacei e bianchi di piccolissime dimensioni.
Misure Spessore parete cm 0.9
Descrizione Frammento di collo con ansa a sezione ovale scanalata, leggermente arcuata.
Inv.
C. K81/147a (fig. 6)
Ubicazione Cefalù Magazzino
Provenienza Cefalù Duomo, Saggio 1
Dati di scavo Basole 21-26 e 28-32 fino a m- 3.50
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio, depurato con inclusi micacei di piccolissime
dimensioni, visibili a luce radente.
Misure Diametro orlo interno cm 10,6, esterno cm 14; spessore parete cm 1,2
Descrizione Frammento di orlo verticale a fascia con profilo interno, convesso ed esterno concavo, con un solco che lo separa dalla spalla. Collo atrofizzato, spalla orizzontale convessa.
Inv C. K80/169
Ubicazione Cefalù Magazzino
Provenienza Cefalù Duomo, Saggio 3
Dati di scavo Sotto fiancata N, Sep. 3.3 m- 0.70 a m-0.90.
Stato di conservazione Frammentario / parete
Impasto Arancio con superfici schiarite, poco depurato con inclusi bianchi di piccole e medie dimensioni ad alta frequenza, rossi (chamotte) di medie dimensioni a media frequenza, grigi di medie dimensioni a bassa frequenza.
Misure Spessore cm 0.6
Descrizione Due frammenti di parete con decorazione incisa a pettine con uno strumento a sette punte.
MEDIEVALI
Inv C. K85/91
Ubicazione Cefalù Magazzino
Provenienza Cefalù Duomo, Torre S
Dati di scavo Testimone, strato II da m- 24,05 a m- 24,45
Stato di conservazione Frammentario / pareti
Impasto Rosso, grigio al nucleo, poco depurato con inclusi bianchi a media frequenza, nero rossicci tondeggianti a media frequenza e neri piccoli a media frequenza.
159
Misure Spessore cm 0,9
Descrizione Tre frammenti di pareti senza cordonature con decorazione dipinta del tipo a broad line; un frammento di ceramica dipinta in bianco con superfici scurite.
Cronologia XI-XII secolo.
Vaso con filtro
Inv C. K85/54 Ubicazione Cefalù Magazzino
Provenienza Cefalù Duomo, Torre S
Dati di scavo Strato II
Stato di conservazione Frammentario / pareti
Impasto Rosso arancio, tipo Zisa.
Descrizione Frammento di ceramica dipinta in bianco con superfici scurite. Spalla convessa con decorazione dipinta in bianco disposta su due registri sovrapposti: uno con ad archetti concentri e uno con serie di tratti obliqui.
Bibliografia TULLIO 1995, p.149, fig. 13.
Cronologia XII secolo.
Vaso con filtro
Inv. C. K85/57
Ubicazione Cefalù Magazzino
Provenienza Cefalù Duomo, Torre S
Dati di scavo Strato II: strato di cantiere.
Stato di conservazione Frammentario / pareti
Impasto Rosso arancio tipo Zisa
Descrizione Frammento di ceramica dipinta in bianco con superfici scurite. Spalla convessa con decorazione dipinta in bianco: tralcio d'edera.
Bibliografia TULLIO 1995, p.149, fig. 13.
Cronologia XII secolo.
mazzara del vallo, rinvenimenti sottomarini ALTOMEDIEVALI
Inv MBA 12
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza
Stato di conservazione Priva del collo
Impasto Arancio chiaro (5YR 6/6), con rari inclusi bianchi e con inclusi di piccole e medie dimensioni di colore grigio chiaro più rari grigio scuro.
Misure H cm 51
Descrizione Collo tronco-conico; spalla inclinata percorsa da solchi paralleli incisi con il pettine; anse leggermente ovoidali; ventre ovoidale; fondo lievemente convesso; 5 tacche sulla spalla. Molto simile a MV19.
160
Confronti PAROLI 1993, fig. 4, 3-4 e ARTHUR et alii 1992, fig. 10, p. 105.
Cronologia VII-VIII secolo.
Inv MBA 19 (fig. 9) Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi., sala della Nave punica
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio chiaro (5YR 6/6), con rari inclusi bianchi e con inclusi di piccole e medie dimensioni di colore grigio chiaro più rari grigio scuro e con tracce di mica.
Misure H. cm 49,1; diametro orlo interno cm 4,6, esterno cm 7,2; Larghezza max cm 33,2/35,1; circonferenza cm 109; capienza lt. 22,95.
Descrizione Orlo estroflesso con concavità interna; collo leggermente tronco-conico; anse a sezione ellittica costolate, impostate immediatamente sotto l’orlo e terminanti sulla spalla; corpo ovoidale; fondo convesso.
Confronti PAROLI 1993, fig. 4, 3-4 e ARTHUR et alii 1992, fig. 10, p. 105.
Cronologia VII-VIII secolo.
Inv. MBA 362 (fig. 10)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Priva di un'ansa.
Impasto Beige rosato (5YR 7/6), depurato, con inclusi di piccole e medie dimensioni grigio chiaro, più rari grigio scuro e bianchi, neri di piccole dimensioni ad alta frequenza.
Misure H cm 50,7; diametro interno cm 5,4, esterno cm 9; Larghezza max cm 36,8; circonferenza cm 125; capienza lt. 27,39.
Descrizione Orlo estroflesso con concavità interna; collo leggermente tronco-conico; anse a sezione ellittica costolate, impostate a metà circa del collo e terminanti sulla spalla; corpo ovoidale; fondo convesso.
Confronti PAROLI 1993, fig. 4.3-4.
Cronologia VIII secolo.
Inv. MBA 360 (fig. 8)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Priva di un'ansa e con un foro al fondo.
Impasto Arancio scuro, compatto, depurato con piccoli inclusi bianchi a media frequenza e grigi di piccole dimensioni a media frequenza.
Misure H. cm 48,9; larghezza max cm 35,2; circonferenza cm 113; diametro orlo interno cm 9 esterno cm 10,6; diametro fondo cm 5,4; capienza lt. 22,81.
Descrizione Orlo ingrossato, estroflesso con concavità interna, collo tronco-conico; anse leggermente ovoidali; spalla inclinata, corpo ovoidale; fondo umbonato.
Confronti ARTHUR 1993, fig. 3.13 e fig. 5.
Cronologia VIII secolo.
161
Anfora Tipo Gunsenin I
Inv MV 364 (fig. 11)
Ubicazione Mazara del Vallo. Comune, Centro Polivalente di Cultura
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Lacunosa all'orlo.
Impasto Arancio (7.5R 5/6), con minuscoli inclusi bianchi e con rara mica bianca di piccolissime dimensioni.
Misure H cm 37.8; diametro orlo interno cm 5.8, esterno cm 9; larghezza max cm 30,8; capienza lt. 12,31.
Descrizione Orlo arrotondato, estroflesso, collo atrofizzato, anse ad angolo retto, impostate sull'orlo che si attestano sulla spalla, spalla poco inclinata, corpo cuoriforme, fondo convesso. Presenta un graffito sulla spalla (H). Pareti percorse da cordonature. Contenevano vino dal momento che in alcuni esemplari turchi si è trovata traccia di resina.
Confronti GUNSENIN 1989, Type I, fig. 2, pp. 269-270; VAN DOORNINCK 1989, fig. 4.
Cronologia IX-XI secolo.
Inv MBA 10 (fig. 21)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Integra
Impasto Rosso (10R 5/8), depuratissimo con inclusi gialli medio piccoli a media frequenza e neri piccoli a bassa frequenza. Superfici lisciate.
Misure H cm 51,6; diametro orlo interno cm 5, esterno cm 6,6; diametro fondo cm 3; Larghezza max cm 42,1; circonferenza cm 132; capienza lt. 34,95.
Descrizione Orlo verticale inclinato verso l’interno e leggermente ingrossato all’esterno; collo tronco-conico; anse ovoidali impostate immediatamente sotto l’orlo fino alla spalla molto inclinata; corpo globulare; fondo convesso con un piccolo umbone; decorazione a pettine sulla spalla e sul ventre con motivi ad onde.
Anfora Brusic Gruppo Vb
Inv MBA 21 (fig. 12)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi., Sala della nave punica
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Priva del collo e di un'ansa
Impasto Beige rosato (5YR 7/6) con grossi inclusi (?) rossi (forse delle macchie di colore più rosso dal momento che sono visibili sul corpo del vaso anche delle striature dello stesso colore), inclusi grigio chiaro di piccole e medie dimensioni a media frequenza e neri di piccole dimensioni.
Misure H cm 54; diametro interno cm 9; Larghezza max cm 41,6/43,7; capienza lt. 44,68.
Descrizione Anse sormontanti con sezione a trifoglio impostate sulla spalla; ventre ovoidale; pareti percorse da cordonature; fondo convesso.
162
Confronti BRUSIC 1976, p. IV,4 dall'isola di Hvar Gruppo Vb.
Cronologia IX-XII secolo.
Inv MBA 18 (fig. 13)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi., sala della Nave punica
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Integra
Impasto Beige rosato (5YR 7/6) con grossi inclusi (?) rossi (forse delle macchie di colore più rosso dal momento che sono visibili sul corpo del vaso anche delle striature dello stesso colore), inclusi grigio chiaro di piccole e medie dimensioni a media frequenza e neri di piccole dimensioni.
Misure H cm 54,5; larghezza max cm 42,2/43,9; diametro orlo interno cm 8, esterno cm 10.6; capienza lt. 41,22.
Descrizione Orlo verticale a larga fascia; corto collo rigonfio, anse a sezione leggermente ovoidali e costolate, lievemente sormontanti; corpo globulare percorso da cannelures; fondo convesso.
Confronti BRUSIC 1976, p. IV,4 dall'isola di Hvar Gruppo Vb.
Cronologia IX-XII secolo.
MEDIEVALI DI PRODUZIONE PALERMITANA
Anfora Tipo
PPA102
Inv. MV 344 (fig. 38)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Restaurata da 2 frammenti. Priva del collo.
Impasto Rosso arancio con numerosi inclusi bianchi.
Misure H cm 42,5; diametro collo cm 7,5; fondo cm 8,4; larghezza max cm 30/31,4; circonferenza cm 101; capacità lt. 17,19.
Descrizione Collo a svasare, anse a sezione ellittica con solco mediano ad angolo retto impostate nella parte bassa del collo fino al punto di raccordo tra la spalla ed il ventre; spalla poco inclinata; corpo ovoidale; fondo umbonato; parete percorsa da cordonature.
Confronti Produzione palermitana? La forma del collo e del corpo ricorda l’anfora palermitana PPA102.
Cronologia XII secolo?
Anfora Tipo M1
Inv MBA 262 (fig. 44)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio con inclusi bianchi medi ad alta frequenza
163
Misure H. cm 33; larghezza max cm 24,8; diametro orlo esterno cm 7; fondo cm 9.
Descrizione Orlo verticale ingrossato; collo cilindrico con nervatura sotto l'orlo; anse con solco mediano; spalla poco inclinata; ventre globulare; fondo umbonato; pareti percorse da cordonature.
Confronti Produzione palermitana?
Cronologia XII secolo.
Inv MV 6 Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Priva dell'orlo
Impasto Di colore rosso.
Misure H. cm 60
Descrizione Anse con solco mediano; spalla inclinata; ventre ovoidale; parete percorsa da cordonature; fondo umbonato; forse dipinta di bruno.
Confronti Produzione palermitana?
Cronologia
XII secolo.
MEDIEVALI ALLOGENE
Inv MV 1137 (fig. 26) Ubicazione Mazara del Vallo. Comune, Centro Polivalente di Cultura
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Lacunosa al collo.
Impasto Rosaceo (10R 6/6), polveroso, depurato, con inclusi ferrosi, rari di grandi dimensioni e medi più frequenti.
Misure H cm 36,6; diametro orlo interno 6.6; larghezza max cm 28, diametro fondo cm 6.4; circonferenza cm 93; capienza lt. 12,68.
Descrizione Anse impostate ad angolo retto, collo a svasare segnato nel punto di attacco delle anse da due solchi concentrici, spalla poco inclinata, percorsa da tre gruppi paralleli di linee incise a pettine, corpo ovoidale percorso da cordonature, fondo umbonato. Nel punto di raccordo tra il collo e la spalla è presente una nervatura a rilievo.
Inv MBA 1 (fig. 25)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Integra
Impasto Beige chiaro (10YR 7/4) più grigio al nucleo (10YR 7/2), molto depurato con tracce di mica, piccolissimi inclusi grigio chiaro a media frequenza.
Misure H cm 45,2; diametro orlo interno cm 9, esterno cm 9,8; fondo cm 7; Larghezza max cm 24,7; capienza lt. 10,94.
Descrizione Orlo verticale, ingrossato all’esterno a sezione semicircolare; collo cilindrico, segnato nella parte mediana da un solco, all’altezza del quale si impostano le anse a sezione ellittica; spalla poco inclinata sulla quale arrivano le anse; corpo
164
ovoidale, percorso nella parte superiore da cordonature; fondo umbonato con cordonature; la fascia risparmiata è di circa cm 12.5.
Cronologia XI-XII secolo?
Inv MBA 23 (fig. 17) Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Priva dell'orlo
Impasto Arancio (10R 6/8-5YR 7/6) depurato, con piccolissima mica.
Misure H cm 96,4; Larghezza max cm 68,2/70,8; capienza lt. 177,5.
Descrizione Grande anfora con corpo biconico. Anse a sezione ellittica con sulla parte sommitale tracce dell’attacco degli apici (diametro cm 3 circa); una nervatura segna l’attacco del collo alla spalla; spalla molto inclinata percorsa da solchi concentrici; il punto di raccordo tra le anse e la spalla è segnato da una ditata. Fondo convesso. In prossimità del fondo la parete è percorsa da cordonature. Sulla spalla graffito con lettere arabe.
Confronti PPA 165 bis Produzione africana: Jerba. MIKAH!"#$% - M&'KIPTZH%
2003 e CIRELLI 2002, tipo IV. Cronologia XII secolo.
Inv MBA 330 (fig. 22)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Integra
Impasto Rosso (2.5YR 5/6), depurato, leggermente poroso con rari inclusi neri di piccole dimensioni.
Misure H. cm 54.4; diametro orlo esterno cm 10; interno cm 6.8; larghezza max cm 30,8; capienza lt. 18,55.
Descrizione Orlo piatto superiormente, sporgente all’interno; collo svasato percorso all’esterno da due solchi concentrici; spalla inclinata; anse a sezione ellittica con solco mediano impostate sulla spalla; corpo piriforme; fondo convesso.
Anfora Tipo A1 della Zisa
Inv MV 368
Ubicazione Mazara del Vallo. Comune, Centro Polivalente di Cultura.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Priva del collo
Impasto Simile a quello di MV 350.2 solo un pò più rosato.
Misure H. cm 41.5; diametro orlo interno cm 9; diametro fondo cm 7.2.
Descrizione Anse segnate da due solchi, corpo ovoidale percorso da cordonature, fondo umbonato.
Confronti D'ANGELO 1976, tipo A1 di produzione palermitana.
Cronologia XI-XII secolo.
165
NORMANNE, palermo
Anfora Tipo D1 della Zisa
Inv MV 350 (fig. 33) Ubicazione Mazara del Vallo. Comune, Centro Polivalente di Cultura.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Fessurata
Impasto Rosso-arancio (10R 5/8), poco depurato con numerosi inclusi bianchi.
Misure H cm 25.4; diametro orlo interno cm 7,6, esterno cm 10; fondo cm 5,4; Larghezza max cm17/18,5; capienza lt. 3,13.
Descrizione Orlo ingrossato a mandorla, larga imboccatura, collo atrofizzato, una nervatura a rilievo segna l’attacco del collo alla spalla; anse a sezione ovoidale ad anello impostate sulla spalla, pareti corrugate, corpo ovoidale, fondo umbonato.
Confronti ARCIFA et alii, 1985-87, fig. 9,b di produzione palermitana, cfr. PPA 134.
Cronologia XI-XII secolo.
Inv. MBA 25 (fig. 23)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Integra
Impasto Rosso arancio (10YR 5/8), duro, compatto, depuratissimo con inclusi bianchi di medie dimensioni a bassa frequenza di piccole dimensioni a media frequenza e con inclusi neri di piccole dimensioni a media frequenza.
Misure H cm 82,4; larghezza max cm 53,6; diametro orlo esterno cm 12,8, interno cm 11,2; capienza lt. 103,33.
Descrizione Orlo verticale arrotondato, leggermente ingrossato all'interno, segnato all’esterno da un solco; basso collo cilindrico, anse a sezione ovale con solco mediano impostate nel punto di raccordo tra il collo e la spalla leggermente inclinata, ventre ovoidale, fondo convesso, pareti cordonate.
Cronologia XI-XII secolo?
Inv. MBA 218 (fig. 24) Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Mazara del Vallo, dal mare, sequestro della Guardia di Finanza.
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio chiaro (10R 6/8) più scuro al nucleo (10R 4/8), molto depurato, compatto con rara mica di piccole dimensioni.
Misure H. 76,6; Larghezza max cm 42; diametro orlo interno cm 10,8, esterno cm 14; diametro fondo cm 6,8; capienza lt. 54,72
Descrizione Orlo verticale, arrotondato, ingrossato all'esterno, separato dalla parete esterna da un solco, collo cilindrico percorso nella parte intermedia da due solchi concentrici in prossimità dei quali si impostano le anse a sezione ellittica che arrivano nel punto di raccordo tra la spalla leggermente inclinata ed il ventre ovoidale, fondo umbonato, pareti cordonate nella parte superiore del
166
recipiente. Nella parte terminale di una delle due anse sono visibili 12 tacche disposte su tre file: la prima di tre tacche la seconda di quattro la terza di cinque.
Cronologia XI-XII secolo?
Anfora Tipo L
Inv. MBA 130 (fig. 46)
Ubicazione Marsala, Baglio Anselmi.
Provenienza Marsala, Relitto A.
Stato di conservazione Restaurata. Lacunosa al collo.
Impasto Tipo Zisa con superfici esterne scurite
Misure H. 60 circa, diametro orlo cm 12, fondo cm 12.
Descrizione Orlo arrotondato, ingrossato all'esterno, anse a sezione ovale con solco mediano impostate in prossimità della spalla leggermente inclinata, ventre ovoidale, fondo umbonato, pareti cordonate, decorazione dipinta in bruno, graffito con lettere arabe sulla spalla. Nel graffito si legge 1 mudd, ovvero, mezzo staio, misura per gli aridi.
Cronologia XI-XII secolo.
PALERMO, palazzo Rostagno
Anfora Tipo PPA 102
Inv. PPR 1 (fig. 37) Ubicazione Palermo, Palazzo Rostagno.
Provenienza Palermo, Palazzo Rostagno.
Dati di scavo Dal riempimento del pozzo.
Stato di conservazione Parzialmente integra / priva di un'ansa e del fondo.
Impasto Tipo Zisa.
Descrizione Della stessa forma di PPA 102, ma con decorazioni in rosso ferraccia su fondo chiaro, differenti: sul collo un motivo ad onda, sulla spalla e sul ventre sottili linee verticali sono alternate a motivi ad onde e a serie di tratti obliqui. Anse a sezione ovale piuttosto piccole, corpo percorso da cordonature eseguite al tornio.
Confronti PPA 102 Nr. esemplari 1
Per le anfore prodotte dalle fornaci di Agrigento si fa rimando a Ardizzone in Agrigento 2007
167
CARINI, c.da San Nicola Gruppo I
Inv CSN 9 (fig. 31)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Marrone chiaro, con numerosissimi inclusi bianchi e più raramente grigi
Misure Diametro orlo interno cm 9.4, esterno cm 12.4.
Descrizione Orlo verticale, ingrossato, a mandorla con un profilo all'esterno leggermente concavo, collo cilindrico lievemente tronco-conico. Superfici scurite senza decorazione.
Inv CSN 10 (fig. 31) Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio duro, compatto con numerosi inclusi bianchi di piccole dimensioni.
Misure Diametro orlo interno cm 15, esterno cm 18.4.
Descrizione Orlo verticale, ingrossato a mandorla con due solchi concentrici, collo cilindrico leggermente tronco-conico. Superfici scurite e decorazioni dipinte in bruno.
Confronti MOLINARI-VALENTE 1995, Tav.III.12 di diametro cm 20
Cronologia XI secolo
Inv CSN 7 (fig. 31)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio, depurato, compatto con numerosi inclusi bianchi di piccole dimensioni ad alta frequenza.
Misure Diametro orlo interno cm 14.6, esterno cm 17.4.
Descrizione Orlo verticale, ingrossato, a mandorla, con una sottile nervatura a rilievo, collo cilindrico; un solco segna il collo.
Inv. CSN 11 (fig. 31) Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9
Stato di conservazione Frammentario / orlo
168
Inv CSN 18 (fig. 31)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 16
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Come CSN 15
Misure Diametro orlo interno cm 8, esterno cm 10.6
Descrizione Orlo verticale, ingrossato, a mandorla con un solco mediano all'esterno, collo atrofizzato, spalla inclinato. Variante dimensionale di CSN 15. 2 esemplari.
Inv. CSN 21 (fig.31)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 16
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Marrone chiaro, combusto
Misure Diametro orlo interno cm 10.6, esterno cm 13.4.
Descrizione Orlo verticale, ingrossato a mandorla leggermente pendulo, percorso all'esterno da un solco; collo atrofizzato spalla piana con una nervatura a rilievo. Superfici scurite.
Inv CSN 15
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US15
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Misure Diametro orlo n.r.
Descrizione Orlo ingrossato, a mandorla, percorso da un solco, collo atrofizzato.
Inv CSN 24 (fig. 32)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 13
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio (2.5YR6/8) con inclusi bianchi di piccole dimensioni ad alta frequenza.
Impasto Arancio duro, compatto con numerosi inclusi bianchi di piccole dimensioni.
Misure Diametro orlo interno cm 8, esterno cm 10.8.
Descrizione Due frammenti ricomponibili con orlo verticale ingrossato a mandorla, collo leggermente tronco-conico.
Gruppo II
169
Misure Diametro orlo interno cm 9 esterno cm 10.6.
Descrizione Variante dimensionale di A2 con collo atrofizzato e nervatura a rilievo nel punto di raccordo tra il collo e la spalla. Superficie a buccia d'arancia.
Confronti MOLINARI-VALENTE 1995, Tav. III. 11 con lo stesso diametro.
Cronologia XI secolo
Inv CSN 14 (fig.31)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 16
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio depurato, compatto duro con inclusi bianchi e piccoli vacuoli circolari.
Misure Diametro orlo interno cm 9, esterno cm 12.4.
Descrizione Orlo ingrossato a sezione triangolare percorso da un solco all'esterno e leggermente sporgente nella parte bassa, collo atrofizzato, superfici esterne scurite con tracce di pennellate nere.
Confronti MOLINARI-VALENTE 1995, Tav. III. 13 con il diametro più grande.
Cronologia XI secolo.
Inv CSN 2
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio depurato, compatto duro con inclusi bianchi e piccoli vacuoli circolari.
Misure Diametro interno cm 10, esterno cm 12.5
Descrizione Orlo verticale, ingrossato a mandorla percorso da due solchi, collo atrofizzato, una nervatura segna l'attacco con la spalla piana.
Confronti MOLINARI-VALENTE 1995, Tav. III. 11 con il diametro più grande
Cronologia XI secolo
Inv CSN 8 (fig.32)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio, poroso con inclusi bianchi
Misure Diametro orlo interno cm 8, esterno cm 10.2
Descrizione Orlo ingrossato, a mandorla, breve collo, una nervatura segna l'attacco del collo con la spalla.
170
Inv CSN 1 (fig.32)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Impasto arancio depurato, duro, compatto con piccoli inclusi bianchi a media frequenza
Misure Diametro orlo interno cm 20, esterno cm 24.
Descrizione Orlo ingrossato, a sezione circolare, corto collo leggermente svasato, decorato all'esterno con una serie di onde incise; larga imboccatura; spalla piana.
Confronti Solo per la forma dell'orlo ricorda l'anfora 88.602 di Agrigento.
Inv CSN 12 (fig.32)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 15
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Come CSN 3
Misure Diametro orlo interno cm 9.4 esterno cm 11.2.
Descrizione Orlo verticale, arrotondato, percorso all'esterno da una nervatura a rilievo nel punto di congiunzione con il collo. Collo atrofizzato, una nervatura segna l'attacco con la spalla. Superfici scurite.
CSN 13
inclusi bianchi a media
una nervatura a rilievo nel
Gruppo III
Inv CSN 13 (fig. 36) Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 15
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure Diametro orlo interno cm 5.4, esterno cm 7.
Descrizione Orlo verticale, obliquo verso l'interno, collo verticale a svasare e leggermente rigonfio segnato all'esterno da cordonature eseguite al tornio. Decorazione ad onde dipinta in rosso.
Confronti Un frammento da US15; LESNES 1998, tav. II,16.
Inv CSN 22 (fig.36) Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 15
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Impasto come CSN 13
171
Misure Diametro orlo interno cm 7.2, esterno cm 8.6.
Descrizione Due frammenti ricomponibili di collo con orlo verticale ingrossato all'interno obliquo percorso all'esterno da un solco.
Inv CSN 25.1 Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 13
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio come CSN 24 con un grosso incluso grigio.
Misure Diametro orlo non rilevabile.
Descrizione Orlo indistinto, leggermente ingrossato all'interno piano superiormente con tre solchi paralleli all'esterno e decorazione dipinta in rosso.
Gruppo IV
Inv. CSN 17 (fig. 36) Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 16
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Come CSN 3
Misure Diametro orlo interno cm 8, esterno cm 10.
Descrizione Due frammenti ricomponibili con orlo verticale, ingrossato a mandorla inclinato verso l'esterno, segnato all'attacco con il collo da un solco, collo cilindrico rigonfio percorso da cordonature e con decorazione dipinta in bruno: tratti obliqui sul labbro una larga fascia bruna, e tratti più sottili e più lunghi obliqui sul collo. Anse a sezione ovale costolonate con un solco mediano. Variante dimensionale di CSN 3.
Confronti Palazzo Rostagno PPA 102; MOLINARI-VALENTE 1995, Tav. III. 16 con lo stesso diametro, ARCIFA 1998, tav. I,a 10. Per il motivo decorativo, cfr. LESNES 1997, p. 44, n.3.
Cronologia Fine X - prima metà XI secolo.
Inv CSN 20 (fig. 31)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US16
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo CSN 17
Misure Diametro orlo interno cm 8, esterno cm 10.2.
Descrizione 3 frammenti. Variante del tipo CSN 17 ma con andamento concavo all'interno. Con decorazione dipinta in bruno.
172
Inv CSN 19 (fig.36)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US16
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure Diametro orlo interno cm 8.4, esterno cm 11.2.
Descrizione Orlo verticale ingrossato a mandorla con un solco nella parte bassa della fascia. Tracce di attacco dell'ansa nel punto di raccordo tra l'orlo ed il collo. Superfici scurite e decorazione dipinta in bruno a linee brune.
Inv CSN 5
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio chiaro con numerosi inclusi bianchi.
Misure Diametro orlo cm 8.
Descrizione Variante del tipo CSN 17: senza la nervatura all'esterno nel punto di raccordo con il collo. Superfici schiarite.
Inv CSN 3 Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio depurato, compatto duro con inclusi bianchi e piccoli vacuoli circolari.
Misure Diametro orlo cm 7.
Descrizione Variante del tipo CSN17, con orlo più verticale rispetto al campione, superfici scurite e decorazione dipinta in bruno.
Gruppo V
Inv CSN 4 (fig. 31)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Stesso impasto di CSN 4.1
Misure Diametro orlo interno cm 7.6, esterno cm 10.2.
Descrizione Frammento con orlo verticale indistinto, leggermente concavo all’interno, separato all'esterno da un gradino, collo cilindrico rigonfio segnato da cordonature. Superfici schiarite.
173
Inv CSN 4.1
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio, poroso, duro con numerosi inclusi bianchi e vacuoli arrotondati.
Misure Diametro orlo cm 6.
Descrizione Variante del tipo CSN 4 con alto orlo verticale arrotondato, leggermente concavo, separato dal collo mediante una carenatura. Ingobbiatura rossa all'esterno.
Confronti Somiglia al tipo 1 della Zisa.
Inv CSN 4.2 (fig. 31) Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9 Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo CSN 4
Misure Diametro orlo interno cm 7.2, esterno cm 9.8.
Descrizione Orlo verticale, arrotondato, separato dal collo mediante una carenatura e segnato all'esterno da un solco. Collo cilindrico ingrossato. Variante del tipo CSN4.
Gruppo VI
Inv CSN 16 (fig.41)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 15
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Misure Diametro orlo interno cm 10.4, esterno cm 13.4.
Descrizione Orlo verticale ingrossato a mandorla percorso all'esterno da 4 solchi una; nervatura all'esterno segna l'attacco con il collo.
Confronti Due frammenti. Provengono dall'US 16.
Inv CSN 23 (fig.41) Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 16
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio duro, compatto, depurato con inclusi bianchi di piccole dimensioni a media frequenza.
Misure Diametro orlo interno cm 10.4, esterno cm 12.8.
174
Descrizione Variante di CSN16 con orlo più piccolo, collo a svasare con decorazione dipinta.
Fondi
Inv CSN 25 (fig. 41)
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US13
Stato di conservazione Frammentario / fondo
Impasto Come A24
Misure Diametro fondo cm 9.6
Descrizione Frammento del fondo con piede ad anello, parete esterna decorato con fasce verticali alternate a serie di tratti obliqui in rosso bruno.
Inv CSN 6
Ubicazione Palermo, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Provenienza Carini, Contrada San Nicola
Dati di scavo 1997, US 9
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Arancio rosaceo, poco depurato, con inclusi bianchi di grandi dimensioni ad alta frequenza.
Misure Diametro non rilevabile
Descrizione Orlo verticale, ingrossato, a fascia con profilo esterno concavo, una nervatura a rilievo percorre la parete esterna del collo.
PALERMO, via Torremuzza
Anfora Tipo PPA 102
Inv PT1 (fig.39,A) Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 81
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 3, Diametro n.r.
Descrizione Piccolo frammento di orlo con tracce di decorazione dipinta.
Anfora Tipo Carini A18
Inv PT2 (fig. 39,E)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
175
Dati di scavo 1997, US 90
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 3,6; Diametro orlo n.r.
Descrizione Piccolo frammento di orlo con tracce di decorazione dipinta in bruno: tratti obliqui in bruno.
Inv PT3 (fig. 39,B)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 83
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 3,7; Diametro orlo n.r.
Descrizione Piccolo frammento di orlo con orlo verticale leggermente convesso all’esterno con una piccola nervatura a rilievo sulla parete esterna.
Olla (?)
Inv PT4 (fig. 39,F)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 83
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 4,2; Diametro n.r.
Descrizione Piccolo frammento di orlo verticale leggermente convesso all’esterno con una piccolo solco nella parte alta del labbro. Decorazione dipinta con un motivo ad onda.
Brocca
Inv PT5 (fig. 39,L)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 73
Stato di conservazione Frammentario / collo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 6,8; Diametro interno cm 1,8, esterno cm 3,4.
Descrizione Stretto collo leggermente a svasare con orlo verticale leggermente inclinato verso l’esterno a sezione triangolare, una piccola nervatura a rilievo a metà circa del collo segna all’esterno il punto di attacco dell’ansa a sezione ovoidale.
176
Anfora Tipo PPA 102
Inv PT6 (fig. 39,G)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 73
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 3,3; Diametro n.r.
Descrizione Piccolo frammento di orlo verticale leggermente ingrossato all’esterno con un piccolo solco nel punto di raccordo con la parete esterna. Decorazione in bruno: serie di tratti verticali e fascia in bruno.
Confronti Anfora Tipo Carini CSN20.
Anfora Tipo Carini CSN4
Inv PT7 (fig. 39,I)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 73
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 4,5; Diametro n.r.
Descrizione Piccolo frammento di orlo verticale leggermente concavo all’interno.
Olla (?)
Inv PT8 (fig. 39,H)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 73
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 5,1; Diametro n.r.
Descrizione Piccolo frammento di orlo verticale piatto superiormente, leggermente concavo all’interno con una piccolo solco nella parte alta del labbro.
Confronti Confrontabile con un’olla prodotta dalle fornaci di Agrigento Tipo 89.114.
Anfora Tipo Carini CSN24
Inv PT9 (fig. 34,D)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 65
Stato di conservazione Frammentario / orlo
177
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 4,3; Diametro interno cm 10, esterno cm 11,8
Descrizione Orlo verticale leggermente inclinato verso l’esterno a sezione triangolare con un piccolo solco all’esterno. Una nervatura a rilievo segna l’attacco del collo alla spalla.
Anfora Tipo Carini CSN15
Inv PT10 (fig. 34, E)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 65
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 4; Diametro interno cm 11, esterno cm 13,6
Descrizione Orlo verticale arrotondato, ingrossato all’esterno percorso da un solco.
Olla
Inv PT11 (fig. 34, B)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 65
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 3,5; Diametro n.r.
Descrizione Orlo ingrossato all’esterno piatto superiormente convesso all’interno.
Confronti Richiama l’olla prodotta ad Agrigento tipo 89.117.
Olla
Inv PT12 (fig. 34, F)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 65
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 4,9; Diametro esterno cm 18,6, interno cm 15,6.
Descrizione Orlo ingrossato all’esterno a sezione triangolare superiormente convesso all’interno. Collo cilindrico, spalla poco inclinata.
Confronti Richiama l’olla prodotta ad Agrigento tipo 89.117. Confronta LESNES 1998, tav. II, 24.
178
Forma aperta
Inv PT13 (fig. 34,C)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 65
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 3,7; Diametro n.r.
Descrizione Orlo indistinto, arrotondato verticale, parete carenata.
Confronti Richiama la forma aperta prodotta ad Agrigento tipo 93.55.
Anfora Tipo Agrigento 88.602
Inv PT14 (fig. 39, D)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 96
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 3,7; Diametro n.r.
Descrizione Orlo verticale arrotondato segnato all’esterno da una grossa nervatura a rilievo.
Confronti Richiama l’anfora prodotta ad Agrigento tipo 88.602. Confronta LESNES 1998, tav. II, 19.
Olla (?)
Inv PT15 (fig. 39,C)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 96
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 3,5; Diametro n.r.
Descrizione Orlo ingrossato all’esterno a sezione vagamente triangolare. Collo cilindrico.
Confronti Richiama vagamente l’olla prodotta ad Agrigento tipo 89.117.
Anfora Tipo PPA 102
Inv PT16 (fig. 39,N)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 80
Stato di conservazione Frammentario / orlo e collo
179
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 5,2; Diametro esterno cm 9,8, interno cm 7,8.
Descrizione Orlo verticale, ingrossato all’esterno segnato all’esterno da una nervatura a rilievo. Collo cilindrico percorso da cordonature con tracce di decorazione dipinta.
Anfora (?)
Inv PT17 (fig. 39,M)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 80
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 8,4; Diametro n.r.
Descrizione Orlo leggermente ingrossato all’esterno, indistinto, piatto superiormente leggermente bifido, con attacco dell’ansa.
Confronti Richiama le anfore agrigentine 93.445 e 93.307.
Anfora Tipo PPA 125
Inv PT18 (fig. 39,O)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 80
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 7,2; Diametro esterno cm 12,6, interno cm 10.
Descrizione Orlo ingrossato all’esterno inclinato verso l’interno, percorso all’esterno da due solchi paralleli. Collo tronco-conico.
Anfora Tipo PPA 102
Inv PT19 (fig. 34,A)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Via Torremuzza
Dati di scavo 1997, US 62
Stato di conservazione Frammentario / orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 4,9; Diametro esterno cm 18,6, interno cm 15,6.
Descrizione Orlo verticale concavo all’interno e convesso all’esterno, distinto dalla parete esterna mediante un solco profondo. Tracce di decorazione dipinta.
180
Anfora Tipo D2 Zisa
Inv T.2 (fig. 35,b) Ubicazione Terrasini, Museo Civico
Provenienza Castellammare Golfo, Località San Cataldo
Dati di scavo Dal mare alla profondità di m-6
Stato di conservazione Intera
Impasto Non rilevabile
Descrizione Orlo ingrossato, verticale a sezione ovoidale, collo atrofizzato, spalla poco inclinata convessa, anse ad anello, ventre tronco-conico percorso da cordonature, fondo umbonato. Decorazione dipinta in bruno come il campione palermitano.
Bibliografia PURPURA 1977, fig.23a, Tav IIIm.
Confronti Tipo D della Zisa
Cronologia XI secolo.
Anfora Tipo D Zisa
Inv T.1 (fig. 35,a)
Ubicazione Terrasini, Museo Civico
Provenienza Palermo
Dati di scavo Probabilmente dalle volte di un edificio.
Stato di conservazione Intera
Impasto Non rilevabile
Descrizione Orlo ingrossato, verticale a sezione ovoidale percorso da due solchi, collo atrofizzato, spalla poco inclinata convessa, anse ad anello, ventre tronco-conico percorso da cordonature, fondo convesso con un piccolo umbone.
Bibliografia PURPURA 1977, fig. 25b, Tav.IIIn.
Confronti Palazzo Abatellis
Cronologia XI-XII secolo.
Palermo, edifici normanni
ANFORE D’IMPORTAZIONE
Inv PPA 87 (fig. 14) Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio (2YR 6/8), depurato con mica gialla a bassa frequenza.
Misure H cm 58; diametro orlo cm 7; capacità lt. 18.35
Descrizione Orlo estroflesso orizzontale convesso, collo tronco-conico concavo, anse a sezione ovale arcuate, spalla inclinata su cui è graffito dopo la cottura un segno di X, corpo ovoide percorso da cordonature, fondo convesso. Scarto d'uso.
Confronti ARTHUR 1989, Fig. 10, p. 88 e s.; ARTHUR 1992, fig. 7:2, n. 818 e fig. 7:3, n. 324 appartenenti al tipo 1 di Otranto datati tra il X e la prima metà dell’XI secolo, p. 206.
Cronologia X-XI secolo.
181
Inv PPA 40 (fig. 19)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Non rilevabile.
Misure H cm 90.4; diametro orlo cm 10.8, fondo cm 8; capacità lt. 85.82.
Descrizione Orlo ingrossato, arrotondato a sezione semicircolare con profilo concavo all'interno, collo a svasare segnato all'esterno da una nervatura, anse a sezione ovale, leggermente costolonate, impostate immediatamente sotto l'orlo fino alla spalla; spalla inclinata segnata tra ansa ed ansa da una serie di piccoli solchi eseguiti al pettine, ventre cilindrico con la parte bassa troncoconica, fondo piatto. Scarto d'uso.
Confronti C'è un esemplare simile a Mazara.
Inv PPA 164 Bis (fig. 18) Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Giallo chiaro (5Y8/4) in superficie e rosa al nucleo (5YR 7/6), leggermente poroso, depurato.
Misure H cm 58; diametro orlo cm 10; capacità lt 24.3
Descrizione Orlo ingrossato a fascia con profilo concavo, collo cilindrico, anse costolonate a sezione ovale, flesse, spalla inclinata, corpo tronco-conico decorato con serie di archetti incisi nell'argilla ancora cruda disposti su più registri, fondo convesso. Scarto d'uso.
Confronti
Cronologia
Egitto.
Fine XI-XII secolo.
ANFORE DI PRODUZIONE LOCALE
Anfora Tipo I
Inv PPA 109 (fig. 45) Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 56.2; diametro orlo cm 10, fondo cm 8.4
Descrizione Identica al tipo G della Zisa anche per motivi decorativi, ma con orlo percorso all'esterno da una nervatura a rilievo a ditate, ed anse costolonate
Nr. esemplari 3
Cronologia XI-XII secolo.
182
Inv PPA 167
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Parzialmente integra / lacunosa all'orlo e al fondo; due frammenti ricomposti.
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 43; diametro collo esterno cm 10
Descrizione Collo cilindrico, anse apicate a sezione ovale, ventre ovale, fondo umbonato rotto. Ventre per più di metà rivestito di ingobbiatura nera con motivi sovraddipinti in bianco: sulla spalla girali e foglie d'edera, sul ventre motivi pseudo epigrafici.
Cronologia XI-XII secolo.
Inv PPA 130 Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Parzialmente integra / lacunosa al collo
Impasto Tipo Zisa
Descrizione Piccola anforetta con collo cilindrico, anse a sezione ovale, spalla inclinata, ventre ovoidale, fondo umbonato rotto. Il corpo percorso da cordonature, si presenta per metà rivestita da un'ingobbiatura nera e decorata con motivi sovraddipinti in bianco: una treccia sulla spalla e trattini obliqui sul corpo. Priva dell'orlo.
Cronologia XI-XII secolo.
Anfora Tipo A5
Inv PPA 90 (fig. 43)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 52; diametro orlo cm 6; fondo cm 6
Descrizione Orlo verticale arrotondato ed indistinto, collo rigonfio, anse a sezione leggermente ovalizzata, spalla inclinata, ventre piriforme, acroma. Contiene quasi 7 litri di acqua (6.9)
Nr. esemplari 2
Cronologia XII secolo.
183
Anfora Tipo B3 Zisa
Inv PPA 154 (fig. 44)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis.
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 35.5; diametro orlo cm 3; fondo cm 6.4
Descrizione Orlo ingrossato a sezione semicircolare, stretto collo cilindrico segnato da due solchi concentrici, anse a sezione quasi circolare, lisce, spalla orizzontale, corpo ovoidale percorso da cordonature eseguite al tornio, fondo umbonato. Decorazione dipinta in bruno: fasce verticali alternate a serie di tratti obliqui, sull'ansa fascia verticale e sul collo tre macchie di colore bruno leggermente irregolari.
Confronti Tipo B3 della Zisa
Cronologia XII secolo.
Anfora Tipo C1
Inv PPA 113 (fig. 45) Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 37; diametro orlo cm 9.6; fondo cm 15.
Descrizione Orlo ingrossato, a sezione quasi semicircolare, collo tronco-conico, anse arcuate a sezione ovale, spalla inclinata, ventre ovoidale, percorso da cordonature eseguite al tornio, largo fondo umbonato. Acroma. Scarto di fornace, Lesionata.
Confronti Richiama il tipo C1 della Zisa.
Cronologia XII secolo.
Anfora Tipo D2
Inv PPA 125 (fig. 45)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Tipo Zisa
Misure h cm 46; diametro orlo cm 12.2; fondo cm 9.4
Descrizione Orlo ingrossato a mandorla, percorso all'esterno da due solchi concentrici effettuati prima della cottura. il corpo è decorato da linee parallele verticali di colore bruno alternate a serie di tratti obliqui. Contiene l 12.3 di acqua ed è probabilmente uno scarto d'uso per le sbrecciature visibili sull'orlo.
Confronti Tipo D2 della Zisa; PEDUTO 1987 (Salerno)
Cronologia XI secolo.
184
Anfora Tipo G1
Inv PPA 122 (fig. 45) Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento delle volte.
Stato di conservazione Integra/ sarcita al fondo.
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 50.8; diametro fondo cm 9.2; orlo cm 12.4
Descrizione Orlo verticale a mandorla segnato all'esterno da un solco, collo cilindrico rigonfio percorso da un solco; anse ad anello costolonate impostate sulla spalla piana, corpo ovoidale percorso da costolature, fondo umbonato. La parete esterna del contenitore è decorata con motivi in bruno: sul collo 4 fasce parallele, sulla spalla e sul ventre due linee più sottili verticali parallele alternate a serie di tratti obliqui. Fondo rifatto. Scarto d'uso.
Cronologia Seconda metà XI secolo.
Anfora Tipo L
Inv PPA 114 (fig. 46) Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 62; diametro orlo cm 10; fondo cm 12.
Descrizione Orlo ingrossato a sezione quasi semicircolare, convesso, separato all'esterno da un solco, collo cilindrico, anse a sezione ovale percorse da un solco, arcuate, spalla poco inclinata, ventre ovoidale percorso da cordonature eseguite al tornio, fondo umbonato. Decorazione dipinta: sul collo 4 fasce orizzontali parallele di colore bruno e altre 4 sulla spalla; sul corpo linee verticali brune alternate a serie di piccoli tratti obliqui.
Confronti Marsala relitto
Cronologia XII secolo.
Anfora Tipo M
Inv PPA 95 (fig. 44) Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Tipo Zisa
Misure h. cm 48; diametro orlo cm 5.2; fondo cm 9
Descrizione Orlo ingrossato all'esterno separato dalla parete esterna mediane un solco, stretto collo cilindrico percorso all'esterno da una nervatura poco sotto l'orlo, anse a sezione ovale con un solco mediano, spalla inclinata, corpo ovoidale percorso da cordonature eseguite al tornio, fondo umbonato. Labili tracce di decorazione dipinta in bruno a larghe pennellate parallele sul collo.
Cronologia XII secolo.
185
Inv PPA 105 (fig. 43)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Parzialmente integra / lacunosa al fondo e all'orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 51; diametro orlo cm 8; fondo cm 10.
Descrizione Orlo verticale arrotondato, segnato all'esterno da una nervatura plastica decorata a ditate e da una costolatura a rilievo, collo cilindrico, anse a sezione ovale impostate nella parte bassa del collo che arrivano nel punto di congiunzione della spala con il ventre, spalla inclinata, corpo ovoidale percorso da cordonature eseguite al tornio, fondo umbonato leggermente rilevato. Priva di decorazioni dipinte.
Confronti Richiama il Tipo A3 della Zisa
Cronologia XII secolo.
Inv PPA 107 (fig. 43)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 38; diametro orlo cm 5; fondo cm 7.4.
Descrizione Variante dimensionale di PPA 105
Confronti Richiama il Tipo A3 della Zisa
Cronologia XII secolo.
Inv PPA 115 (fig. 42)
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 44; diametro fondo cm 8.8; orlo cm 6.4
Descrizione Come PPA 105 ma di dimensioni più piccole, con il corpo piriforme e con il collo leggermente rigonfio.
Confronti Richiama il Tipo A3 della Zisa
Cronologia XII secolo.
Inv PPA 146 (fig. 42) Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
186
Stato di conservazione Parzialmente ricomposta
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 56; diametro orlo cm 8; fondo cm 9.6
Descrizione Orlo verticale leggermente concavo, arrotondato, percorso all'esterno da una nervatura plastica a ditate, collo leggermente tronco-conico, anse a sezione ovale apicate impostate nella parte bassa del collo, spalla inclinata ventre ovoidale percorso da cordonature, fondo umbonato. La parte superiore del vaso è rivestita con un'ingobbiatura di colore rosso, la metà inferiore è risparmiata. Presenta la decorazione dipinta in bianco a linee sottili orizzontali, parallele sul collo e sulla spalla.
Confronti Richiama il tipo PPA 115
Cronologia XII secolo.
Inv PPA 102 (fig. 37) Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra / lesionata
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 38; diametro orlo cm 8.4; fondo cm 9
Descrizione Orlo verticale, convesso, separato all'esterno da un solco, collo svasato rigonfio, più stretto nel punto di congiunzione con la spalla; anse a sezione ovale percorse da costolature e da un solco mediano più profondo; spalla piana, corpo cuoriforme, percorso da cordonature, fondo umbonato. Il corpo è interamente ricoperto da decorazioni lineari in bruno: fasce parallele sul collo e sulla spalla dove sono collegate tra di loro da piccoli trattini obliqui.
Bibliografia SCERRATO 1985, fig. 190
Confronti Palazzo Rostagno; Carini, Palazzo Bonagia; Mondello; LESNES 1997, cat.n.2, fig.3, p. 43.
Cronologia XI secolo.
Anfora Tipo D1
Inv PPA 134 (fig. 45) Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis.
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra con profonde lesioni
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 31.5; diametro orlo cm 9.3; fondo cm 6.5
Descrizione Orlo ingrossato, a mandorla, verticale, collo atrofizzato cilindrico segnato all'esterno da un solco praticato prima della cottura, breve spalla inclinata, anse a sezione quasi circolare che arrivano nel punto di massima espansione del vaso, corpo piriforme percorso da cordonature, fondo umbonato. Acroma.
Bibliografia SCERRATO 1985, Fig. 190
187
Confronti ARCIFA et alii, 1985-87, fig. 9,b; ARCIFA 1998b, fig. 23,5 (Palermo, Castello San Pietro).
Cronologia XI-XII secolo.
Giara
Inv PPA 156 Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 36,6; diametro orlo cm 30; fondo cm 20
Descrizione Orlo ingrossato a mandorla segnato all’esterno da una nervatura plastica decorata a ditate, anse a sezione ovale impostate sull'orlo e sulla spalla, fondo umbonato. Corpo percorso da cordonature.
Cronologia XII secolo.
Vaso con filtro
Inv. PPA 94 (fig. 44) Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis.
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Parzialmente integro / lacunoso al collo.
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 32.4; diametro orlo cm 8.8; fondo cm 9.2.
Descrizione Orlo indistinto, arrotondato, segnato all'esterno da una scanalatura; collo cilindrico leggermente a svasare percorso all'esterno da una serie di nervature a rilievo; anse a sezione ovale, apicate e arcuate, spalla piana, ventre leggermente cuoriforme, fondo umbonato. Ingobbiatura rossa uniformemente distesa su tutta la superficie esterna, decorazioni sovraddipinte in bianco a linee orizzontali parallele sul collo e la spalla e a trattini obliqui sul ventre.
Cronologia XI-XII secolo.
Pentola
Inv PPA Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Misure H cm 16.9; Diametro fondo cm 23.7; orlo cm
188
Descrizione Orlo indistinto, arrotondato, inclinato verso l'interno; due anse a presa piena triangolare e cordone plastico a rilievo decorato a ditate sulla parete esterna tra le anse; corpo cilindrico, fondo piatto. Eseguita al tornio lento; scarto di fornace presenta una lesione al fondo.
Confronti Segesta; Monte Iato.
Cronologia XII secolo.
Vaso da zucchero
Inv. PPA Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, dal restauro di alcuni edifici normanni
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Parzialmente integro / lacunoso all'orlo
Impasto Illeggibile.
Misure H cm 56; diametro orlo cm 26.4, fondo cm 2.
Descrizione Orlo a fascia leggermente estroflesso rigonfio all'esterno nel punto di congiunzione con la parete, corpo conico, segni del tornio all'esterno, fondo convesso con un piccolo foro. Scarto d'uso.
Confronti Falsone, Palazzo Steri.
Cronologia XII secolo.
PALERMO, S. Maria dell’Ammiraglio e Monastero della Martorana
Inv PM 50 (fig. 15)
Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa
Provenienza Palermo, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi della volta, isolato al di sotto della pavimentazione del terrazzo.
Stato di conservazione Integra, lesionata al fondo.
Impasto Arancio 2.5.YR 5/8 non rilevabile nel dettaglio perché l’anfora è intera
Misure Diametro orlo interno cm 11; h. 49.7; diametro fondo cm
Descrizione Orlo estroflesso, leggermente pendulo, con una nervatura a rilievo sulla parte superiore; collo cilindrico; spalla leggermente inclinata con inciso un motivo ad onde disposto su due registri; anse apicate, a sezione ovale impostate sulla spalla; spalla leggermente inclinata e convessa; corpo ovoidale, percorso nella parte bassa da cordonature; fondo umbonato. Scarto d'uso. Il labbro presenta delle sbrecciature e tracce di malta.
Cronologia XI-XII secolo.
Inv PM 165 Bis (fig. 16) Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa
Provenienza Palermo, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi della volta, isolato al di sotto della pavimentazione del terrazzo.
189
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio 2.5 YR 5/8, duro, compatto con qualche incluso bianco e nero di piccole dimensioni.
Misure H m 1; L max cm 70.8; diametro orlo interno cm 20, capienza lt. 177,5.
Descrizione Corpo biconico, anse costolonate con iscrizioni arabe su entrambe. Scarto d'uso. Sull'ansa di destra Scerrato ha letto il nome di Bu Sa'id, quella di sinistra è più evanida.
Bibliografia SCERRATO 1985, fig. 190.
Confronti MBA 23. Produzione africana: Jerba. MIKAH!"#$% - M&'KIPTZH% 2003 e
CIRELLI 2002, Tipo IV Cronologia XII secolo.
ANFORE SOVRADDIPINTE IN BIANCO CON PSEUDO ISCRIZIONI
Inv. PM 157 (fig. 42)
Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa
Provenienza Palermo, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi della volta, isolato al di sotto della pavimentazione del terrazzo.
Stato di conservazione Integra /lesionata
Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi. Tipo Zisa.
Misure H cm 71; diametro orlo cm 13.5; diametro fondo
Descrizione Fondo umbonato. Scarto di fornace. Ingobbiatura scura realizzata con un sottile velo d'argilla diluita come dimostrano le scolature lungo il corpo del vaso, sovraddipinta in bianco con motivi pseudo epigrafici in caratteri cufici.
Cronologia Fine XI - primi decenni del XII secolo.
Inv PM 142 (fig. 42)
Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa
Provenienza Palermo, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi della volta, isolato al di sotto della pavimentazione del terrazzo.
Stato di conservazione Parzialmente integra, priva dell'orlo e di un'apice delle anse.
Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi. Tipo Zisa
Misure H cm 50; diametro collo 7.3; fondo 10.
Descrizione Collo cilindrico rigonfio, anse a sezione ovoidale, apicate, spalla inclinata convessa, corpo ovoidale, fondo umbonato. Decorazione sovraddipinta in bianco su fondo scuro a motivi pseudo epigrafici, il fondo scuro è un ingobbiatura effettuata per immersione e presenta delle scolature, sulla parete esterna nella parte bassa del vaso si vede la traccia della trama di un tessuto, usato nella lavorazione del recipiente.
Cronologia Fine XI- primi decenni del XII secolo.
190
Inv PM 96
Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi della volta, isolato al di sotto della pavimentazione del terrazzo.
Stato di conservazione Parzialmente integra / lacunosa all'orlo.
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 45.5; diametro cm 8.8.
Descrizione Collo cilindrico, anse apicate a sezione ovale, ventre ovale, fondo umbonato rotto. Ventre per più di metà rivestito di ingobbiatura nera con motivi sovraddipinti in bianco: Sulla spalla girali e foglie d'edera, sul ventre motivi pseudo epigrafici.
Confronti PM 117
Cronologia XI-XII secolo.
Inv PM 117 Ubicazione Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
Provenienza Palermo, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi della volta, isolato al di sotto della pavimentazione del terrazzo.
Stato di conservazione Parzialmente integra / priva dell'orlo
Impasto Tipo Zisa
Misure H cm 43; diametro collo cm 8.1
Descrizione Collo cilindrico, anse apicate a sezione ovale, ventre ovale, fondo umbonato rotto. Ventre per più di metà rivestito di ingobbiatura nera con motivi sovraddipinti in bianco: Sulla spalla girali e foglie d'edera, sul ventre motivi pseudo epigrafici.
Confronti PM 96
Cronologia XI-XII secolo.
Inv. PM 158
Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi della volta, isolato al di sotto della pavimentazione del terrazzo.
Stato di conservazione Parzialmente integra/priva del fondo e di un'apice.
Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi. Tipo Zisa.
Misure H cm 57; diametro cm 12,9.
Descrizione Sull'ingobbiatura è passato un panno umido.
Cronologia Fine XI - primi decenni del XII secolo.
Anfora con filtro
Inv. PM 115B (fig.42) Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa
Provenienza Palermo, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana).
191
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi della volta, isolato al di sotto della pavimentazione del terrazzo.
Stato di conservazione Parzialmente integra; filtro lacunoso e priva del fondo.
Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi. Tipo Zisa.
Misure H cm 52; diametro orlo esterno cm 13, interno cm
Descrizione Orlo arrotondato, indistinto, collo cilindrico segnato all'esterno da nervature, spalla poco inclinata, anse arcuate, a sezione ovale, apicate, segnate da due solchi paralleli, con apici plastici, con corpo piriforme percorso da cordonature. Sbrecciatura all'orlo, tracce di malta all'orlo, lesionata. Le superfici esterne sono ingobbiate di argilla di colore nero con decorazione sovraddipinte di bianco con motivi pseudo epigrafici in caratteri cufici.
Bibliografia SCERRATO 1985, Fig. 187.
Confronti Fine XI - Primi decenni del XII secolo.
Anfora con filtro
Inv PM 108 (fig. 42) Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi della volta, isolato al di sotto della pavimentazione del terrazzo.
Stato di conservazione Parzialmente integra; lacunosa al collo e al fondo.
Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi. Tipo Zisa.
Misure H cm 42; diametro cm 9.6; diametro fondo cm
Descrizione Orlo arrotondato indistinto, collo a svasare segnato all'esterno da una serie di nervature parallele; spalla piana; anse a sezione ovale apicate; ventre globulare; fondo umbonato rotto al centro. Ingobbiatura bruna all'esterno ottenuta per immersione, decorazione sovraddipinta in bianco a motivi pseudo epigrafici in caratteri cufici.
Cronologia XII secolo.
ANFORE DI PRODUZIONE LOCALE
Anfora Tipo A6
Inv PM 3 (fig.43) Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa
Provenienza Palermo, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi della volta, isolato al di sotto della pavimentazione del terrazzo.
Stato di conservazione Integra
Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi. Tipo Zisa.
Misure H cm 49; diametro orlo cm 6,6; fondo cm 7.
Descrizione Identica al tipo A della Zisa, ma con tutta la superficie ricoperta da una decorazione dipinta in rosso bruno: nel collo motivo ad onda tra due fasce orizzontali parallele; sulla spalla due linee ondulate sovrapposte e sul corpo entro metope costituite da larghe fasce verticali serie di tratti sottili obliqui. Sull'ansa larga fascia verticale.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
192
Anfora Tipo A6
Inv. PM 2 Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Monastero annesso alla chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio
(la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Parzialmente integra / priva dell'orlo.
Impasto Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi. Tipo Zisa.
Misure H. cm 40,5; diametro collo cm 5.5.
Descrizione Scarto di fornace per le evidenti malformazioni sulla superficie.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A6
Inv. PM 11
Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Monastero annesso alla chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio
(la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi. Tipo Zisa.
Misure H. cm 46.5; diametro orlo cm 6; diametro fondo cm 7.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A6
Inv. PM 13 Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Monastero annesso alla chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra / fondo lacunoso; priva di un'ansa
Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi. Tipo Zisa.
Misure H. cm 46; diametro orlo ovalizzato cm 6.
Descrizione Fondo bucato, una lesione percorre la parete fino al fondo. Priva di un'ansa.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A6
Inv PM 14 Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Monastero annesso alla chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio
(la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
193
Stato di conservazione Integra
Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi.
Misure H. cm 46; diametro orlo cm 6; diametro fondo cm 7.
Descrizione Presenta una decorazione leggermente diversa dalle altre: nel collo 6 fasce orizzontali parallele; sulla spalla due linee ondulate sovrapposte e sul corpo entro metope costituite da larghe fasce verticali serie di tratti sottili obliqui. Sull'ansa larga fascia verticale.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A6
Inv. PM 1
Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa
Provenienza Palermo, Monastero annesso alla chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi della volta, isolato al di sotto della pavimentazione del terrazzo.
Stato di conservazione Parzialmente Integra / priva di un'ansa
Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi. Tipo Zisa
Misure H cm 47; Diametro orlo cm 6.6; fondo cm 7.
Descrizione Scarto di fornace, con l’orlo lacunoso
Cronologia Seconda metà XII secolo.
Anfora Tipo A6
Inv. PM 12
Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa
Provenienza Palermo, Monastero annesso alla chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio
(la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi della volta, isolato al di sotto della pavimentazione del terrazzo.
Stato di conservazione Parzialmente integra / lacunosa al collo e al fondo
Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi.
Misure H cm 44; diametro fondo cm 7
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo G Zisa
Inv PM 10
Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Monastero annesso alla chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio
(la Martorana).
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra / lesionata
Impasto Rosso arancio, depurato con inclusi bianchi. Tipo Zisa.
Misure H cm 43; diametro orlo cm 8.2.
194
Descrizione Tipo G della Zisa. Tutta la superficie del vaso presenta una decorazione dipinta in rosso bruno. 4 fasce parallele sul collo; sulla spalla due serie di motivi ad onde; sul ventre due linee sottili verticali alternate a serie di piccoli tratti obliqui.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
PALERMO, Palazzo della Zisa
Anfora Tipo A
Inv PZ 27202 (fig. 43) Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 46; larghezza max cm 21; diametro orlo cm 5,7, fondo cm 6,8.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul collo e sulla spalla. La superficie priva di decorazioni del recipiente presenta delle scolature di colore bianco opaco.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27203
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra/lesionata.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 55; larghezza max cm 20; diametro orlo cm 5, fondo cm 6,8.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul collo e sulla spalla.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27204
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
195
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra/priva del fondo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 49; larghezza max cm 21; diametro orlo cm 6,8.
Descrizione
Alto orlo verticale indistinto frammentario, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul collo e sulla spalla. La superficie priva di decorazioni del recipiente presenta alcuni segni irregolari sull’argilla fresca.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27205 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra / frammentaria all’orlo e priva di un’ansa
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 49; larghezza max cm 20; diametro orlo cm 6, fondo cm 6,8.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul collo e sulla spalla. Sulla superficie esterna profonde lesioni.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27206 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra / priva dell’orlo
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 46,5; larghezza max cm 20; diametro orlo cm 5,7, fondo cm 6,8.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul collo e sulla spalla. La superficie esterna presenta delle crepe.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
196
Anfora Tipo A
Inv PZ 27239 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Interamente ricomposta.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 40; larghezza max cm 20.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. La superficie del recipiente si presenta irregolare ricoperta da un’ingobbiatura giallina opaca. Al di sotto dell’imboccatura, su entrambe le facce del vaso, pennellate di colore bruno.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27218
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra / priva dell’orlo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 44; larghezza max cm 19; diametro fondo cm 7.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul collo e sulla spalla. La superfici del recipiente presenta una profonda crepa.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27207
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra / priva dell’orlo e di parte del collo
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 45,5; larghezza max cm 20; diametro orlo cm 5,7, fondo cm 6,8.
197
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul collo e sulla spalla. La superficie presenta delle crepe.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27208 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 48; larghezza max cm 18,5; diametro orlo cm 4,6, fondo cm 6,7.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul collo e sulla spalla.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27215 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 48,3; larghezza max cm 18; diametro orlo cm 4,8, fondo cm 7.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul collo e sulla spalla.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27216
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
198
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 51; larghezza max cm 21; diametro orlo cm 5, fondo cm 7.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul collo e sulla spalla. La superficie esterna è di colore giallo verdino.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27217 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 49,6; larghezza max cm 18,5; diametro orlo cm 5, fondo cm 7.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul collo e sulla spalla. La superficie priva di decorazioni del recipiente presenta delle scolature di colore bianco opaco.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27219
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra / priva dell’orlo e del fondo.
Impasto Arancio in superficie e grigio al nucleo, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 49; larghezza max cm 21.
Descrizione Collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul collo e sulla spalla. La superficie del recipiente presenta bolle e depressioni.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
199
Anfora Tipo A
Inv PZ 27220 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra / frammentaria all’orlo
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 44; larghezza max cm 21; diametro fondo cm 7.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. La superficie del recipiente presenta bolle e depressioni ed è rivestita da una spessa ingobbiatura giallo verdina.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27221 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra / frammentaria all’orlo
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 48; larghezza max cm 20; diametro orlo cm 5, fondo cm 7.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. La superficie del recipiente presenta una profonda lesione ed è rivestita da una spessa ingobbiatura giallina opaca.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27222 (fig. 43)
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 48; larghezza max cm 19; diametro orlo cm 5, fondo cm 6,8.
200
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. La superficie del recipiente presenta una lieve lesione, delle bolle e delle depressioni. Su una delle anse è presente un marchio Z.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27223
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Parzialmente ricomposta con una piccola lacuna
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 50,5; larghezza max cm 19; diametro orlo cm 5, fondo cm 6.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. Sulla superficie esterna del recipiente è visibile una lesione sanata dal figulo mentre l’argilla era fresca.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27225 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Priva della parte terminale e del fondo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 46,5; larghezza max cm 20; diametro orlo cm 5.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. La superficie del recipiente presenta numerosi sfaldamenti dovuti alla presenza di grossi inclusi bianchi; profonda crepa.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27226 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
201
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra / frammentaria al collo
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 47; larghezza max cm 18; diametro fondo cm 6,7.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili sul corpo del vaso a gruppi di quattro. La superficie del recipiente presenta due profonde crepe.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27227 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 50; larghezza max cm 20; diametro orlo cm 5, fondo cm 7.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. La superficie del recipiente presenta profonde crepe.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27228 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Priva del fondo e di un’ansa.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 50; diametro orlo cm 5.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. Superfici irregolari con bolle ed alcuni segni praticati nell’argilla fresca.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
202
Anfora Tipo A
Inv PZ 27229 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Priva dell’orlo, del fondo e frammentaria alla parete.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 45,5; larghezza max cm 20.
Descrizione Collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27230
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra / lievemente frammentaria all’orlo
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 50,5; larghezza max cm 18; diametro orlo cm 4,8, fondo cm 6,8.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. La superficie del recipiente presenta una profonda lesione che parte dall’orlo del vaso ed arriva fino al fondo.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27231 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Priva del fondo e frammentaria all’orlo ed alla parete.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 40; larghezza max cm 20.
203
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. La superficie del recipiente si presenta irregolare con numerosi sfaldamenti dovuti alla presenza di grossi inclusi bianchi. Superfici schiarite.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27232
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Frammentaria al collo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 42,5; larghezza max cm 19; diametro fondo cm 7,4.
Descrizione Collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. Superfici irregolari con segni praticati nell’argilla fresca e crepe poco profonde.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27233
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Priva del fondo e frammentaria all’orlo e di parte della parete.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 31,5; larghezza max cm 19.
Descrizione Collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27234 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
204
Stato di conservazione Priva del fondo e frammentaria alla parete.
Impasto Marrone rosato, compatto, depurato con numerosi inclusi bianchi e neri di medie e piccole dimensioni visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 45; larghezza max cm 20; diametro orlo cm 5,5.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. La superficie del recipiente si presenta irregolare con depressioni, bolle e qualche vacuolo e percorsa da lesioni.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27235 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Priva del collo e di un’ansa.
Impasto Arancio in superficie e grigio al nucleo, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 36; larghezza max cm 19; diametro fondo cm 6,9.
Descrizione Anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso divisi in gruppi di tre. La superficie del recipiente si presenta irregolare con numerosi sfaldamenti dovuti alla presenza di grossi inclusi bianchi. Con segni praticati nell’argilla fresca.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27236 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Priva di parte del fondo e della parete.
Impasto Arancio e grigio al nucleo, compatto, depurato con inclusi bianchi e rari neri visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 49,5; larghezza max cm 20; diametro orlo cm 5, fondo cm 7,4.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. La superficie del recipiente si presenta irregolare con bolle, vacuoli e segni praticati nell’argilla fresca Superfici schiarite.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
205
Anfora Tipo A
Inv PZ 27237 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Parzialmente ricomposta, priva del fondo e di parte della parete.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 40,5; larghezza max cm 20.
Descrizione Alto orlo verticale indistinto, collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. La superficie del recipiente si presenta irregolare con numerosi sfaldamenti dovuti alla presenza di grossi inclusi bianchi. Ingobbiatura di colore giallino.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27238 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Parzialmente ricomposta, priva dell’alto orlo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 49; larghezza max cm 20; diametro fondo cm 7.
Descrizione Collo cilindrico leggermente rigonfio segnato da un solco all’attacco con l’orlo, anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso disposte a gruppi di tre. La superficie del recipiente si presenta irregolare con numerosi sfaldamenti dovuti alla presenza di grossi inclusi bianchi. Superfici schiarite.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27363 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, scavo (1973).
Dati di scavo Saggio V, Loci 1-2, inv. di scavo n. 51/174.
Stato di conservazione Alcuni frammenti ricomposti.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 30; larghezza max cm 19.
206
Descrizione Anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. La superficie del recipiente si presenta irregolare con bolle. Superfici scurite ricoperte da una spessa ingobbiatura giallina. Sul collo linee dipinte in bruno.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27364 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa scavo (1973).
Dati di scavo Saggio V, Loci 1-2, crollo, inv. di scavo n. 21/176.
Stato di conservazione Ricomposta da frammenti, priva di parte del collo, di un’ansa, del fondo e della parete.
Impasto Beige scuro, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 25; larghezza max cm 20.
Descrizione Anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27365 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa. Scavo (1973).
Dati di scavo Saggio V, Loci 1-2, crollo, inv. di scavo n. 51/175.
Stato di conservazione Priva di parte del collo, di un’ansa, del fondo e della parete.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 46; larghezza max cm 19.
Descrizione Anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso. Superfici scurite.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A
Inv PZ 27366
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa. Scavo (1973).
Dati di scavo Saggio V, Loci 1-2, crollo, inv. di scavo n. Z 193.
Stato di conservazione Priva della parte superiore e del fondo.
Impasto Arancio beige al nucleo, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
207
Misure H cm 25; larghezza max cm 20.
Descrizione Anse a sezione ovoidale impostate nella parte bassa del collo e terminanti sulla spalla del vaso; ventre ovoidale, fondo umbonato. Cordonature sono visibili dalla spalla quasi fino al fondo del vaso.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A3
Inv PZ 11 (fig. 43) Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 53; larghezza max cm 24; diametro orlo cm 6,5, fondo cm 12,5.
Descrizione Breve orlo verticale arrotondato, segnato all’esterno da un motivo a treccia semplice, collo cilindrico leggermente ingrossato, anse a sezione ellittica impostate nella parte bassa del collo fino alla spalla, corpo ovoidale segnato sulla spalla da cordonature, fondo umbonato. Superficie schiarita con evidenti lesioni e malformazioni.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A3
Inv PZ 15 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 48,5; larghezza max cm 25,5; diametro orlo cm 6,5; fondo cm 12.
Descrizione Breve orlo verticale arrotondato, segnato all’esterno da un motivo a treccia semplice, collo cilindrico leggermente ingrossato, anse a sezione ellittica impostate nella parte bassa del collo fino alla spalla, corpo ovoidale segnato sulla spalla da cordonature, fondo umbonato. Superficie schiarita con evidenti lesioni e malformazioni.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A4
Inv PZ 36 (fig. 43) Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
208
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 44,5; larghezza max cm 22; diametro orlo cm 6,5; fondo cm 11.
Descrizione Breve orlo verticale arrotondato, segnato all’esterno da un motivo a treccia semplice, collo cilindrico leggermente ingrossato, anse a sezione ellittica impostate nella parte bassa del collo fino alla spalla, corpo ovoidale segnato sulla spalla da cordonature, fondo umbonato. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a linee parallele orizzontali sul collo e con due linee parallele ondulate sulla spalla mentre il corpo del vaso è segnato da tratti obliqui alternati a fasce verticali parallele.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A4
Inv PZ 16
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 47; larghezza max cm 22; diametro orlo cm 6,5; fondo cm 12.
Descrizione Breve orlo verticale arrotondato, segnato all’esterno da un motivo a treccia semplice, collo cilindrico leggermente ingrossato, anse a sezione ellittica impostate nella parte bassa del collo fino alla spalla, corpo ovoidale segnato sulla spalla da cordonature, fondo umbonato. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a linee parallele orizzontali sul collo e sulla spalla mentre il corpo del vaso è segnato da tratti obliqui alternati a fasce verticali parallele.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo A4
Inv PZ Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Priva del collo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 39; larghezza max cm 21; diametro fondo cm 11,5.
Descrizione Anse a sezione ellittica impostate nella parte bassa del collo fino alla spalla, corpo ovoidale segnato sulla spalla da cordonature, fondo umbonato. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a linee parallele orizzontali sul collo e con due linee parallele ondulate sulla spalla mentre il corpo del vaso è segnato da tratti obliqui alternati a fasce verticali parallele.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
209
Anfora Tipo B1
Inv PZ 27242 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Frammentaria: si conserva solo la parte superiore.
Impasto Arancio, grigio al nucleo, compatto, depurato con inclusi bianchi di piccolissime dimensioni a bassa frequenza, neri e rossi di medie e grandi dimensioni ad alta frequenza. Tipo Zisa.
Misure H cm 20,5; larghezza max cm 15; diametro orlo cm 3,5.
Descrizione Stretto collo cilindrico percorso da cinque solchi concentrici, orlo verticale, ripiegato all’esterno e separato dal collo mediante un solco. Anse a sezione ellittica impostate nella parte bassa del collo fino alla spalla, corpo ovoidale segnato sulla spalla da cordonature. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a linee parallele orizzontali sul collo e con due linee parallele ondulate sulla spalla mentre il corpo del vaso è segnato da tratti obliqui alternati a fasce verticali parallele.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo B1
Inv PZ 27240 (fig. 44) Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Dal riempimento leggero dei rinfianchi delle volte.
Stato di conservazione Si conserva la parte superiore.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 15; larghezza max cm 18; diametro orlo cm 3,5.
Descrizione Stretto collo cilindrico percorso da cinque solchi concentrici, orlo verticale, ripiegato all’esterno e separato dal collo mediante un solco. Anse a sezione ellittica impostate nella parte bassa del collo fino alla spalla, corpo ovoidale segnato sulla spalla da cordonature. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a linee parallele orizzontali sul collo e con due linee parallele ondulate sulla spalla mentre il corpo del vaso è segnato da tratti obliqui alternati a fasce verticali parallele.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo B1
Inv PZ 27377
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Scavo Zisa (1973).
Dati di scavo Settore V, Loci 1-2, crolli, inv. di scavo n. Z 220.
Stato di conservazione Si conserva il collo e l’attacco delle anse.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
210
Misure H cm 7,3; larghezza max cm 9,5; diametro orlo cm 3,5.
Descrizione Stretto collo cilindrico percorso da cinque solchi concentrici, orlo verticale, ripiegato all’esterno e separato dal collo mediante un solco. Anse a sezione ellittica impostate nella parte bassa del collo fino alla spalla, corpo ovoidale segnato sulla spalla da cordonature. Superficie schiarita tracce di decorazione dipinta in rosso bruno tra le anse.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo B2
Inv PZ 19 (fig. 44)
Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione Integra
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 36,6; larghezza max cm 21,3; diametro orlo interno cm 1,2 esterno cm 3,5, fondo cm 7,4.
Descrizione Stretto collo cilindrico percorso da cinque solchi concentrici, orlo verticale, ripiegato all’esterno e separato dal collo mediante un solco. Anse a sezione ellittica impostate nella parte bassa del collo fino alla spalla, corpo ovoidale segnato sulla spalla da cordonature. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a linee parallele orizzontali sul collo e con due linee parallele ondulate sulla spalla mentre il corpo del vaso è segnato da tratti obliqui alternati a fasce verticali parallele.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo C
Inv PZ 5 (fig. 45)
Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione Lacunosa al fondo ed al ventre.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 44,2; larghezza max cm 29,7; diametro orlo esterno cm 12, interno cm 8,2; fondo cm 14,4.
Descrizione Largo collo leggermente tronco-conico con orlo ingrossato a mandorla inclinato verso l’interno e segnato all’esterno da un solco ben inciso, anse a sezione ellittica, segnate da due solchi, impostate nella parte bassa del collo fino alla spalla, corpo ovoidale segnato sulla spalla da cordonature. Largo fondo umbonato. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a linee parallele orizzontali sul collo e sul corpo del vaso tratti obliqui alternati a fasce verticali parallele. Evidenti malformazioni e lesioni su tutto il corpo del vaso.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
211
Anfora Tipo C
Inv PZ 27243 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione Frammentaria / parte superiore priva di un’ansa.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 15; larghezza max cm 20; diametro orlo esterno cm 9.
Descrizione Largo collo leggermente tronco-conico con orlo indistinto segnato all’esterno da due solchi ben incisi, anse a sezione ellittica impostate nella parte bassa del collo fino alla spalla, corpo ovoidale segnato sulla spalla da cordonature. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a linee parallele orizzontali sul collo e sul corpo del vaso tratti obliqui alternati a fasce verticali parallele.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo C
Inv PZ 27333 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Scavo Zisa (1973).
Dati di scavo Settore V, Loci 1-2, crolli, inv. di scavo n. Z 23/134.
Stato di conservazione Frammentaria / collo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 7,3; larghezza max cm 8,5; diametro orlo cm 7,6.
Descrizione Largo collo leggermente tronco-conico con orlo indistinto segnato all’esterno da due solchi ben incisi. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a linee parallele orizzontali sul collo.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo C
Inv PZ 27373 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Scavo Zisa (1973).
Dati di scavo Settore V, Loci 1-2, crolli, inv. di scavo n. Z 213.
Stato di conservazione Frammentaria / parte superiore.
Impasto Beige scuro, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 15; larghezza max cm 11; diametro orlo cm 9.
Descrizione Largo collo leggermente tronco-conico con orlo indistinto segnato all’esterno da due solchi ben incisi. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a linee trasversali sulla spalla e con una linea verticale sull’ansa.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
212
Anfora Tipo C
Inv PZ A50 Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione parzialmente integra / priva della parte inferiore e del fondo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 31,5; diametro orlo cm 9.
Descrizione Largo collo leggermente tronco-conico con orlo indistinto segnato all’esterno da due solchi ben incisi. Superficie schiarita con decorazione dipinta in bruno a linee parallele orizzontali sul collo.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo C
Inv PZ 18
Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione Integra.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 42; larghezza max cm 26; diametro orlo cm 7; fondo cm 12,5.
Descrizione Largo collo leggermente tronco-conico con orlo ingrossato a mandorla inclinato verso l’interno e segnato all’esterno da un solco ben inciso, anse a sezione ellittica, segnate da due solchi, impostate nella parte bassa del collo fino alla spalla, corpo ovoidale segnato sulla spalla da cordonature. Largo fondo umbonato. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a linee parallele orizzontali sul collo e sul corpo del vaso tratti obliqui alternati a fasce verticali parallele. Sulla spalla una linea ondulata.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo D1
Inv PZ 27352 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Scavo Zisa (1973).
Dati di scavo Saggio II, settore B, strato 1, inv. di scavo n. Z 21/29.
Stato di conservazione Frammentaria / parte superiore.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 16,2; larghezza max cm 10,5.
Descrizione Largo collo cilindrico con orlo indistinto, anse a sezione ellittica percorse da un solco, che si dipartono da metà circa del collo ed arrivano sulla spalla decorata da cordonature; corpo ovoidale.. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a linee verticali alternate da serie di piccoli tratti obliqui sul collo e sul corpo.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
213
Anfora Tipo D1
Inv PZ 27378 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Scavo Zisa (1973).
Dati di scavo Settore V, loci 1-2, strati di crollo, inv. di scavo n. Z 214.
Stato di conservazione Frammentaria / orlo.
Impasto Marrone, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 5; larghezza max cm 10,2; diametro cm 14.
Descrizione Largo collo cilindrico con orlo indistinto.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo D2
Inv PZ 27211 (fig. 45) Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione Parzialmente ricomponibile / priva del fondo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 50; larghezza max cm 13,4; diametro orlo interno cm 14,4, esterno cm 17,2.
Descrizione Largo collo tronco-conico con orlo verticale ingrossato all’esterno a mandorla. Breve spalla inclinata su cui si impostano due piccole anse ad anello; corpo ovoidale. Superficie schiarita con decorazione dipinta in bruno a linee verticali alternate da serie di piccoli tratti obliqui sul collo e sul corpo.
Bibliografia D’ANGELO 1976.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo E1
Inv PZ 27209 (fig. 46)
Ubicazione Palermo, Museo dell'Arte Islamica al Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione Parzialmente ricomponibile / priva del fondo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 63; larghezza max cm 29; diametro orlo interno cm 7,2, esterno cm 10,4.
Descrizione Alto collo cilindrico con orlo verticale concavo all’interno ed ingrossato all’esterno, una nervatura a rilievo è visibile poco sotto l’orlo. Anse a sezione ellittica segnate da un solco si dipartono dalla parte bassa del collo fino al punto di massima espansione del vaso, spalla inclinata; corpo ovoidale. Superficie schiarita con decorazione dipinta in bruno a linee verticali alternate da serie di piccoli tratti obliqui sul corpo e sul collo sei fasce parallele orizzontali.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
214
Anfora Tipo E1
Inv PZ 27210 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione Parzialmente ricomponibile / priva del fondo e dell’orlo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 50,5; larghezza max cm 32.
Descrizione Anse a sezione ellittica segnate da un solco si dipartono dalla parte bassa del collo fino al punto di massima espansione del vaso, spalla inclinata; corpo ovoidale. Superficie schiarita con decorazione dipinta in bruno a linee verticali alternate da serie di piccoli tratti obliqui sul corpo e sul collo sei fasce parallele orizzontali.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo E1
Inv PZ 27214
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione Parzialmente ricomponibile / priva del fondo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 61,5; larghezza max cm 30,5; diametro orlo esterno cm 10,5.
Descrizione Alto collo cilindrico con orlo verticale concavo all’interno ed ingrossato all’esterno, una nervatura a rilievo è visibili poco sotto l’orlo. Anse a sezione ellittica segnate da un solco si dipartono dalla parte bassa del collo fino al punto di massima espansione del vaso, spalla inclinata; corpo ovoidale. Superficie schiarita con decorazione dipinta in bruno a linee verticali alternate da serie di piccoli tratti obliqui sul corpo e sul collo sei fasce parallele orizzontali.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo E1
Inv PZ 27362 Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Scavo (1973).
Dati di scavo Saggio II, Settore B, Strato 2, Inv. Di scavo n. 22/149.
Stato di conservazione Frammentario / spalla con ansa.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 16; larghezza max cm 15,3.
Descrizione Anse a sezione ellittica segnate da un solco si dipartono dalla parte bassa del collo fino al punto di massima espansione del vaso, spalla inclinata. Superficie schiarita con decorazione dipinta in bruno.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
215
Anfora Tipo E2
Inv PZ 27212 (fig. 46) Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione Parzialmente ricomponibile / priva del fondo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 56; larghezza max cm 33; diametro orlo interno cm 8, esterno cm 10,8.
Descrizione Alto collo cilindrico con orlo verticale ingrossato all’esterno e leggermente pendulo, una nervatura a rilievo è visibile poco sotto l’orlo. Anse a sezione ellittica segnate da un solco si dipartono dalla parte bassa del collo fino al punto di massima espansione del vaso, spalla inclinata; corpo ovoidale. Superficie schiarita con decorazione dipinta in bruno a linee verticali alternate da serie di piccoli tratti obliqui sul corpo sul collo tre fasce parallele orizzontali e sulla spalla una linea ondulata precede la decorazione del ventre.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo E2
Inv PZ 27213
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione Parzialmente ricomponibile / priva del fondo e del collo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 50,5; larghezza max cm 32.
Descrizione Anse a sezione ellittica segnate da un solco si dipartono dalla parte bassa del collo fino al punto di massima espansione del vaso, spalla inclinata; corpo ovoidale. Superficie schiarita con decorazione dipinta in bruno a linee verticali alternate da serie di piccoli tratti obliqui sul corpo.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo F
Inv PZ 27241 (fig. 44) Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione Parzialmente ricomponibile / solo la parte superiore
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 18; larghezza max cm 18; diametro orlo interno cm 2,8, esterno cm 6,2.
216
Descrizione Alto collo cilindrico leggermente rigonfio con orlo verticale ingrossato all’esterno a sezione semicircolare. Anse a sezione ellittica che si dipartono dalla parte bassa del collo fino al punto di massima espansione del vaso, spalla poco inclinata. Superficie scurita con decorazione dipinta in bianco.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo F
Inv PZ 27375
Ubicazione Palermo, Museo Archeologico Regionale.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Scavo (1973).
Dati di scavo Settore V, Strati di crollo, Loci 1-2, Inv. Di scavo n. Z 199.
Stato di conservazione Frammentario / spalla.
Impasto Rosso mattone in superficie grigio al nucleo, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 18; larghezza max cm 18; diametro orlo interno cm 2,8, esterno cm 6,2.
Descrizione Alto collo cilindrico leggermente rigonfio con orlo verticale ingrossato all’esterno a sezione semicircolare. Anse a sezione ellittica che si dipartono dalla parte bassa del collo fino al punto di massima espansione del vaso, spalla poco inclinata. Superficie scurita.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
Anfora Tipo G
Inv PZ 20 (fig. 45)
Ubicazione Palermo, Museo dell’Arte Islamica, Palazzo della Zisa.
Provenienza Palermo, Palazzo della Zisa, Sala della Fontana.
Dati di scavo Riempimento leggero sui rinfianchi delle volte
Stato di conservazione Lacunosa al fondo.
Impasto Arancio, compatto, depurato con inclusi bianchi e rossi visibili anche sulla superficie esterna del recipiente. Tipo Zisa.
Misure H cm 49,2; larghezza max cm 30; diametro orlo interno cm 8,4, esterno cm 9,4.
Descrizione Collo tronco-conico con orlo verticale ingrossato all’esterno a mandorla. Anse a sezione ellittica ad anello impostate sulla spalla, spalla inclinata; corpo ovoidale; fondo umbonato. Corpo percorso da cordonature che si interrompono nella parte mediana del vaso per riprendere in prossimità del fondo. Superficie schiarita con decorazione dipinta in rosso bruno a fasce verticali parallele alternate a serie di piccoli tratti obliqui.
Cronologia Seconda metà del XII secolo.
217
219
CONCLUSIONI
In questo studio sulle anfore medievali sono state perseguite due direttrici di ricercacomplementari: da un lato quella dell’analisi dettagliata del materiale anforico docu-mentato nella Sicilia occidentale dall’VIII al XII secolo, al fine di definirne le tipolo-
gie e di precisarne l’epoca, le aree di provenienza nonché di elaborare le carte di distribuzio-ne dei rinvenimenti; dall’altro quella dell’esplorazione delle implicazioni che i dati emersisuggeriscono nel panorama dell’economia siciliana, mettendoli in relazione con le rare fontiscritte e con le vicende storico-economiche note dell’isola. Parallelamente all’indagine tipo-logica, infatti, è stato possibile, correlando con le fonti scritte la messe di informazioni chel’analisi di questo particolare tipo di contenitore è in grado di fornire, ricavare alcuni indizisugli scambi commerciali della Sicilia e sulle rotte mercantili che transitavano nei pressi del-l’isola. Tuttavia, siamo consapevoli che per il medioevo lo studio dei contenitori da traspor-to non possa da solo essere sufficiente a tracciare un quadro storico-economico dettagliato.Infatti, sia la crisi delle anfore quale recipiente per il trasporto delle derrate alimentari a favo-re di contenitori alternativi quali gli otri in pelle o le botti, sia la pratica molto diffusa in que-sto periodo di riciclare i contenitori ridimensiona notevolmente il modo in cui i dati desumi-bili dallo studio delle anfore possano essere utilizzati per tracciare un quadro dei circuiti com-merciali nonché della produzione ed esportazione di derrate alimentari e delle altre merci cheviaggiavano in recipienti di terracotta. L’obiettivo della ricerca è stato di conseguenza anch’es-so duplice: quello di ampliare le nostre scarse conoscenze sulla cultura materiale siciliana diquesto periodo come pure quello di aggiungere un tassello nel mosaico della storia economi-ca dell’isola nei momenti di passaggio prima dalla dominazione bizantina a quella islamica epoi ancora a quella normanna. La lacunosità dello stato degli studi e della documentazionearcheologica sulla Sicilia occidentale dall’VIII al XII secolo è stato il fattore limitante che piùha pesato nello sviluppo di questo lavoro. È stato possibile, tuttavia, identificare per la pri-ma volta alcune produzioni locali del periodo islamico, l’area di provenienza di una serie dianfore importate nell’isola e, pur nella grande imprecisione focale imposta dalla frammenta-rietà della documentazione in nostro possesso, proporre un’ipotesi di interpretazione in chia-ve storico-economica dei dati emersi. Per l’VIII secolo le informazioni dedotte dall’identifi-cazione di anfore provenienti dall’Italia centro-meridionale e dall’analisi della loro diffusio-ne nella Sicilia occidentale hanno permesso di confermare l’ipotesi secondo cui l’isola, duran-te l’età tematica, era inserita nel circuito commerciale interregionale che gravitava intornoalla città di Roma, sebbene ormai ridotto rispetto al passato sia per volume di scambi che perampiezza. I collegamenti marittimi pertinenti, dovevano interessare soprattutto il Tirrenocentro-meridionale in particolare la Campania, la Calabria e la Sicilia. Ciò troverebbe con-ferma nella carta di distribuzione delle anfore da trasporto con corpo ovoidale e fondo con-vesso, provenienti dall’hinterland campano e destinate, sembra, alla commercializzazione delvino. Ulteriori indizi dell’esistenza di queste relazioni commerciali vengono forniti dai sitidella Sicilia occidentale che hanno restituito fasi di vita relative all’età tematica: Marettimo,Cefalù ed in misura minore Palermo. I contenitori da trasporto qui rinvenuti provengono,
infatti, tutti dall’area campana. Che il flusso commerciale attestato tra la Sicilia occidentale ele principali città della costa tirrenica fosse regolare e costante troverebbe conferma nell’en-tità dei rinvenimenti di Cefalù e di Marettimo. Come attestato dalle fonti storiche del perio-do la Sicilia avrebbe esportato verso Napoli, ma soprattutto Roma prevalentemente cerealie di contro importato vino di produzione campana. Questa ipotesi è coerente con i rinveni-menti anforici testè menzionati. La presenza di questi contenitori da trasporto a Marettimoed il ritrovamento di questo tipo di manufatto nei fondali antistanti la costa di Mazara delVallo e di San Vito Lo Capo ci fanno certi che una delle rotte seguite dai convogli adibiti aicommerci con il Tirreno centro-meridionale passava ad Ovest dell’isola. Relativamente al IXsecolo la totale assenza di contenitori da trasporto nella Sicilia occidentale è dovuta sicura-mente in parte all’insufficiente stato degli studi. Ulteriore spiegazione potrebbe comunquetrovarsi nel rallentamento dei traffici marittimi registrato in questo periodo nel Mediterra-neo occidentale imputabile alla incombente pirateria musulmana. Dalle fonti scritte traspa-re comunque che le relazioni commerciali con il Tirreno centro-meridionale dovettero con-tinuare, anche se verosimilmente in forma ridotta, dal momento che a partire dall’836 le cittàcampane stipularono con l’emiro di Palermo un trattato di alleanza che aveva quale obietti-vo principale la continuità di tali rapporti. La permanenza degli scambi commerciali con lacosta campana ed il Tirreno centro-meridionale è d’altra parte documentata dalla presenzasporadica in alcuni siti della Sicilia occidentale di Forum Ware databile a questa epoca. Perquanto riguarda invece le produzioni locali non si conoscono a tutt’oggi le manifatture iso-lane relative a tutto l’arco di tempo compreso tra la seconda metà del VII ed il IX secolo.
Nel periodo compreso tra il X ed il XII secolo in tutto il bacino del Mediterraneo si regi-stra una ripresa dei commerci a lunga e media distanza. La quasi totale mancanza di attesta-zioni archeologiche sulle anfore d’importazione, è dovuta quindi a nostro giudizio, al caren-te stato degli studi. Infatti, questo dato è in netta contraddizione con quanto emerge dalla let-tura delle fonti scritte contemporanee: le lettere dei mercanti ebrei della Geniza del Cairo ele Fatwas di Kairouan, ovvero i pareri giuridici espressi dai locali dottori della legge. In que-sti documenti, infatti, viene descritta una realtà economico-commerciale molto vivace, fattadi relazioni internazionali che vedevano nei principali porti della Sicilia importanti fulcricommerciali del Mediterraneo islamico. Le città di Palermo e di Mazara, non svolgevano sol-tanto la funzione di bacino di raccolta delle merci prodotte nel territorio, ma anche quella dicentri di stoccaggio di beni importati da altre aree geografiche. La vitalità di questa realtà eco-nomica è documentata a livello archeologico soltanto dalle produzioni locali, molto fioren-ti soprattutto a Palermo dagli inizi del X fino al XII secolo. La carta di distribuzione di que-sti prodotti, mostra un’ampia circolazione a livello regionale ed, a partire dalla seconda metàdel X secolo, ma soprattutto nel corso dell’XI, anche a livello mediterraneo con la presenzadi anfore siciliane nei mercati dell’Italia centrale e settentrionale, in relazione evidentemen-te con l’attività delle città marinare, in primo luogo di Amalfi e in Provenza e Ifriqiya. Espor-tazioni siciliane in Italia d’altra parte erano note anche grazie alla presenza nelle facciate del-le chiese pisane di ceramica invetriata prodotta nell’isola. È molto probabile quindi che der-rate alimentari e beni pregiati viaggiassero insieme verso queste mete. L’elaborazione della ti-pologia dei manufatti locali ci ha permesso di riconoscere alcune caratteristiche morfologi-che e decorative peculiari delle forme più antiche e di distinguere le produzioni più propria-mente islamiche da quelle databili ad età normanna.
220
Sulla base delle analisi mineralogico petrografiche si è identificato nella città di Palermoun centro in cui la produzione di anfore perdura ininterrottamente dal X al XII secolo. Lostudio di alcuni siti di età islamica, recentemente indagati con metodo stratigrafico ed in par-te ancora inediti, ha consentito di far risalire l’inizio della produzione palermitana agli inizidel X secolo e di arricchire la tipologia delle anfore normanne prodotte nel capoluogo sici-liano, per altri versi già note, con una serie di forme più antiche databili ad età islamica. Si ècostruita così una crono-tipologia, costituita da 18 forme e da una serie di varianti nella qua-le sono state evidenziate le caratteristiche peculiari della produzione. All’interno dell’interoarco cronologico della produzione palermitana, l’elaborazione di questa crono-tipologia ciha permesso di seguire la tendenza evolutiva verso la progressiva semplificazione, segnata dalievi cambiamenti evidenti sia in alcuni dettagli morfologici che nei motivi decorativi. È sta-to possibile, infatti, osservare nelle forme più antiche di questa produzione una grande raffi-natezza nell’esecuzione riscontrabile in particolare nella ricchezza dei dettagli morfologici vi-sibili sia negli orli articolati ed elaborati, costolati all’esterno ed evidenziati da una o più ner-vature plasticamente rese, sia nelle anse apicate, particolarmente elaborate nelle grandi anfo-re con decorazione a motivi sovraddipinti in bianco a vegetali stilizzati e con pseudo iscrizio-ni. Questa tendenza evolutiva è riscontrabile altresì nelle anse costolate, molto comuni tra leforme chiuse databili ad età islamica che presentano nella parte mediana un solco più profon-do che può essere considerato in nuce il solco caratteristico delle anse delle anfore di età nor-manna, nonché negli orli modanati percorsi da uno o più solchi dei contenitori islamici, ca-ratteristica questa non più riscontrabile nelle forme simili di età normanna. Infine, la nerva-tura in rilievo che segna il passaggio tra il collo e la spalla dei contenitori più antichi, non siriscontra più negli esemplari dello stesso tipo databili al XII secolo. Per quanto riguarda ledecorazioni dipinte sul corpo dei contenitori può notarsi anche qui, la progressiva semplifi-cazione delle stesse all’interno di una sistematica standardizzazione dei motivi dipinti. In que-sto processo evolutivo è stato possibile riconoscere alcune tappe fondamentali: negli esem-plari più antichi ricorre, forse già anteriormente al X secolo, una decorazione dipinta a cap-pi continui di matrice bizantina. A questa fa seguito, divenendo predominante durante la pri-ma metà del X secolo, uno schema decorativo a larghe fasce verticali parallele alternate a li-nee sinuose presenti senza variazioni di rilievo su tutta la superficie del vaso. La transizionedal motivo a linee sinuose verso i tratti obliqui sarebbe confermata dal rinvenimento, nei li-velli di frequentazione databili alla fine del X secolo identificati in alcuni siti recentementeidagati, di alcuni frammenti di pareti di anfore in cui lunghi tratti obliqui molto ravvicinatisono legati da nessi trasversali quasi fossero una linea sinuosa irrigidita. Questi motivi dipin-ti sono attestati soltanto nel momento di passaggio tra le due decorazioni (seconda metà delX secolo) e tendono a scomparire nel secolo successivo. Verso la fine del X secolo diventapredominate la decorazione costituita da larghe bande verticali parallele, alternate ad un se-rie di piccoli tratti obliqui, che, abbiamo visto, caratterizzerà tutta la ceramica dipinta di pro-duzione locale fino alla seconda metà del XII secolo. Nel corso del XII secolo l’ordito deco-rativo tende ancora verso un’ulteriore semplificazione. In questi recipienti, infatti, come èstato osservato da L. Arcifa le larghe bande verticali tendono a dividersi in due linee paralle-le più sottili e tutta la decorazione appare più corsiva ed affrettata.
Produzioni locali sono state individuate anche ad Agrigento dove recentemente è statomesso in luce un quartiere ceramico databile tra la fine del X e la prima metà dell’XI secolo.
221
Va tuttavia osservato che le forme prodotte da queste fornaci sembra abbiano una diffusionelimitata al territorio circostante ed essere così destinate alla circolazione locale. Infatti, l’uni-co esemplare attribuibile a questa produzione, isolato al di fuori del sito delle fornaci di Agri-gento, proviene dallo scavo di Caltabellotta. L’analisi comparativa delle tipologie pertinentialle due manifatture siciliane di Palermo e di Agrigento ci ha permesso di riconoscere la loroappartenenza dal punto di vista della morfologia ad una koinè mediterranea fortemente in-trisa della stessa tradizione romana e protobizantina comune anche alle coeve produzioninord africane e di individuare quei caratteri peculiari che, grazie all’elaborazione di una cro-no-tipologia, individuano un nuovo fossile guida per il periodo della dominazione islamicadell’isola. Per quel che riguarda il XII secolo sembra possibile cogliere nelle manifatture pa-lermitane della ceramica comune e delle anfore una chiara continuità con il passato islamico:permangono le stesse forme con gli stessi motivi decorativi del’XI secolo anche se, come an-ticipato, è stato possibile riscontrare la tendenza evolutiva verso la semplificazione sia nel-l’ordito delle decorazioni sia nelle forme, tendenza già in atto nella seconda metà dell’XI se-colo. La stessa continuità è riscontrabile anche nelle modalità tecniche della produzione dalmomento che non sembra vi siano state trasformazioni di rilievo delle tecnologie elaboratein precedenza. Soltanto alla fine del XII secolo, in concomitanza con il momento di rotturafra l’elemento islamico della popolazione e la corte, - che avrà come conseguenza la deporta-zione dei musulmani a Lucera alla metà del secolo successivo sarà possibile ravvisare una to-tale frattura con il passato e l’inizio di un nuovo ciclo. Auspichiamo che gli esiti conseguiticon la presente ricerca possano costituire il primo passo per una migliore conoscenza dellacultura materiale della Sicilia tra l’ultimo secolo della presenza bizantina e la conquista nor-manna dell’isola, ed aggiungere un piccolo tassello alla comprensione delle dinamiche econo-miche e commerciali in questo periodo così carente di fonti.
222