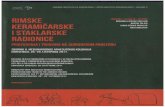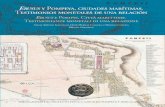Milazzo. I materiali dallo scavo della fattoria di Via Ciantro: ceramica fine e anfore da trasporto
Le anfore da pesce adriatiche
Transcript of Le anfore da pesce adriatiche
u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i pa d o vad i pa rt i m e n t o d i a r c h e o l o g i a
antenor quaderni 15
olio e pesce in epoca romana
produzione e commercio nelle regioni dell’alto adriatico
atti del convegno (padova, 16 febbraio 2007)
a cura di stefania pesavento mattioli e marie-brigitte carre
estratto
2009
edizioni quasar
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
come appare chiaro dal contributo di maria stella busana, chiara d’incà e silvia forti in questo volume, gli indizi di attività produttive nel settore del pesce in istria e nell’arco dell’alto e medio adriatico occidentale sono molto meno manifesti rispetto a quelli della produzione olearia: il panorama che si può ricavare dalle testimonianze archeologiche è assai lontano dalle evidenze ben note (e qui in parte riprese da darío bernal e emmanuel botte) di altre regioni e anche le fonti non sono particolarmente eloquenti circa la vocazione di territori che pure si affacciavano su un mare pescoso e adatto allo sfruttamento delle risorse. maggiori apporti si possono ricavare dallo studio delle anfore: sulle rotte dell’adriatico infatti circolavano, oltre a contenitori che attestano una importazione di garum e salsamenta dalla penisola iberica, dal mediterraneo orientale, dall’ita-lia meridionale e dalla sicilia1, anche altri di fabbricazione locale, nei quali sicuramente erano tra-sportati i prodotti della pesca, come confermano le iscrizioni e talora residui ben riconoscibili.
nell’ambito della ricerca finanziata dall’ateneo patavino ci si è proposti di dare sistema-ticità a un tema dai contorni non ben definiti e oggetto finora solo di cenni cursori. a tal fine si sono innanzitutto enucleati due gruppi maggiori di anfore: il primo comprende le anfore di accertata origine adriatica (in particolare dressel 6a e dressel 6b) dal contenuto “difforme” rispetto a quanto tradizionalmente ritenuto2, il secondo le anfore di piccole dimensioni per le quali diversi elementi concorrono a far ipotizzare una originaria destinazione al commercio delle salse di pesce dell’adriatico3.
Les sauces de poissons dans des amphores adriatiques: un indice d’importation en vrac?
lorsque commencèrent les recherches sur les amphores impériales de l’adriatique, l’iden tification de leur contenu était fondée en bonne partie sur les lectures de tituli picti4, gé-nérant une certaine confusion. leur réexamen, associé à celui des contextes de découverte et à de meilleures définitions typologiques, a permis d’établir que les amphores dressel 6a conte-
1 per le importazioni betiche, cfr. pesavento mattioLi 2000b, per quelle dal mediterraneo orientale e dal mar nero, BeLotti 2008. molto modesti sono gli arrivi delle anfore da pesce tirreniche, ora riconosciute nelle dressel 21-22 (Botte 2008 e in questo volume).
2 cfr. in generale carre, pesavento mattioLi 2003a.3 la sintesi e le conclusioni qui si proposte sono il risultato di molte riflessioni e di un lungo lavoro in colla-
borazione: in particolare tuttavia l’elaborazione della parte sulle anfore dal contenuto anomalo è di marie-brigitte carre, di quella sulle anforette di stefania pesavento mattioli (i tituli picti) e di chiara belotti (la tipologia). i dise-gni delle anfore inedite sono di silvia tinazzo (dipartimento di archeologia, università di padova).
4 voir par exemple les propositions de fausto zevi, reprises par paolo baldacci et ezio buchi: bibliographie dans carre 1985.
Le anfore da pesce adriatiche
Marie-Brigitte Carre, Stefania Pesavento Mattioli, Chiara Belotti
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
216 marie-Brigitte carre, stefania pesavento mattioLi, chiara BeLotti
naient le vin de la côte adriatique (Picenum, plaine du pô, région d’aquilée) tandis que l’huile était conditionnée dans les amphores ovoïdes de la côte médio-adriatique et les dressel 6b, sûrement fabriquées en istrie et probablement aussi dans la cisalpine5. cependant certaines mentions (restes de contenu et inscriptions) ne sont pas conformes à ce schéma. après une présentation de l’ensemble du corpus, quelques pistes de recherche seront proposées pour ten-ter d’expliquer ces contenus anormaux.
dresseL 6a
on connaît deux dressel 6a contenant des restes de poisson: à salzburg6, une amphore timbrée au nom de T. Helvius Basila contenait une sauce à base de sardines (Sardina pilchar-dus et Engraulis encrasicolus)7, assez probablement de l’allec8; à vérone, des arêtes de pois-son ont été signalées dans un autre exemplaire portant le même timbre et un graffito isp9. d’autres dressel 6a portent des inscriptions mentionnant des sauces de poissons. sur une petite amphore de vérone un titulus G(arum) / HIS / P.A.O est peint en lettres rouges sur le col10. cette découverte confirme la proposition de lecture faite par paolo baldacci d’un titu-lus peint en rouge sur le col d’une amphore trouvée à milan et timbrée au nom de C. Cauto-rius Celer: C(arum) / HIS11. nous reviendrons plus loin sur les développements possibles de HIS.
signalons également les huit inscriptions de novare citées par fausta scafile12, sans transcription et sans illustration typologique. sept d’entre elles mentionneraient un garum geticum, la dernière un garum coktum. on en compterait quatre sur dressel 7-11, trois sur dressel 6a et on ne sait pas sur quel support se trouve la dernière inscription. on peut déduire de l’article de luisa brecciaroli taborelli13, qui a revu les fiches, que l’inscription ga( ) co( ) se trouve sur une dressel 6a «classique». deux autres inscriptions, mentionnant le mystérieux garum geticum, seraient en revanche apposées sur une variante de dressel 6a de petite dimension et à longue pointe14. les quatre autres se trouveraient donc sur dressel 7-11. si le «garum geticum» semble un hapax, on peut signaler pour ga( ) co( ) un éven-tuel parallèle avec une inscription de rome peinte sur une amphore dressel 18, pour la-quelle h. dressel propose un développement incertain: Hal(lec) vel Hal(lex) Coc(tiva) (aut) soc(iorum)15. au-delà de ces spéculations, l’association des mêmes inscriptions sur les deux types d’amphores, à supposer qu’elle soit vérifiée, est extrêmement intéressante et il est ur-gent de procéder à un réexamen soigneux de ce groupe d’objets, qui contient peut-être la réponse à toutes nos questions.
5 une mise au point dans carre, pesavento mattioLi 2003a et 2003b.6 heger 1986, fig. 1, p. 133; fig. 5, p. 137 et pl. 3.7 Lepiskaar 1986, pp. 167 et sv. 8 L’allec est, selon pline (nat. 31, 95) soit une étape dans la préparation du garum, la pâte non entièrement dé-
composée et non filtrée, soit une purée de petits poissons (Étienne, mayet 2002, p. 51). 9 cipoLLa 1881, p. 12.10 pesavento mattioLi 2000a, p. 113, fig. 2. l’amphore est haute de 83 cm. 11 BaLdacci 1967-68, p. 26, timbre 30 et fig. 5b p. 13, sur une amphore haute de 0,90 m. il proposait aussi la
lecture o(lei), que le titulus de vérone permet d’exclure. 12 scafiLe 1980.13 BrecciaroLi taBoreLLi 1987, pp. 139-140, notes 100 et 101.14 scafiLe 1980, pl. lXvii, 2.15 cil Xv, 4730; la dressel 18 est une amphore de tradition punique, destinée à contenir des salaisons de pois-
sons, et produite en maurétanie tingitane et en bétique: Étienne, mayet 2002, pp. 110-113.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
Le anfore da pesce adriatiche 217
a fossombrone, une dressel 6a porte le graffitto mvr, dans lequel on peut reconnaî-tre la muria16, sauce de poisson salé17 dont pline (nat. 31,94) célèbre la qualité qui provient de dalmatie.
enfin il existe un cas incertain, à salzburg, où une dressel 6a porte, en rouge sur le col, le titulus FLOS / VET /(annorum) X et sur une quatrième ligne des lettres presque illisibles que l’on peut reconnaître comme des tria nomina18. Flos qualifie fréquemment les sauces de poisson (surtout garum, mais aussi liquamen ou muria). bien que rien ne mentionne explicite-ment le produit transporté19, on peut compter cet exemplaire parmi nos amphores à sauces.
dresseL 6B
moins fréquentes sont les attestations de produits à base de poisson sur les dressel 6b, amphores à huile. p. baldacci signale une inscription presque effacée en lettres noires sur le col d’une dressel 6b20, sc/////liquam////, suivie de chiffres illisibles, qui porte sous l’anse une inscription verticale AA CI et un timbre presque illisible sur la lèvre, ta//alia///m. on peut proposer pour la première ligne le développement sc(ombri) liquam(en), selon un modèle connu ailleurs 21.
on se contentera d’évoquer ici les cas de deux amphores mentionnant le lymp(hatum?), sans trancher sur la nature de ce produit, qui fait depuis toujours l’objet de discussions22. henrich dres-sel et la plupart des chercheurs à sa suite ont identifié le lymphatum comme une sorte de garum23. récemment, toni silvino et matthieu poux24 se sont prononcés en faveur du vin. la découverte dans le port de pise d’une amphore de bétique dressel 9 portant l’inscription vinlvmp, Vin(ata vel atum) Lump(ha vel hatum), pourrait, pour les éditeurs, confirmer l’hypothèse d’une sauce correspondant à l’oenogarum évoqué par apicius et martial25. qu’il s’agisse de sauce de poisson, de vin ou de sauce de poisson dans du vin, la plupart des inscriptions connues sont apposées sur des amphores dressel 9. bien que le problème posé par le contenu de ce type reste ouvert et mal-gré la rareté des inscriptions mentionnant les sauces de poisson sur les dressel 9 de bétique26, il est choisi comme un des modèles pour les imitations lyonnaises d’amphores à sauce de poisson («dressel 9 similis», infra), ce qui pourrait plaider en faveur d’un contenu lié à la mer et c’est à ce titre que nous mentionnons ici les inscriptions suivantes.
paolo baldacci a lu, sur un haut de panse d’amphore de sa forme iii (donc dressel 6b), trouvée à milan, le titulus en lettre noires lvr. pci / de.dd. plini npa.X. a.XXXi, qu’il développa L(ymphatum) v(etus) r(ubrum) P(ondo) CI / De (praediis) D.D. Plini(orum)
16 pesavento mattioLi 2000a, p. 113.17 Étienne, mayet 2002, p. 47.18 heger 1986, fig. 1, p. 133, amphores; fig. 5, p. 137, épigraphie et pl. 3, photos.19 Flos peut être utilisé pour d’autres produits comme le miel: Liou 1993, p. 137. pour b. liou (1988, p. 173), il
ne fait cependant aucun doute que l’adjectif qualifie le garum ou la muria.20 BaLdacci 1967-68, p. 14, fig. 8. comme la précédente, elle a été trouvée en corso v. emanuele en novembre
1961. les transcriptions des inscriptions sont celles de l’auteur. 21 cil iv, 2588 et cil iii, 12010, 48. 22 Étienne, mayet 2002, p. 52.23 Ad cil Xv, 4736. 24 siLvino, poux 2005, p. 508.25 pesavento mattioLi, Buonopane 2002, pp. 789-791, p. 794 n. 2. 26 cependant, on connaît une inscription Vet(us) Liqu(amen) Sc(ombri) sur une dressel 9: desBat, Lemaître
2000, p. 796 et fig. 8, 1.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
218 marie-Brigitte carre, stefania pesavento mattioLi, chiara BeLotti
N(igri) (et) Pa(ternini) X a(nnorum) XXXI, considérant que le produit mentionné était du vin27 (fig. 1). le lymphatum n’étant jamais abrégé par sa simple initiale, cette inter-prétation est restée fort douteuse jusqu’à la publication par gernot piccottini d’un titulus en noir sur le col d’une dressel 6b du magdalens-berg, lvm. p(ondo) cX / l.l28 (fig. 2). cette inscription permet de pro-poser une nouvelle lecture29 pour l’inscription de l’amphore de milan, que l’on développera Lymp(hatum) P(ondo) CI / De (praediis) D.D. Plini(orum) N(igri) (et) P(aternini) a(nnorum) X a(nnorum) XXXI30.
en revanche, nous ne retiendrons pas ici les graffiti sur deux amphores du magda-lensberg à cause des nombreuses incertitudes qui planent sur ces objets. les identifica-tions des amphores, surtout quand il s’agit de fragments, sont souvent à réviser; les ins-criptions ne s’inscrivent pas dans des séries connues par ailleurs; enfin subsistent des dou-tes sur les développements proposés. on a proposé de voir dans le graffito gren, sur une amphore identifiée comme dressel 6a31, la mention de G(arum) Ren(ianum), jamais attesté, ou l’abbréviation du nom Cren(is). pour le graffito GAR. SEC32 sur le fragment de col d’une seconde amphore identifiée comme dressel 6b, le développement suggéré est gar(um) sec(undarium). mais seule la muria est qualifiée de second ordre (cil Xv, 2, 4726) et le point entre les deux parties du graffiti évoque davantage la mention d’un nom de personne que d’un contenu.
queLques considÉrations sur La signification de ces tituli
la mention de sauces de poisson sur des amphores traditionnellement interprétées com-me conteneurs à vin ou à huile peut avoir deux explications: ou bien une série d’amphores produites sur place, que l’on ne sait pas encore distinguer des amphores à huile et à vin, était réservée au transport des produits à base de poisson; ou bien il s’agit d’une réutilisation d’am-phores disponibles et le contenu est spécifié précisément parce que ce n’est pas le contenu ha-bituel. un bon exemple de réemploi est celui du navire de grado, dont les amphores à origine et contenu primaire variés transportaient des poissons salés33.
27 BaLdacci 1972, p. 129, app. 6 et fig. 32 et 33. cfr. aussi tassaux 2001, p. 54 note 31.28 piccottini 2000-2001, pp. 376-377.29 voir aussi pour comparaison les inscriptions des amphores de pise: pesavento mattioLi, Buonopane 2002,
p. 791 et fig. 1 p. 795. 30 cette relecture ne résout pas tous les problèmes d’interprétation de cette inscription, sur laquelle nous nous
proposons de revenir ailleurs. 31 maier maidL 1992, p. 116. 32 maier maidL 1991, p. 122, n. 170 = maier maidL 1992, p. 110. les identifications typologiques sont souvent
peu dignes de foi. 33 auriemma 2000.
fig. 1 - dressel 6b da milano con titulus pictus menzionante lym-phatum (BaLdacci 1972, figg. 32-33).
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
Le anfore da pesce adriatiche 219
le dossier des dressel 6b est maigre: l’une porte la mention de liquamen, les deux autres s’inscrivent parmi les amphores à lymphatum, sauce dont la nature est encore discutée. la série des dressel 6a, amphores à vin, est un peu mieux documentée et permet quelques ré-flexions complémentaires.
pour une possible production adriatique d’amphores spécialisées dans le transport de sauces ou salaisons, une piste de recherche a été lancée par luisa brecciaroli taborelli. elle a distingué parmi les amphores de vercelli deux exemplaires, malheureusement anépigra-phes, ayant un rapport dimensionnel différent des autres, plus ou moins 1/3 par partie (col/épaule, panse, pointe) et dont la hauteur est comprise entre 90 et 95 cm34, variante qu’elle a remarquée sur les amphores de novare portant les inscriptions qui mentionnent le ga-rum. cette caractéristique avait déjà été notée par paolo baldacci à propos de l’amphore de milan35, stefania pesavento mattioli l’évoque pour celle de vérone et une des amphores de salzburg entre dans cette catégorie. mais ces traits morphologiques peuvent répondre à un choix délibéré d’amphores ayant une forme particulièrement adaptée pour contenir des sau-ces de poisson ou mieux s’expliquent par la présence massive de ces objets dans leur région de production, la cisalpine36. la présence du timbre t.h.b sur les deux amphores de véro-ne et salzburg contenant des restes de poissons peut être simplement liée à la fréquence de
l’estampillage de ces amphores. d’éventuelles réponses à ces hypothèses ne pourront venir que du réexamen de tout le corpus, notamment des amphores de novare.
s’il s’agit d’une réutilisation, hypothèse que nous privilégions, il faut se demander où étaient fabriquées les sauces qui les emplissaient. outre l’éventualité d’une production locale, sur laquelle nous reviendrons plus loin, un indice se trouve peut-être dans les mentions his des amphores de vérone et milan, qui peuvent être développées His(tricum) ou His(panum). on éliminera le premier dans la mesure où les produits istriens sem-blent plutôt être signalés par l’abréviation Histr( )37. en revanche, on connaît d’autres inscriptions mentionnant du garum his( )ou hisp( ), par exemple sur trois dressel 7-11 du magdalensberg38 et une dressel 8 de Poetovio39, clairement interprétables ici comme hisp(anum). elles fournissent une clef de lecture pour les tituli des ampho-res dressel 6a, ce que pourrait confirmer le graffito ISP sur la découverte ancienne de vérone40.
34 BrecciaroLi taBoreLLi 1987, p. 140.35 BaLdacci 1967-1968, p. 11.36 ces amphores semblent en effet se rattacher à des productions de l’italie septentrionale caractérisées par des
dimensions inférieures à celles des amphores picéniennes; voir là-dessus en dernier lieu pesavento mattioLi 2002 et carre, pesavento mattioLi 2003a, p. 271.
37 par ex. maier maidL 1992, p. 120 et Bezeczky 1994, p. 99.38 Bezeczky 1994, p. 108, n. 153 et 153a, fig. 40, 153, marquées respectivement gf / his et gf / hisp. piccottini
2000-2001, p. 382: [ga]rv[m] / hisp / q.q. caeciliorvm / p.m.c. les Quinti duo Caecilii sont des exportateurs polyvalents de produits de bétique. leur nom est apposé aussi bien sur des amphores à saumure que sur des amphores à huile, à rome (cil Xv, 3646, 4753 et 4754) comme dans la vallée du rhône (lyon et st-romain-en-gal, desBat, Liou, LequÉment 1987, p. 156 et 164-165) ou à narbonne (port-la-nautique, Liou 1998, p. 98 et 101, fig. 11).
39 Bezeczky 1994, p. 108, n. 154 et fig. 40.40 on ne suivra pas l’hypothèse de curtis 1991 (p. 164 et note 2), pour qui il s’agirait de l’abréviation du nom
Hispanus.
fig. 2 - dressel 6b dal magdalensberg con titulus pictus menzionante lymphatum (piccottini 2003, p. 44).
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
220 marie-Brigitte carre, stefania pesavento mattioLi, chiara BeLotti
le problème du sens à donner à ces tituli a déjà été bien posé pour les amphores de l’axe rhin-rhône. on y retrouve en effet la mention HIS ou HISP sur des amphores loca-les qui imitent les amphores à saumure ibériques dressel 7-11. on peut voir dans le contenu une sauce locale fabriquée à la mode espagnole41 mais, outre le silence des textes à l’égard de cette recette, la constatation qu’une amphore d’augst portant le titulus pictus G(arum) Hisp(anum) s’intégrait dans la série des productions lyonnaises42 a incité à suivre de préfé-rence la piste de l’indication d’origine d’une sauce importée dans d’autres conteneurs43. la présence d’amphores à garum de fabrication lyonnaise dans les camps militaires du limes germanique a conduit armand desbat et stefanie martin Kilcher à préciser cette interpré-tation en se fondant sur le parallèle des épaves à dolia transportant du vin méditerranéen transvasé à l’arrivée44. ainsi les sauces, arrivées du littoral gaulois ou de tarraconaise ou de bétique45 en dolia ou tonneaux, étaient-elles reconditionnées à lyon dans des amphores de fabrication locale. les témoignages des conteneurs primaires sont rares, dans la mesure où le contenu des dolia n’a pas été conservé. on ne connaît qu’un seul tonneau avec des traces de poissons, trouvé dans le golfe de fos mais dont la provenance est inconnue46; la meilleure attestation d’un transport en tonneau reste la bonde portant une marque de bétique réuti-lisée comme bouchon pour une dressel 9 similis47 trouvée à lyon. ces découvertes mettent en évidence un système fondé sur le transport en vrac, lié en partie à l’armée, qui avait pris place vers les camps du rhin pour la fourniture de produits de grande consommation origi-naires de méditerranée.
ce parallèle permet d’émettre pour nos amphores dressel 6a ou 6b, dont la forme n’évoque pas une provenance espagnole, l’hypothèse d’un étiquetage signalant la nature et l’origine du produit. les arrivées, modestes mais constantes, d’amphores à sauce de poisson ibériques témoignent en effet de la faveur dont ces productions jouissaient en cisalpine. en revanche, les modalités de transport et de transvasement jusque sur les lieux de consomma-tion restent incertaines, car nous ne disposons pas pour l’heure des indices mis en évidence en gaule. le transport a pu s’effectuer dans des amphores hispaniques ou mieux en ton-neaux ou barriques et la revente au détail dans des conteneurs locaux. cette hypothèse de la réutilisation des amphores les plus fréquentes sur les marchés cisalpins n’est au demeurant pas incompatible avec celle d’une production d’amphores imitant celles de bétique, dont nous n’avons pas de preuve pour l’instant: la présence de tituli picti mentionnant du garum, peut-être identiques sur des amphores dressel 6a et 7-11 de novare, en est un indice à vé-rifier.
41 LauBenheimer 2004, pp. 156-158. 42 martin kiLcher 1990 et 1994, p. 422, p40, fig. 187, avec bibliographie antérieure. l’amphore appartient à
son groupe 10 (dr. 9 similis) = type lyon 3b. 43 l’hypothèse d’un transport primaire en amphores se trouve déjà dans desBat, Liou, LequÉment 1987, p.
156, celle des tonneaux est évoquée dans un article paru l’année suivante (Liou 1988, p. 173). outre le garum on connaît aussi la muria hispana (martin kiLcher 1994, p. 422 et fig. 187 pour les amphores d’augst et Baudoux 1996, p. 78, fig. 55, 6 pour un exemplaire de strasbourg). tous ces tituli picti sont apposés sur des amphores type lyon 3b (desBat, dangrÉaux 1997).
44 desBat, martin kiLcher 1989, pp. 355-356.45 voir pour les diverses hypothèses de provenance f. laubenheimer (LauBenheimer 2004, p. 157) qui semble
exclure une provenance espagnole; a. desbat appuyé par s. martin Kilcher, après avoir proposé le littoral gau-lois, envisage pour sa part une origine espagnole (desBat 1991, p. 324; desBat, dangrÉaux 1997, p. 88; martin kiLcher 2002, p. 351).
46 marLière 2002, pp. 60-61.47 desBat 1991.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
Le anfore da pesce adriatiche 221
Le anforette adriatiche da pesce
le attestazioni di dressel 6a e dressel 6b con resti ittici o con tituli picti menzionanti salse di pesce, lasciando aperto il problema dell’effettiva origine del loro contenuto, non re-cano alcuna conferma certa alla possibilità che anche lungo il litorale dell’adriatico si prati-cassero attività di trasformazione dei prodotti della pesca. nuovi ritrovamenti e il riesame di materiali già editi tuttavia hanno indotto a individuare una famiglia di anfore destinate apposi-tamente alla loro commercializzazione.
già da alcuni anni brunella bruno aveva, in via preliminare, definito “anforette nordi-taliche” diversi contenitori, riconosciuti in più siti dell’italia settentrionale, per morfologia e corpo ceramico molto simili alle anfore olearie adriatiche dressel 6b, da cui si differenziavano per le dimensioni più ridotte48. le stesse caratteristiche sono riconoscibili nelle anfore, classi-ficate aquincum 78, attestate in molte località della pannonia, come è stato documentato dalle ricerche di tamas bezeczky49, mentre non trovano confronto in contenitori provenienti da al-tre aree geografiche.
se dunque appariva molto verosimile la parentela di tali anforette con le anfore di pro-duzione adriatica, restava tuttavia incerto il loro contenuto, ipotizzabile come oleario solo sulla base dell’affinità con le dressel 6b. lo spunto per riconoscerlo è venuto dal recupero del carico della nave affondata presso grado50, dove erano presenti, assieme a contenitori di varia origine in cui si trovavano ancora resti di diverse specie di pesci, circa duecento anfore di piccole dimensioni, dalle caratteristiche molto simili a quelle delle “anforette norditali-che”. poiché i tituli picti apposti su alcune di queste menzionavano il liquamen, in occasio-ne del loro studio preliminare è stato proposto che in esse, chiamate “per comodità grado i”, andassero riconosciute appunto le anfore da pesce dell’adriatico51. nello stesso tempo alla medesima conclusione si arrivava in seguito al ritrovamento di un’anforetta simile a pe-schiera sul lago di garda e alla revisione di una conservata al museo di este, entrambe con tituli picti riferibili a salse di pesce, e si estendevano i confronti ad altri esemplari diffusi in italia e a quelli classificati in precedenza come aquincum 7852.
la revisione dei vecchi ritrovamenti e i nuovi che si sono aggiunti hanno consentito di disporre di un quadro abbastanza ampio su cui indagare e di avanzare una proposta di classi-ficazione tipologica di questi contenitori, la cui pertinenza alla grande “famiglia” delle anfore di produzione adriatica appare confermata anche dalle direttrici di diffusione che interessano esclusivamente i territori italici e provinciali serviti dalle rotte dell’adriatico.
i tituli picti
in via preliminare sembra comunque opportuno proporre una breve rassegna dei diversi tituli picti che compaiono sui contenitori, anche perché proprio da questi si è avuta una con-ferma del contenuto, residui del quale non sono stati riscontrati nelle anforette della nave di grado (né negli altri esemplari, rinvenuti quasi sempre frammentari o in siti terrestri), diversa-mente da quanto è accaduto per gli altri contenitori trasportati, che contenevano lische di vari pesci.
48 per le “anforette norditaliche”, cfr. Bruno, Bocchio 1991, p. 27249 la sintesi più recente sulla distribuzione è in Bezeczky 2005, pp. 63-65.50 cfr. auriemma 2000 e ora anche tonioLo 2002-2003 [2007].51 auriemma 2000, pp. 34-37.52 pesavento mattioLi 2000a, pp. 114-115.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
222 marie-Brigitte carre, stefania pesavento mattioLi, chiara BeLotti
oltre ai tituli picti delle anforette di grado, per un’analisi dettagliata dei quali si rimanda al contributo ad essi dedicato in questa sede, ne erano già noti, in quanto oggetto di pubbli-cazione, circa una decina, presenti sulle anforette di peschiera, este, corte cavanella presso adria, castelfranco emilia, urbisaglia e Vindobona53. a questi si possono ora aggiungere (ol-tre a quello di altino presentato qui nel contributo di silvia cipriano e francesca ferrarini) alcuni inediti di aquileia: uno è stato letto su un contenitore proveniente dai vecchi ritrova-menti e conservato nei magazzini del museo, altri su anforette frammentarie rinvenute tra i molti materiali di uno scavo effettuato nell’area di un tratto del canale anfora, il corso d’ac-qua artificiale che collegava la colonia al mare e che fu soggetto a progressivo interramento a partire dal i secolo d.c.54.
tutti i tituli sono tracciati in nero55, in lettere capitali corsive, con ductus e schemi or-ganizzativi molto diversi tra loro. nonostante la lacunosità di molte iscrizioni e le indubbie difficoltà di lettura, un elemento comune risulta prevalente (ed è quello che interessa in questa sede, lasciando ad indagini future, sperabilmente arricchite da nuove segnalazioni, un’interpre-tazione più analitica delle diverse scritte), cioè l’indicazione del liquamen quale prodotto con-tenuto: essa compare sia sull’anforetta di peschiera che su quelle di grado; inoltre è leggibile su una di corte cavanella, su cinque di aquileia, su quelle di castelfranco emilia e di altino e su quella, oggi non più rintracciabile, di Vindobona. si tratta nel complesso di una ventina di attestazioni, mentre solo su un contenitore di urbisaglia il contenuto segnalato è la muria e su quello di este il riferimento sembrerebbe essere al garum. Liquamen compare sempre abbreviato LIQ, con la l che talora, come aVindobona, castelfranco emilia, aquileia e al-tino (fig. 3a e fig. 10; fig. 2 nel contributo di silvia cipriano e francesca ferrarini), è tracciata molto accuratamente, con una curva all’indietro56, talora in modo più sbrigativo (figg. 3b-c); è spesso aggiunto flos, sia sulla stessa linea che sulla seconda (anforette di peschiera, di castel-franco emilia, di corte cavanella), a volte accompagnato da un’ulteriore qualifica non sempre interpretabile57.
53 per la bibliografia dei singoli ritrovamenti si rimanda alla tabella i.54 maseLLi scotti 2005. si ringrazia franca scotti della soprintendenza ai beni archeologici del friuli-venezia
giulia per averci dato la possibilità di prendere visione dei materiali di canale anfora, nella prossima pubblica-zione dei quali siamo state coinvolte: a questa si rimanda per l’edizione completa dei tituli picti delle anforette.
55 fa eccezione uno di urbisaglia, che è in rosso, ma che si discosta completamente dagli altri, recando solo le iniziali dei tria nomina (forti 2000, pp. 114-115, n. 13.)
56 come, per fare solo qualche esempio, in una dressel 14 del pecio gandolfo (Liou, rodriguez aLmeida 2000, n. 3. pp. 16-17, con altri confronti) o in alcuni urcei pompeiani (cil iv, 4719, 9415, 10280 e 10281) o in un’anfora di tipo non determinabile (ma sicuramente iberica, poiché commercializzata da un M. Valerius Maximus) da Augusta Vindelicorum (cil iii, 12010, 48).
57 la revisione dell’anforetta di corte cavanella presso adria (tonioLo 1987, p. 109) alla luce dei confronti con gli altri esemplari, fa propendere per interpretare la lettera della prima linea come una a (come nelle anforette
fig. 3 - Tituli picti su anforette adriatiche da pesce “tipo grado i” da aquileia (scala anfore 1:4).
a b c
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
Le anfore da pesce adriatiche 223
Tituli picti menzionanti liquamen, liquamen flos, liquamen excellens, liquamen flos pri-mum o excellens sono ben noti sia su anfore da salse di pesce iberiche che su loro imitazioni galliche; in alcuni casi l’aggiunta di antipolitanum ne precisa la provenienza o quella di scom-bri il tipo di pesce da cui era ricavato58; inoltre lo stesso contenuto è segnalato su quarantadue urcei di pompei (il 48% del totale degli esemplari censiti), dove compare nella maggior parte dei casi come optimum e su alcuni con il riferimento a umbricio scauro, forse da interpretarsi come fatto “alla maniera di scauro”59.
che salsa fosse precisamente il liquamen e in cosa si differenziasse dal garum resta tut-tavia ancora dubbio, anche se una recente ampia revisione dei metodi di conservazione del pesce e di preparazione delle salse ha fatto il punto sul significato da attribuire ai diversi nomi con i quali queste sono indicate60: per quanto riguarda il liquamen, termine riferito da colu-mella pure genericamente a sostanze liquide61, sembra potersi concludere che almeno fino al i secolo d.c. liquamen e garum fossero due salse ottenute dalla macerazione con sale e al sole delle interiora e di piccoli pesci, ma diverse, come prova il fatto che a pompei entrambe erano prodotte da umbricio scauro62. ad un certo punto, forse dalla fine del ii secolo, i due termini furono usati con lo stesso significato o addirittura divenne comune nel mondo latino l’uso di liquamen (nell’editto di diocleziano, a liquamen corrisponde nel testo greco garon63).
la maggioranza delle anforette conteneva dunque una salsa di pesce denominata liquamen: il fatto che dovesse trattarsi di una preparazione molto liquida sembra confermato dalle loro ri-dotte dimensioni, dalla presenza frequentemente riscontrata di una spessa impeciatura (la quale peraltro serve anche ad escludere un contenuto oleario, come inizialmente si poteva ipotizzare per la somiglianza con le dressel 6b) e dall’assenza di resti ittici nelle anforette di grado. solo nell’esemplare di urbisaglia è indicato un contenuto di muria: questa oltre ad essere generica-mente identificabile con la salamoia, rappresentava anche una salsa di pesce ben documentata (e pure segnalata sugli urcei di pompei), per la quale, come è stato più volte sottolineato, secondo plinio era rinomata la dalmazia64. del tutto anomalo è infine il titulus dell’anfora di este, di dif-ficile interpretazione pur nella chiarezza della lettura, dove forse è ricordato il garum65.
nei tituli picti delle anforette talora sono indicate delle cifre, presenti nella prima riga assieme a una lettera e a un segno, come a grado, o nella seconda (fig. 3a), o alla fine, prima o dopo le iniziali dei tria nomina che a volte concludono la serie di iscrizioni. si tratta di cifre
di grado, cfr. il contributo di r. auriemma e s. pesavento mattioli in questa sede) e per la presenza dell’indica-zione, molto evanida di liquamen prima di flos sulla seconda.
58 per una sintesi delle attestazioni di liquamen su anfore di forme diverse, cfr. ehmig 2003, pp. 65-66; su anfo-re galliche, LauBenheimer 2004, p. 155: il tipo di scrittura e le abbreviazioni sono in genere varie; può essere scritto intero (anche con flos non è usato il genitivo, v. ad esempio cil iv, 5714 e 9414 e commento in faBrini marengo 2002, pp. 124-125), o abbreviato liquam, ma più spesso liq.
59 una completa rassegna degli urcei pompeiani è stata effettuata in occasione delle ricerche per la tesi di dot-torato di e. botte (Botte 2008); per una approfondita analisi delle produzioni di umbricio scauro, cfr. Étienne, mayet 1991.
60 Botte 2008; cfr. anche Étienne, mayet 2002, pp. 43-53.61 coLum. 7, 4, 7; 9, 8, 9; 9, 14, 17; in columella tuttavia il termine appare anche con riferimento ai salsamenta
(9, 14, 3). per i diversi usi del termine, cfr. TLL, vii, 2, cc. 1474-1475. per curtis (1991, p. 34) rimane la più enig-matica delle salse.
62 come mostrano le iscrizioni degli urcei raffigurati nel mosaico della sua casa (etienne, mayet 2002, pp. 48-51), oltre a quelle sugli esemplari rinvenuti.
63 Edict. Diocl. 3, 6-7.64 pLin. nat. 31, 94. per ampia illustrazione, cfr. faBrini marengo 2002, pp. 125-127, e Botte 2008. per gli ur-
cei pompeiani v. ad esempio cil iv, 9430-34.65 per i problemi interpretativi si rimanda a pesavento mattioLi, Benvenuti 2001, p. 172; cfr. ora anche to-
nioLo 2002-2003, p. 127, nota 35.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
224 marie-Brigitte carre, stefania pesavento mattioLi, chiara BeLotti
una proposta di cLassificazione tipoLogica
la verifica delle attestazioni, unitamente allo studio di materiale inedito, ha permesso di ap-purare all’interno delle anforette norditaliche l’esistenza di più tipi, per i quali si propone un pri-mo tentativo di classificazione, classificazione che certamente andrà verificata sui diversi esem-plari per i quali ancora non è stato possibile un controllo autoptico68 e che in futuro ci si augura possa essere perfezionata grazie a nuove segnalazioni e a ulteriori indagini di tipo archeometrico.
diverse (tranne nel caso di grado, dove si ripete XX; XX è anche sull’anfora di urbisaglia e su quella di aquileia a fig. 3a), che, partendo da Xvi arrivano a XXX nell’esemplare di castel-franco emilia. non sembra possibile trovare una chiave di lettura comune: non può trattarsi ovviamente del riferimento agli anni di invecchiamento, che peraltro non è mai associato a li-quamen; se si deve pensare a indicazioni di capacità in sextarii, il contenuto varierebbe da circa 9 litri a 16, forse troppo pochi per le dimensioni pur ridotte delle anfore66. non è da escludere, ma difficile da verificare, data la frammentarietà della maggior parte delle anfore iscritte, che si possa riconoscere l’indicazione relativa al peso in libbre dell’anfora vuota (variabile dunque tra i 5 e i 10 kg circa), peso che, come si è ora riscontrato, era segnalato, assieme a quello del contenuto, nelle dressel 21-22, le anfore da pesce tirreniche67. resta comunque uno dei tanti problemi irrisolti e per il quale forse non va cercata una soluzione univoca: probabilmente si tratta in alcuni casi del numero del contenitore in una serie o in un lotto commercializzato, in altri di un’indicazione ponderale, senza che sia possibile ricostruire uno schema organizzativo comune dei dati che compaiono.
la disomogeneità dei tituli picti delle anforette è d’altronde ben evidente: una certa analo-gia (prodotto – flos – indicazione ponderale – tria nomina) si può riscontrare solo tra l’anfora di peschiera e quella di urbisaglia (fig. 4), pur con contenuto diverso. potrebbe essere questo l’unico piccolissimo e labile indizio di una organizzazione commerciale vicina a quella che sta dietro alle anfore da garum e salsamenta della betica.
66 per i diversi valori del sextarius e per il rapporto tra capacità e peso, si rimanda all’ancora valida voce in Da-remberg-Saglio, iv, pp. 1286-1287.
67 Botte 2008 e in questo volume. in effetti il peso medio di alcune anforette intere, ma non iscritte, è risultato essere di 5 kg.
68 È ad esempio il caso delle molte anfore diffuse in pannonia, cfr. supra, o di alcuni esemplari rinvenuti nel ba-cino danubiano, che forse potrebbero rientrare nel gruppo (BjeLajac 1996, fig. 1).
fig. 4 - Tituli picti su an-forette adriatiche da pe-sce da peschiera (pesa-vento mat tio Li, Ben-venuti 2001, fig. 2) e da urbisaglia (faBrini, marengo 2002, fig. 2).
a b
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
Le anfore da pesce adriatiche 225
alcuni punti vanno tuttavia preliminarmente precisati. il primo è di carattere terminolo-gico: piuttosto che di anforette norditaliche proponiamo di parlare, pur nella consapevolezza dell’estrema genericità del termine, di “anforette adriatiche da pesce”, visto che la loro origine, come si è detto, parrebbe riconducibile alle coste dell’adriatico e il loro contenuto essere un prodotto derivato dalla lavorazione del pesce, come suggeriscono i tituli picti menzionanti il liquamen, la muria e forse anche il garum.
un’ulteriore puntualizzazione riguarda poi la notevole somiglianza tra i contenitori cui ci si riferisce e la serie più piccola delle dressel 6b69, simile nell’impostazione generale, quan-tunque le fattezze delle anforette appaiano più minute e le pareti decisamente più sottili (lo spessore in genere misura 1 cm), con la conseguenza di un peso notevolmente inferiore; tale distinzione, facilmente percepibile con l’autopsia, risulta più difficoltosa sulla base della sola documentazione grafica, motivo per cui si è evitato di prendere in considerazione gli esem-plari per i quali era impossibile essere certi dell’esatta pertinenza. più marcate risultano invece le differenze del corpo ceramico, alquanto più depurato nelle anforette e con una colorazione che in genere tende ad assumere le tonalità del nocciola, del giallino oppure del grigio quando il pezzo si è conservato in un ambiente “lagunare”70.
riguardo all’analisi tipologica, si è approntata una preliminare seriazione, che molto deve ai materiali ancora inediti rinvenuti in canale anfora ad aquileia e che presumibilmente tro-verà ulteriori migliorie con l’edizione integrale del carico della nave di grado. tra le “anfo-rette adriatiche da pesce” in primo luogo sono stati enucleati due tipi, mentre in un gruppo a parte si sono per ora riunite le anfore, certamente da pesce, per le quali i pochi dati a disposi-zione non permettono di procedere ad una precisa ripartizione. un’ulteriore questione riguar-da infine le anforette prodotte a loron in istria, il cui contenuto rimane ancora incerto.
69 per un quadro sulle dressel 6b di piccole dimensioni, prodotte sicuramente anche in istria, si rimanda ai contributi (e alla bibliografia ivi citata) presentati in questo volume da v. degrassi, p. maggi, g. mian e da Y. ma-rion, dove come criterio discriminante tra i due formati è stato considerato il diametro esterno dell’orlo pari a 11 cm, misura al di sotto della quale non sembrerebbero comparire bolli.
70 tale fenomeno di alterazione cromatica sembrerebbe interessare di frequente le anforette adriatiche, come mostrano per esempio gli esemplari della nave di grado, di corte cavanella e di canale anfora.
fig. 5 - anforette recuperate nella nave di grado (deLL’amico 1997, fig. 6).
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
226 marie-Brigitte carre, stefania pesavento mattioLi, chiara BeLotti
Le anforette adriatiche da pesce tipo “Grado I”
tra le “anforette adriatiche da pesce” un primo tipo è rappresentato dagli esemplari recu-perati nella nave affondata nelle acque di grado (fig. 5), caratterizzati, in generale, da un breve orlo svasato verso l’alto, che solitamente presenta un labbro inspessito e inclinato esternamen-te; la superficie esterna di frequente è segnata da una o più scanalature parallele incise prima della cottura, talora da una linea ondulata. l’altezza dell’imboccatura in media misura 3-4 cm (in alcuni esemplari anche 2 cm); il diametro esterno è di 8-10/11 cm, mentre quello interno in genere è pari a 6-8 cm. il collo è troncoconico, mediamente alto 6-8 cm, e si raccorda al corpo senza soluzione di continuità; alla sua estremità superiore e sulla spalla si innestano le anse, minute, a sezione quasi ovale (2-3 cm) e con gomito ad angolo quasi retto; la loro altezza è di circa 7-10 cm. il corpo è ovoidale, talora allungato, con un’ampiezza massima di 27-30 cm e termina in un piccolo puntale pieno generalmente di forma conica. l’altezza totale di queste anforette oscilla tra i 55 e i 70 cm, la capienza è pari a 17 litri71. gli esemplari rinvenuti a gra-do, punto di partenza, come si è detto, della problematica qui affrontata, rivelano tuttavia una varietà di formati, diversificati sia nella morfologia dell’orlo che in quella del corpo, per i quali manca tuttora una precisa seriazione. il corpo ceramico presenta un ampio spettro di tonalità, che variano dal giallo chiaro, al nocciola, all’arancione o ancora più frequentemente al grigio (probabilmente a causa dell’ambito in cui si sono conservate); in tutti i casi l’impasto appare molto depurato.
71 auriemma 2000, p. 34.
fig. 6 - anforette adriatiche da pesce “tipo grado i” da aquileia.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
Le anfore da pesce adriatiche 227
al momento anforette riferibili a questo primo tipo sono state riconosciute principalmente nella Regio X, dove si ritrovano, oltre che nel relitto di grado (fig. 5), a trieste72, aquileia73 (fig. 6), oder-zo, altino, padova, este74, nel polesine (villadose e corte cavanella), a brescia75 e cavriana (manto-va)76, mentre nella Transpadana sono state ricono-sciute a torino77; altre attestazioni si hanno infine a aidussina in slovenia e a Vindobona (fig. 7a)78.
i tituli picti presenti su diversi esemplari non lasciano dubbi su quali dovevano essere i prodotti trasportati in queste anfore; anche la presenza di im-peciatura riscontrata in molte rappresenta un’ulte-riore conferma all’ipotesi di una salsa di pesce come contenuto79.
in assenza di centri di produzione noti, la cro-nologia è suggerita dai contesti di rinvenimento, che in genere rimandano a un periodo compreso tra il ii secolo d.c. e gli inizi del iii.80. riguardo alla prove-nienza, non è ancora possibile identificare un pre-ciso ambito geografico: le indagini archeometriche effettuate in occasione della ricerca hanno riscontra-
72 per gli esemplari di trieste (via del seminario e via crosada) si rimanda al contributo di v. degrassi, p. mag-gi, g. mian in questo volume.
73 ad aquileia si registra il più alto numero di ritrovamenti: quasi un centinaio di esemplari sono stati recupe-rati negli strati di accrescimento di canale anfora, mentre un numero imprecisato è stato rinvenuto in un contesto di bonifica rinvenuto in località colombara (dove erano disposte orizzontalmente insieme ad anfore africane ii; cfr. maseLLi scotti 1998, p. 110, fig. 4); un esemplare (inv. 598) con titulus pictus menzionante il liquamen, si conserva presso i magazzini del museo archeologico di aquileia (v. fig. 3).
74 per oderzo cfr. sandrini, saccocci, raLLo 1988, p. 82, fig. 23, n. 3. per gli esemplari di altino si rimanda al contributo di s. cipriano e f. ferrarini in questo volume. a padova almeno tre anforette erano presenti nel grande apprestamento messo in luce in loc. roncaglia di ponte san nicolò (per un quadro sul contesto cfr. mazzocchin 1998; gli esemplari sono inediti). per l’esemplare di este si veda pesavento mattioLi, Benvenuti 2001, p. 172, fig. 3.
75 diversi esemplari sono stati rinvenuti a villadose (comunicazione di giuliana m. facchini, che si ringrazia). l’esemplare di corte cavanella (tonioLo 1987, fig. 20) presenta un orlo ad anello alquanto minuto simile a quello delle anfore rinvenute nel deposito del Capitolium di brescia (Bruno 2002, nn. 3, 4); per gli altri rinvenimenti nella città (contesti vari e domus di santa giulia) si veda Bruno 1996, p. 200, fig. 131 e Bruno, Bocchio 1999, p. 233, tav. Xcviii, nn. 1-2; un’ulteriore anforetta, ora esposta nel museo civico di santa giulia, proviene dalle domus dell’ortaglia.
76 portuLano 2007, p. 272, fig. 1, n. 5.77 cfr. il contributo di e. quiri in questo volume (in particolare fig. 3, n. 1).78 per aiudussina si veda vidrih perko, ŽBona thkman 2005, fig. 4, n. 4; per Vindobona bezeczky 2005, tav.
14, n. 102. 79 tutte le anforette facenti parte del carico della nave di grado conservano uno spesso strato di pece nera;
tracce di pece si ritrovano anche in diversi esemplari di aquileia (dove tuttavia l’impeciatura presenta una colora-zione giallastra e una consistenza quasi spugnosa) e nei contenitori di altino, este e corte cavanella.
80 il naufragio del relitto di grado si colloca alla metà del ii secolo; le cronologie di trieste (piazza barbacan, via del seminario) rimandano a un arco cronologico compreso tra la metà del ii e gli inizi del iii d.c., così come il deposito del Capitolium di brescia. la bonifica in loc. colombara ad aquileia si data tra il ii e il iii secolo d.c., cronologia che pressappoco coincide anche con il periodo di imbonimento di canale anfora (iniziato già nel corso del i secolo), da dove provengono numerosissimi esemplari. il santuario dei dioscuri a este rimane in uso almeno fino alla seconda metà del ii secolo d.c. (per la cronologia del santuario si veda da ultimo Baggio Bernardoni
fig. 7 - anforette adriatiche da pesce “tipo grado i” e “con orlo a fascia” da Vindobona (Bezeczky 2005, pl. 14, nn. 102, 100).
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
228 marie-Brigitte carre, stefania pesavento mattioLi, chiara BeLotti
to una forte omogeneità petrografica tra loro nei campioni rinvenuti ad aquileia e, all’elabo-razione statistica delle analisi chimiche, anche con alcune anforette di padova, confortando l’ipotesi che si tratti di una stessa produzione81.
Le anforette adriatiche da pesce “con orlo a fascia”
l’identificazione di questo secondo tipo è stata possibile grazie ai ritrovamenti di canale anfora ad aquileia, in quanto la conservazione dell’impeciatura interna ha permesso di rico-noscere come “da pesce” una serie di anforette dalle caratteristiche morfologiche molto simili.
si tratta sempre di recipienti dalle piccole dimensioni, quantunque non così minute come quelle di grado, caratterizzate da un orlo a fascia svasato, alto circa 4 cm (diametro interno 10 cm, esterno 11-12), distinto dal collo troncoconico (h. 11-12 cm) da una sorta di scalino, e da anse a bastone con gomito arrotondato (h. 12-13; sezione 3 cm); di nessun esemplare aquileiese si conserva la forma completa (fig. 8). analogamente alle grado i il corpo ceramico appare ben depurato. È probabile che a questo gruppo possa essere riferibi-le l’esemplare rinvenuto ad altino e presentato in questo volume da silvia cipriano, impe-ciato internamente e caratterizzato da un orlo a fascia quasi verticale solcato alla base da una profonda scanalatura82.
da un punto di vista petrografico e chimico, i tre esemplari di aquileia analizzati risul-tano omogenei con le precedenti anforette83: resta dunque da chiedersi se le peculiarità for-mali che distinguono i due tipi siano da ricondurre a differenti officine dislocate nel mede-simo ambito geografico oppure semplicemente a diverse fasi cronologiche della stessa fab-brica; in questo senso nessuna indicazione giunge dagli esemplari aquileiesi, la cui cronolo-
gia, in attesa del complessivo studio di canale anfora, rimane genericamente compresa tra il i d.c. e la metà del iii secolo, momento in cui si verifica l’im-bonimento del corso d’acqua84.
a questo quadro dai contorni sfu-mati si aggiunge la questione della pre-senza in diversi contesti di recipienti che da un punto di vista morfologico e metrologico non si discostano dalle an-forette di questo tipo, ma al cui interno non si è mai riscontrata la conservazio-ne di impeciatura: esse si caratterizzano per l’orlo a fascia svasato, spesso di-stinto alla base da una sorta di scalino, e per il corpo dall’andamento affusola-
to, desinente in un piccolo puntale di forma troncoconica (h. totale 70 cm circa). al momento
2002). più generiche sono le datazione di corte cavanella, villadose nel polesine e quelle audissina in slovenia e di Vindobona. i contenitori di altino provengono da strati databili alla prima metà del ii d.c. b. bruno e s. boc-chio riferiscono della presenza di tali recipienti a brescia (depositi vari) già in livelli di i d.c., mentre le attestazioni in contesti più tardi sarebbero residuali. per la bibliografia relativa a questi contesti di rinvenimento si rimanda a quanto detto in precedenza e alla Tabella 1.
81 per le analisi si rimanda al contributo, in questo volume, di c. mazzoli, l. maritan e s. pesavento mattioli.82 cfr. la figura. 2 nel contributo di s. cipriano e f. ferrarini.83 nell’elaborazione delle analisi chimiche, invece, solo due esemplari risultano compatibili.84 scotti 2005.
fig. 8 - anforette adriatiche da pesce “con orlo a fascia” da aquileia.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
Le anfore da pesce adriatiche 229
esemplari con tali peculiarità sono stati rinvenuti in italia settentrionale ad aquileia85, oder-zo86 (fig. 9a), concordia sagittaria87, padova (fig. 9c), verona88, brescia, voghenza (ferrara)89, milano90, biella91, vercelli, tortona, ivrea, e torino92, a urbisaglia nelle marche93 e a Vindobo-na94 (fig. 7b); un esemplare quasi integro è stato recuperato nelle acque di vis in croazia95 (fig. 9b).
il problema di fondo rimane quello dei contenuti, in quanto l’assenza di impeciatura e di ti-tuli picti – ad eccezione delle iniziali su uno di urbisaglia, scritte tuttavia in dimensioni maggiori
85 si tratta di esemplari inediti (di cui uno ricostruito interamente) provenienti dagli scavi effettuati in loc. villa raspa.
86 cipriano, ferrarini 2001, fig. 22.87 un esemplare inedito proveniente dal piazzale antistante la cattedrale (per il contesto si rimanda a cipriano
2001).88 un’anforetta integra è stata rinvenuta a roncaglia di ponte san nicolò (l’esemplare è inedito; per lo scavo si
veda mazzocchin 1998). per l’esemplare conservato nella collezione del museo archeologico del teatro romano di verona cfr. pavoni, BeLotti 2005, fig. 1.
89 oltre agli esemplari riportati nella carta archeologica della lombardia (Bruno 1996, fig. 131, n. 1), un altro recipiente, proveniente da villa faucanier (inv. mr 2181), è esposto presso il museo civico di santa giulia. per voghenza si veda Voghenza 1984, p. 150, n. 4, tav. XXXiii, tomba 51, n. 4.
90 Bruno, Bocchio 1991, tav. cXviii, nn. 116,118 (scavi metropolitana); Bruno 2003, fig. 1, n. 6 (scavi cortili università cattolica cava uc vii).
91 diversi esemplari sono presenti nella necropoli romana di biella (brecciaroLi taBoreLLi 2000, pp. 250-251 284-285, tombe nn. 315, 222, 323).
92 per l’esemplare di vercelli, conservato presso il museo leone, e per quello di tortona si veda BrecciaroLi taBoreLLi 1987, p. 147, tav. X, n. 3. per ivrea BrecciaroLi taBoreLLi 1998, p. 88, nn. 195-196, tav. XXXv. per to-rino si rimanda al contributo di e. quiri in questo volume.
93 forti 2004 (a nota 15 l’autrice riporta inoltre la notizia della presenza di anforette nel porto di ancona).94 bezeczky 2005, pl. 14, n. 100.95 gLušcevic 2006, tav. ii, n. 8.
fig. 9 - anforette adriatiche da pesce “con orlo a fascia” da oderzo (cipriano, ferrarini 2001, fig. 22), vis (gLušcevic 2006, tav. ii, n. 8) e padova (esemplare inedito).
a b c
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
230 marie-Brigitte carre, stefania pesavento mattioLi, chiara BeLotti
e in rosso96 – non permette di identificarli con sicurezza in prodotti della lavorazione del pesce. per quanto riguarda l’assenza di impeciatura, tuttavia, non è forse lecito considerarla un fattore discriminante, soprattutto in relazione alla difficoltà di conservazione e al fatto che non tutti i contenitori destinati a trasportare pesce erano impeciati, come nel caso delle dressel 21/2297: probabilmente solo per una salsa come il liquamen era consigliabile impermeabilizzare il con-tenitore, ma non è detto che per altri prodotti, di qualità inferiore, si utilizzasse la stessa prassi. quanto ai tituli picti, che comunque non compaiono su tutte le anforette di grado e su tutte quelle impeciate, la loro assenza può essere dovuta a una infinità di motivi, quali in genere il rapporto percentuale tra anfore iscritte e no, le cui ragioni rimangono ancora oscure. solo future analisi archeometriche e ulteriori ritrovamenti potranno forse chiarire se, come sembra, tali re-cipienti siano realmente da identificare con le anforette adriatiche da pesce “con orlo a fascia”. se così fosse, almeno stando alla documentazione disponibile, rispetto alle grado i lo smercio di queste anforette apparirebbe da un lato più precoce (vista la loro presenza già in contesti della prima età imperiale98), dall’altro più capillare, soprattutto per quanto riguarda la Transpadana; interessante è poi notare come entrambi i tipi raggiungano i centri della pannonia.
Le altre anforette adriatiche da pesce
esistono poi altre anforette, rinvenute ad aquileia nel canale anfora (fig. 10), peschiera (fig. 4a), castelfranco emilia99 e a urbisaglia100 (fig. 4b), i cui tituli picti e la presenza di impe-ciatura depongono a favore di un contenuto ittico, ma che morfologicamente si discostano dai precedenti tipi.
96 come si è visto, i tituli picti tracciati in rosso e in dimensioni maggiori in genere sembrerebbero riferirsi ad una fase di riutilizzo dell’anfora, a differenza di quelli scritti in nero, che solitamente presentano una grafia più ordinata e minuta.
97 sulla questione delle dressel 21/22 si rimanda al contributo di e. botte in questo volume. 98 l’esemplare di oderzo proviene da una bonifica databile tra il 45/50 e il 78/80 d.c.; a milano tali anforette
sono presenti già dalla prima età imperiale; la necropoli di biella si data tra la seconda metà del i e la metà del ii d.c., così come i contesti di torino (armeria reale).
99 gli esemplari di canale anfora sono inediti; per l’anfora rinvenuta a peschiera si veda pesavento mattioLi, Benvenuti 2001, pp. 170-172. per l’esemplare conservato al museo civico archeologico di castelfranco emilia, proveniente dal territorio e recante un doppio titulus pictus menzionante liquamen, cfr. cesari, neri 2006, p. 105.
100 faBrini, marengo 2002: l’anforetta proviene dall’area del tempio-criptoportico dell’antica Urbs Salvia.
fig. 10 - anforette adriatiche da pesce da aquileia.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
Le anfore da pesce adriatiche 231
si tratta di contenitori in genere caratterizzati da un orlo a fascia più o meno modanato, da collo troncoconico e da anse flesse a bastone. gli esemplari di castelfranco emilia e di ur-bisaglia presentano poi dimensioni estremamente ridotte, soprattutto nel diametro del corpo che non supera i 15 cm101.
Le anforette di Loron
un discorso a parte meritano, infine, le anforette rinvenute in quantità non trascurabili nell’officina istriana di loron, per le quali, considerata anche la presenza di frammenti defor-mati, è stata avanzata l’ipotesi di una produzione locale102.
la frammentarietà degli esemplari recuperati non permette di ricostruirne la forma com-pleta: essi si distinguono comunque dalle serie più piccole delle dressel 6b prodotte a loron soprattutto per le pareti sottili (1 cm circa) e per le dimensioni estremamente ridotte dell’or-lo, il cui diametro esterno al massimo arriva a misurare 8 cm103. gli esemplari presentati in questo volume da Yolande marion rivelano una varietà nella morfologia dell’imboccatura, che può presentarsi svasata verso l’alto (anche solcata da una linea ondulata) oppure a ciotola. alla prima variante di orlo sembrerebbe corrispondere un’ansa a sezione rotonda con gomito ad angolo ottuso104, caratteristica che è stata notata anche in alcune dressel 6b rinvenute sem-pre a loron in livelli di età imperiale105 e in un esemplare di concordia sagittaria (presente in una bonifica databile alla seconda metà del ii d.c.), che riporta il bollo retrogrado palma t.a.n+, noto anche nel sito produttivo istriano106. all’orlo a ciotola sembrerebbe invece asso-ciata un’ansa a gomito con angolo arrotondato e leggermente rilevato. il collo è sempre tron-coconico, la spalla arrotondata e il corpo ovoidale; l’altezza massima è stata stimata intorno ai 40/45 cm108.
il contenuto di queste anforette rimane incerto. il fatto di essere state rinvenute nel luo-go di produzione, dove probabilmente vennero “scartate” in una fase precedente all’utilizzo, spiega perché in nessuna di queste siano state riscontrate tracce di impeciatura e iscrizioni di-pinte; la “familiarità” con le anforette adriatiche da pesce, unitamente alle dimensioni estre-mamente ridotte dell’imboccatura (ancora più piccola rispetto alle altre), sembra comunque suggerire un contenuto ittico.
101 l’anfora di castelfranco emilia è alta 51 cm. 102 Lorun, Loron 2005, p. 124, fig. 7, n. 8; cfr. inoltre il contributo di Y. marion in questo volume. 103 alla luce della proposta di Y. marion di fissare come criterio discriminate tra le dressel 6b di grande for-
mato e le dressel 6b di piccolo formato il diametro esterno inferiore a 11 cm, si potrebbe quindi considerare, ai fini della distinzione tra queste anforette e le dressel 6b piccole prodotte a loron, la misura del diametro esterno inferiore a 8 cm.
104 come attesta anche l’esemplare rinvenuto a loron nella campagna di scavo del 2004 (Lorun, Loron 2005, fig. 7, n. 8), dove si nota il caratteristico “nastro di argilla” che modella l’attacco inferiore nell’ansa nel punto di unione con la spalla, che pare essere un elemento distintivo di molte delle anfore prodotte nell’officina.
105 carre et al. 2005, p. 111, fig. 14.106 per l’anfora di concordia sagittaria cfr. BeLotti 2004, p. 86, anfora n. 50; per quella di loron cfr. carre et
al. 2005, p. 109. 108 carre et al. 2005, p. 111.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
232 marie-Brigitte carre, stefania pesavento mattioLi, chiara BeLotti
L’apporto deLLe anfore aLLa questione deLLa produzione di garum e salsamenta neLL’adriatico
nonostante siano ancora molti i problemi che rimangono aperti, la revisione dei dati sul-le anfore testimonianti un consumo di prodotti ittici nelle zone servite dalle rotte dell’adriati-co ha offerto alcuni spunti di riflessione che possono servire di base per ulteriori approfondi-menti.
in primo luogo si è potuto constatare che alle importazioni di garum e salsamenta dall’italia meridionale e dalla sicilia, dalla spagna, dal mediterraneo orientale e dall’africa, testimoniate dall’arrivo di anfore ivi fabbricate, si affianca, lungo un arco piuttosto ristretto di tempo (entro la metà del i secolo d.c. al massimo), il riutilizzo di anfore vinarie e olearie locali per contenere salse diverse, come provano le iscrizioni, o pesce conservato, come mo-strano resti di una certa consistenza ancora presenti all’interno (verona e salisburgo). per tali prodotti si può ipotizzare una provenienza dalla spagna in altre anfore o in botti o barili e un travaso all’arrivo in anfore che erano facilmente disponibili o in piccoli contenitori dei quali non resta traccia riconoscibile109. l’uso di contenitori di dimensioni modeste per le salse di pesce è d’altronde confermato dagli urcei pompeiani e nelle nostre zone dalla presenza di un titulus pictus menzionante il liquamen su un frammento di trieste riconosciuto come di cera-mica comune110.
dopo la metà del i secolo d.c. e sopratutto con gli inizi del ii cominciano ad essere usate piccole anfore, che per la loro forma si segnalano come di fabbricazione locale: la creazione di contenitori specifici a nostro parere è un chiaro indizio dell’avvio nei territori dell’adriatico di una produzione di salse come il liquamen, il cui particolare pregio è segnalato dalla frequente menzione flos. non si può escludere tuttavia che in situazioni particolari si riutilizzassero per il liquamen flos anfore di recupero: è questo il caso delle anfore di origine cretese (anch’esse di non grandi dimensioni e impeciate), rinvenute a corte cavanella nel polesine, dove le indica-zioni dei tituli rimandano allo stesso prodotto111.
stando alle presenze quantitative delle anforette adriatiche da pesce nell’italia settentrionale padana e nelle province danubiane, il consumo di tali salse, che si affiancava a quello non inter-rotto di salsamenta e garum importati, non prevedeva quantitativi molto grandi e non necessita-va di contenitori molto capienti. questa trasformazione trova confronto, senza poter per adesso mettere in connessione i due dati, con l’evoluzione nella misura delle dimensioni dei contenitori della valle del rodano: qui le imitazioni di anfore spagnole spariscono dai siti di consumo alla fine del i sec. d.c. e sembra che vi succedano altri contenitori come brocche o anforette112, su una delle quali, di sicura fabbricazione lionese, un titulus pictus menziona il liq(uamen)/ Apic /G. Rufi113, con una formula molto vicina a quella dei tituli picti della cisalpina.
se l’analisi generale delle anfore da pesce, in rapporto alle importazioni scandite nel tem-po e alla presenza di un gruppo di contenitori riconducibili all’ambito adriatico sia per mor-fologia che per direttrici di diffusione, depone dunque a favore di una produzione locale di contenitori (e di conseguenza del loro contenuto), ancora non sono individuabili le zone dove col-
109 non è escluso tuttavia che anche in cisalpina possa esserci stata una produzione di contenitori imitanti le anfore da pesce iberiche, in modo analogo a quanto successe nella valle del rodano (cfr. supra). le indagini finora condotte sulle anfore della Venetia non hanno fornito elementi in tal senso; rimangono da analizzare le centinaia di anfore rinvenute in emilia e tuttora inedite.
110 maseLLi scotti et al. 2004, pp. 99-101: il contesto di ritrovamento è databile entro la metà del i sec. d.c.111 tonioLo 1987, pp. 90-92: le anfore, ora identificate come ac4, hanno tutte subito un processo di viraggio
cromatico molto intenso (sul quale si intende avviare un progetto di indagini archeometriche).112 desBat, dangreaux 1997, pp. 92-94.113 desBat, Liou, LequÉment 1987, pp. 154-156, l17, fig. 7.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
Le anfore da pesce adriatiche 233
locare tale produzione, che non risulta attestata nelle fornaci note (con esclusione forse del caso di loron). neppure le analisi archeometriche sono state di aiuto, poiché tutti i campioni analizzati sia dal punto di vista minero-petrografico che chimico risultano comporre un gruppo molto omoge-neo, ma che, tranne casi sporadici, non trova confronto con i gruppi risultanti dalle analisi di con-tenitori la cui origine è certa (come in particolare per le anfore istriane) o ipotizzabile con un certo margine di sicurezza (come ad esempio per quelle attribuite all’ambito medioadriatico).
le anfore da pesce adriatiche risultano quindi molto meno “eloquenti” rispetto a quelle da vino e da olio: si è cercato tuttavia di proporre un quadro di insieme nel quale poter inseri-re i dati di nuovi ritrovamenti e di ulteriori analisi archeometriche che possano offrire risposte alle molte domande che ancora rimangono in sospeso.
1 - tabella riassuntiva delle attestazioni delle anforette adriatiche da pesce.
anforette adriatiche da pesce tipo “grado 1”Luogo di rinvenimento Impeciatura Tituli picti Bibliografia
relitto di grado X Liquamen auriemma 2000, pp. 34-37 trieste (piazza barbacan; via del seminario)
degrassi, maggi, mian in questo volume
aquileia, canale anfora X Liquamen esemplari ineditiaquileia (loc. colombara) maseLLi scotti 1998, p. 110, fig. 4 aquileia (vecchi ritrovamenti) Liquamen esemplare ineditooderzo X lettere
illeggibilisandrini, saccocci, raLLo 1988, p. 82, fig. 23, n. 3
altino X Liquamen cipriano, ferrarini in questo volumepadova (loc. roncaglia) esemplari ineditieste X Garum? pesavento mattioLi, Benvenuti 2001, p. 172, fig. 3 cavriana portuLano 2007, p. 272, fig. 1, n. 5corte cavanella (rovigo) X Liquamen tonioLo 1987, fig. 20villadose (rovigo) comunicazione di g.m. facchinibrescia (Capitolium) Bruno 2002, nn. 3, 4brescia (santa giulia) Bruno, Bocchio 1999, p. 233, tav. Xcviii, nn. 1-2brescia (vari contesti urbani) Bruno 1996, p. 200, fig. 131; Bruno, Bocchio 1999,
p. 233brescia - Domus ortaglia esemplare inedito torino (armeria reale) quiri in questo volume, fig. 3aidussina vidrih perko, ŽBona thkman 2005, fig. 4, n. 4 vindobona Liquamen bezeczky 2005, pl. 14, n. 102
anforette adriatiche da pesce “con orLo a fascia” Luogo di rinvenimento Impeciatura Tituli picti Bibliografia
aquileia (canale anfora) X esemplari ineditiaquileia (villa raspa) esemplare inedito concordia sagittaria (piazzale) esemplare inedito oderzo cipriano, ferrarini 2001, p. 68altino X cipriano, ferrarini in questo volumepadova. roncaglia inedito verona (museo archeologico) pavoni, BeLotti 2005, fig. 1brescia (villa faucanier) esemplare ineditobrescia (contesti vari) Bruno 1996, fig. 131, n. 1
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
234 marie-Brigitte carre, stefania pesavento mattioLi, chiara BeLotti
voghenza Voghenza 1984, p. 150, n. 4, tav. XXXiii, tomba 51, n. 4
milano (metropolitana) Bruno, Bocchio 1991, tav. cXviii, nn. 116,118milano (cortili università cattolica)
Bruno 2003, fig. 1, n. 6
vercelli (museo leone) BrecciaroLi taBoreLLi 1987, p. 147, tav. X, n. 3tortona BrecciaroLi taBoreLLi 1987, p. 147ivrea BrecciaroLi taBoreLLi 1998, p. 88, nn. 195-196, tav.
XXXv, nn. 195-196biella brecciaroLi taBoreLLi 2000, pp. 284-285, 250-251,
tombe nn. 315, 222, 323 torino (armeria reale) quiri in questo volumeurbisaglia forti 2004vis gLušcevic 2006, tav. ii, n. 8vindobona bezeczky 2005, pl. 14, n. 100
Altre Anforette AdriAtiche dA pesce Luogo di rinvenimento Impeciatura Tituli picti Bibliografia
aquileia, canale anfora X Liquamen esemplari inediti peschiera X Liquamen pesavento, Benvenuti 2001, pp. 170-172urbisaglia (ancona) Muria faBrini, marengo 2002castelfranco emilia (territorio) Liquamen cesari, neri 2006, p. 105
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
Le anfore da pesce adriatiche 235
BiBLiografia
auriemma r. 2000, Le anfore del relitto di Grado e il loro contenuto, in MEFRA, 112, pp. 27-51.Baggio Bernardoni e. 2002, Un santuario occidentale? Un problema aperto, in Este prero-mana: una città e i suoi santuari, a cura di a. ruta serafini, treviso, pp. 276-280.BaLdacci p. 1967-68, Alcuni aspetti dei commerci nei territori cisalpini, in AttiCeSDIR, 1, pp. 7-50.BaLdacci p. 1972, Le principali correnti del commercio di anfore romane nella Cisalpina, in I problemi della ceramica romana di Ravenna, della Valle Padana e dell’alto Adriatico (Raven-na 1969), bologna, pp. 103-131.Baratta g. 1994, circa alpes ligneis vasis condunt circulisque cingunt, in ArchClass, Xlvi, pp. 233-260.Baudoux j. 1996, Les amphores du nord-est de la Gaule, paris (daf, 52). BeLotti c. 2004, Ritrovamenti di anfore a iulia concordia: aspetti topografici ed economici, gruaro (venezia).BeLotti c. 2008, Le importazioni di derrate dal Mediterraneo orientale nella Cisalpina in età romana: i dati delle anfore (tesi di dottorato di ricerca in scienze archeologiche, università di padova).Bezeczky t. 1994, Amphorenfunde vom Magdalensberg und aus Pannonien. Ein Vergleich, Klagenfurt.Bezeczky t. 1998, Amphora types of Magdalensberg, in AVes, 49, pp. 225-242.Bezeczky t. 2005, Roman Amphorae from Vindobona, in vindobona. Beiträge zu ausgewähl-ten Keramikgattungen in ihrem topographischen Kontext, a cura di f. Krinzinger, AF, 12, Wien, pp. 35-107.BjeLajac 1996, Amfore gornjomezijskog Podunavlja [Amphorae of the Danubian Basin in Up-per Moesia], Archäologisches Institut, Belgrad, Monographien, 30, belgrado. Bonifiche e drenaggi 1998 = Bonifiche e drenaggi con anfore in epoca romana: aspetti tecnici e topografici, atti del seminario di studi (padova, 19-20 ottobre 1995), a cura di s. pesavento mattioli, modena.Botte e. 2008, Salaison et sauces de poissons en Italie méridionale et en Sicile durant l’Anti-quité, thèse de doctorat, université lumière lyon 2, sous la direction de m. Jean-Yves em-pereur.BrecciaroLi taBoreLLi L. 1987, Per una ricerca sul commercio nella Transalpina occidentale in età romana: ricognizione sulle anfore di “Vercellae”, in Atti del Convegno di Studi nel centenario della morte di Luigi Bruzza, 1883-1983 (Vercelli, 6-7 ottobre 1984), vercelli, pp. 129-208.BrecciaroLi taBoreLLi L. 1998, La villa suburbana di Eporedia, in QuadAPiem, 15, pp. 41-92.BrecciaroLi taBoreLLi L. 2000, Alle origini di Biella. La necropoli romana, torino. Bruno B. 1996, Le anfore, in Carta archeologica della Lombardia. V. Brescia. La città, mode-na, pp. 199-205.Bruno B. 2003, Le anfore della Cava UC VII. Considerazioni sulle anfore nei contesti data-bili tra la tarda età antonina e la prima età Severiana, in Dall’antichità al Medioevo. Aspetti insediativi e manufatti, atti delle giornate di studio (milano, 24 gennaio 2000; milano, 24 gennaio 2001), a cura di s. lusuardi siena, m.p. rossignani, milano, pp. 85-97. Bruno B. 2002, Importazioni e derrate nel tempio: l’evidenza delle anfore, in Nuove ricerche sul capitolium di Brescia. Scavi, studi, restauri, a cura di f. rossi, milano, pp. 277-307.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
236 marie-Brigitte carre, stefania pesavento mattioLi, chiara BeLotti
Bruno B., Bocchio s. 1991, Anfore, in Scavi MM3. Ricerche di archeologia urbana a Milano durante la costruzione della linea 3 della metropolitana. 3.1. I reperti, a cura di d. capogros-so, milano, pp. 259-298.Bruno B., Bocchio s. 1999, Le anfore da trasporto, in S. Giulia di Brescia gli scavi dal 1980 al 1992: i reperti preromani, romani e alto medioevali, a cura di g.p. brogiolo, firenze, pp. 231-260.carre m.-b. 1985, Les amphores de la Cisalpine et de l’Adriatique au début de l’Empire, in MEFRA, 97, 1, pp. 207-245. carre m.-B., pesavento mattioLi s. 2003a, Anfore e commerci nell’Adriatico, in L’archeolo-gia dell’Adriatico dalla Preistoria al Medioevo, a cura di f. lenzi, atti del convegno (raven-na, 7-9 giugno 2001), firenze, pp. 268-285.carre m.-B., pesavento mattioLi s. 2003b, Tentativo di classificazione delle anfore olearie adriatiche, in AquilNost, lXXiv, cc. 453-476.carre et al. 2005= carre m.-B., kovacic v., marchiori a., rosada g., tassaux f., Lorun-Loron, Porec-Parenzo, Istria. Una villa maritima nell’agro parentino: la campagna di ricerca 2004, in HistriaAnt, 13, pp. 99-118.cesari, neri 2006 = Guida al Museo Civico di Castelfranco Emilia, a cura di l. cesari, d. neri, castelfranco emilia (modena). cipoLLa c. 1891, Verona, in NSc, pp. 9-14.cipriano s. 2001, Aspetti economici, in Concordia Sagittaria tremila anni di storia, a cura di p. croce da villa, e. di filippo balestrazzi, concordia sagittaria, pp. 192-196.curtis r.i. 1991, garum and salsamenta: production and commerce in materia medica (stu-dies in ancient medicine 3), leiden. deLL’amico p. 1997, Il relitto di Grado: considerazioni preliminari, in Archeologia subacquea. Studi, ricerche e documenti. II, roma, pp. 93-128.deLussu f., Wikens B. 2000, Le conserve di pesce. Alcuni dati da contesti italiani, in MEFRA, 112, pp. 53-654. desBat a. 1991, Un bouchon de bois du Ier s. ap. J.-C. recueilli dans la Saône à Lyon et la question du tonneau à l’époque romaine, in Gallia, 48, pp. 319-336.desBat a., dangreaux b. 1997, La production d’amphores à Lyon, in Les productions des ate-liers de potiers antiques à Lyon; 2eme partie: les ateliers du Ier s. ap. J.-C., a cura di a. desbat, Gallia, 54, pp. 73-104.desBat a., Lemaître s. 2000, Les premières importations d’amphores de Bétique à Lyon, in Congreso Internacional ex baetica amphorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el Im-perio Romano (Sevilla-Écija, 17-20 de diciembre de 1998), Écija, pp. 793-815.desBat a., Liou b., LequÉment r. 1987, Inscriptions peintes sur amphores: Lyon et Saint-Romain-en-Gal, in Archaeonautica, 7, pp. 141-166.desBat a., martin kiLcher s. 1989, Les amphores sur l’axe Rhône-Rhin à l’époque d’Au-gust, in Amphores romaines et histoire économique: dix ans de recherche, actes du colloque de sienne (22-24 mai 1986), rome, pp. 341-365.egger r. 1963, Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1960 und 1961, in Carinthia I, 153, pp. 3-297.ehmig u. 2003, Die römischen Amphoren aus Mainz, möhnesee. Étienne r., mayet f. 1991, Le garum à la mode de scaurus, in Alimenta, pp. 187-194.Étienne r., mayet f. 2002, Salaisons et sauces de poisson hispaniques, Trois clés pour l’écono-mie de l’Hispanie romaine, ii, paris.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
Le anfore da pesce adriatiche 237
faBrini g.m., marengo s.m. 2002, L’uso della salsa da pesce nella testimonianza di un’anfo-retta urbisalviense, in Picus, XXii, pp. 115-130.forti s. 2004, Nuovi esemplari di anfore tipo “Grado I” da urbs salvia, in Picus, XXiv, pp. 101-123.gLušcevic s. 2006, Vis, l’antico porto, in Archeologia subacquea in Croazia. Studi e ricerche, a cura di i. radic rossi, venezia, pp. 59-89.heger n. 1986, Frührömische Amphoren aus der Stadt Salzburg (Mozartplatz 4), in Grabun-gen im Hof des Hauses Mozartplatz 4 in Salzburg, Bayerische Vorgeschichtsblätter, 51, pp. 132-161.LauBenheimer f. 2004, Les inscriptions peintes sur les amphores gauloises, in Gallia, 61, pp. 153-171.Lepiskaar J. 1986, Tierreste in einer römischen Amphore aus Salzburg (Mozartplatz 4), in Grabungen im Hof des Hauses Mozartplatz 4 in Salzburg, Bayerische Vorgeschichtsblätter, 51, pp. 163-185Liou B. 1988, Le contenu des amphores, typologie et épigraphie: quelques cas aberrants ou em-barrassants, in SFECAG, actes du congrès d’orange (12-15 mai 1988), marseille, pp. 171-177.Liou B. 1993, Inscriptions peintes sur amphores de Narbonne (Port-la-Nautique), in Archaeo-nautica, 11, pp. 131-148.Liou B. 1998, Inscriptions peintes sur amphores de Narbonne. Port-La-Nautique (Aude). III, in RANarb, 31, pp. 91-102.Liou B., rodriguez aLmeida e. 2000, Les inscriptions peintes des amphores du Pecio Gandol-fo (Almeria), in MEFRA, 112, pp. 7-25.Lorun, Loron 2005 = marchiori a., kovacic v., cipriano s., mondin c., mazzocchin s. 2005, Progetto “L’Istria e il mare”: Lorun-Loron (Porec-Parenzo, Istria). Lo scavo di un com-plesso di età romana nell’agro parentino (2004), in QuadAVen, XXi, pp. 116-128.maidL v. 1990, Die Inschriften auf den Amphoren vom Magdalensberg und ihre wirtschaftli-chen Aspekte. Eine Zusammenfassung, in Carinthia I, 180, pp. 63-84.maier maidL v. 1991, Graffiti und dipinti auf Keramik, in Instrumenta inscripta latina, cata-logo della mostra, pécs, p. 122.maier maidL v. 1992, Stempel und Inschriften auf Amphoren vom Magdalensberg, Klagen-furt.marLière e. 2002, L’outre et le tonneau dans l’Occident romain, montagnac.martin kiLcher s. 1990, Fischsaucen und Fischconserven aus dem römischen Gallien, in Ar-chéologie Suisse, 13, pp. 37-44.martin kiLcher s. 1994, Die römischen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst, augst. martin kiLcher s. 2002, lucius urittius verecundus, négociant à la fin du Ier siècle, et sa marchandise découverte à Mayence, in Vivre, produire et échanger: reflets méditerranéens, mélanges offerts à bernard liou, a cura di l. rivet, m. sciallano, montagnac, pp. 343-353.maseLLi scotti f. 1998, Bonifiche e drenaggi con anfore ad Aquileia, in Bonifiche e drenaggi 1998, pp. 107-111.maseLLi scotti f. 2005, Aquileia, Canale Anfora, in AquilNost, lXXvi, 2005, cc. 372-376.maseLLi scotti f. et al. 2004 = maseLLi scotti f., degrassi v., mandruzzato L., mian g., provenzaLe v., riccoBono d., tiussi c. 2004, La domus di Piazza Barbacan (Trieste): le fasi e i materiali, in AttiMemIstria, civ (lii n. s.), pp. 19-158.
Olio e pesce in epoca romana: produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico
238 marie-Brigitte carre, stefania pesavento mattioLi, chiara BeLotti
mazzocchin s. 1998, Un caso in area extraurbana: Roncaglia di Ponte San Nicolò, in Bonifi-che e drenaggi 1998, pp. 169-174.pavoni m.g., BeLotti c., Anfore romane a Verona: la collezione del Museo Archeologico, in QuadAVen, XXi, pp. 183-191. pesavento mattioLi s. 2000a, Anfore: problemi e prospettive di ricerca, in Produzione cera-mica in area padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricer-ca, atti del convegno internazionale (desenzano del garda, 1999), a cura di g.p. brogiolo, g. olcese, mantova, pp. 107-120.pesavento mattioLi s. 2000b, Anfore betiche in Italia settentrionale: direttrici di approvvi-gionamento e rapporti con le produzioni locali di olio e di conserve e salse di pesce (I e II secolo d.C.), in Congreso Internacional ex baetica amphorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano (Sevilla-Écija, 17-20 de diciembre de 1998), ecija, pp. 733-757.pesavento mattioLi s. 2002, Una produzione nord-italica di anfore bollate, in Vivre produire et échanger: reflets méditerranéens, a cura di l. rivet, m. sciallano, montagnac, pp. 391-394. pesavento mattioLi s., Benvenuti e. 2001, Due anforette con tituli picti dal Veneto, in Qua-dAVen, Xvii, pp. 169-173.pesavento mattioLi s., Buonopane a. 2002, Alcuni tituli picti su anfore di produzione beti-ca rinvenute nel porto di Pisa, in L’Africa romana, atti del Xiv convegno di studio (sassari, 7-10 dicembre 2000), a cura di m. Khanoussi, p. ruggeri, c. vismara, pp. 789-800.piccottini g. 2000-2001, Neues zum Wein- und Lebensmittelimport in die Stadt auf dem Magdalensberg, Kärnten, in AAustr, 84-85, pp. 373-385.portuLano B. 2007, Le principali fasi di occupazione della “villa rustica” di San Cassino di Cavriana, scavi 1968/69. il contributo dei materiali rinvenuti nel riempimento della cisterna: alcune riflessioni, in Contributi di Archeologia in memoria di Mario Mirabella Roberti, atti del Xvi convegno archeologico (cavriana, 15-16 ottobre 2005), AnnBenac, Xiii-Xiv, pp. 271-285.sandrini g.m., saccocci a., raLLo g. 1988, Cinque pozzi romani ad Oderzo, in QuadA-Ven, iv, pp. 63-95. scafiLe f. 1980, Un deposito di anfore romane rinvenuto a Novara, in Studi di Archeologia dedicati a Pietro Barocelli, torino, pp. 220-222. siLvino t., poux m. 2005, Où est passé le vin de Bétique ? Nouvelles données sur le conte-nu des amphores dites «à sauces de poisson et à saumures» de types Dressel 7/11, Pompéi VII, Beltrán II (Ier s. av. J.-C. - IIe s. apr. J.-C.) in SFECAG, actes du congrès de blois (5-8 mai 2005), marseille, pp. 501-514. tassaux f. 2001, Production et diffusion des amphores à huile istriennes, in Strutture portuali e rotte marittime nell’Adriatico di età romana, a cura di c. zaccaria, Antichità Altoadriatiche, Xlvi, pp. 501-543.tonioLo a. 1987, I contenitori da trasporto di età romana nel Polesine di Rovigo, in AVen, X, pp. 87-128.tonioLo a. 2002-2003, Uso e commercio di oggetti da riutilizzare nell’antichità. Un caso nor-dadriatico, in AVen, XXv-XXvi, pp. 109-147.vidrih perko v., ŽBona thkman B. 2005, Ceramic finds from Ajdovšcina-fluvio frigido, an early roman road station and late roman fortress castra, in ReiCretActa, 39, pp. 277-286.Voghenza 1984 = Voghenza. Una necropoli di età romana nel territorio ferrarese, ferrara.