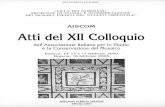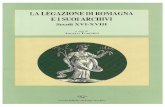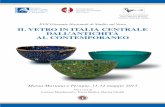Controversie sul Sabato e sul Millennio: secondo i Gädl inediti di Täwäldä-Mädḫən e di Fiqəṭor
Mediolanum: dati inediti dallo studio dei livelli preromani
Transcript of Mediolanum: dati inediti dallo studio dei livelli preromani
MEDIOLANUM : DATI INEDITI DALLO STUDIO DEI LIVELLI PREROMANI
Stefania Casini (1), Marco Tizzoni (2)
Riassunto. Gli Autori prendono in considerazione le origini di Mediolanum alla luce degli ultimi scavi effettuati nella città dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia e in particolar modo i materiali provenienti dagli scavi di via Moneta, di grande importanza sia per la loro estensione sia per il fatto che vennero condotti sino al raggiungimento del terreno sterile. I materiali che indicano con certezza la presenza di un insediamento nell’area di Mediolanum risalgono al periodo Golasecca III A (seconda metà V-prima metà IV secolo a.C.). Questa fase più antica è caratterizzata da bronzi e ceramiche che trovano precisi confronti in altri abi-tatati e sepolture di questa cultura. Inoltre, a partire dal IV secolo a.C. compare anche una ceramica definita di “tipo ligure”, essendo caratteristica degli abitati dell’Appennino ligure e piemontese, ma che oltre ad essere presente anche in ampie zone del Piemonte si trova in altri siti lombardi ed è presente con ritrovamenti isolati anche nell’area etrusco-padana. Per quanto riguarda il LT C e D è stato possibile appurare la presenza di ceramiche iberiche e di probabili imitazioni prodotte localmente. Tali ceramiche giungevano nella città tramite i porti liguri e mostrano come Milano fosse parte di un’estesa rete commerciale gestita dai mercanti italici e che si estendeva anche ben oltre le coste tirreniche.
Résumé. Les auteurs considèrent les origines de Mediolanum à la lumière des fouilles récentes effectuées dans la ville par le Service Archéologique National. Ils examinent tout spécialement les matériaux des fouilles de la Rue Moneta, de grande importance dans la mesure où il s’agit de fouilles très étendues et conduites jusqu’au niveau du terrain stérile. Les matériaux qui indiquent avec certitude la présence d’un habitat dans la zone de Mediolanum remontent à la période Golasecca III A (seconde moitié Ve – première moitié IVe siècle av. J.-C.). Cette phase ancienne est caractérisée par des bronzes et des céramiques qui trouvent des comparaisons précises dans d’autres habitats et sépultures de cette culture. En outre, à partir du IVe siècle apparaît une céramique dite de « type ligure », qui est caractéristique des habitats des Apennins Ligures et du Piémont. Elle a été retrouvée dans de vastes zones du Piémont et dans d’autres sites de la Lombardie et, avec des découvertes isolées, également dans la zone de l’Étrurie de la plaine du Pô. Pour ce qui concerne la période LT C et D, on a pu s’assurer de la présence de céramiques ibériques et de probables imitations produites localement. Ces céramiques arrivaient dans la ville par l’intermédiaire des ports liguriens et elles montrent que Milan faisait partie d’un vaste réseau commercial géré par les mercatores italici et qui s’étendait aussi au-delà des côtes tyrrhéniennes.
(1) Civico Museo Archeologico, piazza Cittadella 9 - I - 24129 Bergamo - [email protected](2) Via Pria Forà 4 - I - 20127 Milano - [email protected]
Dalla prima sintesi di R.C. de Marinis nel 1984 (de Marinis, 1984, p. 28-32), che faceva il punto sui rari ritro-vamenti preromani di Milano, la documentazione si è note-volmente arricchita grazie ai numerosi scavi archeologici effettuati nel centro della città, a tal punto che oggi è neces-sario rianalizzare l’insieme dei materiali protostorici in un contesto più ampio che consideri anche gli aspetti storici, economici e politici di Mediolanum preromana.
Come evidenziato da de Marinis (de Marinis, 1984, p. 28-29), durante i primi secoli della I Età del ferro l’area su cui sorge Milano non ha restituito testimonianze di insediamento, né di frequentazione, al contrario della fas-cia di territorio a settentrione. Con lo sviluppo della cultura di Golasecca e l’intensificarsi dei commerci nel V secolo a.C., l’area milanese vede la formazione di piccoli
centri, quali Melzo, Melegnano, Legnano, Cuggiono e la comparsa di Mediolanum.
Definire il momento di fondazione dell’abitato gola-secchiano resta a tutt’oggi difficoltoso. La fibula ad arco serpeggiante di tipo Gaiaccio (Ceresa Mori, 2001, fig. 2), rinvenuta in giacitura secondaria in un livello di via Moneta (fig. 2, A) è attribuibile al G. II B, ma tale singolo indizio è da considerare con cautela nello stabilire la pre-senza di un vasto insediamento, del quale si può invece parlare per quanto riguarda il successivo periodo G. III A1.
Ritrovamenti di questo periodo denotano, infatti, la presenza di un abitato piuttosto esteso (come minimo di circa 80 ettari (Ceresa Mori, Tizzoni, 2004, p. 44), definito
1. Carta di distribuzione dei rinvenimenti golasecchiani in de Marinis 1984, fig. 23, aggiornata in Ceresa Mori, Tizzoni 2004, fig. a p. 42.
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 355p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Stefania Casini, Marco Tizzoni
356 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
dai numerosi ritrovamenti, prevalentemente databili tra la seconda metà del V e la prima metà del IV secolo a.C., con l’eccezione di alcune ceramiche rinvenute nello scavo nel cortile di Palazzo Reale (fig. 1, D), le cui forme sono attestate nel corso di tutto il V secolo a.C. (Jorio, 1987, p. 133, fig. 130). Da via Meravigli proviene un simulacro di fibula (fig. 1, C), attribuibile con ogni probabilità alle fasi G. III A2 e A3, da piazza Cordusio un’armilla a punte stondate e una fibula Certosa di tipo Teržan Xa (fig. 1, A), entrambe attribuite al G. III A2, da via Valpetrosa un altro simulacro di fibula e ceramiche tra cui olle cordonate (Ceresa Mori, 1992-93). Dallo scavo condotto presso la Biblioteca Ambrosiana, oltre a ceramiche golasecchiane, si conoscono anche un simulacro di fibula e due fibule Certosa, di cui una di tipo X-n2 databile al G. III A3 (fig. 1, B). Ceramiche golasecchiane in giacitura secondaria sono state rinvenute nello scavo presso la Basilica di S. Eustorgio (Casini, Tizzoni, 2009), tutte inquadrabili a par-tire dal G. III A3. Le ciotole carenate rinvenute in via Cesare Correnti e in via Conca del Naviglio, oltre che al Carrobbio (Ruffa, 2004, p. 46-49), non sono a nostro avviso sufficienti per attribuire questi ritrovamenti al V secolo a.C., poiché la loro presenza in contesti di LT B e C è documentata non solo in molte associazioni tombali, ma anche nei livelli preromani di via Moneta3 e la varia-bilità della forma molto elevata ha reso finora difficile individuare un elemento di discrimine tra i pezzi golasec-chiani e quelli La Tène4.
I due ritrovamenti dell’Ospedale Maggiore (S. Antonino) e di San Pietro in Sala5 attestano la presenza di aree sepolcrali del G. III A, poste rispettivamente a sud-est e a nord-ovest dell’abitato, probabilmente lungo le due principali vie di accesso, l’una dalla regione dei laghi e l’altra dal Lodigiano. Il ritrovamento di Sant’Antonino (fig. 1, E) si data al G. III A3 per la presenza di una fibula di tipo Lodigiano var. B, una di tipo tardo-alpino var. C, oltre all’anello decorato a occhi di dado.
Un discorso a parte, a seguito di ulteriori verifiche, merita il ritrovamento di via S. Maria Segreta, dal quale proverrebbero due kantharoi di bucchero pesante databili alla fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C., poiché tali materiali furono acquistati sul mercato antiquario, fatto che ne rende incerta la provenienza (de Marinis, 1984, p. 31, fig. 19).
2. Ceresa Mori et alii, 1990, p. 179, figg. 196-198 ; Tizzoni, 1992, fig. a p. 261.3. Per i contesti tombali si vedano Stöckli, 1975, p. 19, Abb. 18, Tori et alii, 2010, p. 205-206.4. Per una breve descrizione del problema si veda Casini, Motta, 2011, p. 461-463.5. S. Antonino : de Marinis, 1981, p. 168-170, tav. 58, n° 1-8. Non posse-diamo una relazione sui ritrovamenti di San Pietro in Sala, ma un disegno di P. Castelfranco conservato presso il Museo Archeologico P. Giovio di Como sul quale sono annotati i ritrovamenti golasecchiani di Milano. Accanto alla dicitura S. Antonino è riportato anche questo ritrovamento. Gli Autori ringraziano la dott. Marina Uboldi che ha gentilmente fornito le immagini del disegno del Castelfranco.
In questo contesto sono particolarmente importanti i ritrovamenti di via Moneta, data l’estensione dello scavo e il fatto che sia stato indagato l’intero deposito, fino ai livelli sterili. A tutt’oggi si tratta del sito chiave per la comprensione della successione insediativa e dei caratteri culturali che questa ha assunto nel corso del tempo, in particolare per analizzare il passaggio tra gli aspetti gola-secchiani e quelli La Tène, succedutisi senza soluzione di continuità.
I lIvellI pIù antIchI dello scavo dI vIa Moneta
Quelli che possiamo considerare i livelli più antichi della I fase di insediamento (V-III secolo a.C.), hanno restituito ciotole decorate a vernice rossa corallina, in un caso, probabilmente riferibile a una ciotola carenata (US 2169, fig. 2, B), associata a una fibula Certosa tipo IX-a di B. Teržan (Teržan, 1977, p. 329-330, fig. 22), datata dai contesti paleoveneti alla prima metà del V secolo a.C. (Este III medio) ; il tipo è diffuso in area slovena e ates-tina, ma non mancano attestazioni in Trentino Alto Adige. Nella cultura di Golasecca esemplari sono presenti nel Canton Ticino (ripostiglio di Arbedo, Gudo t. 39 e Cerinasca t. 75) e in territorio bergamasco a Zanica e Verdello6. L’aspetto interessante riguarda il fatto che si tratti di una delle testimonianze più antiche dell’insedia-mento golasecchiano.
Una ciotola con pittura rossa corallina, con confronti nella tomba della Ca’ Morta 110 del G. III A2 (de Marinis, 1981, tav. 39, n° 9-11), è in un altro caso (US 1324, fig. 2, C1) associata ad un frammento probabilmente di una coppa decorata a stralucido rosso (fig. 2, C2), un tipo attestato in numerose tombe del G. III A1, assai raro nella fase successiva, e a olle ovoidi di impasto anche grosso-lano (fig. 2, C3-4), che hanno molti confronti nell’abitato protostorico di Como, in particolare in via Isonzo-La Pesa7, dove compaiono a partire dai livelli di G. III A1. Gli stessi confronti valgono anche per la ciotola e per le olle di impasto grossolano dell’ US 587 (fig. 2, D1-2 e 6-7). Queste unità stratigrafiche di via Moneta potrebbero essere dunque attribuite al G. III A1/A2.
Sempre sulla base dei confronti con la ceramica dall’abitato protostorico di Como, alcuni livelli possono essere datati alle fasi più recenti del G. III A (A2/A3) (UUSS 591, 2068, 1216, 288, 1760) ; le olle di impasto grossolano di forma ovoidale (fig. 3, A5, B8-9 ; fig. 5, A4, B7 ; fig. 6, A1), decorate sulla spalla con linee di unghiate trovano confronto tra le ceramiche di via Isonzo-La Pesa (Casini et alii, 2001, fig. 15, n° 2, 5, 14 ; fig. 16, n° 10-12)
6. Le fibule di Zanica e Verdello in Casini, 1988, in cui sono erronea-mente classificate come tipo VII-c.7. Il materiali di Prestino, via Isonzo-La Pesa è ancora prevalentemente inedito. Per un’esemplificazione dei confronti citati si veda Casini et alii, 2001, fig. 14, n° 2 (G. III A1) e fig. 14, n° 10 (G. III A2).
MediolanuM : dati inediti dallo studio dei livelli preromani
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 357p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
e hanno un riferimento cronologico nelle sepolture di Esino Lario (Casini, 1983) del G. III A3-LT B. Nell’insediamento di Como sono in uso a partire dai livelli del G. III A2.
In questi livelli più tardi di via Moneta compaiono anche olle di impasto grossolano, lavorate al tornio, con un caratteristico orlo a sezione triangolare poco sviluppato (fig. 4, B11, fig. 5, B6, fig. 9, A4), che sembrano anticipare le olle di grandi dimensioni caratterizzate da un impasto grossolano di colore beige chiaro, inornate o decorate sulla spalla da solcature orizzontali inframmezzate da tacche, sempre con orlo triangolare, ma espanso che risul-tano frequenti nei livelli medio e tardo La Tène. È possi-bile che questa forma compaia nel G. III A3 e che abbia uno sviluppo nel corso del LT B ; in questo periodo ha un’attestazione anche a Prestino, via Isonzo-La Pesa8.
A partire dai livelli di IV secolo a.C., accanto alla ceramica golasecchiana, compaiano una forme molto dif-fusa in ambiente ligure tra IV e II secolo a.C. Si tratta di olle di impasto grossolano, con corpo situliforme, spesso eseguite senza il tornio e con una decorazione a chevrons o a tratti obliqui incisi sulla spalla, che talvolta presentano anche una serie di tacche sul margine del piede (fig. 6, A2-5, fig. 9, A3). Questo tipo di ceramica è diffusa nell’appennino ligure e piemontese, nell’insediamento di Guardamonte di Gremiasco, a Bec Berciassa, a Montaldo di Mondovì, Cassine-loc. Noceto, Dernice-fraz. Vigana, Serravalle Scrivia (Gambari, Venturino Gambari, 1988, p. 135-137). In Piemonte è diffusa dal Canavese al Pinerolese (Gambari, Venturino Gambari, 1988, p. 131). Ritrovamenti isolati si conoscono in aree pertinenti fino al IV secolo a.C. alla cultura di Golasecca a Zavattarello (Pavia) (Simone Zopfi, 2001, p. 205-225, fig. 5, n° 3), alla Sforzesca in Lomellina (Trucco, 1979, tav. VIII, n° 5) e a Vergiate (Varese) (Tizzoni, 1984, tav. XCII, c), in contesti non utili per la datazione. Alcuni esemplari privi di un contesto datante (Rapi, 2009, tav. VII, n° 92-93, 99-100), sono presenti tra i materiali delle raccolte di Rondineto, dove, al contrario di via Isonzo-La Pesa, sono attestate le fasi La Tène fino a tutto il II secolo a.C. Un frammento di questa ceramica compare tra i materiali dell’abitato pro-tostorico di Bergamo (Convento di San Francesco), ma la documentazione pubblicata non fornisce elementi utili alla collocazione cronologica (Poggiani Keller, 2011, p. 381-413, fig. 5, n° 20). Va segnalata, infine, la presenza di queste forme in ambiente etrusco-padano, a Casalecchio di Reno (Bologna), nella struttura II, databile tra la metà del IV e il III secolo a.C., dove è classificata come olla tipo IV (Ferrari, Mengoli, 2005, p. 39, fig. 47, n° 333, 332, 335, 336). Altri frammenti di questa ceramica provengono dagli scavi della Biblioteca Ambrosiana a Milano, i cui materiali sono in corso di riesame.
8. Dall’es 208, materiale in parte inedito, in parte in Casini et alii, 2001, fig. 16, n° 4-11.
Poiché in via Moneta a Milano queste forme mancano nei livelli di II secolo a.C., le datazioni fornite dai confronti permettono di circoscrivere a un periodo tra la seconda metà del IV e il III secolo a.C. la loro presenza nei livelli di questo scavo, come ad esempio l’ US 456 (fig. 5, B e 6, A), dove sono associate a ciotole carenate dipinte con ver-nice rossa corallina e olle globulari decorate a tacche di tradizione golasecchiana ; la dracma padana loro associata, datata tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., è un punto di riferimento cronologico importante (Arslan, 1990, p. 78-79)9 e una conferma dell’attribuzione. Forme cera-miche di tipo ligure compaiono poi nell’ US 1175-1192 in associazione con un bicchiere a portauovo (fig. 6, B6), decorato a occhi di dado del LT B2, olle globulari di impasto fine decorate a fasci di sottili solcature orizzontali (fig. 7, n° 6) e olle globulari con orlo schiacciato a sezione ovale e corpo decorato da cordonature orizzontali, di deri-vazione golasecchiana (fig. 7, n° 8).
L’ US 1175-119210 risulta particolarmente interessante per la presenza di tipi ceramici che compaiono qui per la prima volta o in modo esclusivo. Tra questi grosse ciotole a vasca troncoconica profonda, orlo ingrossato esterna-mente, talvolta con lievissimo accenno di carenatura (fig. 7, n° 3-4). In via Moneta questa forma sembra perdurare a lungo, con esemplari di varie dimensioni, almeno fino a tutto il LT D.
Sempre nell’ambito della tradizione culturale golasec-chiana si può inserire la grande olla globosa (Tizzoni, 1991), decorata a cordonature orizzontali, completamente dipinta con la tecnica a risparmio, con pittura rosso-mar-rone, su fondo leggermente più chiaro, con motivi decora-tivi geometrici (fig. 8, n° 2) e dotata di un coperchio con dente d’innesto, decorato nel medesimo modo. La forma richiama le olle cordonate del G. III A, mentre la decora-zione dipinta si stacca dai modelli golasecchiani e presenta una nuova e complessa sintassi decorativa. La sua data-zione, già proposta tra il IV e gli inizi del III secolo a.C., può essere meglio definita al LT B2 sulla base delle asso-ciazioni presenti nell’unità stratigrafica.
I lIvellI dello scavo dI vIa Moneta : le fasI dI roManIzzazIone
Per quanto riguarda i periodi LT C e D, la principale novità emersa dallo studio della ceramica dei livelli di via Moneta è rappresentata dall’attestazione di ceramiche iberiche sia come importazioni di originali, sia come imi-tazioni (Casini, Tizzoni, 2012, p. 165-178). La forma più facilmente riconoscibile è rappresentata dai kalathoi ibe-rici, detti anche sombreros de copa (Pericot, 1979).
9. Si veda anche per la discussione della ceramica Casini, Motta, 2011, p. 461-463.10. In questa us sono presenti materiali di notevole interesse, poiché unici tra i ritrovamenti di Milano. Ne viene presentato qualche esemplare dato che la discussione integrale dei materiali richiederebbe molto più spazio di quello del presente articolo.
Stefania Casini, Marco Tizzoni
358 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Tre sono i frammenti sicuramente importati dall’area iberica. Lo rivelano l’alta qualità della ceramica, la finezza dell’impasto, la perfetta cottura e la decorazione che trova confronti nel repertorio della produzione iberica.
Il frammento proveniente dall’ US 1126-1139 (fig. 9, B1 e 1a), con materiali attribuibili genericamente al I secolo a.C., è decorato con semicerchi concentrici e fasci di linee parallele verticali e può essere ascritto al gruppo A3 o al gruppo A5 di Conde i Berdós (Conde i Berdós, 1991, p. 159-162), senza la possibilità di un’ulteriore pre-cisazione, in assenza della parte inferiore. Si tratta in ogni caso di produzioni ampuritane. I kalathoi A3, al di fuori della penisola iberica sono diffusi anche nel Rossiglione, in Linguadoca e in Provenza lungo la fascia costiera ; un esemplare della serie A5 è attestato ad Aleria in Corsica. Lungo le coste italiane esemplari del gruppo A3 sono pre-senti a Ventimiglia, a Vado Ligure e Luni in Liguria, a Malandrone e Castiglioncello in Toscana e forse anche a Pompei. Il gruppo A5 è tra i meno diffusi, attestato nella penisola italiana solo a Castiglioncello e Libarna11. Da un punto di vista cronologico i kalathoi del gruppo A3 sono prodotti tra l’ultimo quarto del II secolo a.C. e il 60/70 a.C., mentre quelli del gruppo A5 coprono un periodo che abbraccia il II secolo e le prime decadi del I secolo a.C.
Il secondo frammento è attribuibile al gruppo B6/B7 per il caratteristico orlo ad ampia tesa fortemente agget-tante verso l’interno (fig. 9, B3). È dipinto con pittura rosso scura in gran parte abrasa e un ingobbio di colore arancione sulla parte appiattita dell’orlo. Mancando la parte inferiore del corpo con la decorazione, non è possi-bile un’attribuzione più precisa. In ogni caso, secondo Conde i Berdós questo gruppo ha una diffusione esterna alla penisola iberica, e la sua produzione viene localizzata nell’area di Enserune (Linguadoca), ispirata probabil-mente dai modelli degli ateliers di Fontscaldes (Tarragona). Il tipo ha attestazioni in Italia, a Ventimiglia e a Genicciola in Liguria, più a sud, a Castiglioncello e a Fosso delle Cannelle in Toscana, a Pompei e a Ischia, oltre che in Sardegna, a Perfugas, Olbia e Cagliari (Conde i Berdós, 1992, p. 127-129, fig. 18). Il gruppo si diffonde tra le decadi finali del II e l’inizio del I secolo a.C. Il frammento di via Moneta proviene dall’ US 355/91, attri-buibile genericamente al LT D, sulla base di materiali associati.
Il terzo è un frammento di parete che reca una deco-razione realizzata con pittura di colore rosso scuro molto diluita, costituita da metope campite da un motivo a X (fig. 9, B2 e 2a), che trova confronto in un esemplare dalla necropoli di Castiglioncello, privo di associazioni di cor-redo (Lamboglia, 1954, p. 118-119, fig. 36-38) ; si tratta di un kalathos cilindrico, provvisto di anse, con una deco-razione costituita da una fascia inferiore di metope con
11. Per quanto riguarda la distribuzione dei gruppi si veda Conde i Ber-dós, 1991, fig. 20 (A3) e 32 (A5).
motivi a X, sopra la quale si dispiega un motivo a tralci di edera e fiori, che induce Conde i Berdós (Conde i Berdós, 1991, fig. 29, n° 1-2, 30, 2-3) ad attribuirlo al gruppo B6/B7. Il frammento di Milano, dunque, come il precedente, è di probabile produzione delle officine di Enserune ; pro-viene da un livello (US 33, scavo 1990) che ha restituito materiali databili genericamente al LT D.
Per gli altri pezzi l’attribuzione risulta problematica e apre nuovi sviluppi nella discussione.
Un frammento conserva l’orlo e la parte superiore del corpo (fig. 10, n° 1). La decorazione è eseguita con pittura liquida di colore rosso e raffigura in modo molto schema-tico un tralcio di foglie (d’alloro ?). Questo motivo vege-tale, così schematico ed elementare, non ha un confronto preciso nel repertorio iconografico dei kalathoi iberici e neanche nelle imitazioni prodotte a Enserune. Si può escludere con certezza che si tratti di una produzione ampuritana ; si potrebbe pensare a un’imitazione medio-lanense di alto livello, che si rifà da un lato a una forma conosciuta in città e apprezzata, dall’altra alle decorazioni di altre forme della ceramica iberica di età antico-impe-riale12. La particolare morfologia delle pareti di quest’esemplare, che creano sotto il labbro un cordone con corrispondente incavo all’interno, indica che il copista mediolanense conosceva gli esemplari di Fontscaldes (Guerin, 1993, p. 90, fig. 2, n° 1). Quindi anche questi tipi di kalathoi, sino ad ora non documentati a Milano, dove-vano essere presenti tra le ceramiche iberiche del II secolo a.C. importate nella città. Il pezzo proviene da un’unità stratigrafica (US 511), con scarsi materiali, ma cronologi-camente coerenti e databili al LT D, senza la possibilità di indicare più precisamente la fase, una cronologia che non si accorda con i pezzi iberici che avrebbero ispirato la decorazione, di poco più recenti.
Altri quattro esemplari variamente frammentati, di cui qui è presentato un solo vaso la cui forma è parzialmente ricostruibile (fig. 10, n° 3 e 3a), provengono da livelli databili genericamente al LT D e recano una decorazione completamente diversa dal repertorio iconografico iberico, anche se la forma del labbro a tesa orizzontale richiama decisamente quella del kalathos, del quale è ripetuta anche l’ingrossatura interna, che spesso è un carattere peculiare. La decorazione e la forma hanno un confronto in un esem-plare rinvenuto in via Cesare Correnti 24 (Ceresa Mori et alii, 1992-93, p. 119-121 ; Ruffa, 2004, p. 47), ricostruito in buona parte e datato al I secolo a.C. Anche questo ha il labbro orizzontale a tesa come quello dei kalathoi, ma il corpo è ovoide, completamente dipinto con pittura diluita marrone, ad eccezione di una fascia orizzontale, disposta sopra la spalla, con un motivo di linee tremule e virgolette su fondo chiaro. La particolarità della forma e
12. Conde i Berdós, cui è stato sottoposto il frammento in fotografia, sostiene di non avere mai visto una decorazione simile tra i kalathoi iberici e ci segnala la decorazione che compare su alcuni recipienti chiusi in Abascal Palazón, 1987-88, fig. 6, n° 15-16, fig. 7, n° 2.
MediolanuM : dati inediti dallo studio dei livelli preromani
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 359p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
della decorazione non trova confronti precisi nel reperto-rio della ceramica iberica a noi noto, nonostante le somi-glianze formali (soprattutto il labbro a tesa e la forma del corpo con diametro massimo ribassato, che contraddis-tingue le forme chiuse iberiche : Mata Parreño, Bonet Rosado, 1992, fig. 7, n° 11-12). Confronti per questo vaso sono noti a Este nella necropoli di casa di Ricovero, in un ritrovamento del 1928 (Callegari, 1933, fig. 2) : in una fossa sono stati raccolti circa 250 vasi fittili contenenti ceneri di cremati, forse provenienti da contesti tombali intercettati nei precedenti lavori edificatori. Almeno due recipienti di questo gruppo sono del tutto simili agli esem-plari di Milano. A questo stadio delle conoscenze è impos-sibile stabilire con certezza se si tratta di produzioni mediolanensi di ispirazione iberica, come sembra più probabile, o della testimonianza di relazioni con l’am-biente veneto dove i recipienti sarebbero stati realizzati.
Che nell’area di Milano fossero prodotte imitazioni dei kalathoi iberici era già stato segnalato dalla presenza di una rozza replica proveniente dal contesto funerario del LT D2 di Paderno Dugnano (Milano) (Negroni Catacchio, 1974, p. 207, fig. 49 a p. 208). Poiché la produzione dei kalathoi iberici cessa nella prima metà del I secolo a.C. e dunque anche l’importazione, si può pensare che succes-sivamente essi vengano realizzati localmente, con una certa libertà nell’interpretare la forma e la decorazione.
A questo riguardo è interessante notare la comparsa delle situle Eggers 16 proprio nel corso del LT D1 (Bolla et alii, 1991). Queste situle e in particolare modo le varianti 2 e 5, che presentano orlo a tesa orrizontali, hanno una morfologia estremamente simile ai kalathoi iberici, tanto da indurre a pensare che ne siano una copia in bronzo. Essendo le situle posteriori alla comparsa e alla diffusione dei più antichi esemplari di kalathoi iberici lungo le coste italiane, è lecito pensare che in questo caso non fu il reci-piente metallico a fungere da modello per gli esemplari ceramici, ma, all’opposto, furono questi ultimi che ispira-rono la creazione degli esemplari in lamina bronzea.
Per quanto riguarda l’Italia settentrionale, a parte i numerosi ritrovamenti di ceramica iberica in contesti d’abitato della costa ligure (Ventimiglia, Vado Ligure, Genova e Luni13), il kalathos è la sola forma iberica documentata nell’entroterra, a Cuneo, Libarna e Casalcermelli nell’Alessandrino14, ed esclusivamente in contesti funerari.
Analogamente agli abitati liguri, invece, i ritrova-menti di Milano dimostrano la presenza di altre forme
13. Ventimiglia : Lamboglia, 1954. Vado : Grosso, 1955. Genova : Lam-boglia, 1954, fig. 25 ; un fr. dagli scavi di S. Silvestro (settore QB, strati IVb, V, V1) : Milanese, 1987, n. 664, fig. 104. Luni, pp. 54-55, tav. 88, n° 14-15, 18.14. A Cuneo, un esemplare presumibilmente integro, è conservato privo di indicazioni di provenienza nel Museo locale (Lamboglia, 1954, p. 113-114, fig. 19). A Libarna, un esemplare integro si trova al Museo Archeo-logico di Genova-Pegli (Lamboglia, 1954, p. 114-115, fig. 20). Da Casal Cermelli, due esemplari provengono dalle tombe 1 e 3 (Lo Porto, 1952).
iberiche, sia dipinte sia non decorate. L’analisi della cera-mica di via Moneta, infatti, ha permesso di riconoscere numerosi altri frammenti di ceramica dipinta (fig. 9, B4-5, fig. 11, 2), pertinenti a forme chiuse e aperte, oltre a fram-menti di anfore iberiche15. Inoltre, in occasione di una revisione dei materiali emersi da altri scavi effettuati nel centro di Milano16, è stato possibile verificare come questo tipo di ceramica sia venuto in luce anche in altri punti della città, come ad esempio negli scavi di piazza Duomo (fig. 11, n° 3-4) in occasione dei lavori per la Metropolitana Milanese17, in via Cesare Correnti, alla Crocetta (fig. 11, n° 5) e in via Broletto (fig. 11, n° 6). Purtroppo la dimen-sione di tutti questi frammenti non permette una precisa classificazione, ma il tipo di impasto e di pittura sembrano rimandare à lina provenienza iberica.
Al pari dei kalathoi, anche altre forme presentano imitazioni locali, come dimostra un piatto dipinto (fig. 11, n° 1) da via Moneta, ridepositato in una US cronologica-mente non omogenea. La forma richiama i piatti iberici a larga tesa orizzontale assai diffusi tra il IV e il II secolo a.C. (Bonet Rosado, 1995, p. 413, fig. 210, A.III.8.1) ; la decorazione è una reinterpretazione di temi presenti su questo tipo di ceramica, come il motivo stellare centrale ; di gusto prettamente locale sono, invece, i triangoli trat-teggiati, il colore marrone e rosso della campitura e, soprattutto, la vernice grafitifera che ricopre esternamente la vasca, del tutto assente sulle produzioni iberiche.
La via attraverso la quale i prodotti iberici giungevano a Milano è certamente quella che faceva capo a Genova. Le importazioni iberiche di Milano, segnalate ora per la prima volta, offrono un nuovo importante tassello per la definizione degli aspetti culturali e storici della città, attorno alla quale ruotarono certamente interessi commer-ciali di varia natura da parte dei coloni italici che, proba-bilmente a partire dalla fine del III secolo a.C., cominciarono a insediarsi non solo in ambito urbano, ma anche nel territorio circostante, attratti dalla possibilità di sfruttamento delle risorse di svariata natura dell’Italia settentrionale, a costi bassi e con elevati ricavi.
Nel II secolo a.C. i mercanti italici crearono una rete commerciale lungo le coste tra la penisola iberica e quella italiana18, fino alla Sicilia, per veicolare prodotti di lusso, metalli e derrate alimentari. Grazie allo storico legame tra
15. Questi materiali sono ancora inediti e in studio, in vista di una pub-blicazione integrale della ceramica di via Moneta.16. Gli Autori ringraziano la dott. Anna Maria Ceresa Mori, che ha per-messo di revisionare tutti i materiali provenienti dai suoi scavi.17. Gli esemplari in questione non risultano pubblicati su Scavi MM 1991, ma sono stati identificati recentemente nel corso di una revisione della ceramica dipinta. Tuttavia va segnalato che la scarsa incidenza di questi pezzi tra tutto il materiale emerso dagli scavi per la metropolitana è probabilmente dovuto al fatto che l’indagine del deposito si è spesso arrestata quando lo spazio era sufficiente per la costruzione delle gallerie, lasciando intatti i livelli più antichi (LT C e D1), dove è maggiormente presente, in generale, la ceramica dipinta iberica e locale.18. Per la Liguria una breve sintesi in Gambaro, 2004, p. 498-500 con bibliografia.
Stefania Casini, Marco Tizzoni
360 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
le popolazioni celtiche del milanese e quelle liguri della costa, Milano entrò nel circuito di questa rete commer-ciale, finora unica città dell’entroterra dove sono attestati prodotti iberici.
Già da tempo era nota agli imprenditori italici la ric-chezza agricola della pianura padana e l’importanza delle zone alpine come fonte di approvvigionamento di materie prime tra cui i metalli ; una testimonianza significativa della presenza a Milano di imprenditori latini è offerta dal ritrovamento di condensatori per la preparazione dell’os-sido di zinco, le cui proprietà medicinali, erano già note all’epoca (Tizzoni, 1996).
Proprio entro questo quadro va letto il ritrovamento di Arcisate (Piana Agostinetti, Priuli, 1988) (Varese), datato intorno al 75 a.C., un gruppo di oggetti d’argento, le cui circostanze di rinvenimento sono ignote, apparte-nuto a Tito Utio e sua figlia, come si evince dalle iscrizioni sugli oggetti stessi. La famiglia degli Utii è attestata in età
repubblicana in una vasta zona della penisola tra Umbria, Sannio e Lucania, ma il dato più interessante è offerto da un lingotto di piombo di tipo spagnolo rinvenuto in un relitto presso Hjéres (Francia), datato tra il 73 e il 50 a.C. e stampigliato con il nome C. Uitius C. F. Il collegamento tra gli Utii di Arcisate e il personaggio del lingotto, già messo in luce da Piana Agostinetti, permette di pensare che siamo di fronte a una famiglia di imprenditori/com-mercianti latini di successo, stanziati in questi territori per interessi commerciali. Il ritrovamento di ceramiche ibe-riche a Milano sembra confermare queste relazioni com-merciali tra l’Iberia e l’area, gestite dai mercanti italici.
Non possiamo, dunque mediolanense, che ribadire l’importanza del deposito archeologico di via Moneta, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione dei carat-teri, dello sviluppo e del ruolo di Mediolanum preromana, che potranno essere delineati in modo conclusivo quando lo studio dei materiali sarà completato.
MediolanuM : dati inediti dallo studio dei livelli preromani
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 361p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 1. Materiali della cultura di Golasecca rinvenuti a Milano. A, armilla e fibula Certosa da via Broletto, angolo piazza Cordusio (da de Marinis, 1984) ; B, fibula Certosa e simulacro di fibula dalla Biblioteca Ambrosiana ; C, simulacro di fibula da via Meravigli ; D, bicchiere e olletta da Palazzo Reale (da Jorio, 1987) ;
E, cortile di S. Antonino (da de Marinis, 1984) (bronzi, rid. 1:2 ; ceramica, rid. 1:3).
Stefania Casini, Marco Tizzoni
362 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 2. Milano, via Moneta. A, fibula tipo Gaiaccio (G. II B). B-D, livelli del G. III A1/A2. E, livello del G. III A2/A3 (disegni e foto S. Casini, M. Tizzoni. Bronzi, rid. 1:2 ; ceramica, rid. 1:3).
MediolanuM : dati inediti dallo studio dei livelli preromani
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 363p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 3. Milano, via Moneta. A-C, livelli del G. III A2/A3 (disegni e foto S. Casini, M. Tizzoni ; ceramica, rid. 1:3).
Stefania Casini, Marco Tizzoni
364 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 4. Milano, via Moneta. A-B, selezione di materiali da livelli del G. III A2/A3 (disegni e foto S. Casini, M. Tizzoni ; ceramica, rid. 1:3).
MediolanuM : dati inediti dallo studio dei livelli preromani
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 365p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 5. Milano, via Moneta. Selezione di materiali da A, livello del G. III A2/A3 e B, livello della fine del IV e inizio III secolo a.C. (disegni e foto S. Casini, M. Tizzoni ; ceramica, rid. 1:3).
Stefania Casini, Marco Tizzoni
366 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 6. Milano, via Moneta. Selezione di materiali da A, livello della fine del IV-inizi III secolo a.C. e B, livello del LT B2 (disegni e foto S. Casini, M. Tizzoni ; ceramica, rid. 1:3).
MediolanuM : dati inediti dallo studio dei livelli preromani
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 367p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 7. Milano, via Moneta. Selezione di materiali da un livello del LT B2 (disegni e foto S. Casini, M. Tizzoni ; ceramica, rid. 1:3).
Stefania Casini, Marco Tizzoni
368 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 8. Milano, via Moneta. Ricostruzione della forma dell’olla e del coperchio dipinti dal livello del LT B2 e ricostruzione schematica dei motivi decorativi
(disegni e foto S. Casini, M. Tizzoni ; ceramica, rid. 1:4).
MediolanuM : dati inediti dallo studio dei livelli preromani
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 369p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 9. Milano, via Moneta. A, selezione di materiali da un livello del LT B2 ; B, 1-3 kalathoi iberici, 4-5 frammenti di ceramica iberica
(disegni e foto S. Casini, M. Tizzoni ; ceramica, rid. 1:3).
Stefania Casini, Marco Tizzoni
370 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 10. Milano, via Moneta. Probabili imitazioni locali di ceramica iberica (disegni e foto S. Casini, M. Tizzoni ; ceramica, rid. 1:3).
MediolanuM : dati inediti dallo studio dei livelli preromani
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 371p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
Fig. 11. Milano. 1, piatto di imitazione iberica da via Moneta ; 2, vasetto di importazione iberica da via Moneta ; 3-4, frammenti di ceramica iberica da Piazza Duomo, scavi MM ; 5, frammento di ceramica forse iberica da Milano-Crocetta ;
6, frammento di vaso iberico da via Broletto (disegni e foto S. Casini, M. Tizzoni ; ceramica, rid. 1:3).
Stefania Casini, Marco Tizzoni
372 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012)p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
abascal palazón J.M., 1987-88, « Olpes pintados de època imperial en Alicante », Saguntum, 21, p. 361-377.
arslan e., 1990, « Le monnayage celtique de la plaine du Po (IVe-Ier siècle av. J.-C.) », Études Celtiques, XXVII, p. 71-102.
bolla M., boube ch., GuIllauMet J.-p., 1991, « Les situles », in : feuGère M., rolley c. dir., La vaisselle tardo-répu-blicaine en bronze, Actes de la Table Ronde CNRS, Lattes, 26-28 avril 1990, UPR 290 (Lattes)-GDR 125 (Dijon), Dijon, p. 7-22.
bonet rosado h., 1995, El Tossal de Sant Miquel de Llíria la antigua edeta y su territorio, Diputación de Valencia, Valencia.
calleGarI a., 1933, « IV. Este. Suppellettile funebre trovata nell’orto di Casa di Ricovero », Notizie degli scavi di anti-chità, 1933, p. 121-146.
casInI s., 1983, « Materiali del Golasecca III A provenienti dal territorio comasco », Rivista Archeologica Antica Provincia e Diocesi di Como, f. 165, p. 105-173.
casInI s., 1988, « Ritrovamenti ottocenteschi di sepolture gola-secchiane nel territorio bergamasco », Notizie Archeologiche Bergomensi, 6, p. 109-161.
casInI s., Motta f., 2011, « Alcune iscrizioni preromane inedite da Milano », in : casInI s. dir., “Il filo del tempo”, Studi di preistoria e protostoria in onore di R.C. de Marinis, Bergamo, p. 459-469 (Notizie Archeologiche Bergomensi, 19).
casInI s., tIzzonI M., 2009, « I materiali protostorici », in : J. MIlls et alii, « Milano, Chiostri di S. Eustorgio », Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, 2007, Milano, p. 137-140.
casInI s., tIzzonI M., 2012, « Kalathoi iberici e loro imitazioni nella Mediolanum celtica », Notizie Archeologiche Bergomensi, 18, 2010, p. 165-178.
casInI s., de MarInIs r.c., rapI M., 2001, « L’abitato protos-torico di Como », in : La protostoria in Lombardia, Atti del III Convegno Regionale, Como (22-24 ottobre 1999), Como, p. 97-140.
ceresa MorI a., 1990-91, « La tarda età del Ferro a Milano alla luce dei recenti ritrovamenti », Sibrium, XXI, p. 247-258.
ceresa MorI a., 1992-93, « Milano, via Valpetrosa 10 », Notiziario Soprintendenza Archeologica della Lombardia, p. 129-131.
ceresa MorI a., 2001, « Le origini di Milano. Stato degli studi e prospettive di ricerca », in : La protostoria in Lombardia, Atti del III Convegno Regionale, Como (22-24 ottobre 1999), Como, p. 363-380.
ceresa MorI a, tIzzonI M., 2004, « Milano nell’età del Ferro », in : ceresa MorI a. dir., L’anfiteatro di Milano e il suo quartiere, Milano, Skira, p. 41-45.
ceresa MorI a., paGanI c., howes b., whIte n., 1990, « Milano. Indagini nell’area del foro. Biblioteca Ambrosian a », Notiziario Soprintendenza Archeologica della Lombardia, p. 173-181.
ceresa MorI a., de donno M., GallI e., 1992-93, « Milano, Via Cesare Correnti 24 », Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, p. 119-121.
conde I berdós M.J., 1991, « Le produccions de kalathoi d’Empúries i la seva diffusió mediterrània (segles II-I a.C.) », Cypsela, IX, p. 141-168.
conde I berdós M.J., 1992, « Una producció ceràmica carac-terística del món ibèric tardà : el kalathos “barret de copa” », Fonaments, 6, p. 117-169.
de MarInIs r.c., 1981, « Il periodo Golasecca III A in Lombardia », Studi Archeologici, I, p. 43-300.
de MarInIs r.c., 1984, « La città in Lombardia. La sua nascita e la sua evoluzione », in : Archeologia urbana in Lombardia, Modena, Panini ed., p. 22-33.
ferrarI s., MenGolI d., 2005, « I materiali di età celtica dalla struttura 2 di Casalecchio di Reno (BO), zona “A” », in : vItalI d. dir., Studi sulla media e tarda età del ferro nell’Italia settentrionale, Bologna, p. 15-148.
GaMbarI f., venturIno GaMbarI M., 1988, « Contributi per una definizione archeologica della seconda età del Ferro nella Liguria interna », Rivista di Studi Liguri, LIII, 1987, p. 77-150.
GaMbaro l., 2004, « Le correnti commerciali. La Liguria », in : de MarInIs r.c., spadea G. dir., I Liguri. Un antico popolo tra Alpi e Mediterraneo, Genova, p. 498-500.
Grosso G., 1955, « La ceramica iberica di Vada Sabatia », Rivista di Studi Liguri, XXI, f. 3-4, p. 271-278.
GuerIn p., 1993, « Le sombrero de copa : quelques résultats récents », Documents d’Archéologie Méridionale, 16, p. 88-92.
JorIo s., 1987, « Milano. Palazzo Reale. Scavo nell’angolo SW del cortile principale », Notiziario Soprintendenza Archeologica della Lombardia, p. 132-137.
laMboGlIa n., 1954, « La ceramica iberica negli strati di Albintimilium e nel territorio ligure e tirrenico », Rivista di Studi Liguri, XX, f. 2, p. 83-125.
lo porto f.G., 1952, « Una necropoli di età repubblicana nell’Alessandrino », Rivista di Studi Liguri, XVII, f. 1-2, p. 46-66.
Luni, 1977, frova a. dir., Scavi di Luni. Relazione delle cam-pagne di scavo 1972-1973-1974, 2 voll., Roma, ed. Bretschneider.
Mata parreño c., bonet rosado e., 1992, « La cerámica ibérica : ensayo de tipología », in : Estudios de Arqueología ibérica y romana, Homenaje a Enrique Pla Ballester, Valencia, 1992, p. 117-173. (Serie de Trabajos Varios, 89).
MIlanese M., 1987, Scavi nell’oppidum preromano di Genova, Roma, ed. Bretschneider (Studia Archaeologica, 48).
neGronI catacchIo n., 1974, « I ritrovamenti di Casate nel quadro del celtismo padano », in : Atti del Convegno cele-brativo del Centenario, Como, Società Archeologica Comense, p. 169-254.
pIana aGostInettI p., prIulI s., 1988, « Il tesoro di Arcisate », Archeologia Classica, XXXVII, 1985, p. 182-237.
BIBLIOGRAFIA
MediolanuM : dati inediti dallo studio dei livelli preromani
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012). 373p. 355-374 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014
perIcot l., 1979, Ceràmica ibérica, Barcelona.
poGGIanI Keller r., 2001, « Il centro proto-urbano di Bergamo e il sistema dei siti collinari coevi tra Oglio e Adda », in : La protostoria in Lombardia, Atti del 3° convegno Archeologico Regionale, Como 22-24 ottobre 1999, Como, p. 381-413.
rapI M., 2009, La seconda età del Ferro nell’area di Como e dintorni, Como (Archeologia dell’Italia Settentrionale, 11).
ruffa M., 2004, « I materiali protostorici », in : ceresa MorI a. dir., L’anfiteatro di Milano e il suo quartiere, Skira, Milano, p. 46-49.
Scavi MM 1991, caporusso d. dir., Scavi MM3. Ricerche di archeologia urbana a Milano durante la costruzione della linea 3 della MM 1982-1990, 3 voll., Milano.
sIMone zopfI l., 2001, « Nuove testimonianze dell’età del Ferro nella provincia di Pavia », in : La Protostoria in Lombardia, Atti 3° Convegno Archeologico Regionale, Como 22-24 ottobre 1999, Como, p. 205-225.
stöcKlI w.e., 1975, Chronologie der jüngeren Eisenzeit im Tessin, Basel, Veröffentlichung der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (Antiqua, 2).
Teržan B., 1977, « Certoska Fibula (Die Certosa Fibel) », Arheoloski Vestnik, XXVII, p. 317-443.
tIzzonI M., 1984, I materiali della tarda età del Ferro nelle Civiche raccolte Archeologiche di Milano, Milano. (Rassegna di Studi del Civico Museo Archeologico e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano, suppl. III).
tIzzonI M., 1991, « Rapporto preliminare su tre nuovi tipi di ceramica dipinta dall’oppidum di Milano », in : La céra-mique peinte celtique dans son contexte européen, Actes du symposium International d’Hautvillers, 1987, Châlons-sur-Marne, p. 159-166.
tIzzonI M., 1992, « Prime osservazioni sui materiali preromani provenienti dagli scavi di via Moneta e dalla Biblioteca Ambrosiana in Milano », Sibrium, XXI, 1990-91, p. 259-263.
tIzzonI M., 1996, « Condensatori per la produzione dell’ossido di zinco da Conca del Naviglio a Milano », Notizie Archeologiche Bergomensi, 4, p. 111-120.
torI l., carlevaro e., della casa ph., pernet l., SchmidT-Sikimić eds, 2010, La necropoli di Giubiasco (TI), III. Le tombe dell’età del Bronzo, della prima età del Ferro e del La Tène antico e medio, Zurigo, Museo Nazionale Svizzero (Collectio Archaeologica).
trucco f., 1979, Aspetti e problemi dell’età di La Tène antica e media tra Ticino e Sesia, Milan, 68 p., 39 pl. (Rassegna di Studi del Civico Museo Archeologico e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano, XXIII-XXIV)