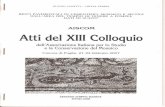G. R. BELLINI- F. SPOSITO, Pavimenti inediti dalla villa romana in loc Cardegna, AISCOM XVI...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of G. R. BELLINI- F. SPOSITO, Pavimenti inediti dalla villa romana in loc Cardegna, AISCOM XVI...
571
GIOVANNA RITA BELLINI – FRANCESCA SPOSITO
PAVIMENTI INEDITI DALLA VILLA ROMANA IN LOC. CARDEGNA
(CECCANO, FR)
1. Introduzione
Nel biennio 1996-1998 fu riportata alla luce una villa romana di ragguardevo-li dimensioni nell’ambito delle attività archeologiche per la realizzazione della li-nea ferroviaria ad Alta Velocità Roma-Napoli.
La villa si trova nella media valle Latina, nei pressi della sponda destra del fiume Sacco; anticamente essa era compresa nell’ager di ager di ager Fabrateria Vetus, sito pre-romano e romano del Lazio interno, corrispondente all’odierna Ceccano1.
L’attività di scavo ha interessato unicamente la fascia del sedime ferroviario, cor-rispondente al settore settentrionale della villa, mentre un intervento di tipo esten-sivo nel settore meridionale ha consentito, quanto meno nelle linee essenziali, la conoscenza planimetrica del complesso, che occupa un’area di circa 7500 mq2.
L’indagine ha altresì messo in evidenza lo stato di conservazione non ottima-le delle strutture, imputabile alle numerose ed abbondanti spoliazioni subite inin-terrottamente nel corso dei secoli, a cui vanno aggiunti i danni arrecati dagli scas-si agricoli.
Lo studio analitico dei materiali condotto nel 20053, unitamente alla tecni-ca edilizia impiegata – rappresentata fondamentalmente dall’opera laterizia e li-stata – ha consentito di inquadrare l’edificio in un arco cronologico compreso tra l’età tardo-repubblicana, attestata esclusivamente dai reperti ceramici, e la tar-da età imperiale. A partire dalla seconda metà del III secolo d.C. è stato in al-tra sede ipotizzato che la villa sia stata trasformata in fastosa mansio collegata alla mansio collegata alla mansiovia Latina, arteria stradale fondamentale per il collegamento di Roma con i cen-tri interni del Lazio4.
1 Livio dà notizia che il sito, occupato dai Volsci, si sottomise a Roma nel 329 a.C. (Liv., VIII, 19). La trasformazione di Fabrateria Vetus in municipio è attestata epigraficamente solo dopo la guerra so-ciale (CIL, X, 5657; AE, 1979, 140-141). Per un inquadramento generale della città si rimanda a AE, 1979, 140-141). Per un inquadramento generale della città si rimanda a AE S. AN-TONINI, Fabrateria Vetus. Un’indagine storico-archeologica, Roma 1988.
2 Lo scavo è stato effettuato dalla Soc. Geosonda S.p.A. con la direzione scientifica di G.R. Bellini e la collaborazione sul campo di P.F. Chiocci, F. Pompilio, L. Ruggiero e R. Tomassi, che si sono oc-cupati della relazione di scavo, dell’apparato planimetrico e fotografico della villa. Una prima presen-tazione del complesso si trova in S.L. TRIGONA, ‘La villa romana di Cardegna, Ceccano (FR). I mate-riali’, in Dalle sorgenti alla foce. Il bacino del Liri-Garigliano nell’antichità: culture, contatti, scambi, Atti del Convegno, Frosinone, 10 novembre 2005, a cura di C. Corsi ed E. Polito, Roma 2008, pp. 231-239 e successivamente in G.R. BELLINI, S.L. TRIGONA, ‘Le terme della villa di Cardegna, Ceccano (Fr)’, in Sor-genti e terme dalla valle del Sacco, a cura di R. Padovano, Padova 2009, pp. 304-313, ove però si fa men-zione di uno solo dei pavimenti oggetto di questo studio.
3 TRIGONA 2008, cit. a nota 2, p. 232.4 Ivi, p. 238; BELLINI, TRIGONA 2009, cit. a nota 2, p. 312.
572
2. L’articolazione planimetrica
La villa fu costruita secondo schemi planimetrici ampiamente codificati e con-divisi5. Si articola infatti in tre nuclei principali: il settore settentrionale, dove si apre un vasto giardino colonnato (T), un settore centrale dove si sviluppa la zo-na residenziale, ed infine un settore meridionale, che ospita la pars rustica com-prensiva di hortus (fig. 1).
Gli scavi archeologici hanno inoltre rilevato la presenza di un muro di recin-zione, probabilmente turrito, presso il quale si aprivano gli ingressi alla villa; uno di questi è stato riconosciuto in prossimità di un piazzale basolato sul lato orien-tale del settore abitativo.
Attorno al giardino porticato gravitano due settori termali, situati rispettiva-mente lungo i lati sud-ovest ed est (fig. 2)6.
Il complesso termale orientale, che conserva i paramenti delle murature pre-valentemente in opera laterizia, ha un orientamento lievemente divergente rispetto agli ambienti limitrofi, forse indicativo di una maggiore anteriorità7. I vani termali si distribuiscono attorno ad una sala quadrangolare (N) pavimentata da un tessel-lato con scena marina. È stato inoltre riconosciuto un ambiente absidato adibito a si distribuiscono attorno ad una sala quadrangolare (N) pavimentata da un tessel-lato con scena marina. È stato inoltre riconosciuto un ambiente absidato adibito a si distribuiscono attorno ad una sala quadrangolare (N) pavimentata da un tessel-
frigidarium (O) ad ovest dell’ambiente N, ed una zona riscaldata a sud-est munita frigidarium (O) ad ovest dell’ambiente N, ed una zona riscaldata a sud-est munita frigidariumdi praefurnia (Q) e di un praefurnia (Q) e di un praefurnia calidarium, con annesse vasche semicircolari (U).
Le terme sud-occidentali sono composte da almeno cinque vani a differente planimetria disposti in modo paratattico da est a ovest, con paramenti esterni in opera laterizia e listata. Tra i vari ambienti si distinguono quattro calidaria (A, B, calidaria (A, B, calidariaD, H) ed almeno un frigidarium (I). I vani si impiantano su strutture preesisten-ti che dovevano avere una differente destinazione d’uso; si pensi, ad esempio, al-l’ambiente A, ovvero una cisterna contraffortata che, a partire dalla metà del III secolo d.C., fu ricolmata, ripavimentata ed allestita a spazio riscaldato8.
Tale trasformazione d’uso è stata considerata un’ulteriore prova a sostegno dell’ipotesi di un cambiamento funzionale dell’insediamento ed una sua conversio-ne da centro produttivo-residenziale a mansio9mansio9mansio . A nord ed a nord-ovest delle terme sono stati riportati in luce ulteriori ambienti con piani in tessellato (V, R1, R2, S, T1, T2) ed in opera spicata (C), di cui non è nota la destinazione d’uso.
A sud del giardino porticato si estende il secondo nucleo della villa, destina-to all’abitazione del dominus. La pars urbana, incardinata su un asse nord-sud, è caratterizzata dalla presenza di un peristilio seguito da un atrio centrale attorno al quale, come di consueto, si dispongono le stanze di soggiorno e rappresentan-za, ancora da identificare nella loro specifica funzione.
Infine, l’indagine archeologica ha accertato la presenza di una pars rustica pres-pars rustica pres-pars rusticaso il margine meridionale del pianoro, costituita da una successione di vani qua-drangolari funzionali all’alloggiamento del personale e dei locali di servizio.
(G.R.B.)
5 Per planimetrie similari al complesso fabraterno si veda, a titolo esemplificativo, M. MORETTI, A.M. SGUBINI MORETTI, La villa dei Volusii a Lucus Feroniae, Roma 1977, in part. v. La villa dei Volusii a Lucus Feroniae, Roma 1977, in part. v. La villa dei Volusii a Lucus Feroniae Planimetrie genera-li, tavv. I-II.
6 Il rifornimento idrico di entrambe le strutture termali era garantito da un acquedotto a cui si al-lacciavano una serie di canalizzazioni funzionali alla distribuzione idrica, come si evince dalla tav. XXXallegata alla relazione di scavo. V. inoltre BELLINI, TRIGONA 2009, cit. a nota 2, p. 308.
7 TRIGONA 2008, cit. a nota 2, p. 232.TRIGONA 2008, cit. a nota 2, p. 232.TRIGONA8 Il mutamento funzionale è confermato dal materiale ceramico rinvenuto nel riempimento di una
canaletta limitrofa (canaletta X); v. TRIGONA 2008, cit. a nota 2, pp. 232-233. 9 V. nota 4.
573
3. I rivestimenti pavimentali
Numerose e variate sono le pavimentazioni restituite dalla villa – ad oggi ine-dite con l’eccezione di un solo pavimento – concentrate presso il settore sud-oc-cidentale del giardino porticato T e nelle terme orientali (fig. 2)10. Nello speci-fico si conservano 9 rivestimenti in tessellato, 2 lastricati marmorei e 3 pavimen-ti a commessi laterizi disposti a spina di pesce, oltre ad una gran quantità di ele-menti marmorei pertinenti a rivestimenti parietali e pavimentali, per il cui studio si rimanda ad un precedente contributo11. Si segnala infine la presenza, presso la maggior parte dei vani indagati, di numerose preparazioni pavimentali prive del rivestimento originario.
3.1. I tessellatiPer quanto concerne i rivestimenti in tessellato, sono presenti soprattutto mo-
saici monocromi, ma si conservano anche tessellati bicromi con motivi geometri-ci, geometrico-figurati e figurati. In ogni caso, va registrato il loro stato di conser-vazione frammentario e/o lacunoso.
Sono 6 i frammenti musivi monocromi bianchi a filari di tessere disposte a or-dito dritto rinvenuti presso una serie di ambienti o parti di essi di incerta identifi-cazione ubicati a sud e a sud-ovest del giardino porticato T (V, R1, R2, S, T1, T2).
La modesta qualità dei rivestimenti (fig. 3) potrebbe essere indicativa di una destinazione secondaria di tali spazi, che potrebbero di conseguenza essere con-notati come ambienti di servizio e/o utilitari.
Presso l’ambiente BB, a sud del giardino T, si conserva un tessellato bicro-mo con motivi geometrico-figurati (fig. 4). Il manufatto è bordato da un’ampia fascia monocroma bianca seguita da tre linee nere e da tre linee bianche alterna-te ad un doppio filare di tessere nere, che delimitano una composizione centrata costituita da quattro ottagoni caricati da volatili stanti su rami e da quattro squa-dre poste sulle diagonali, campite da trecce a quattro capi, gli spazi di risulta in losanghe e triangoli. Non è leggibile la decorazione del quadrato centrale di cui s’intravede unicamente un piccolo quadrilatero delineato a lati concavi e rettilinei opposti, con una croce a tratto inclusa.
Lo schema decorativo è di origine centro-italica e risulta attestato a Stabia12
e nel suburbio romano13; per quanto concerne la composizione dello pseudoem-
10 I rivestimenti pavimentali sono in corso di schedatura da parte di chi scrive nell’ambito della tesi di dottorato facente parte del Progetto TESS elaborato dall’Università degli Studi di Padova. Ringrazio sentitamente la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e nello specifico il Soprintendente dott.ssa M. Sapelli Regni e la dott.ssa G.R. Bellini, direttore scientifico dello scavo, per avermi consen-tito lo studio del materiale. Desidero inoltre ringraziare la prof.ssa F. Ghedini, il prof. F. Guidobaldi e la dott.ssa F. Rinaldi per il proficuo scambio di idee sull’analisi delle pavimentazioni.
11 TRIGONA 2008, cit. a nota 2. Le decorazioni parietali in marmi policromi, pur non eguaglian-do la fastosità di quelle limitrofe di Casale di Madonna del Piano a Castro dei Volsci, palesano le me-desime esigenze ornamentali. Si veda M.C. LAURENTI, ‘I pavimenti. La decorazione parietale. Sintesi delle informazioni e datazione. Gli apparati decorativi’, in Il Museo Civico Archeologico di Castro dei Vol-sci, a cura di M. Fenelli e P. Pascucci, Roma 2009, pp. 43-54, tavv. VII, X-XI; EADEM, ‘La villa romana di Casale a Castro dei Volsci’, in Papers of the Fourth Conference of Italian Archaeology, a cura di E. Her-ring, R. Whitehouse and J. Wilkins, IV, 2, Londra 1992, pp. 119-144, in part. pp. 124-125 e pp. 127-128, figg. 7-9 e figg. 12-13; Archeologia Medievale nel Lazio. L’insediamento di Castro dei Volsci, a cura di G.R. Bellini, Frosinone 1992, p. 25, figg. 5-6 e figg. 7-9; EADEM, ‘Mosaici e sectilia pavimenta dalla Villa sectilia pavimenta dalla Villa sectilia pavimentaromana di Castro dei Volsci’, in AISCOM IAISCOM IAISCOM , pp. 189-213, in part. pp. 194-197 e pp. 199-200, figg. 3-4. I, pp. 189-213, in part. pp. 194-197 e pp. 199-200, figg. 3-4. I
12 Ora Museo di Napoli: BLAKE 1936, p. 117, tav. 25, 2: metà del II d.C.13 Villa di Quarto di Montebello presso Prima Porta, ambiente G (ora Metropolitan Museum of
Art, NY): v. O. MARUCCHI, ‘Di un pavimento a mosaico con figure egizie scoperto presso la via Flami-
574
blema ed i riempitivi degli elementi geometrici, un confronto puntuale proviene blema ed i riempitivi degli elementi geometrici, un confronto puntuale proviene blemadalle Marche14.
Risalendo la Penisola, uno schema similare – qui in versione iterata – è resti-tuito da Rimini15. Infine, spostandoci più a nord, si segnala un manufatto restitui-to da Legnano-Villabartolomea (Vr)16. Il motivo decorativo risulta impiegato anche nel corso dei secoli successivi, come provano alcuni esemplari restituiti da Roma17, da Brescia18, da Aquileia19 e di provenienza extraterritoriale20.
Sulla base dei confronti proposti, si propende per una datazione del manu-fatto intorno alla prima metà del II secolo d.C.
L’ambiente NN, prospiciente sul lato meridionale del giardino porticato, è pa-vimentato da un mosaico bordato da una successione di fasce in tessere bianche e nere alternate che circoscrivono un punteggiato di crocette (fig. 5).
Tali soluzioni sono diffusamente presenti lungo tutta la Penisola nel corso del I secolo a.C.21 fino ad almeno il II secolo d.C.22, ragion per cui, anche in conside-razione della genericità del motivo decorativo, non è stato possibile fornire un’in-dicazione cronologica di massima per il rivestimento.
nia’, in BullCom, 1892, pp. 160-174, tavv. VII-VIII; K. WERNER, Mosaiken aus Rom. Polychrome Mosaikpavi-mente und Emblemata aus Rom und Umgebung, Roma 1994, pp. 94-96 (K38): fine del I sec. d.C.-inizio del mente und Emblemata aus Rom und Umgebung, Roma 1994, pp. 94-96 (K38): fine del I sec. d.C.-inizio del mente und Emblemata aus Rom und UmgebungII sec. d.C. Da ultimo, v. M. DE FRANCESCHINI, Ville dell’agro romano, Roma 2005 (Monografie della Car-ta dell’Agro Romano, 2), pp. 12-15, fig. 4.3: II sec. d.C. Il mosaico, policromo su fondo bianco, è strut-turato sul medesimo schema geometrico dell’esemplare fabraterno; inoltre, come nel nostro caso, le squadre sono campite dal motivo della treccia.
14 Domus dei Coiedii di Suasa, ambiente BC: v. S. DE MARIA, ‘Mosaici di Suasa: tipi, fasi, botteghe’, in AISCOM III, pp. 401-424, in part. pp. 406-407, figg. 9-10: inizi del II sec. d.C. Si noti l’utilizzo del AISCOM III, pp. 401-424, in part. pp. 406-407, figg. 9-10: inizi del II sec. d.C. Si noti l’utilizzo del AISCOM IIImotivo della treccia all’interno delle squadre e l’inserzione di volatili stanti su ramoscelli, alternati a paperelle, all’interno degli ottagoni, analogamente all’esemplare fabraterno.
15 M.L. STOPPIONI, ‘I mosaici pavimentali della domus di piazza Ferrari a Rimini’, in AISCOM I, pp. AISCOM I, pp. AISCOM I409-431, in part. fig. 2: II sec. d.C.; v. anche J. ORTALLI, ‘Rimini: la domus “del Chirurgo”domus “del Chirurgo”domus ’, in Aemilia. La cultura romana in Emilia Romagna dal III secolo a.C. all’età costantiniana, catalogo della mostra, a cura di M. Calvani (Bologna, 18 marzo-16 luglio 2000), Venezia 2000, pp. 512-526, in part. pp. 513-518.
16 Anche in questo caso gli ottagoni sono caricati da animali, qui un cinghiale ed un cane da cac-cia: F. RINALDI, Mosaici e pavimenti del Veneto. Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza (I sec. a.C.-VI sec. d.C.), Roma 2007 (Quaderni di Antenor, 7), pp. 132-133, tavv. Quaderni di Antenor, 7), pp. 132-133, tavv. Quaderni di Antenor XXI, 1 e XXII, 1-2: fine del I sec. d.C.-metà del II sec. d.C., con ulteriori esemplificazioni dello schema.
17 DE FRANCESCHINI 2005, cit. a nota 13, pp. 237-238, fig. 82.1 e fig. 82.5: II-III sec. d.C. (qui con esagoni in luogo degli ottagoni).
18 F. MORANDINI, F. SLAVAZZI, ‘Pavimenti decorati nelle domus dell’Ortaglia di Brescia. Alcuni esem-domus dell’Ortaglia di Brescia. Alcuni esem-domuspi’, in AISCOM IX, pp. 111-120, in part. pp. 112-113: II-III sec. d.C.AISCOM IX, pp. 111-120, in part. pp. 112-113: II-III sec. d.C.AISCOM IX
19 P. LOPREATO, ‘Le Grandi Terme di Aquileia. I mosaici del frigidarium’, in IVCollIntMos, pp. 87-98, in part. p. 92, tav. XLIV, 1: piena età costantiniana. Da Aquileia si veda anche un manufatto recen-temente restituito dalla Domus delle Bestie Ferite presentato per la prima volta all’interno di questo volume, che gli Autori datano a partire dalla metà del IV sec. d.C.: M. BUENO, M. NOVELLO, ‘Aquileia (UD). Un nuovo mosaico figurato dalla Casa delle Bestie ferite’.
20 Si tratta di due esemplari restituiti dall’Inghilterra e, nello specifico, da Rapsley nel Surrey (v. D.J. SMITH, ‘Roman mosaics in Britain before the fourth century’, in IICollIntMos, pp. 269-289, in part. p. 274, tav. CXII, 2: 220-280 d.C.) e da Woodchester (v. D.J. SMITH, ‘Three fourth-century Schools of Mosaics in Roman Britain’, in ICollIntMos, pp. 95-114, in part. pp. 105-111, fig. 18: IV sec. d.C.) Nel secondo caso lo schema è adoperato come riempitivo di un riquadro pertinente ad una composizio-ne geometrica più complessa.
21 RINALDI 2007, cit. a nota 16, pp. 80-83, con esemplificazioni, a cui aggiungiamo, per la vicinan-za geografica alla villa di Cardegna, un rivestimento musivo da Anagni (FR): R. FRASCA, ‘Mosaici ine-diti da Anagni’, in AISCOM XII, pp. 189-202, in part. pp. 193-194, figg. 5-6: età sillana-prima età augu-AISCOM XII, pp. 189-202, in part. pp. 193-194, figg. 5-6: età sillana-prima età augu-AISCOM XIIstea. Si veda anche DE FRANCESCHINI 2005, cit. a nota 13, p. 9, fig. 2.15: età augustea.
22 RINALDI 2007, cit. a nota 16, p. 83. Per attestazioni analoghe di ambito centro-italico si veda DE FRANCESCHINI 2005, cit. a nota 13, p. 21, fig. 5.21: II sec. d.C.; M. DE FRANCESCHINI, Villa Adriana. Mosai-ci, pavimenti, edifici, Roma 1991, pp. 33-34: II sec. d.C.; dalla Toscana si veda M. BUENO, ‘Volterra e Se-galari: mosaici di età adrianea’, in AISCOM X, pp. 809-820, in part. pp. 811-812, fig. 2: età adrianea.AISCOM X, pp. 809-820, in part. pp. 811-812, fig. 2: età adrianea.AISCOM X
575
Spostandoci ora nel settore termale orientale, l’ambiente N ha restituito l’uni-co mosaico figurato della villa, il cui soggetto è una scena marina che evoca indi-scutibilmente la funzione della sala. Anche in questo caso il manufatto si conser-va in stato precario; in più parti sono visibili lacune provocate dagli interventi di spoliazione, tesi presumibilmente anche all’asportazione delle lastre marmoree di un secondo piano pavimentale che, in un momento successivo, sostituì il tessella-to. Una successione di fasce bicrome in colori contrastanti circoscrive il campo di cui si conserva, presso il margine inferiore sinistro, un delfino a cui sembra fare da pendant, sul lato opposto, un secondo delfino (fig. 6). Al di sopra degli anima-pendant, sul lato opposto, un secondo delfino (fig. 6). Al di sopra degli anima-pendantli acquatici si dispongono due amorini alati cavalcanti capri marini muniti di spi-re pisciformi (fig. 7).
Si può verosimilmente ipotizzare che in origine si trattasse di una composi-zione centripeta con delfini disposti ai margini del mosaico ed eroti inquadranti una scena centrale, andata persa.
Soluzioni in tessellato campite da scene marine in redazione bicroma cono-scono un ampio utilizzo in età adrianeo-antonina23, quando si assiste al momen-to di massima diffusione degli impianti termali, soprattutto all’interno di architet-ture domestiche. Le tematiche musive privilegiate sono principalmente a sogget-to marino, le quali acquistano una notevole popolarità in particolar modo in area centro-italica.
Il manufatto fabraterno è avvicinabile a tipi analoghi provenienti da Ostia24, da Roma e suburbio romano25, oltre ai mosaici con scene marine restituite dalle vicine terme site in località La Cona del Popolo (Supino, Fr)26.
Sulla base dei confronti proposti ed in conformità alle indicazioni cronologi-che suggerite anche per il mosaico con ottagoni e squadre precedentemente ana-lizzato, si avanza per il tessellato una datazione compresa nella prima metà del II secolo d.C.
Infine, ancora presso le terme orientali si conservano due frammenti musivi riconoscibili unicamente dal rilievo archeologico (fig. 2). Immediatamente a nord dell’ambiente N si conserva un tessellato monocromo bianco, bordato da una fa-scia in colore contrastante (G); è visibile inoltre, a sud del calidarium O, una pic-calidarium O, una pic-calidarium
23 BECATTI 1961, p. 316; v. anche BECATTI 1965, in part. pp. 22-23.24 BECATTI 1961, Terme di Buticosus, p. 30, n. 52, tavv. CXXIX, CXXX, CXXXIII: 115 d.C. Di recente
alcuni studiosi hanno abbassato la cronologia del pavimento: v. A. PELLEGRINO, F. PANARITI, TH. MO-RARD, ‘Note su alcuni mosaici ostiensi di nuova e remota acquisizione’, in AISCOM X, pp. 793-807, in AISCOM X, pp. 793-807, in AISCOM Xpart. pp. 801-802, fig. 8: metà del II sec. d.C. V. anche BECATTI 1961, pp. 47-52, in part. nn. 70-71, tavv. CXXV-CXXV-CXXV CXXVI e tav. CLX: Terme di Nettuno, 139 d.C.
25 M. DI MENTO, P. QUARANTA, ‘Mosaico con soggetto marino rinvenuto in località San Basilio a Roma’, in AISCOM XII, XII, XII pp. 287-293: II sec. d.C.; G. MESSINEO, ‘Conservazione in situ dei mosaici. Il in situ dei mosaici. Il in situcaso della villa di Livia e della villa sulla via Cassia alle sorgenti dell’Acquatraversa’, in AISCOM II, pp. AISCOM II, pp. AISCOM II215-222, in part. pp. 218-219, fig. 6 (si confrontino, in particolare, le figure dei delfini): II sec. d.C.; DE FRANCESCHINI 2005, cit. a nota 13, p. 46, fig. 8.2 e fig. 8.4: età severiana; ivi, p. 61, fig. 15.2: prima metà II sec. d.C.; ivi, p. 203, figg. 72.4-5: prima metà II sec. d.C. (si confrontino, in part., la resa del-le code degli animali marini); ivi, pp. 247-248, fig. 85.5 e figg. 85.7-85.8: prima metà II sec. d.C.; ivi, p. 262, figg. 9.3-9.7: II sec. d.C. Dalla Toscana si veda P. RENDINI, ‘La villa Domitia dell’isola di Gian-Domitia dell’isola di Gian-Domitianutri (Isola del Giglio, Grosseto). Tipologie di pavimenti’, in AISCOM V, pp. 141-152, in part. p. 143, AISCOM V, pp. 141-152, in part. p. 143, AISCOM Vfig. 3: fine del I sec. d.C. - inizi del II sec. d.C; Dall’Etruria meridionale e dalla via Ostiense si veda S. AURIGEMMA, ‘Mosaici da Casal di Statua e da Risaro’, in Bd’A, XLVI, 4, 1961, pp. 150-159. Da Casal di Statua (ora presso Villa Giulia, loggia del Ninfeo) v. in part. figg. 5 e 7: I-II sec. d.C.; da Risaro (ora Museo Nazionale Romano) v. in part. fig. 16.
26 Si tratta dei mosaici restituiti dal frigidarium e dal calidarium delle terme; v. calidarium delle terme; v. calidarium R. FRASCA, ‘Mosaici figurati e sectilia pavimenta dal complesso termale di Supino’, in sectilia pavimenta dal complesso termale di Supino’, in sectilia pavimenta AISCOM XI, pp. 233-244, in part. pp. AISCOM XI, pp. 233-244, in part. pp. AISCOM XI234-237, figg. 2-3. Da ultimo v. R. FRASCA, ‘Supino: le terme di La Cona del Popolo’, in Sorgenti e ter-me 2009me 2009me , cit. a nota 2, pp. 289-298, in part. p. 290, figg. 2-3 e fig. 5: età adrianea.
576
cola porzione di tessellato bianco delimitato da due fasce monocrome in colore contrastante (O1).
Campiture omogenee regolarizzate da una o più fasce in tessere nere sono dif-fuse almeno a partire dalla seconda metà del I sec. a.C. fino in età tardo-antica27. Pertanto, in mancanza di dati archeologici più puntuali, non è possibile avanzare una proposta di datazione basata unicamente su considerazioni di tipo stilistico.
3.2. I lastricati marmoreiDalle terme orientali provengono anche due lastricati marmorei: un primo ri-
vestimento costituisce la pavimentazione dell’ambiente N che aveva sostituito il tes-sellato con scena marina in un momento sicuramente successivo alla prima metà del II secolo d.C., epoca in cui è ascrivibile il mosaico; il secondo esemplare pa-vimenta la vasca absidata O.
Pur non essendo note le specie marmoree, si tratta in ambedue i casi di pa-vimentazioni realizzate con materiale di riutilizzo, testimonianza di uno scadimen-to della qualità delle decorazioni che potrebbe caratterizzare le ultime fasi di vi-ta della villa.
3.3. Commessi laterizi disposti a spina di pesceL’edificio ha restituito tre rivestimenti a commessi laterizi a spina di pesce,
localizzati presso l’ambiente C a sud-ovest del giardino colonnato, presso un vano sito all’estremità nord-orientale dell’edificio (K) e nelle vicinanze di uno degli in-gressi principali28 alla villa (Y, fig. 8). In mancanza di un’articolazione temporale maggiormente dettagliata dei differenti settori abitativi, non è stato possibile defi-nirne l’attribuzione cronologica.
3.4. Le preparazioni pavimentaliPer completezza, va segnalata infine la presenza di una gran quantità di pre-
parazioni pavimentali di cui non sono pervenuti i piani originali, e di cui non è possibile accertare l’eventuale presenza in tracce dei rivestimenti pertinenti. Si trat-ta fondamentalmente di preparazioni in cementizio a base fittile, in alcuni casi29
arricchite da inclusi tufacei e ceramici di piccole dimensioni. Allo stato attuale si può unicamente supporre che, almeno nella maggior parte dei casi, il rivestimento originale fosse costituito da marmi pregiati, saccheggiati e spoliati già in antico.
(F.S.)
4. Articolazione cronologica e considerazioni conclusive
Sebbene la presenza di rivestimenti di uso comune quali il tessellato con pun-teggiato di crocette, le stesure musive monocrome bianche e/o i rivestimenti costi-tuiti da semplici commessi laterizi non abbia fornito indicazioni aggiuntive, l’anali-si stilistico-tipologica dei mosaici con motivi geometrico-figurati e figurati ha con-sentito di individuare una importante e fondamentale fase costruttiva, probabil-
27 RINALDI 2007, cit. a nota 16, pp. 70-71, con esemplificazioni. 28 Il dato sembrerebbe comprovato dalla presenza di un ambitus definito da due colonne di cui
rimangono i blocchi di fondazione che si impostano sul piano a commessi laterizi disposti a spina di pesce.
29 Piano di calpestio del giardino T.
577
mente anche strutturale. Questo nuovo dato permette di proporre una più arti-colata successione delle fasi di vita della villa che potrebbe essere ritenuta, in ba-se ai materiali archeologici30, già esistente in età tardo-repubblicana, ma che fu ri-strutturata e arricchita della decorazione musiva che abbiamo descritto nella pri-ma metà del II secolo d.C.; successivamente subì una ulteriore trasformazione –stavolta solo parziale – che, da quanto emerge dai dati di scavo, deve considerar-si posteriore alla metà del III secolo d.C., forse correlabile alla conversione del-la villa in mansio.
L’abitazione sembra comunque essere rimasta in uso ancora a lungo, poi-ché i materiali ceramici indicano la sussistenza dell’insediamento fino al VI seco-lo d.C. Purtroppo le esigenze connesse con i limiti imposti dall’opera ferroviaria non hanno consentito una conoscenza puntuale del complesso; si auspica quindi una ripresa delle indagini che potrebbe permettere di rinvenire nuove pavimen-tazioni, oltre a consentire una più precisa datazione di quelle qui segnalate e ri-maste ispezionabili per tempi brevi.
(G.R.B.-F.S.)
30 TRIGONA 2008, cit. a nota 2.
578
Fig. 1 – Ceccano (FR), villa in loc. Cardegna, planimetria generale (Archivio SBAL - Scavi TAV - Ceccano - Loc. Cardegna - opera VI43).
579
Fig.
2 –
Cec
can
o (F
R),
vill
a in
loc
. C
arde
gna,
rili
evo
arch
eolo
gico
con
in
dica
zion
e de
i ri
vest
imen
ti p
avim
enta
li ub
icat
i pr
esso
i s
etto
ri s
ud
e su
d-oc
cide
nta
le d
el g
iard
ino
port
icat
o T
e n
elle
ter
me
orie
nta
li (r
iliev
o M
. B
ombe
lli,
mod
ific
ato
da L
. A
ru.
Arc
hiv
io S
BA
L -
Sca
vi T
AV
-
Cec
can
o -
Loc
. C
arde
gna
- op
era
VI4
3).
580
Fig. 4 – Ambiente BB, tessellato con motivi geometrico-figurati (Archivio SBAL - Scavi TAV - Ceccano - Loc. Cardegna - opera VI43).
Fig. 3 – Corridoio R1, mosaico mono-cromo bianco con tessere disposte a or dito dritto (Archivio SBAL - Scavi TAV - Ceccano - Loc. Cardegna - ope-ra VI43).
581
Fig. 5 – Ambiente NN, tessellato con punteggiato di crocette bicrome in colori contrastan-ti (Archivio SBAL - Scavi TAV - Ceccano - Loc. Cardegna - opera VI43).
Fig. 6 – Ambiente N, tessellato con scena marina, delfino, particolare (Archivio SBAL - Sca-vi TAV - Ceccano - Loc. Cardegna - opera VI43).
582
Fig. 8 – Ingresso orientale Y, commessi di laterizio disposti a spina di pesce (Archivio SBAL - Scavi TAV - Ceccano - Loc. Cardegna - opera VI43).
Fig. 7 – Ambiente N, tessellato con scena marina, erote su capro marino, particola-re (Archivio SBAL - Scavi TAV - Ceccano - Loc. Cardegna - opera VI43).