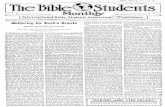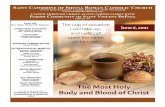Rivestimenti musivi e marmorei dello Xystus di Piazza Armerina alla luce dei nuovi scavi, in C....
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Rivestimenti musivi e marmorei dello Xystus di Piazza Armerina alla luce dei nuovi scavi, in C....
ENRICO GALLOCCH IO - PATRIZIO PENSABENE
RIVESTIMENTI MUSIVI E MARMOREI DELLO XYSTUS DI PIAZZA ARMERINA
ALLA LUCE DEI NUOVI SCAVI
Il peristilio ovoidale della Villa di Piazza Armerina, meglio noto come xystus, è stato oggetto di recenti indagini a rch eologiche nell'ambito dei lavori di restauro de lla Villa ad o pera del Centro Regio na le per il Restauro di Palerm0 1• L'interlento, finalizzato al ripristino delle antich e canali zzazio ni idrau liche, è partito dalIa semplice pulizia della superfic ie già rintracciata con i vecchi scavi, iniziati a fine '800 e conclusi negli anni '50 del secolo scorso da C .V. Centili2 : o ltre a piccoli lacerti di mosaico, tutti riposizionati in situ dopo un consolidam e n to in ceme nto, durante i precedenti restauri e ra stato m esso alla luce l'inte ro strato di pre parazione della superficie musiva, che interessava tutta l' area del cortil e, ad eccezione di un cordolo, rivestito in lastre di calcare bian co, ch e segue il pe rimetro disegnato dai pilastri d el portico.
Grazie a questo interven to preliminare è tuttavia emersa una serie di tagli rettilinei o circolari che in terrompe la continuità del massetto di preparazione (figg. 1-2): lo scavo dei re la tivi riempimenti ha permesso di acquisire nuovi dati sia per ricostruire l' immagine del monumentale cortile tardoantico, sia per analizzare le fasi ad esso precedenti e seguenti.
I tagl i rettilinei visibili sulla superficie del cortil e sono riconducibili ad una rete di canalizzazione che scorreva circa cm 50 al di sotto del piano mosaicato. Essa si compone di canali dotati di spallette in muratura e in alcuni di essi sono stati anche rinvenuti lacerti di fistulae plumbee (fig . 3) che, in ques ti casi, dimostrano chiaramente la funzione di adduzio ne dei condotti.
Osservando le sezioni dei tagli è stato possibile anali zzare le stratigrafie e le strutture sottostanti il live llo pavimentale tardoantico. In particolare è emerso un piano in cocciopesto di spessore variabile tra cm lO e 15, con superficie ben levigata3. Il fatto ch e questa pavime ntazione sia visibile in entrambe le sezion i del canale principale che attraversa il cortile attesta che essa sia stata tagliata proprio a favore della creazio ne di un grande collettore.
Gli otto tagli circolari individuati sono invece azion i successive, identificabili come fosse di scari co di età medievale: i riempimenti si ca l-atte ri zzavano pe r la presenza di materiale ceram ico d i fine X - inizio XI secolo, dunque riconducibile al periodo arabo-norma nno. Lo scavo degli interri medievali ha permesso di individuare, attrave rso la pulizia d elle pareti dei tagli, ulteriori piani in cocciopesto, asportati in coin cide nza delle fosse e posti a quote inferiori rispetto al precedente, su pian i tra cm 90 e m 2 più bassi del pavimento a mosaico di età tardoantica.
l Si desidera ringraziare l'arch. G. Me ti per la costante auenzione a ll e problcmatiche arc heotogiche connesse al progello di restauro , nonché l'arch. M. Alf' \I1o e ta dou.ssa G. Agosta per il continuo confronto sui risu ltati degli scavi. Si ringrazia inoltre la dou. ssa M.C. l.e ntini per la fiducia costalllemente rinnO\'ata a ll e atti"ità dell 'U niversità L.a Sapienza di Roma presso la Villa del Casale.
2 G.\'. GE:\Tll .l, La villa /"Oli/alla di /JiazZ({ Arll/erina, Palazzo bndio, I-III , Osimo 1999. 3 II piano era g ià stato visto dal Genti li che lo ritene"a pertin ente a cos truzioni precedenti la vi l
la tardoantica (GENTll.l 1999, c iI. a nota 2, I, p. 202).
333
In un caso, oltre ad un pia n o prese nte in sezi o ne, se ne è riscontrato un secondo, in coincide n za de l q uale si co ll ocava il fond o de lla fossa , a circa 2 m di profondità ri spe tto al pavime n to ta rdoantico: lungo il ma rg in e o rientale del fond o del taglio e ra no rimaste de pos i ta te un a serie di las trin e mannoree in forma di accumulo disordina to , ch e proseg uiva o ltre il limite della sezio ne (fig. 4). Erano presenti e lem e nti di spessore vari abile di marmi bia nchi e co lo rati-', nonché framm e nti di g rappe bro nzee .
Grazie all' anali si stra tigrafi ca appa re chiaro com e i pia ni in cocciopesto apparo tengan o ad una fase edili zia preced e nte a ll a costruzio ne de l complesso sala tricoraperi stilio o\-oidale: si tratte rebbe di una se rie di p avim entazioni a cui al momento risulta impossibile da re una pla nim e tri a, ma che si sa re bbe ro sviluppate su dil'ersi piani , segue ndo l'anda mento n a tura le de l terreno, degradante da est verso ol'est Esse sarebbe ro in correlazio ne con le strutture m esse in evidenza già negli anni '80 da E_ De Miro nell 'area a lle spa ll e de l ninfeo se micircolare posto all'estremità ovest de l cortil e": lo studioso r invenn e due sta nze aperte su di un corridoio appare ntem ente pilas trato, ch e fu ro n o interpre tate come res idui di un piccolo peristilio rela ti\ o a ll a f ~lse de lla cos idde tta Villa Rusti ca, O\'\"e ro un complesso precedente a ll ' impia n to tardoanti co, data to tra la fin e del I e la fin e del III sec. d.C.
Durante le ultim e indagini a rcheologich e si è po tu to osse rvare che questi \11-
ni , n o n so lo e rano pavimen tati a nch 'ess i in cocciopes to, ma si po nevano alla med esima quota de l piano riscon tra to ne ll a fossa m edievale dello xystus a loro più prossima. Nella sezione d ella stessa fossa inoltre è sta to possibile individuare alcu· ne strutture che sembrano ave re andam en to paralle lo a que lle viste dal De Miro. Appa re dunque eYide n te che gli ultimi da ti di scavo sullo :x)'sl us siano da ri collegare ad un complesso abbas tanza \'<lS tO, che, pur essendo ancora diffic ilmente defi nibile, p ro babilme nte p rosegui va ve rso est su te rrazzame nti superiori: i resti mar· mo re i individuati , che po trebbe ro appa rte ne re ad un rivestim e n to parietale in OPILl
secl ilfP, dimostre re bbe ro la ri cc hezza decora tiva presente in q uesti \"ani e permetterebbero quindi di sfumare que ll ' imm agin e "rustica" che tutte le strutture in precedenza individuate al di sotto de i mosaici ta rdoantichi aveva no o fferto.
All o sta to attuale d elle ri ce rche sulla Villa mancano an cora dati stratigrafi. ci in equivocabili pe r stabilire la conte mpo rane ità o la pos te ri o rità del nucleo trio cl ini o-x)'slus ri spe tto a ll e resta n ti zo ne de l complesso . Nell a sto ri a degli studi sul monumento, già il Lugli soste nn e come il triclinio, con l' a nn esso peristil io OI·oi· da le, fosse success ivo d i alme no cin q ua nt 'a nni al pe ri stili o quad ra ngolare ed alle terme ' : insieme a ll a "to rtuosità" d e i perco rsi di racco rdo co n gli altri nuclei. a loro \'o lta fr u tto di modifi ch e ed adattame nti , anche i mosa ici dell a sala triabsidata venn ero conside ra ti dallo studi oso pos te rio ri per di ffo rmit;-ì stili sti che e per di ffe· re n ti sce lte cromaticheK.
-I Si so n o r icon osciu te las tre in giall o ant ico . rosso antico . greco scrill O. ;t rriC él llo , breccia di Sciro, cipolli no. porf ìdo. portaSa l1 la. ard esia. sc rpc l1 l in o. \'(' rdc antico .
. , E. DE \ l IJ{O. ' LI \ 'il la cie l Casa le ci i Piana Arm eri na. \,JuO\'(' ri("t·IT Ilt"·. i" 1.0 "illa /"Oli/aI/a del [a .
. \alp di Pia::a .-I /"II/nil/", .'.lt i cle li a 1\ ' riun io ne sc il'l1lifi ca clc ll a Sc uo la d i perk / io namcnto in Archeologia Class ica de Il T ni n .' rsit,ì di Ca tania (Piaua Armerina 2R se llembre - I o II ohrl' 19f13)_ a clIra di G. Riaa e S. Garrano ( C-Irch) . 23. pp. 58-73. in pa ri . pp. 65-67 e fig. :) a p. 63.
Il 'e lla stessa fo ssa sono ino ltre sl<Hi rin H .' llli ti fra lllln en l i di inton aco di pin lo. 7 G. l. U :J.I , 'Co nlribu lO a ll a sto ri a ccli li /i" d e ll a \" ill a ro ma na cii Piaua r\rmerin a·. in RlASA, XX·
XXI , 1963. pp. 21\-1\2. in parl. p . 62. H L L"( ;I.I 1963. ( il. a nota 7, p. 34 c pp. 51\-:-,9; in co ntrappos i/ io ne ". S. SI·:rrIS. ' Per I" interprela
zio ne ci i Piau a Arm erina ' . in IHEFRA. 1\7. 1975. pp. 965-9fl2. che a ll r' ''T rs" un'ana li si s( manti ca delle iconogra fi e de ll a sa la trico ra indi"iclua I"ull ilariclù p roge lllla ic clei m osa ici clcl la \'i ll a.
334
Osserì/ando i mosaici d e l com p lesso tr iclinio-x)'stus, compresi i corrido i di raccordo con gli altri se ttori d e lla villa, a n ch e negli ultimi stu d i son o e m e rse alcun e ~elle iconografi ch e connesse a particola ri posizioni topografi ch e all'in te rno d ella re idenza, che pe rme tton o di sostenere la poste riorità de l qua rtie re in esam e, inlieme a quella dell ' ingresso ad arco trio nfa le, r ispetto al com plesso pe ristilio quaarangolare-term e .
A.na lizzando in particola reCJ l' a rea scop e rta de ll o x)'stus, si p uò n o ta re com e il motiro a zig-zag qui presen te (fi g. 3) si r iscontri anch e in una p iccola esed ra semicircolare al centro d e l cor tile di racco rdo tra il pe ristilio ovoidale ed il corriaDio della Grande Caccia (fi g . 5), n on ch é ai piedi de lla sca lin ata cen trale ch e co llega il peristilio quadran golare e il corrido io d ella Grande Caccia (fi g. 6). In tutti e Ire i casi le scelte cro ma tich e d ei quadrati , ch e, alte rna ndosi, gen e ra no il motiro, sono pressoch é uguali , pu r n o n ri scon trandos i le stesse misure lo. Va so tto lineato come proprio l'ul tim o caso citato ven ga unanim e m ente ri co nosciuto, negli ItlIdi sull 'argom ento, com e apparte n en te ad una fase ta rda o comunque ad un rifucimento cii un precedente tappe to musivo Il. Ne lle fasce laterali d e l m osaico sono rapp resentati due kantharoi dai quali fuoriescono e lem e n ti vegetali che, solo nel lato norcl , si accompagnan o alla scritta Bonifatius segui ta d a i segni II, III e TV (gli ultimi due ripe tuti clue vo lte) . Proprio il Iwn tharos è un motivo che si rinviene in pun ti no teyo li connessi co n il complesso tri clinio-x)'stus: esso in fatti compare nelle clue soglie cii accesso ai corrido i ch e pongo no in com unicazio ne il peristilio quacl rangolare ed il corriclo io d e lla Gra nde Caccia con il com plesso in esame, ed un terzo è cla ri costruire n ella lunetta semicircolare d i accesso d a no rd al portico clello x)'stus. Il significato cii ques ta ra pp resen tazio ne va posto in relazio ne col nome ci i Bonifatius e coi n ume rali a lui collegati e, sia ch e si segua la tende nza a riconclurli acl acclam azioni d i un venatorl '2, sia che li si ricoll eghi ad una specifica sodalitas1:" è la lo ro posizione topografi ca a segnare un nuovo percorso all'interno cl elia yill a , a cui va sommata an ch e la p iccola latrina o ttagona, posta alle spalle clella basilica, ch e presenta sulla su pe rfic ie pavimentale un unico g ra ncle kan/haros cla cui fuo riescon o girali con foglie cI ' edera. Q uest' ul tima rappresenta la prol"a cii un allargam ento clei pe rcorsi pubblici an che in aree pe rime trali es te rne ai l'an i prin cipali cle lla vill al~, fatto probabilmen te alla base cle ll a necessità ci i r ive-
9 In questa sede . per esigenze di sintesi. si soprassiede d all'an al isi de ll e iconografie de i mosa ici posti nell'ambulacro de ll a corte e de ll e sale ape rte su d i esso. In q u esti pa"im enti è g ià stata nota ta una differe nziazione rispetto agli a ltri n uclei de ll a \ 'ill a: si "eda in particolare A. RI CCI in A. C\R.-\:\OI:\1. A, RiccI. \1. DE \ 'OS. Filosofiana . La villa di Pia:~a Armerina. III/maginf di un arislorraliro roll/{/II0 al Ip/IIjJo di Costal/ til/o. Palerm o . 1982 . pp . 300-307
IO Già il Carandini , confron tando i tappeti m usi"i con moti" i a zig-zag l' isibi li ne ll a Villa , ipot izza una posteriorità . m a se m p re a ll'inte rn o de l lì ' secolo. del complesso triclinio-xnll/s. p u r in asse n za d i indagini stratigrafi c h e: " . C. A'[POLO. A. C-\R.-\:\OI:\I, G . Pu:u . P. PE:\5.-\I;E:\E , 'La , 'i1l a de l Casa le a Piazza ,\nnerina. Saggi st ra ti grafic i ed a ltre ricerche- , in tHEFRA , 83. 197 1. pp . 14 1-281. in pa rI. pp. 175. 239.
Il L'ipotesi d i una posteriorità del mosaico d i BOllifalius " iene già ""an zata in A:-I po l.o. C-\R.-\:\DI\1. PL'CCI. PE:\S.-\BE:\E 1971. ciI. a nota IO , pp. 236-239 , n el COI1lesto dell'anal isi del mosaico a p rotomi animali del gran d e Peristil io; il Ge nti li ( GE:\TIl ,1 1999 , ciI. a nola 2. I, pp. 77-79) co nsidera il mosa ico contemporaneo con q u e llo de l Peristi lio. con fro nta ndo il l11oti\'() a zig-zag con esempi tun isin i d i III sec. d.C. ed ipo ti zzando inse ri menti poste riori solo ne ll e fasce lateral i con i /wnlharoi. Ln ico a no n rilelare alcuna poste riori tà è il LlI gli (LL'eLl 1963, ciI. a n ota 7, pp . 46-47 ) .
12 Già in S. \L-\ZZ,-\RI:\O. Trallalo di sloria IDllla/w, Il, ROllla. 19:;6, pp, 326-32 7 e poi. con maggio re approfond imento. in .-\:-11'01.0. C-\R.-\:\DI:\ I. PL'CCI. PE:\S .. \RF.:\E 197 1, ciI. a no ta l O. p . 2:')0.
l~ _-\. BESCH,-\OL-SI-I . 'La mosaique de eh asse à l'Amphiteatre decolll'e rl a Sm ira t l'n Tun isic·. in C/Ul/, 100.1966. pp. 1 3 -l-I.~7_ in pa r I. p , 1S7,
14 Si noti in panicola r m odo la trasfo r mazione da fi nestre a porte de ll e ape n llre a i la li d clla bas ilica . in conness ione con il corrido io della Grande Caccia: pe r ognU ll <:l delle finestre fu necessaria l'aggiu nta di due grad ini (cfr. .. \:-11'01.0. C\R_\:\DI:\ I. PU:CI. PE:\S,-\BE:\E 197 1. ci I. a nola IO. p. 162) ,
335
stire con intonaco dipinto le pareti esterne di molti ambienti. Questa azione, che segue sicuramente una prima fase edilizia, poiché è posteriore all'aggiunta di pio lastri a sostegno della murature , può dunque forse essere contemporanea alla costruzione del nuovo complesso meridionale, che allarga ulteriormente lo spazio a disposizione del dominus.
All'interno di questa ristrutturazione possono essere inserite anche le corti che precedono e seguono l'arco tripartito. La costruzione di un nuovo accesso, insie· me proprio alla creazione del peristilio ovoidale, avrebbe comportato infatti la di· struzione di una serie di vani precedenti e, in questo caso, tutto il piano di fron· te all'Arco tripartito sarebbe stato abbassato, generando un dislivello di quasi m l rispetto alla quota delle strutture più antiche, nonché determinando la necessi· tà di rimodellare l'accesso al vestibolo con mosaico di adventus. A nord dell 'arco di ingresso questo abbassamento appare confermato anche dal fatto che, nel mu· ro che delimita ad est la corte poligonale, sia rimasto visibile un arco di scarico connesso ad una condotta fognaria, che scorreva ad una quota superiore rispetto a quella del nuovo piano pavimentale.
Si può dunque affermare che la costruzione del complesso sala triabsidataperistilio ovoidale sia collegata ad un importante intervento di rinnovamento ed espansione di tutta la villa, in rapporto a nuove e più ampie esigenze del domi· nus. Il nucleo , non a caso posto a sud, si definisce come un maestoso triclinio estivo, lussuosamente decorato e raccordato da percorsi anch'essi sontuosi, pur se ricavati entro spazi di risulta. All'interno di questo contesto l'acqua gioca un ruo· lo fondamentale: le nuove scoperte permettono di ricostruire un reticolo di canalizzazioni per il funzionamento di almeno sei fontane e per l'alimentazione del ninfeo all' estremità ovest del cortile (fig. 7). All'interno di questo quadro si vuo· le proporre un'ulteriore suggestione legata all'acqua, che, seppur attraverso labili indizi, potrebbe spiegare il tipo di disegno a zig-zag per il tappeto musivo all' interno della corte: la presenza di un leggero sguscio, conservato in pochi punti lungo il perimetro dei tre lati del portico, ai piedi dei pilastri e dei bassi muretti che li collegano, unita all'inclinazione di tutta la preparazione per il mosaico verso il punto di uscita del collettore principale, permette di immaginare la presenza di un meccanismo che generasse, quantomeno in alcuni momenti, il completo allagamento della corte scoperta con un leggero velo d'acqua. Come per il triclinio della villa tardoantica di Faragola l ", si potrebbe infatti ipotizzare che durante incontri ufficiali o in occasione di sontuosi banchetti, svolti magari presso l'adiacente sala triabsidata e forse allargati ad ospiti disposti ne lle tre stanze presenti su ciascun lato lungo del peristilio, l 'acqua che "allagava" l'area scoperta offrisse, oltre ad un soave refrigerio durante la calura estiva, anche infiniti giochi di luce e riflessi, accentuati dal motivo a zig-zag, o per meglio dire "ad onda", scelto appositamente per il contesto. Allo stesso modo, la piccola esedra presente nel corridoio di passaggio tra corridoio della Grande Caccia e peristilio ovoidale, dotata del medesimo modello di tappeto musivo, avrebbe potuto svolgere la funzione di piccola fontana semicircolare.
La creazione del nuovo imponente impianto richiese il potenziamento del rifornimento idrico, realizzato attraverso un nuovo braccio di acquedotto, a testimonianza di come l'acqua si ponesse quale valore aggiunto del linguaggio architettonico , al fine di esaltare l'autorappresentazione del proprietario.
l'i G. VOLPE, G. DE FELICE, M. TCRCHIANO, 'Musiva e seclilia in una lussuosa residenza rurale dell'A!Jlllia tardoanlica: la villa cii Faragola (Asco li Satriano, Foggia)', in Musiva el SectiLia, l, 2004, pp. 127-158, in parto p. 152.
336
t
Fig. l - Villa del Casale, Rilievo dello scavo presso lo Xystus (rilievo E. Gallocchio).
Fig. 2 - Villa del Casale , Foto del cantiere di scavo dello Xystus (foto E. Gallocchio).
337
Fig. 3 - Villa del Casale, Tratto di fistula plumbea per il rifornimento delle fontane della corte (foto E. Callocchio).
338
Fig. 4 - Villa del Casale, Scavo di uno dei pozzi medievali con residui di opus sectile sul fondo (foto E. Gallocchio).
Fig. 5 - Villa del Casale, Mosaico a zig-zag presso il corridoio di raccordo tra lo Xystus e l'Ambulacro della Grande Caccia (foto E. Gallocchio) .
339