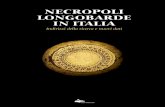I conventi francescani a Piazza Armerina: architettura e trasformazione
Transcript of I conventi francescani a Piazza Armerina: architettura e trasformazione
I conventi francescani a Piazza Armerina:architettura e trasformazione
Domenica Sutera
Esaminare l’architettura dei Francescani a Piazza Armerina non significaunicamente risolvere i problemi filologici attualmente esistenti sulle fasi crono-logiche o ancora delineare il profilo dei promotori e degli artefici, nomi deltutto ignoti alla storiografia. Si tratta piuttosto di un’occasione di verifica su untema molto più generale che coinvolge la storia della città e la rende particolarerispetto al contesto isolano. Studiare le famiglie francescane, Ordini che conti-nuano, nonostante le differenze interne, a professare un’immagine pubblica dipauperismo, ha permesso di saggiare la risposta, più o meno cosciente, che laciviltà costruttiva locale ha dato alle novità e invenzioni di un cantiere che haofferto effettivamente a tutta la città nuove ragioni concrete alle architetture ealle loro trasformazioni: la fabbrica della Chiesa Madre. Motore culturale diPiazza Armerina, l’edificio religioso più importante è strettamente relazionatocon le diverse sedi francescane, per ragioni di natura economica e culturale, maanche e soprattutto urbanistica e costruttiva.
La storiografia architettonica dei Francescani di Piazza Armerina si rivelascarna di notizie e di esaurienti fonti archivistiche. Inoltre, alla forte presenzafisica, sociale, spirituale e culturale dei vari rami della famiglia francescana (fratiMinori Conventuali, Osservanti Riformati, Cappuccini e Clarisse), che operaronoa Piazza per più secoli con le loro sedi strategicamente insediate nel territorio,oggi non corrisponde una altrettanto significativa “presenza architettonica” neltessuto urbano ed extraurbano. In alcuni casi, sono ancora oggi esistenti e frui-bili alcuni conventi, chiostri e chiese francescane all’interno del centro abitato,ma è pur vero che in altri esempi, come per il convento degli Osservanti Rifor-mati di Santa Maria del Gesù, o ancora di più per il monastero delle Clarisse,solo alcuni frammenti (dai portali ai simboli francescani), costituiscono gli uniciindizi per un’individuazione e ricostruzione ideale del manufatto ormai perdutoo solo parzialmente integro nelle sue tre componenti essenziali di chiesa, con-vento e chiostro. Come ha rilevato la storiografia più recente,1 le notizie sul pri-
1 Lo stato degli studi relativo alle famiglie francescane e alle loro sedi a Piazza Armerina
Domenica Sutera284
mo insediamento dell’Ordine francescano in questo centro e la sua successivaattività sono dense di incertezze, ma già a partire dal XIII secolo si avvicendaro-no nella cittadina le edificazioni di più complessi tra centro storico e area extra-urbana. Si può dedurre, sulla base della scelta dei luoghi delle sedi dell’Ordinea Piazza, una volontà di ripartizione delle diverse aree di influenza dentro e fuo-ri il circuito murario, mediante la creazione di poli urbani o extraurbani signifi-cativi.2 Seguendo, infatti, la progressiva espansione della città da ovest a est delcolle Mira agli inizi del Seicento, le famiglie francescane occupano in modoequilibrato le diverse aree della città: la chiesa e il convento dei frati MinoriConventuali costituiscono, insieme al castello aragonese e alla matrice, gli edificimonumentali dell’“acropoli” sul monte; le sedi degli Osservanti Riformati(Santa Maria del Gesù e San Pietro), insistono, all’esterno della città moderna,su aree di facile accessibilità e di passaggio obbligato per immettersi nel centrourbano; il convento dei Cappuccini domina, invece, la città meridionale dal pia-no di Sant’Ippolito, mentre il monastero delle Clarisse trova il definitivo inse-diamento all’interno del circuito murario, nel piano del Padre Santo.
Una rappresentazione di Piazza della seconda metà del Seicento3 esplicitachiaramente il ruolo di tutti i conventi francescani rispetto alle sedi degli altriOrdini conventuali. Anche i complessi extraurbani, quali quelli dei Cappuccinio dei due nuclei dei frati Riformati, vengono rappresentati secondo una forma ecollocazione ideali ai margini delle mura, trasponendo così, a mezzo della re-stituzione grafica, la consapevolezza del loro significativo raggio di influenzadalla campagna al centro abitato. La tavola mostra, inoltre, il rapporto direttoche questa corona di fabbriche ha con il suo centro ideale, la chiesa madre, ful-cro sperimentale degli aggiornamenti linguistici per tutta l’età moderna nellacittadina.
Dotati quasi tutti di una modesta consistenza economica, pur sempre deri-
si è soffermato sul contributo di L. VILLARI, Storia Ecclesiastica di Piazza Armerina, Messina1988, pp. 223-259. Si vedano inoltre: F. CAGLIOLA, Almae Siciliensis Provinciae Ordinis Mi-norum Conventualium S. Francisci. Manifestationes novissimae, sex explorationibus com-plexae, Venezia 1644 (ristampa a cura di F. ROTOLO, Palermo 1984), p. 115; G. P. CHIARANDÀ,Piazza città di Sicilia antica, nuova, sacra e nobile, Messina 1654, pp. 215-221, 227; R. PIRRI,Sicilia sacra, a cura di A. MONGITORE e V. M. AMICO [1ª ed. Palermo 1644-1649], 2 voll., Palermo1733, rist. anast. Bologna 1987, vol. I, p. 587; P. CAGNI, Piazza Armerina nei secoli, Piazza Ar-merina 1969; ID., Monumenti di Piazza Armerina, in «Demetra» 1 (1993), schede n. 16, pp. 46-47; n. 17, pp. 48-50; n. 26, pp. 67-69; n. 36, pp. 87-88.
2 A. CASAMENTO, Francescani e città: il ruolo dell’Ordine Mendicante nello sviluppo ur-banistico di Mazara, in Francescanesimo e cultura in Sicilia (secc. XIII-XVI), Atti del Convegnointernazionale di studio, Palermo 7-12 marzo 1982, in «Schede Medievali» 12-13 (gennaio-dicembre 1987), p. 322.
3 Si tratta in realtà di due vedute quasi identiche, risalenti rispettivamente al penultimo eall’ultimo decennio del XVII secolo, pubblicate in L’Archivio Trigona di Canicarao. Piazza e lasua Nobiltà fra XVI e XVIII secolo, catalogo a cura di S. PARISI, Enna 1986, pp. 7-29.
I conventi francescani a Piazza Armerina: architettura e trasformazione 285
vata da questue, elemosine dei fedeli o beneficenza soprattutto privata o dellacomunità urbana, ma gratificati socialmente da numerose vocazioni che richie-devano una maggiore ricettività dei locali, nel corso dei secoli le sedi francesca-ne di Piazza evidenziano l’esigenza di trasformare e ampliare le vecchie struttu-re preesistenti, dando vita a un’incessante attività edilizia tra XVI e XVII secolo.Significativo è il fatto che quasi contemporaneamente alla completa riconfigu-razione monumentale della chiesa madre (dal 1598),4 le famiglie francescanerifonderanno le loro sedi, rafforzando anche figurativamente la loro presenzasul territorio e sulla città.
I tre conventi francescani fuori le mura -i Cappuccini, i Minori OsservantiRiformati del convento di Santa Maria del Gesù e di San Pietro- saranno infattiufficialmente coinvolti dal testamento del barone Marco Trigona, attraverso lacostituzione di un legame burocratico ed economico tra chiesa madre, nominataerede universale, e i tre conventi. In cambio della partecipazione dei guardianifrancescani all’elezione dei fidecommissari esecutori testamentari, sarà infattigarantito ogni anno alle loro sedi un legato di cento onze per «marami, conzi etrepari»,5 ricavate dai proventi dell’eredità.
Se non si può comunque parlare di una vera e propria architettura france-scana nella città, tuttavia queste trasformazioni architettoniche, con le loro speci-fiche valenze linguistiche e costruttive, rientrano in pieno nelle diverse stagionidell’architettura presenti a Piazza fra tardo rinascimento e barocco. In tal sensoun probabile denominatore comune dell’architettura di queste sedi francescanepuò essere ricondotto alla volontà di trasformazione delle strutture preesistentisecondo linguaggi “aggiornati”, soprattutto nei dettagli o nel disegno dei por-tali, cappelle e decorazioni interne. Nel nostro caso, l’esigenza di rinnovamentosi manifesta in particolare nel progressivo adeguamento dei nuovi manufattiall’utilizzo del mattone a vista e della sua tecnica di lavorazione. Il mattone èinizialmente misto alla pietra locale, in cocci oppure impiegato da solo a facciavista fino ad assumere una duplice funzione strutturale e insieme estetica, se-condo la prassi costruttiva e figurativa che caratterizza tutta Piazza dal Seicentoin poi, con chiaro riferimento a quanto accade intorno al cantiere della chiesamadre, interamente realizzata in mattoni pieni a cortina.
La storia architettonica e costruttiva dei diversi conventi francescani effet-tivamente attraverserà questo processo di trasformazione e adeguamento che av-verrà in modo progressivo, dal monastero delle Clarisse a quello dei FrancescaniConventuali. Diversamente sarà per il convento dei Cappuccini e di San Pietro,
4 D. SUTERA, I progetti per la chiesa madre di Piazza Armerina e l’architetto Orazio Torria-ni: 1598-1628, tesi di dottorato in «Storia dell’Architettura e Conservazione dei Beni Architetto-nici» (XVIII ciclo), tutors M.R. Nobile e R. Bösel, Università degli Studi di Palermo 2006.
5 Testamento del Barone Marco Trigona, Piazza Armerina 1930, LXXI, p. 56.
Domenica Sutera286
dove la particolare “dipendenza” dalla fabbrica della chiesa madre riguarderàragioni urbanistiche o comuni modelli di riferimento.
Il monastero del Secondo Ordine delle Clarisse è il convento di più anticafondazione attualmente presente a Piazza, costruito a spese del barone della Bi-fora, Guglielmo Caldarera, nel 1320, discendente di Ruggero Caldarera «la cuicasa fu poi Monasterio di Santa Chiara»,6 come riporta il noto storico piazzeseChiarandà. Adiacente alle mura cittadine nel piano del Padre Santo, fu in se-guito affiancato dai complessi di San Giovanni Evangelista delle monache be-nedettine e dei Teatini. Il monastero era dotato di chiesa, ampio chiostro e ilconvento offriva spaziosi locali per il ricovero delle monache e delle educande.Le fonti esistenti sul complesso conventuale si fermano qui, ma alcuni docu-menti conservati presso l’Archivio di Stato di Enna portano alla luce nuove in-formazioni sul monastero, sui suoi possedimenti e sulla sua storia costruttiva neltempo.
In primo luogo si posticipa al 13 giugno 13467 (anziché al 1320, comefinora riportato dalla storiografia), il testamento di Guglielmo Caldarera, rogatodal notaio Jacobo de Valento che sottoscrive la volontà di fondare a Piazza ilmonastero di Santa Chiara. Dopo aver cambiato diverse sedi nel 1346 e nel1481, per ampliare il monastero e per celebrare la solennità del Santissimo Sa-cramento che si praticava a Santa Chiara fin dal 1350 (la cui processione“esterna” coinvolgeva dal 1522 anche e solo la chiesa madre),8 il 15 settembre1576 «si incominciò ad edificare lo terzo loco della chiesa del monasterio nelpiano del padre santo, […] e nel 1589 si ridusse la fabbrica a termine di potersinella chiesa celebrare».9 Un altro documento registra infatti esiti di pagamento,sottoscritti dal notaio Pietro Tomasino di Piazza, per la costruzione «della fab-brica della ecclesia nova cu li soi officini»,10 a partire dal 25 agosto 1588 e pertutto il 1589. Alle soglie del XVII secolo, il monastero di Santa Chiara eraquindi uno dei maggiori centri religiosi della città tanto che nel 1654 il con-vento ospitava ben ottanta monache ed era sede di una delle più importanti pro-cessioni cittadine in collegamento diretto con la chiesa madre. Nel documento,inoltre, sono riportati pagamenti a vari mastri e manovali per materiali da co-struzione (pietre, salme di calce, chiodi) per la realizzazione di “cantonere” emuri, grate di ferro per finestre, paramenti per il monastero. Tra i maestri coin-
6 G. P. CHIARANDÀ, Piazza città di…, cit., p. 269.7 Enna, Archivio di Stato (ASE), Atti delle Corporazioni Religiose Soppresse, 1576-
1605, vol. 555, cc. 6r- 11r. 8 L. VILLARI, Storia Ecclesiastica…, cit., p. 56.9 ASE, Atti delle Corporazioni Religiose Soppresse, f. 3 r-v. Il documento è trascritto in
appendice.10 ASE, Notai Piazza Armerina, not. Pietro Tomasino, vol. 2281, 73 c. 3 ss.
I conventi francescani a Piazza Armerina: architettura e trasformazione 287
volti si trovano frequentemente citati i nomi di Giovanni Zaguzu «in conto dellamaestria della cantonera dell’ecclesia e dell’intaglio»;11 Antonino di Lentini,con i suoi quattro manovali pagati per tre giornate di lavoro per «dirupari li ca-si»12 e il «fabricator et sculptor» Luca Castello, per la maestria impiegata nellafabbrica della chiesa, il 3 febbraio 1589. Si trattò, quindi, di un cantiere abba-stanza impegnativo che richiese l’opera di maestranze specializzate e operanti inambito locale. Il maestro muratore Luca Castello, ad esempio, risulta ancora at-tivo in città nel 1605 come perito per stimare un tenimento di case13 e ancoranel 1607 nel cantiere della chiesa madre a fianco dell’ingegnere Giovanni Maf-fei che ne diresse i lavori dal 1605 al 1609.14
Nel corso del secolo successivo si può assistere anche a Santa Chiara adinterventi di ammodernamento, così come è avvenuto in altre fabbriche presentia Piazza nate nel Seicento, dalla facciata della chiesa madre a quella di SantoStefano o alla vicina, ma incompleta San Lorenzo dei Teatini. Attualmente èpossibile osservare due portali settecenteschi dal timpano curvilineo spezzato diimpronta borrominiana recanti a rilievo il simbolo dell’Ordine; probabilmentesi trattava di due ingressi posti sul fianco della chiesa, che doveva essere rettan-golare e a unica navata.
Singolare a Santa Chiara, ma lo ritroveremo anche nel convento di SantaMaria del Gesù, è l’adozione di un paramento murario con pietra a vista“rincocciata”15 o “scagliata” con elementi in laterizio o con mattoni rotti ograste (rimasugli), tecnica che in qualche modo, oltre a rinforzare la malta tra lecommessure, arricchisce esteticamente il prospetto di un’architettura sostan-zialmente povera.
Coerenti alla Riforma, le confraternite presenti a Piazza concepirono i lo-ro conventi come delle “case di ritiro”, isolate dal centro urbano e con archi-tetture semplici e modeste, dove le chiese erano tutte a navata unica coperta avolta, arricchite in seguito da arredi e paramenti, frutto di probabili donazioni. I
11 Ibidem .12 Ibidem .13 Ibid., not. Angelo Perrucio, vol. 2015, c. 226.14 Ibid., not. Giuseppe Palermo, vol. 4911, cc. 429r-431v. Cfr. anche Piazza Armerina,
Archivio Storico Diocesano (ASDPa, in corso di inventariazione), Fondo Collegiata Chiesa Ma-dre, Archivio II, n. corda 27 (11-4-7), cc. 593r-v; Ibid., Archivio I, Mandati originali fattiall’undicesimo thesoriero Andrea di Assari per conto dell’heredità del quondam Marco Trigona,Lauria Trigona et Assari, Patrimonio ordinario, et della Casa dell’Orfane, l’anno quinta et sextainditione 1607 et 1608, n. corda 27, c. 59r.
15 Dal termine “rincocciatura”: fodera per rivestire i muri vecchi fuori squadra, formata dafrantumi di mattoni, schegge di tufo calcareo e malta comune, dello spessore di 4 cm. Si veda A.MAZZAMUTO, Glossario dei termini tecnici siciliani, in F. GIOVANETTI (a cura di), Manuale del re-cupero del centro storico di Palermo, Palermo 1997, p. 391.
Domenica Sutera288
frati, infatti, non possedevano per propria scelta né beni immobili né rendite,concesse tuttavia dal Concilio di Trento: i Cappuccini, ad esempio, il cui mo-dello di vita era basato esclusivamente sulla povertà assoluta, edificarono il lorosecondo convento a partire dal 1592 accanto alla chiesa della Madonna delleGrazie, nel piano di Sant’Ippolito. La fabbrica era rivolta verso la città modernae la sua acropoli, costituendo un’altra “roccaforte” francescana della quale iCappuccini entrarono definitivamente in possesso nel 1606.16 Per costruire inuovi locali i frati utilizzarono il ricavato della vendita della vecchia sede e leelemosine del senato; inoltre, come riportano le fonti, rifiutarono un legato di150 onze l’anno, utilizzate solo parzialmente per la costruzione del nuovo mo-nastero,17 ma usufruirono invece sicuramente del lascito del testamento del ba-rone Marco Trigona, come si legge in alcuni documenti conservati pressol’archivio della chiesa madre.18
Probabilmente molti frati erano anche mastri, muratori e falegnami, im-pegnati nella costruzione delle loro chiese e case: a questa ragione forse sonoanche da riferire le caratteristiche di semplicità e di essenzialità linguistica dellesedi o l’assenza di nomi di architetti o tecnici noti a cui attribuire costruzionisolo apparentemente diverse tra loro. È la tecnica muraria adoperata in alcuni diquesti conventi che ne determina il “riscatto” estetico e in un certo qual modoli nobilita.
Il primo convento a Piazza dei frati Riformati o volgarmente detti
16 Sulle due sedi dei frati cappuccini il Pirri (Sicilia … , cit., p. 587) riporta: «sedem sibielegerunt in loco, qui dicebatur Turris Renda, nunc cappuccinorum vetus templum, deide an. 1592,caeli gravitate, mutatis domiciliis, venerunt in id templum, quod est in planitie S. Hippolyti àcivitate 500 p. […]».
17 Si veda S. CUCINOTTA, Popolo e clero in Sicilia nella dialettica socio-religiosa fra Cin-que-Seicento, Messina 1986, p. 465.
18 Nel corso del XVII secolo saranno numerosi gli interventi di manutenzione per i treconventi indicati nel testamento Trigona, per citarne solo alcuni: ASDPa, Fondo CollegiataChiesa Madre, Archivio I, Mandati originali fatti al ventesimo ottavo thesoriero della Maggiorechiesa di questa città di Piazza, Don Francesco Starrabba barone degli Scibini, per conto delle he-redità delli quondam Marco Trigona, di Lauria Trigona et Assari, di Saltamuri, della Casa D’Orfane,et di Aurelio di Messina, et Giacomo Buccheri nell’anno nona inditione 1625 et 1626, n. corda58, c. 4 (convento di San Pietro); ASDPa, Mandati originali fatti al trentesimo thesoriero dellaMaggiore chiesa di questa città di Piazza, Giulio Trigona barone della Montagna di Marzo, perconto delle heredità delli quondam Marco Trigona, di Lauria Trigona et Assari, et di Don GiuseppeSaltamuri, della Casa D’Orfane, di Aurelio di Messina, di Giacomo Buccheriet a conto delle renditepervenute dalla elemosina raccolta per la Madonna Santissima nell’anno undicesima indittione1627 et 1628, n. corda 62, f. 337 (convento dei Cappuccini); ASDPa, Ordini e mandati originalidell’heredità delli quondam Marco, et Lauria Trigona, Casa d’Orfane, Aurelio di Messina, GiacomoBuccheri alias Scozzarella, Canonicato di Beatrice Sanfilippo, Legato lasciato dalli Trigoni, teso-rieri Dottor Don Melchione la Monaca dell’anno tertia inditione 1664 e 1665, Giuseppe Trigonadel quondam Orazio quarta inditione 1665 e 1666, Giuseppe Trigona del quondam Orazio quintainditione 1666 e 1667, n. corda 96, c. 224r (Santa Maria del Gesù).
I conventi francescani a Piazza Armerina: architettura e trasformazione 289
“zoccolanti”, stanziatisi a Santa Maria del Gesù in contrada Rambaldo, ne offreun valido esempio: si tratta di un complesso di cui è tuttora incerto l’anno difondazione.19 Forse una data, il 1450, ovvero vent’anni dopo l’arrivo dell’Os-servanza a Piazza, incisa su una campana realizzata dal «magister Nicolaus deTurturici»,20 può costituire un iniziale indizio per la realizzazione del primo in-sediamento extraurbano a confine con il vecchio cimitero, con chiesa e con-vento, costituito da trenta celle, un noviziato e una biblioteca.21 Al 1578, in se-guito alla raggiunta autonomia di una propria custodia,22 si può ascrivere la ri-configurazione del doppio portico in facciata. La chiesa, anche qui ad aula co-perta a volta a botte lunettata, presenta infatti un singolare ingresso laterale pre-ceduto da un prospetto a doppio loggiato coperto a padiglione e definito infe-riormente da un portico pilastrato ritmato da archi a tutto sesto. L’ordine supe-riore, più tardo, è scandito da archi ribassati di matrice iberica, su colonninemonolitiche in pietra arenaria. Il paramento murario tra i sostegni, così come ipilastri a sezione quadrata e gli archi, sono realizzati in mattoni pieni attual-mente a vista, persino la pavimentazione, assestata a spinapesce, presenta gradinicon mattoni posti a coltello [fig. 1]. In tal senso il laterizio da materiale da co-struzione diventa “cortina” acquisendo qualità estetica e architettonica, ma inquesto caso senza soluzioni di continuità materiale tra sostegno, superficie mu-raria, cornici aggettanti e pavimento. Unico elemento di diversificazione è inve-ce dato dall’assestamento degli elementi (in spessore o di fascia, in chiave, acoltello, a spinapesce), che determina la varietà nella composizione. Nella prati-ca siciliana le strutture realizzate in mattoni erano tuttavia destinate quasi sempreall’intonaco e, anche se erano riconosciuti i vantaggi statici offerti da tale mate-riale per la creazione di strutture leggere, non apparteneva alla tradizione co-struttiva locale la possibilità di fabbricare a “cortina”, come invece avvenivaancora frequentemente nelle altre realtà regionali, relativamente a Firenze, Mila-no e Roma, soprattutto nell’edilizia tra Quattrocento e Seicento. Con molta pro-babilità anche parte del prospetto del portico di Santa Maria del Gesù di Piazzadoveva essere intonacato, come dimostrano alcune tracce nella superficie mura-ria, secondo una configurazione che invece lasciava a vista il disegno strutturaledelle arcate in mattoni. Un precedente significativo dell’uso del laterizio perstrutture in alzato, come archi e colonne, si riscontra a Castelbuono (nelle Ma-donie) verso la seconda metà del Cinquecento, all’interno della vecchia matricee nelle chiese di Sant’Antonio Abate e di Santa Maria della Catena. Tali inter-
19 Il Cagni (Piazza Armerina…, cit., p. 100) afferma che il convento fu fondato nel 1451dal beato Matteo vescovo di Agrigento, ma non indica alcun riferimento documentario.
20 S. CUCINOTTA, Popolo e clero…, cit., p. 459.21 Si veda D. CICCARELLI (a cura di), La circolazione libraria tra i francescani di Sicilia, 2
voll., Palermo 1990, vol. I, p. XIX.22 R. PIRRI, Sicilia…, cit., p. 587.
Domenica Sutera290
venti sono da riferire alla presenza di maestranze specializzate di origine lom-barda (e di committenza prevalentemente francescana), come il mastro “longo-bardo” Bernardino Lima, attivo inoltre ad Enna nel duomo intorno al 1566 eforse fino al 1575.23 Sul fianco laterale del complesso conventuale di Santa Ma-ria del Gesù a Piazza ritorna, invece, la singolare “rincocciatura” che con ef-fetto “puntinato” evidenzia questa volta non l’elemento strutturale, qui in pie-tra locale, ma il legante, ovvero malta nella commessura tra gli elementi e rin-forzata da cocci in laterizio, come già visto nel monastero di Santa Chiara.
Nel corso del Cinquecento i frati minori conventuali trasformarono la lo-ro sede24 in cima al colle Mira, rocca già nobilitata, come detto, dalla presenzadel castello aragonese e della chiesa madre. I frati conventuali si assicuravanocosì una postazione privilegiata e contemporaneamente di controllo dalla zonapiù alta del centro, a guardia della sottostante valle Rocca e Castellina. Per primifurono edificati il chiostro quadrato dal peristilio con colonne silicee monoliti-che con al centro un serbatoio di acqua piovana e l’attigua chiesa, ampliata nelsecolo successivo. Come altri impianti del periodo, la chiesa è a unica navatasormontata da volta a botte lunettata; l’aula è preceduta da un vestibolo a tre ar-chi con volta a crociera e culmina in un presbiterio a pianta quadrata con volta apadiglione. I frati conventuali vivevano di questue ma, avendo accettato le con-dizioni concesse dal Concilio di Trento nel considerare il complesso come ente-convento, possedevano anche beni immobili che garantivano cospicui introiti, inparticolare una rendita da terreni in conduzione diretta, formula che realizzavaun maggiore profitto.25 Tra tutti i conventi finora esaminati, quello dei frati con-ventuali era quindi il più agiato, condizione che garantì la possibilità di rag-giungere una maggiore monumentalità e figuratività. Nel corso del Seicento(1605-1664) furono pertanto edificati la nuova chiesa26 (quella vecchia fu adi-
23 Questi maestri importano «[…] forme e metodi costruttivi della terra d’origine ed in talsenso non si può non rilevare, in contrasto con la tradizione edilizia locale che predilige la pie-tra, l’uso diffuso, che ritroviamo in quasi tutti gli edifici di questi maestri longobardi, del lateriziovariamente sagomato per cantonali, cornici di finestre e porte, volte, archi, colonne, capitelliecc… […]». Si veda E. MAGNANO DI SAN LIO, Castelbuono capitale dei Ventimiglia, Catania1996, pp. 63, 65, 73; fig. 18, 74; note 145, 256; doc. 4; per la citazione p. 77.
24 I Francescani minori conventuali si trasferirono nel 1332 nell’antico castello a norddella città «allo scopo di meglio fortificare la vetta di Mezzogiorno, molto più importante dellaprima fortezza» cfr. A. BONIFAZIO, Chiesa di S. Francesco d’Assisi di Piazza Armerina, Piazza Ar-merina 1950, pp. 5-6. L’autore precisa che re Martino I e la regina Maria per le spese di trasfor-mazione e costruzione della nuova chiesa, assegnarono ingenti quantità di denaro ai frati, più lasomma annuale di tre monete d’oro per il loro sostentamento.
25 S. CUCINOTTA, Popolo e clero…, cit., pp. 358, 447.26 A. BONIFAZIO, Chiesa di S. Francesco…, cit., pp. 6-7. «La chiesa è larga e lunga m. 8 x
35, possiede cinque altari parati con buoni quadri e quattro statue; nonché ottimi paramenti sacriche servono per la messa e per le altre ufficiature». Ibid., p. 10.
I conventi francescani a Piazza Armerina: architettura e trasformazione 291
bita a sagrestia), il campanile a tre livelli con una terminazione a cono rivestitoda ceramica policroma, e il lungo braccio meridionale verso l’attuale via Cavourcon il balcone in pietra arenaria dalle mensole intagliate, mentre nel 1640 furealizzato il piano antistante chiesa e convento.
In realtà soprattutto questo complesso risente del fervore costruttivo“imposto” dalla vicina chiesa madre che proprio nel corso del Seicento si stavarinnovando, secondo il progetto dell’architetto romano Orazio Torriani,27 rivo-luzionando i caratteri costruttivi delle fabbriche contemporanee e successiverealizzate a Piazza. L’eco della nuova facies architettonica della matrice si riper-cuote decisamente sul complesso francescano, dal campanile alla facciata dellachiesa, realizzati con altrettanti mattoni a cortina a faccia vista tra spessi canto-nali e con eleganti portali in pietra locale [fig. 2]. Le novità introdotte da Tor-riani in Sicilia, nell’ambito dell’impiego del laterizio come materiale da costru-zione alternativo alla pietra, trovavano in realtà un precedente “illustre” a Mes-sina: la tecnica del mattone a faccia vista e la bicromia generata dall’ac-costamento con la pietra locale, erano già state applicate proprio da un sicilianoproveniente da Roma, Giacomo Del Duca, in particolare nella tribuna della chie-sa di San Giovanni di Malta (1591 ca.), divisa da paraste giganti in campiture dimattoni pieni a “cortina”.
La chiesa di San Pietro del ramo dei Minori Riformati, già a partire dalCinquecento lontana dal centro abitato, fu ampliata dopo la licenza di occupa-zione ottenuta dai frati di Santa Maria del Gesù e a spese della comunità cittadi-na furono successivamente edificati l’annesso chiostro quadrato con archi atutto sesto su tozze colonne polistili e il convento, per accogliere i numerosi no-vizi. Nel panorama delle chiese e conventi francescani presenti a Piazza, questocomplesso costituisce un caso a sé, sia per il ruolo che riveste nei confronti dellacittà come chiesa-pantheon, con sette cappelle gentilizie e come convento distudio, sede di un’accademia con una ricca biblioteca, sia per le qualità lingui-stiche e formali delle sue architetture, grazie alla presenza di maestri cultural-mente aggiornati e alle dipendenze di ricchi e colti committenti, in particolare lafamiglia Trigona. È significativo il fatto che i nomi di alcuni artefici, protagoni-sti delle continue “riforme” della matrice, si trovino attivi anche in questa fab-brica francescana: Antonuzzo Gagini realizza l’arco della Cappella d’Asaro(precedente di quello in alabastro di Caltanissetta della chiesa madre, 1594);28
27 ASDPa, Fondo Collegiata Chiesa Madre, stanza II, Misc., Discorso sopra la pianta del-la Madre Chiesa della città di Piazza in Sicilia fatta da Horatio Torriani Inginiero et ArchitettoRomano di sua Maestà in Roma e Discorso sopra la tavola grande cioè della nave principale etdelle crociere et volte del choro, 1-5-3, cc. s.n.
28 A. RAGONA, Il Santuario di Maria SS. Delle Vittorie in Piazza Armerina, Genova s.d.,s.n.p.
Domenica Sutera292
Gio. Domenico Gagini junior (fabbricatore della tribuna della chiesa madre dal1622 al 1626, poi distrutta nel 1628)29 viene incaricato nel 1619 per pavimenta-re la cappella della Madonna e stuccare la volta; nel 1666, il maestro scalpellinoLeonardo De Luca (in quegli anni capomastro della chiesa madre), verrà invececoinvolto nella sistemazione dei locali del convento.30 La singolarità di questocomplesso francescano traspare soprattutto dai colti riferimenti architettonicipresenti nella fabbrica della chiesa. L’essenziale prospetto è infatti nobilitato dalportale in pietra arenaria, soluzione che probabilmente attinge al repertorio diimmagini e modelli -fasce, riquadri, volute, targhe, sfere e pinnacoli- forniti dalLibro Extraordinario di Serlio o dalle incisioni di Domenico Fontana. Ancheall’interno dell’aula non mancano chiari riferimenti a temi e a modelli noti, inparticolar modo sono evidenti le analogie tra il disegno dell’arco della cappelladei Boccadifuoco e il portale “delicato” rappresentato nella tav. XVIII del vo-lume di Serlio,31 autore che vanta proprio a Piazza una delle più precoci appli-cazioni in Sicilia del suo celebre trattato, in particolare nella sopraelevazione delcampanile della matrice (dal 1555 ca.).32 Non è inverosimile sostenere infatti,dato il rapporto di reciproca dipendenza tra conventi francescani e chiesa ma-dre, imposta dal testamento Trigona, un’agevole trasmissione e assimilazionenel tempo di modelli di riferimento, materiali e tecniche costruttive, finoall’impiego della stessa manodopera specializzata. Questo edificio, in continuatrasformazione nei secoli, ha dato pertanto un imput significativo alle confrater-nite dei Francescani qui presentate che, con poco e in un ormai lontano tempo,offrirono a Piazza una consistente e significativa presenza architettonica.
ASE, Atti delle Corporazioni Religiose Soppresse,vol. 555, 15 settembre 1576, f. 3r-v.
Lo monasterio di santa Clara della città di Piazza fu costruito et edificato dal quondamDon Guglielmo Caldarera si come si vede in un atto di testamento di detto quondam celebra-to nelli atti di notar Jacobo de Valento a dì 13 juni 14 Ind. 1346 copia del quale atto è deferi-ta a carte 4 di questo libro.
29 ASDPa, Fondo Collegiata Chiesa Madre, Archivio I, Mandati originali…, cit., n. corda58, c. 67r.
30 Ibid., Ordini e mandati…, cit., n. corda 96, c. 1080r.31 Si veda in particolare il sistema delle nicchie tra paraste scanalate su alti basamenti a
riquadri ai lati dell’arco centrale di ingresso alla cappella. Per un approfondimento sulla fortunadel trattato di Serlio in Sicilia cfr. F. SCADUTO, Serlio e la Sicilia, Palermo 2000.
32 Si tratta del Quarto e del Terzo Libro, pubblicati per la prima volta rispettivamente nel1537 e nel 1540. Si veda: D. SUTERA, Il campanile della cattedrale di Piazza Armerina, dal tardo-gotico al rinascimento, in «Lexicon. Storie e architettura in Sicilia» 5-6 (2007-2008), in c.d.s.
I conventi francescani a Piazza Armerina: architettura e trasformazione 293
Il suddetto monasterio have havuto la sua chiesa in diversi lochi lo primo fu sottonome di santa Clara, la porta et fenestre erano verso il ponente, era di longheza di canni setiet di largheza tre; fu profanata per farvi lo dormitorio sopra et lo refetorio sotto per comododel monasterio, et la chiesa fu trasferita nel secondo loco in una capella vicina, di nome ettitulo di santa Maria Madalena, la qual capella lasciato lo nome della Madalena fu chiamatasanta Clara. Questo fu a tempo della Abadessa Angela lo Monaco della città di Palermo nelanno 1481. La porta et le fenestre della chiesa della Madalena erano verso lo mezo giornoma per più comodità fu fatta una porta verso lo ponente et murata quella del mezo giorno.Era la sudetta seconda chiesa di longheza di canni novi et larga canni tre.
L’anno 1565 essendo Abadessa la priora soro Francisca Trioro della città di Piazza fufatto di novo il tetto di detta chiesa seconda di tavoli lavorati si come si vede nel predettoloco.
Nel anno 1576 per ampliare lo monasterio sudetto e per più comodità di celebrare lasollennità del Santissimo Sacramento la qual sollennità dalla fondazione del monasteriosempre have celebrato et celebra lo giorno et per tuta la ottava nel vespero et compieta can-tandosi et elevandosi lo sudetto Santissimo Sacramento ogni giorno doi volti si come sivede per una sententia copia della quale è deferita nel libro a carti 10, parve alla città et allisuperiori trasferire la chiesa nello piano del padre santo ove erano certe boteghelle del mona-sterio si locavano nella fera di piazza, perciò a dì 15 di setembre della quinta Indizione delanno 1576 predetto si incominciò ad edificare lo terzo loco della chiesa del monasterio nelpiano del padre santo, della lungheza et largheza appare, essendo Abadessa nel detto Mona-sterio la Reverenda soro Francisca Triodo, Cappellano lo Reverendo don Francisco Marino,Procuratore lo magistro Ieronimo Inserra. Nel anno 1589 si ridusse la fabrica a termine dipotersi nella chiesa celebrare, onde con la licentia del ordinario si come appare per privilegiocopia del quale si vede nel presente libro a carti 9 si celebrò la prima messa dal suddetto donReverendo Francisco Marino Cappellano a dì 28 di magio il giorno si celebrò la festa dellaSantissima Trinità del 1589.
Nel anno 1584 lo Illustrissimo et Reverendissimo Monsignor don Vincentio li Cu-telli Vescovo di Catania, nel discorso della visita di questa città di Piazza della reliquia secoportava laxao al Monasterio di santa Clara de ossibus S. Vincenti et Anastatis martiri perordine di detto Monsignor fu fatto un incasto di argento nel quale si conserva la suddetta re-liquia nella chiesa di detto Monasterio.
Nel anno 1588 venne in questa città di Piazza alla visita lo Reverendissimo don Fa-brizio Mendosio Vicario Generale Apostolico et nel discorso della visita del suddetto Mona-sterio di Santa Clara lasciò de capillis sancte Clare quali disse averli portato da Assisi et disuo ordine fornu incastate in un incasto di argento il quale si conserva nella suddetta chiesa.