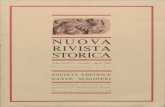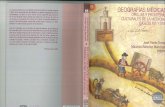Libri francescani della Civica Biblioteca Aprosiana: alcune riflessioni per una storia del convento...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Libri francescani della Civica Biblioteca Aprosiana: alcune riflessioni per una storia del convento...
Il Forte dell'Annunziata di Ventimiglia
Dalla antica chiesa di San Lazzaro al Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi"
a cura di DANIELA GANDOLFI
Ventimiglia 2015
INDICE
10/11 Prefazioni
13 Per la storia di un monumento sospeso sul mare di D. GANDOLFI
17 A. CERIOLO VERRANDO
Nuovi documenti sul convento dell'ordine dei frati Minori Osservanti e sulla chiesa dell'Annunziata di Ventimiglia
31 L. SCAPPATICC I
Libri francescani della Civica Biblioteca Aprosiana Alcune riflessioni per una storia del convento dell 'Annunziata di Ventimiglia
47 S. VIALE
Il forte San Paolo e la ridotta dell'Annunziata Storia e architettura della fortificazione ottocentesca di Ventimiglia
85 A. PALMERO
Proposta di sovrapposizione della preesistenza del Convento Francescano del XVI secolo con la ridotta ottocentesca dell'Annunziata
91 P. G, C ORINO
Artiglieria da fortezza
97 E. V IOLA
L'irrequieto soggiorno del giovane luogotenente Camillo Cavour a Ventimiglia
109 R, ROCCIA
Di forte in forte: Camillo Cavour, luogotenente del Genio
123 F, PIUMA
Il forte dell'Annunziata: da ridotta militare a museo della città
175 D. G ANDOL FI
Il Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" di Ventimiglia Una storia lunga e inquieta
223 0. V IALE
Il recupero del forte dell'Annunziata come sede del Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi"
235 F.A. PALMERO, R, PIACENTINI
I nuovi lavori di completamento e allestimento del Museo "Girolamo Rossi", 2004-2012
241 D, GANDOLFI
Il Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" oggi. Esposizione, attività, progetti
LIBRI FRANCESCANI DELLA CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA ALCUNE RIFLESSIONI PER UNA STORIA DEL CONVENTO DELL'ANNUNZIATA
DI VENTIMIGLIA
Leandra Scappaticci*
I percorsi della storia si fondano, si sno
dano e si ancorano attorno nelle molteplici
testimonianze dirette a noi giunte, tra cui i
reperti archeologici, architettonici, documentari e librari. Questi ultimi, spesso con
siderati di secondo ordine, e oggi conserva
ti in archivi e biblioteche di diversa natura
- ecclesiastica, statale e privata -, risultano
essere preziosi per comprendere e ricostrui
re in maniera più ampia contesti storico
culturali, rapporti istituzionali, economici e cultuali del nostro passato. La ricerca di
manoscritti e frammenti negli archivi e nel
le biblioteche italiane rappresenta, al pari
di uno scavo archeologico, un'impresa fruttuosa all'interno di una ricca miniera: ad
ogni strato corrisponde un fondo librario o archivistico all'interno del quale, sorpren
dentemente, si possono ritrovare testimo
nianze di una qualche importanza, ignora
te per tanti secoli, inedite, mai identificate
o scientificamente valorizzate.
Uno 'scavo librario' recentemente intra
preso da chi scrive nella Civica Biblioteca
Aprosiana di Ventimiglia permette ora di
approfondire una fase meno indagata della storia ecclesiastica della città, e in particola
re del convento dell'Annunziata, la cui glo
ria si alimentava finora su notizie storiche
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali
31
desunte dalla sopravvivenza di reperti do
cumentari, materiali e architettonici. Tali
notizie, riunite da Girolamo Rossi nella Storia della città di Ventimiglia, ci conduco
no attraverso i primi secoli di attività del
convento, la cui fondazione si colloca il 7
febbraio del 1503, durante l'episcopato di
Domenico Vaccari, giunto a Ventimiglia
nel 1502, in seguito al trasferimento dalla sede savonese di Noli 1•
Istituito con il consenso di Luigi XII re di Francia, il convento dell'Annunziata dei Frati Francescani Minori Osservanti venne edi
ficato in località Cassine, nei pressi di Porta Nizza, "a un trar di balestra fuori della porta
occidentale della città, sopra una cresta sta
gliata di monte, che mena a precipizio nel
mare"2 • Nel medesimo luogo si trovava la chiesa di San Lazzaro, con annesso ospedale
per la cura dei lebbrosi, che in precedenza era
stata ceduta "per uso e comodo del nuovo
convento da erigersi, mediante un convenu
to compenso" dal capitolo della Cattedrale
alla nascente congregazione francescana: lo si apprende da una bolla di Leone X del 14
marzo 1517, oggi conservata presso l'Archi
vio della Curia di Ventimiglia3•
La costruzione del convento fu suppor
tata inizialmente dalla famiglia Orengo:
LEANDRA SCAPPATICCI
resta difatti traccia nell'iscrizione dell'altare maggiore posizionato originariamente all'interno della chiesa dedicata all'Annunciazione; risalgono poi ai due secoli successivi la realizzazione, all'interno della chiesa, di una cappella dedicata alla Madonna del Carmine, di giuspatronato della famiglia Massa, e la costruzione, negli ultimi cinque anni del Seicento, di un organo e di un coro4•
L'introduzione dei Minori Osservanti a Ventimiglia si colloca in un periodo assai fervido per la diocesi locale che, grazie ai provvedimenti posti in essere dai vescovi succeduti dalla fine del Quattrocento fino al Cinquecento, vide la realizzazione di quattro sinodi (1471, 1503, 1564, 1565), la costruzione del Palazzo Episcopale (1564), la dotazione di un coro per i canonici della Cattedrale (1565) e l'ingresso di nuovi ordini religiosi, con la conseguente edificazione di conventi, tra cui quello degli Agostiniani nelle vicinanze di Tenda (1471-1484), dei Minori Osservanti a Sospello e San Dalmazzo (1471-1484), dei Francescani a Mentone e degli Agostiniani Scalzi in città, nel sito Bastita posto a oriente del fiume Roia, poi dedicato alla Consolazione, ove già sorgeva la chiesa di S. Simeone (1487)5.
La presenza francescana a Ventimiglia si era già affacciata all'incirca cinquanta anni dopo il riconoscimento ufficiale dell'Ordine, avvenuto per volere di papa Innocenzo III nel 1209. Prodromi dell'avvenuto ingresso dei Frati Minori Conventuali si collocano nel 1258, a fronte della citazione documentaria di una ecclesia sancti Franci
sci, supportata poi dalla presenza di una do-
32
mus ftatrum minorum, la cui sede si situa probabilmente nelle prossimità del forte San Paolo e in un secondo tempo, nel 1313, in ecclesia nova all'interno delle mu
ra cittadine6. In pieno clima di riforma, nel vortice dei
dissidi e delle divisioni avvenute all'interno dello stesso Ordine, e spesso tenuti a bada mediante provvedimenti emessi dal papa che mirava a perseguire l'unità dei Francescani, si instaurò nel 1503 il secondo convento francescano dell'Annunziata, pertinente ai Minori Osservanti.
La convivenza dei Conventuali e degli Osservanti era reduce da una lunga e sofferta parabola, i cui assi e precari equilibri erano in continua evoluzione7• Gli ultimi esiti derivavano dall'intervento di Paolo II, Cum sacer ordo del 28 febbraio 1467, con cui si venivano a fissare i risultati di un' ampia consultazione avvenuta tra i maggiori responsabili di Conventuali e Osservanti . La lettera papale concedeva che gli Osservanti, ottenuta la licenza della sede dalla sede apostolica, fossero liberi di costruire "nuove case" o di riceverne da "principi, signori, comunità o altri" anche nelle località dove già esistesse un insediamento dei Conventuali 8• Le decisioni pontificie miravano poi, nei decenni successivi, ad arginare i contrasti, con il fine di mantenere illesi i rapporti tra Conventuali e Osservanti; ciò nonostante il baricentro era più volte sottoposto a cambiamenti, sovversioni e divisioni all'interno dell'Ordine.
Nei primi decenni del XV secolo, contestualmente alla fondazione del convento dell'Annunziata, si registra un vero passaggio della leadership istituzionale dai Con-
LIBRI FRANCESCANI DELLA CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA
ventuali agli Osservanti, messo in atto poi
da Leone X nell 1te vos del 29 maggio 1517
e nell ' Omnipotens Deus del 12 giugno
1517. L'Ordine si sottoponeva così sotto
l'autorità dei ministri Osservanti che garantivano l'intera rappresentanza istituzio
nale: Nihil ibi actum est, nisi quod magiste
rium ordinis, generalatus officium et regimen
traslatum est a conventualibus Minoritis ab
eos qui dicti sunt de Observantia, invitis et
recalcitrantibus et de praescriptione conten
dentibus9.
I frati dell'Osservanza erano difatti rite
nuti "veri e certi frati dell'Ordine del beato
Francesco" poiché avevano sempre rispetta
to una stretta osservanza della Regola ed
una pratica rigorosa di povertà. La preva
lenza Osservante viene dunque ad affer
marsi a discapito dei Conventuali, ai quali
erano sottratte mansioni, poteri e responsa
bilità di rilievo: è quanto mai significativo,
a tale proposito, il fatto che, durante le fun
zioni e le processioni, i frati della "regolare
Osservanzà' dovessero sempre precedere i
Conventuali 1°.
LA BIBLIOTECA E I LIBRI DEI FRANCESCANI
Le fondazioni degli Ordini Mendicanti e
in particolare quelle dei Francescani non
presuppongono più la coesistenza di veri e
propri scriptoria conventuali situati in spa
zi definiti e organizzati, che tanto avevano
caratterizzato l'attività del monachesimo
medioévale occidentale e che ora appariva
no totalmente anacronistici. Nell'orizzonte
ideologico dell'Ordine francescano - o dei
frati Minori - inizialmente il libro è consi-
33
derato , se letto, strumento di edificazione
e, se trascritto, opera manuale; altrimenti il libro stesso è visto con sospetto , sia perché
il voto di povertà ne teme il valore, sia per
ché la predicazione dei Francescani è gui
data non dalla dottrina ma dall'esempio 11 •
Dalla Regula Buffata di San Francesco e
dalle Costituzioni si desume che lo studio
non rappresenta il fine primario della vo
cazione. I frati che non sanno il latino non
sono difatti costretti ad impararlo, ma de
vono pregare e amare con cuore puro, gm
dati dall'umiltà e dalla pazienza: et non cu
rent nescientes litteras discere, sed attendant
quod super omnia desiderare debent habere
Spiritum Domini et sanctam eius operatio
nem, orare semper ad eum puro corde et ha
bere humilitatem, patientiam in persecu
tione et infirmitate, et diligere eos qui nos
persequuntur et reprehendunt et arguunt,
quia dicit Dominus { .. }' 2•
Lo studio non costituisce pertanto il ful
cro dell'esperienza conventuale, è semmai
strumento per l'attività di predicazione e
di preghiera nei diversi momenti della
giornata, durante le Ore dell'Ufficio come
nella celebrazione della Messa . Il libro è es
senzialmente finalizzato all'esercizio spiri
tuale e devozionale, non è veicolo di alfa
betizzazione o di acquisizione dei primi
rudimenti della lingua per i frati nescientes
litteras: Propter hoc omnes fratres sive clerici
sive laici faciant divinum Officium, laudes
et orationes, secundum quod debent facere.
Clerici faciant Officium et dicant pro vivis et
pro mortuis secundum consuetudinem cleri
corum. Et pro defectu et negligentia fratrum
dicant omni die Miserere mei Deus cum Pa
ter noster; et pro fratris defonctis dicant De
LEANDRA SCAPPATICCI
profundis cum Pater noster. Et libros tantum
necessarios ad implendum eorum officium
possint habere. Et laicis etiam scientibus leg
ere psalterium liceat eis habere illud Aliis ve
ro nescientibus litteras librum habere non liceat13.
Le Sacre Scritture rivestivano pur sempre
un ruolo di primaria importanza e nelle suc
cessive disposizioni, tra cui il Commento alla
Regola di Ugo Digne del 1252 e l'Epistola de tribus quaestionibus di Bonaventura da Ba
gnoregio (1254), erano considerate testo ca
pitale per lo studio. Luso legittimo dei libri
per gli uffici dell'Ordine era poi ribadito nel
la bolla di papa Niccolò III, Exiit qui semi
nat (1279), anche se la sola fruizione e non
la proprietà dei libri era concessa ai frati per
un periodo limitato 14•
Quando si pensi ai conventi dell'Ordine
francescano è dunque lecito chiedersi di qua
li libri disponessero le biblioteche interne.
Certamente non mancavano i libri liturgici
di destinazione sia 'corale' con Bibbie, Mes
sali, Antifonari, Graduali, Salteri, sia indivi
duale con Breviari e volumi portatili, tra cui
le raccolte di prediche e scritti dei fondatori
e teologi rappresentanti dell'Ordine 15•
Ciò che resta oggi della Biblioteca del
convento dell'Annunziata dei Minori Os
servanti è testimoniato da alcuni libri che ci
sono stati tramandati attraverso cinque se
coli di storia, e che oggi sono conservati a
Ventimiglia, nella Civica Biblioteca Apro
siana. La raccolta, seppur deturpata nel
corso dei secoli e della cui originaria entità
non siamo purtroppo informati da inven
tari o da ulteriore documentazione, ci resti
tuisce un quadro omogeneo, esclusivamen
te di destinazione liturgica 16•
34
Per officiare la liturgia delle Ore nei va
ri momenti della giornata e della notte i
Francescani utilizzavano un Antifonario in
pergamena, in cinque tomi di cui oggi ne
restano quattro, gli attuali manoscritti 33,
34, 35, 36 della Civica Biblioteca Aprosia
na di Ventimiglia, attribuibili alla fine del
XIV e al XV secolo 17• Nei codici si rintrac
cia la mano di un solo copista che verga il
testo in una lettera textualis di buona ese
cuzione, ben allineata sul rigo, di modulo
medio-grande e regolare, piuttosto spezza
ta e contrastata che presenta, tra i vari trat
ti significativi, R sempre maiuscola in fine
parola o di periodo, in pochi casi anche al
l'interno di parola, z in forma di e cedi
gliata e in pochissimi casi eseguita a forma
di 7 con voluta inferiore (fig. 1) 18• Al me
desimo copista è attribuibile la compila
zione della musica con una notazione qua
drata disposta su tetragrammi costituiti da
quattro linee rosse, con indicazione delle
chiavi musicali di do e fa e del custos a fine
rigo (fig. 2).
Nel momento della confezione dei quat
tro libri di medio-grandi dimensioni un
miniatore si occupò poi, su indicazione di
letterine-guida apposte nel margine esterno
dal copista nel momento della compilazio
ne dei testi (v. ad es. fig. 3, margine ester
no), di realizzare lettere decorate tra cui si
distinguono, per importanza e raffinatezza
nel disegno, iniziali filigranate in rosso e
blu, con aggiunta di elementi zoomorfi co
me teste di drago e di uccelli.
Tali lettere sono rivestite di particolare
significato e, ad una prima vista d'insieme,
consentono al lettore-cantore di compren
dere che in quel punto inizia l'Ufficio di un
LIBRI FRANCESCANI DELLA CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA
·~-_,... -.....~,11---i-------.--, - ----- ~ ---;----~~- --- ~"'-='-'--'-■-"'-■--'I: (111? 110 ft1m d1gnus cmn l .-1 .. 1~,.. I 'I .. = -~ ~ M? I • -I-. ~ .,m c.1la:.1mcn cu1s foluc _,.,-.._~~- . ~-+----------.-~~
35
Ventimiglia , Civica Biblioteca Apr osiana , ms. 33, c. 39r.
2 Ventimiglia , Civica Bibliote ca Aprosiana, ms. 34, cc . 24v-25r.
3 Ventimiglia , Civica Biblioteca Aprosiana, ms. 33, c. 35r.
LEANDRA SCAPPATICC I
4 6 Vent imig lia, Civica Biblioteca Aprosiana, ms. 34, c. 6/Jr. Ventimig lia, C ivica Biblioteca Ap rosiana, ms. 36, c. l 06r.
5 7 Vent imig lia, C ivica Biblioteca Ap rosiana, ms. 35, c. l v Ventimig lia, C ivica Bib lioteca Aprosiana, ms. 36, c. l lOr.
~ quom.1 -ronnn" fuf rrptr mc .---- ~ +--~----¼---·-- I '\, .~11rrt't bfl9~ ~
36
LIBRI FRANCESCANI DELLA CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA
giorno liturgico importante. Esse si vengono difatti a stagliare, con il primo responsorio del primo Notturno, in corrispondenza di tempi forti, come la Domenica delle Palme, la feria quinta del Giovedì Santo e la Pasqua (figg. 4-5) 19•
I quattro tomi dell'Antifonario contengono tutti i canti da eseguire durante la preghiera delle Ore di un intero anno liturgico, con suddivisione ciclica del Temporale dall'Avvento al mese di novembre (mss. 33, 34, 35) e del Santorale di cui sopravvive solo il Comune (ms. 36), poiché il Proprio era racchiuso nel volume purtroppo andato perduto.
La filiazione francescana dei quattro volumi emerge oltre che dalle due annotazioni, l'una coeva e parzialmente illeggibile, Istud antiphonarium est fratrum minorum
<sancte Maria de> e Iste liber est conventus
fratrum minorum 20, l'altra posteriore e pertinente al convento dell'Annunziata, Perti
net ad locum Annunciationis virginis Marie
de ordine minorum regularis observantie An
no Domini 1579 die 27 maii, e Est fratrum
minorum conventus Annunciate urbis Vinti
millii anno Domini 15 79 die 2 7 maii2 1, dal contenuto del manoscritto 36 che nell'ultima parte reca le feste proprie dell'Ordine francescano, tra cui quelle dedicate a s. Antonio, s. Chiara (fig. 6) e alle stigmate di s. Francesco (fig. 7)22 •
I quattro codici pervennero all'Annunziata molto probabilmente il 27 maggio 1579, quando uno dei frati, forse colui che investiva mansioni di maggior responsabilità nella gestione patrimoniale, ne registrò l'ingresso e l'avvenuto possesso. Da quel momento i libri furono utilizzati per
37
un ampio lasso di tempo, almeno fino al XVIII secolo: lo testimoniano le numerose correzioni e integrazioni, tra cui l' aggiunta del Credo genovese in canto fratto nelle ultime due carte del manoscritto 35 (fig. 8).
Il titolo attribuito al Credo, Genovese, rimanda chiaramente alla regione ligure e si ricollega ad una tradizione ben documentata in manoscritti musicali francescani del-1' area genovese. La melodia non rispetta più i canoni estetici del repertorio gregoriano: si nota difatti l'utilizzo di una notazione musicale con elementi ritmico-proporzionali, e di alterazioni cromatiche; sulla base dell'incipit essa è riconducibile al Cre
do Genovese B attestato nel manoscritto 92 del Centro studi francescani di Genova 23
(v. fig. 86).
Sa Ventimiglia , Civica Biblioteca Apr osiana, ms. 35, c. 130v.
8b Trascr izione musicale
del ms. 35, cc. l 30v-l 3 l r.
9 Ventimiglia , Civica
Biblioteca Aprosiana, ms. 37, c. l6r.
LEANDRA SCAPPATICCI
Credo Genovese-
l'ITT • Hl • JX' • t\'1\ • t~•ro. fai; • K'·H .' 111 \X~ • [1 ct
<.'1 m - ~-! - si - h1 li - um 1.:1 m u -num l)o - m1-num k-sum {7 1n-
!.ium. Fi - h - wn f.);_, - 1 u -m - ili-•'
cu-13 De-1un dc I~ - o. lu
Ge - 111 - t, ,r:11 Ili.Hl fa.:, - tum, CQII ~u l,-!;t11 n • 1, - a• k m P,i lit I)<.,. quc,r
38
l\<)-S(Wm ,a • lu · !cm ck • SC<.11 - 1.ht d,: CQC '" Et in- ~--r-
no • tos t' ~! dc S!Jt • ri - tu S:m cw e:.: 1-.ln - n - a \'ìr - g1 -
:~~~ ~ ~~~ ~~.L _"'--"=;-~--""-====!.~=-':'..=-=::'.<>=_--·~ h.;,, - mo fa.: Cn1 • Cl • fi · )(\J~
e - lH\lll f.'10 o,;1 - bis ~uh Pvn - ti - <' f>i - h,1 - lO pas
pul 1115 est f) re -sur-re ~1t urr-ti-a di - e se .
Cll!I - dum ,;,.,n - J1lll l.'.l (l - :;c~'ll - d,t m ~ !urn, s.c -
det ad de - Me-ram P:i - !rÌ $ Èl i-ltl-i1Jnl ven-Hl- nLS e'Sl cwn glo- n-
ti _iu-d1 - ,:a • re '•l • ,·01 .:t mor · 1!1 - os. W·JUS ~ · gn1 mm c-nt
L'impegno liturgico dei Francescani, al quale il fondatore aveva dato ogni priorità, si svolgeva, oltre che nei ritmi dell'Uf
ficio, nella celebrazione della Messa. Se per la celebrazione dell'Ufficio era di sup
porto l'Antifonario secolare, per la Messa
i Francescani intemeli utilizzavano un Graduale, l'attuale manoscritto Aprosiano
37 che, prodotto nella seconda metà del XV secolo e all'inizio del XVI secolo,
giunse al convento il 27 maggio 1579 insieme ai codici finora analizzati 24 (fìg. 9) . Nel recto della prima carta è difatti pre
sente la nota Pertinet ad usum fratrum minorum regularis observantiae seu conventus Annunciate urbis Vintimillii anno domini 1579 die 27 maii, vergata dal medesimo scrivente dell'Antifonario.
Il Graduale Aprosiano 37 contiene i soli canti da eseguire durante la Messa: l' introi-
LIBRI FRANCESCANI DELLA CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA
to nel momento dell'ingresso, il brano in
terlezionale del graduale, costituito da un
responso e da un versetto, l'alleluia, le anti
fone di offertorio e di communio che ac
compagnano rispettivamente l'offerta dei
doni e il momento della comunione. Esso
racchiude tutte le Messe del Temporale ,
dalla prima Domenica di Avvento alla ven
tiquattresima Domenica dopo Pentecoste.
Almeno un secolo dopo, nel momento
in cui furono realizzati , rispettivamente nel
1695 e nel 1698, un organo e un coro per
il convento 25, giunsero all'Annunziata libri
più recenti e cartacei: gli attuali manoscrit
ti Aprosiani 38 e 39. In entrambi i casi si
tratta ancora di due codici musicali, l'uno
Antifonario della seconda metà e della fine
del XVII secolo con la serie degli Uffici sia
del Temporale - dal sabato che precede la
prima Domenica di Avvento alla ventiquat
tresima Domenica dopo Pentecoste - , sia
del Santorale - che inizia con la festa di
sant 'Andrea e termina con Clemente e il
Comune dei santi -, l'altro Graduale-Ky
riale riservato alla Messa.
Del Graduale 39 siamo sufficientemente
informati dalla sottoscrizione di mano del
copista che dichiara , nel recto della prima
carta , il nome , il luogo e la data in cui ter
mina il suo lavoro , nel 1693: In nomine do
mini amen anno ab eiusdem nativitate cur
rente 1693 indictione prima die vero 4 maii
incipit proprium missarum de sanctis factum
a patre Ioanne Baptista Molinari a Spigno
ordinis fratrum minorum S. Francisci con
ventualium provincie Genue nunc guardia
nus conventus Terdone sedente in apostolico
throno Innocentio XII civitatis Neapolis co
gnomento Pignatelli.
39
---- --. . .... ~---- -- --
Il copista Giovanni Battista Molinari di
Spigno è frate dei Minori Conventuali della
provincia di Genova, residente nel convento
di Tortona . Egli è copista laborioso, la cui
'firmà contraddistingue altri due codici fran
cescani ritrovati da chi scrive nella Chiesa di
S. Francesco a Cassine e in Acqui nell'Archi
vio Vescovile26 • È presumibile che egli sia sta
to copista di professione e che scrivesse sia
per uso interno, sia per denaro su commis
sione di conventi del medesimo Ordine, di
slocati nei vari luoghi della 'provincià france
scana. La sua seri ttura , una tarda textualis dal
tratto pesante, è ben riconoscibile in base al
le seguenti lettere significative: d tonda con
tratto obliquo prolungato che termina ad
uncino; g in due forme: con occhiello infe
riore angoloso a sinistra o a forma di 8 con
10 Ventimig lia , Civica Biblioteca Ap rosiana , ms. 39, c . l 05r.
11 Vent imiglia , Civica
Biblioteca Ap rosiana, Z 12 bis 28,
fron tespizio.
12 Ventimiglia , Civica
Biblioteca Ap rosiana, Z 12 bis 28, c. lr.
LEANDRA SCAPPATICC I
i!
PSALTERII ROMANI ~: Pars Primtt. •.
'; Dìurnales Horas Contincrts , Pfabnos(of:d.-r,&.Hymnm. ~ Qgi ad Primi. Ttnii,~xti.
& N 1:m5,.1c ad Vtfpa:J ,,'Si: Completorium w:ir.ui folcm. ' 0 1dzmsvc!UM1no:umHynmiAddl1mur in Fine.
IVXT.\. NORM7\M .BREV!ARll Ex Dcoet\1 S.itti)ìinéh C)C,Ji; TritkfltfniR.dbruci.
P J Qµrn,i l'òtdiu, Mn'.ÌJt\l luflù ,td11:1. 0.."hUOfVITiql!e0:mc-nu1 ,& Vri1amSummol'lltnPOltri.~tunll
-..u!tor,ucc rccogniti • J'l'.F./,~wCafon,d,Sp,Jia Gt'llllmfJrd . .,:W11tr.
~ri(/iglJ Ubjtrù. •J)t1inra1a~ Fwmll/4, Curtaa ~
-· .1--IV!HNll.f . · ~ !.ANctr JtCl'llDi Martirù
:(ìnc prolif:lf.Jliucl.a verhera. -- qu:e 1wr.r:fuirumrJrI CONI uet = qFi ch2.rit:ite Jcrvid irs 1 rof;imrj{TJsJ._~~qligit._ _ cc1111dus:..u:a:.rmrp tt ::: ri d et mi n-àsq11 r principis - vi n.ctcisg;a~ 1,·rmans _rejeros _ u 6Lque c1/1çrstum preiw;d Iremit lyrannus: marprrm ~ mitreiis ad oras Al fin
Jidem 6wto Janquine _ Jig.narc. 1andem ph.ù11Lt. - -.:: .Ycmt, trn.unphars.trenue- .
morlem pt.o Cbnsto sustrnet sacra cruòre roscida U r6-.s Jù lg et inter ccJeras
Tunosa6afto rCJpt~c. et vota, qµc, percn n1.ter -
- -ti-6i .'P rrrn nter Jundtn~ns 6cni.c,nus u.sque-.raJC1pe
Ur 6 rn1 .... Po Tenf ey· rii l_ig e _ -- mol"UO.f repe Ile J ur a _Jo mes, ciolò,:e.s, 1:ird · -
-:--Onx.r focceJrnnt rxr6a~s
40
occhiello superiore sormontato al centro da segno a forma di gancio; tra le abbreviazioni: -m finale con segno a forma di 7 con voluta inferiore appena al di sotto del rigo; et espresso da nota tironiana a forma di 7.
Della Biblioteca conventuale sopravvivono inoltre due volumi a stampa di grandi dimensioni, il Salterio-Innario Z 12 bis 28 e l'Innario Z 12 bis 29, en
trambi stampati a Genova per il convento di S. Maria della Pace.
Il primo libro a stampa, realizzato nel 1656 per i frati Minori, Psalterii romani
pars prima diurna/es horas continens psalmos scilicet et hymnos qui ad Primam, Tertiam, Sextam et Nonam , ac ad vesperas et Comple
torium recitari solent Ordinis vero Minorum
Hymni adduntur in fine. Iuxta normam breviarii ex decreto [ ... ] (fig. 11) contiene il salterio liturgico con salmi e inni distribuiti nei vari giorni e nelle diverse ore e, per una annotazione posteriore, attesta gli usi locali della chiesa di Ventimiglia. Nell'ultima carta aggiunta e sul contropiatto poste
riore una mano presumibilmente ottocentesca verga il testo dell'inno e di una orazione da cantare e proclamare durante la festa di Secondo 27 , il santo nominato ufficialmente patrono di Ventimiglia a partire dal 1579 (fig. 12)28 •
Nel secondo libro, l'attuale Innario Aprosiano Z 12 bis 29 stampato nel 1646, sono racchiuse all'interno due sezioni distinte: Hymnarii novi pars prima, nocturnales hymnos continens propriosque Minorum Ordinum complectens a ftatre Io
anne Augustino Casono de Spedia Genue Minorum ob re excusa atque ab ipso sumptibus sui Ioannis Baptiste Casoni ex anf'
LIBRI FRANCESCANI DELLA CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA
fratris impressa 1646. Genuae in Convento
sanctae Mariae pacis (pp. I-CII); Hymnarii novi pars seconda diurna/es hymnos con
tinens propriosque minorum ordinum complectens a fratre Ioanne Augustino Casono de Spedia Genuensis minorum ob re excusa
atque ab ipso sumptibus sui Ioanne Baptiste Casonj ex Ant° fratris impressa. 1646. Genuae in Convento sanctae Mariae Pacis
(pp. 1-96). Il libro contiene gli inni, composizioni
poetiche con strofe identiche nella loro struttura metrica, per cui la melodia, medesima per l'intero brano, è presente solo sulla prima strofa, con adozione di notazione musicale quadrata su tetragrammi. Esso, confezionato appositamente per la liturgia dei Frati Minori, comprende feste francescane, tra cui quella dedicata alle stigmate di san Francesco (fig. 13).
Stando a quanto emerge dallo 'scavo' librario ora condotto nella Civica Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia, la collezione libraria del convento dell'Annunziata è ri
dotta ai soli strumenti indispensabili per la pratica liturgica e musicale. I libri non erano collocati in un locale adibito alla Biblioteca, ma nella sacrestia o nella stessa chiesa, pronti all'uso dei frati che pregavano e cantavano durante le ore del giorno e della notte. Dalla sacrestia i libri, di dimensioni medio-grandi, erano posti su un apposito leggio all'interno del coro, affinché l'intera comunità potesse leggere dal medesimo codice.
Quanto alla produzione libraria all'interno dello stesso convento non è ipotizzabile l'esistenza di uno scriptorium o l' at-
41
UC{f~pimò;,liU
;~~ .. il • ~ ~ ~ ~~"'V .. ncrnç rccenfet myftcrta17. ·
,;~• ~ ~ sj•._~ .. I • " ~ ~· vbi falutirçtern ç -oati):11
~ 1 ~el e : ~~;i t1tlcg(a: -oum -1'racif ~tllt
tività di frati copisti dediti alla produzione di libri. Con gli Ordini Mendicanti si assiste difatti ad "un vero e proprio rovesciamento nel rapporto tra le diverse articolazioni della cultura scritta'' per cui nei conventi "contava leggere libri; di qui una biblioteca articolata in una sezione aperta alla pubblica consultazione e in un deposito finalizzato al prestito, ma in ogni caso incrementata da libri di diversa origine - acquistati, fatti copiare, scambiati solo se utili - e, ove prodotti all'interno dello stesso monastero, trascritti non in uno scriptorium definito come spazio e come struttura organizzata, ma per iniziativa individuale (anche se controllata) o, spesso, ad opera di scriptores esterni" 29 .
13 Ventimiglia , Civica Biblioteca Aprosiana, Z 12 bis 29, Il sezione, p. 64.
LEANDRA SCAPPATICCI
Il convento dell'Annunziata, di fonda
zione cinquecentesca, non poteva certa mente contare su una Biblioteca sedimentata, in cui fossero conservati i libri neces
sari tanto alla celebrazione quotidiana della liturgia, quanto all'esecuzione dei canti .
I Francescani di Ventimiglia si procurarono altrove i "ferri del mestiere": l'Antifo
nario in quattro tomi - attuali manoscrit
ti 33, 34, 35, 36 -, in cui erano compresi tutti i canti da eseguire durante la pre
ghiera delle Ore di un intero anno liturgico, il Graduale attuale codice Aprosiano 37 , l'Antifonario 38 e, infine, il GradualeKyriale con i brani del Proprio e dell 'Or
dinario da eseguire durante la Messa, copiato da Giovanni Battista Molinari .
All'interno della comunità francescana si
accumula il materiale necessario per la celebrazione della liturgia. Il trascorrere dei secoli è registrato dalle mani che continuano
a correggere e integrare i libri oggi sopravvissuti, per cui convivono per lungo tempo
i volumi più antichi del XV secolo, i manoscritti della fine del 1600 e i libri stam
pati nel 1646 e nel 1656. Tutte le testimonianze, valide nei contenuti , nella forma e
pur sempre leggibili, sono utilizzate almeno fino alla data di cessione definitiva del convento al governo, avvenuta nel 1831 con la
conseguente realizzazione del forte. La vita economica dei Francescani ruo
ta attorno ad un traffico limitato di libri che sono concessi ad usum da altre comunità, molto probabilmente facenti capo al
capoluogo ligure. Secondo un uso consueto, ben documentato all'interno delle comunità dei Mendicanti , si tendeva a can
cellare ogni nota di possesso anteriore al-
42
l'ultima acquisizione; ciò a prova del fatto
che la maggior parte dei traffici economici che vertevano intorno ai libri fosse 'ille
gale'. La tendenza a cancellare gli ex libris
rinvia a una necessità di azzeramento della storia del codice che ha probabilmente
anche la funzione di eliminare le pezze d'appoggio per possibili e temute rivalse da parte del possessore precedente . Se i
codici sono, secondo la celebre definizione, le armi dei frati, si direbbe che quelli
acquisiti legalmente circolano con il porto d'armi, gli altri con la matricola abrasa30 • I manoscritti Aprosiani 33, 34 , 35 e 36 mostrano difatti come i frati avessero eraso accuratamente l'originaria annotazione di
possesso, di cui sono leggibili solo queste
parole: Istud antiphonarium est fratrum
minorum <sancte Marie de> e Iste liber est
conventus <de>31• La dedicazione mariana , faticosamente leggibile, permette con una ·
qualche prudenza di attribuire tali libri al Convento di Santa Maria della Pace , il
medesimo per il quale furono stampati
l'Innario Aprosiano Z 12bis 28 e il Salte
rio Z 12 bis 29. Il complessivo bottino librario dei Fran
cescani è dunque attinto dal capoluogo ligure; della provincia è il frate conventuale Giovanni Battista Molinari che scrive il
Graduale ms. 39, come di origine genovese
e afferenti allo stesso convento mariano so
no i due libri a stampa sopra citati. Echi di tale 'furto', molto probabilmente
autorizzato e forse messo in pratica dagli stessi confratelli che da Genova si trasferirono
nell'estremo Ponente ligure, emergono in un altro libro conservato presso la Biblioteca
Clarence Bicknell dell'Istituto Internazionale
LIBRI FRANCESCANI DELLA CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA
di Studi Liguri di Bordighera, Fondo antichi
e rari, II J 6. Sul frontespizio del volume Ragionamento di Odoardo Ganducio della conversione de' Gentili e particolarmente de' Genovesi predetta da Esaia profeta, stampato a Ge
nova da Giuseppe Pavoni nel 1626, si trova
la nota di possesso del frate Dionisio di Ge
nova della Biblioteca di Santa Maria della Pa
ce, Prater Dionysius a Genua Bibliothecae Sancta Maria Pacis Genue, seguita da quella
di Iacobi Viscardi Congregationis Terdonii Genuae (fìg. 14).
Dalla disamina globale delle poche testi
monianze a noi giunte si percepisce come il convento dell'Annunziata avesse aderito pie
namente al programma originario delle pre
scrizioni dell'Ordine: ai frati, che avevano
come fine essenziale la predicazione e l' apo
stolato, non occorreva una biblioteca di let
tura o di pubblica utilità che comprendesse
una molteplicità di autori, né tanto meno i
classici. Il libro è pur sempre considerato con
sospetto, desta curiosità nefaste e distoglie i
frati dagli interessi primari dell'Ordine; esso
è da intendere come strumento d'uso e mai
come oggetto di possesso o di accumulo.
I Francescani di Ventimiglia, difatti, ci
hanno tramandato solo i libri indispensa-
43
RAGIONAMENTO , D I OD OARDO GANDVCIO
DELLA . CO ,NVHRSIONE
DE' GENTILI P ARTICOLARMENTE:
DE~
GENOVESI · PR:EDE:TTADAESAIA
PROF E. T A, ·~
bili per la preghiera, reperti che oggi per
mettono una maggiore conoscenza dei
modi e dei caratteri della liturgia praticata
e trascritta, e che consentono di compren
dere, forse più coscientemente di prima ,
l'importanza di uno 'scavo librario' come
veicolo di storia.
14 Bordighera, Biblioteca Claren ce Bicknel l, IISL. Fondi antichi e rari, Il J 6.
LEANDRA SCAPPATICCI
NOTE
Rossi 1886, pp. 189-190, 338. 21 Sono riportate rispettivamente sul contropiat-
Rossi 1886, pp. 189-190. to anteriore del ms. 33 e, in forma abbreviata,
Copia della stessa è consultabile presso la Bi-nel margine inferiore della prima carta dei
blioteca Bicknell dell'Istituto Internaziona le di mss. 34 e 35.
Studi Liguri di Bordighera (Archivio IISL, Fondo 22 Nel manoscritto Aprosiano 36 si trovano nell'or-documenti e manoscritti). dine: In vigilia beati Antonii (cc. 81 v-93v); In fe-
Rossi 1886, pp. 338,481; v. anche Folli 1994, p. 18. sto sancte Clare (cc. l 06r- l l Or); In testo san-
Rossi 1886, pp. 187-198. ctorum stigmatum (cc. l 10r-l l 7v).
23 Baroffio 1998, pp, 69-78: 72, 77; sui vari Credo in 6 Belloni 1974, pp. 101-102; Balletto 1985, nn. 92, 398; Folli 1994, p. 14.
canto fratto v. anche Il canto fratto l'altro gre-goriano 2005. Quanto all'attività musicale dei
Per un quadro storico completo sull'evoluzione Francescani si rinvia anche a Owens 1986. dell'ordine si rimanda almeno a Merlo 2003; v. anche I Frati Minori 1986.
24 Per una descrizione più dettagliata si rimanda
Merlo 2003, p. 348. a Scappaticci 2008, pp. 37-40, 50-51.
25 Rossi 1886, p. 481. 9 Merlo 2003, pp. 378-379. 10
26 Sui due codici si rimanda a Scappaticci 2008, Idem, pp. 364-381. 11 Caval lo 1987, pp. 331-422: 400-411.
pp. 40-41. 27 Hymnus sancti Saecundi martir is. Quae pro-12 Regula bullata, X, 9-11. Si rimanda qu i all'ed izio-
ne presente in La letteratura francescana 2004, bra vine/a verbera que mors secundum con-
p.12 1. teret qui charitate fervidus profana lussa ne-gligit./Secundus /ras impii ridet minasque prin-
13 Regula non bullata, lii, 3-9: edizione in La lette - cipis vinctusque firmans ceteros ubique Chri-ratura francescana 2004, p. 11. stum predicat./Fremit tyrannus: martirem mit-
14 Per un ampio quadro su tale tematica si riman- tens ad oras Albii fidem beato sanguinem si-da a Libri, biblioteche e letture dei frati mendi- gnare tandem precipit./Venit triumphat stre-cant/2005. nue mortem pro Cristo sustinet sacro cruore
15 Sulle var ie tipologie testuali dei libri liturgici v. lo rose/da urbs fulget Inter ceteras./Tu nos ab al-
studio fondamentale di Baroffio 1990, pp. 143- to respice et vota que perenniter tibi precan-
192. tes fundimus benignus usque suscipe./Urbem
16 I codici sono stati per la prima vo lta esaminati potenter dirige morbos repelle iurgia fames
da un punto di vista codicologico e paleogra-dolores prelia oras laccessant barbaras (c. lr).
fico in Scappat icc i 2008. <Ora t io>. lesu Secondi premium da nos per ipsum firmiter eterne amore glorie caduca
17 Per la descrizione dei singoli codici si veda cuncta spernere amen ( contropiatto poste-Scappaticci 2008, pp. 34-35, 44-50; la datazione riore). erronea di Amiet 1983 è ridiscussa, su base pa-
28 Per un quadro sulla vita e la tradizione del san-leografìca, in Scappaticci 2008, pp. 35-36. 18 Per un'analisi più ampia vedi Scappaticci 2008,
to si rimanda almeno a Crovella 1968.
pp. 35-36. 29 Cavallo 1987, p. 402. 19 Si trovano nell'ordine nel ms. 34, cc. 60r, 75r e nel 30 Pellegrini 2004, pp. 187-214: 207-208.
ms. 35, c. lv. 31 Si tratta rispettivamente de lle annotazioni pre-20 Le due annotazioni a ttribuibili alla medes ima senti in Ventimiglia, Civica Biblioteca Aprosiana,
manò si trovano rispettivamen te ne l ms. 33 ms. 33, contropiatto posteriore e in ms. 36, c. (controp iatto posteriore) e nel ms. 36 (c. 93v). 93v: v. Scappat icci 2008, p. 43.
44
LIBRI FRANCESCANI DELLA CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA
BIBLIOGRAFIA
Am iet R. 1983, Manoscritti liturgici conservati a Genova, Savona, Albenga e Ventimiglia , in "Rivista lngauna e intemelia" , XXXIV-XXXV (1979-1980), pp, 19-31.
Balletto L 1985, Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amando/esio dal 7 258 al 7 264 (Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, XXIII), Bordighera.
Bel Ioni V. 197 4, // Duecento francescano in Liguria, Genova.
Baroffio G. 1990, / manoscritti liturgici, in Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento, a cura di Viviana Jemolo e Mirella Morelli, Roma.
Baroffio G . 1998, Fonti trascurate per la storia del gregoriano in Italia: i Kyriali francescani della Liguria, in "Analecta Musicologica", 15, pp . 69-78: 72, 77.
Cav allo G . 1987, Dallo ·scriptorium' senza biblioteca alla biblioteca senza ·scriptorium', in Dal�'eremo al cenobio , La civiltà monastica in Italia dalle origini all 'età di Dante, a cura di Giovanni Pugliese Carratelli, Milano .
Crovella E. 1968, Secondo, in Bibliotheca sanctorum, 11, Roma, coli. 814-819.
Folli A 1994, La chiesa di S. Francesco a Ventimiglia, Ventimiglia.
I Frati Minori 1986 = / Frati Minori tra '400 e '500, Assisi.
Il canto fratto /' altro gregoriano 2005 = Il canto fratto /' altro gregoriano, Atti del convegno internazionale di studi (Parma-Arezzo, 3-6 di-
45
cembre 2003), a cura di Marco Gozzi e Francesco Luisi (Miscellanea musicologia, 7), Roma.
La letteratura francescana 2004 = La letteratura francescana, voi. I: Francesco e Chiara d'Assisi, a cura di Claudio Leonardi, Milano .
Libri, biblioteche e letture dei frati mendicanti 2005 = Libri, biblioteche e letture dei frati mendicanti, secoli Xlii-X/V, Atti del 32 Convegno Internazionale (Assisi, 7-9 ottobre 2004) (Atti dei Convegni della Società internazionale di studi francescani, n.s. 15; SISF convegni, 32), Spoleto .
Merlo G. G. 2003, Nel nome di San Francesco: storia dei frati minori e del francescanesimo fino agli inizi del XVI secolo, Padova.
Owens J. A 1986, Music and the Friars Minor in fifteenth and sixteenth-century lta/y, in / Frati Minori tra '400 e '500, Assisi, pp. 169-188.
Pellegrini L. 2004, Libri e biblioteche nella vita economica dei mendicanti, in L'economia dei conventi dei frati minori e predicatori fino alla metà del Trecento, Atti del XXXI Convegno internazionale (Assisi, 9-7 7 ottobre 2003) (Atti dei Convegni della Società internazionale di studi francescani e del Centro interuniversitario di studi francescani, 14), Spoleto.
Rossi G . 1886, Storia della città di Ventimiglia, Oneglia.
Scappaticci L. 2008, Manoscritti francescani "itineranti" della Biblioteca Civica Aprosiana di Ventimiglia, in "Aprosiana", XVI, pp . 32-57.