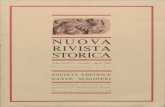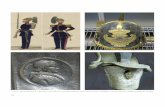Il fondo cavalleresco d’interesse ispanistico della Biblioteca Civica “Romolo Spezioli” di Fermo
Un lungo percorso a ostacoli: l’inclusione dei non cittadini tra test di integrazione,...
Transcript of Un lungo percorso a ostacoli: l’inclusione dei non cittadini tra test di integrazione,...
XXIX Convegno annuale SISP Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Arcavacata di Rende (Cosenza) 10 - 12 settembre 2015 Sezione: Partecipazione e movimenti sociali (Participation and Social Movements) Panel 6.4: I percorsi dell'immigrazione tra emergenza e cittadinanza: problemi, sfide, benefici (chair: Manlio Cinalli)
Un lungo percorso a ostacoli: l’inclusione dei non cittadini tra test di integrazione, discriminazioni e
stratificazione civica Enrico Gargiulo (Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” –
[email protected]) Introduzione Nell’Italia contemporanea, il percorso di “integrazione” dei non cittadini è costellato da
numerose barriere di natura legale e amministrativa, e si caratterizza perciò come un lungo (e lento) cammino, irto di ostacoli, che a volte assumono la forma della legge o del decreto mentre altre volte acquistano sembianze meno visibili e dirette. Spesso, infatti, regolamenti, provvedimenti amministrativi e “semplici” prassi burocratiche rallentano, seppur in maniera non sempre evidente, il processo di inclusione degli immigrati.
Obiettivo delle prossime pagine è analizzare le modalità attraverso cui questo percorso a ostacoli si va articolando e le ragioni che lo rendono così impervio, soprattutto a partire dalla metà del primo decennio degli anni 2000. A riguardo, il contributo si basa sui risultati di un lavoro di ricerca avente come ambito le politiche di esclusione di livello locale e le politiche di integrazione di livello statale. Più in dettaglio, il paper – nel tentativo di provare a estendere la portata teorica di analisi già intraprese1 – riprenderà alcuni dati, elementi e spunti di riflessione emersi da un duplice percorso di indagine, focalizzato da un lato sulle iniziative volte a negare la residenza a stranieri regolarmente presenti in Italia, e quindi aventi diritto all’iscrizione anagrafica, e dall’altro sull’Accordo di integrazione e sulle visioni istituzionali dell’interazione tra cittadini e non cittadini che circondano l’introduzione di questo strumento.
Soltanto alcuni tipi di barriere, dunque, saranno oggetto di attenzione nelle prossime pagine. Nello specifico, saranno assenti analisi e riflessioni puntuali sulle tortuose procedure di accesso al territorio italiano, sui respingimenti alla frontiera o in mare, sulle condizioni giuridiche dei migranti irregolari. Il paper, invece, si focalizzerà sugli ostacoli 1 Che verranno costantemente richiamate nel corso del lavoro.
incontrati da coloro che sono già entrati in Italia e sono riusciti a ottenere, prima o dopo il loro ingresso, lo status di migranti “regolari”. Oggetto di riflessione, pertanto, non saranno gli “ultimi” ma, per così dire, i “penultimi”: quei soggetti cioè che hanno avuto successo nella non facile impresa di garantire a se stessi – e alle proprie famiglie – una condizione di “legalità” ma che vedono minacciata tale condizione a causa dell’introduzione di requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno o di barriere amministrative a livello comunale.
A tal fine, il paper si focalizzerà sui mezzi di esclusione impiegati dalle autorità centrali e locali, cercando così di far emergere i fini a cui questi sono preposti, mostrando le conseguenze che possono produrre, anche a prescindere dalle intenzioni di chi ne fa uso, ed evidenziandone le interazioni. A questo scopo, si farà ricorso a un insieme di strategie di indagine piuttosto eterogeneo: analisi documentale e del discorso, interviste, analisi di dati quantitativi e qualitativi2.
1. “Se vuoi rimanere ti devi adattare”: l’integrazione civica come strumento di
selezione degli immigrati meritevoli e integrabili 1.1 La civic integration e la sua diffusione in Europa Negli ultimi quindici anni, la civic integration è diventata un’idea centrale nell’ambito
delle politiche di integrazione degli immigrati. Apparsa in Olanda sul finire degli anni Novanta – dove il Newcomer Integration Act è entrato in vigore nel 1998 (Kostakopoulou 2010) –, questa visione dei rapporti tra “autoctoni” e “nuovi arrivati” si è rapidamente diffusa in molti stati europei.
Nella letteratura sui fenomeni migratori, con l’espressione “civic integration” si fa solitamente riferimento a due aspetti delle politiche di inclusione: l’ingresso formale della nozione di “integrazione” nel quadro normativo dei vari stati; l’organizzazione di corsi, programmi di orientamento, test e contratti (Carrera e Wiesbrock 2009, 3). In breve, l’idea di integrazione civica implica che i cittadini di paesi non comunitari sono tenuti a soddisfare alcuni requisiti per essere autorizzati a fare ingresso e/o a soggiornare nel territorio di un paese europeo: più in dettaglio, questi soggetti devono apprendere la lingua del paese ospitante e i suoi valori civici e culturali. In diversi stati, tra cui la Francia, la Germania e l’Olanda, l’introduzione della civic integration ha fatto sì che la concessione oppure il rinnovo del permesso di soggiorno fossero subordinati al superamento di esami e test che certificano il raggiungimento dei requisiti linguistici e civici (Joppke e Morawska 2003).
Le singole declinazioni statali dell’idea di civic integration3, nonostante le differenze, condividono un comune carattere selettivo ed escludente. Secondo alcuni studiosi, questo
2 Per approfondimenti circa le strategie di indagine e i dati impiegati, si rimanda ai singoli contributi citati nel testo. 3 Nel campo – ormai molto vasto e certamente non sintetizzabile in maniera adeguata in queste pagine – degli studi sulla civic integration, gli studiosi si dividono tra coloro che mettono in luce come la diffusione
carattere è riconducibile a una visione nazionalista della società (Carrera e Wiesbrock 2009, 4), accomunabile alle visioni coercitive e unidirezionalmente assimilazioniste presenti in passato (Kostakopoulou 2010, 957) oppure differente, in quanto orientata a identificare una identità nazionale genuina e “autoctona” distinguendola dal sentimento identitario che coinvolge anche i cittadini di origine immigrata4 (Suvarierol 2012, 213). Secondo altri studiosi, invece, il contenuto escludente dell’idea di civic integration deve essere considerato il risultato, più che di una visione nazionalista, di una certa forma di liberalismo, “repressivo” e “disciplinante”, orientato a costringere gli individui a sviluppare le proprie capacità produttive e auto-regolative, nel cui ambito la nozione di integrazione civica svolge una funzione simile alle politiche di workfare (Joppke 2007, 14), puntando quindi non ad ottenere l’uniformità culturale ma a promuovere l’autonomia funzionale individuale (Goodman 2010, 754).
Le due interpretazioni, più che contrapposte, sembrano essere complementari: il richiamo a una presunta cultura nazionale come modello per i “nuovi arrivati” è perfettamente compatibile con i meccanismi repressivi e disciplinari di stampo neoliberale. Come si vedrà meglio in seguito parlando del caso italiano, l’innesco di meccanismi orientati a controllare categorie svantaggiate della popolazione immigrata e a regolarne in qualche misura la partecipazione al mercato del lavoro può procedere di pari passo con l’impiego di retoriche nazionaliste. Ciò non significa, tuttavia, che l’idea di integrazione sottostante alla civic integration corrisponda esclusivamente a quello che in letteratura viene definito assimilazionismo5. In altre parole, sebbene sia spesso indicata con l’etichetta di neoassimilazionismo, l’integrazione civica può contemplare la presenza di componenti e discorsi multiculturali (Jacobs e Rea 2007), impiegati chiaramente in maniera strumentale. Riprendendo Carrera e Wiesbrock (2009), sembra sensato affermare che la civic integration «può essere considerata una nuova linea discorsiva volta a nascondere le pluricontestate logiche classiche dell’assimilazione e dell’acculturazione», anche impiegando retoriche e argomenti apparentemente opposti a esse.
1.2 La via italiana alla civic integration: l’integrazione da diritto a dovere L’adesione ai principi della civic integration da parte dei decisori politici italiani inizia
a manifestarsi nel 2006, quando, nell’ambito di una proposta di riforma della legge sulla cittadinanza presentata dall’allora Ministro dell’interno Giuliano Amato, l’acquisizione dello status di cittadino viene subordinata al superamento di un test di lingua e di cultura italiana nonché alla sottoscrizione di una Carta dei valori della cittadinanza e
di questa idea abbia sancito la fine dei modelli nazionali di integrazione (tra tutti: Joppke 2007, 2) e coloro che, al contrario, evidenziano come tale idea sia compatibile con la presenza di differenti percorsi statali (ad esempio Jacobs e Rea 2007). Per qualche dettaglio in più sulle due posizioni si rimanda a Gargiulo 2014c. 4 Sulla questione “nazionale” legata ai processi migratori in società caratterizzate da elevati livelli di nuovi arrivi cfr. Antonsich e Matejskova 2015. 5 Come già indicato in precedenza, il dibattito sui modelli di integrazione ha raggiunto ormai dimensioni ragguardevoli. Per un primo riferimento alle tipologie dei modelli cfr. Castles e Miller 1993; Castles et al. 2003; Zincone 2009.
dell’integrazione6, un documento avente l’obiettivo di riassumere e rendere espliciti i principi fondamentali dell’ordinamento italiano che regolano la vita collettiva dei cittadini e dei non cittadini7. La Carta non acquista immediatamente forza giuridica, assumendo semplicemente il «valore di direttiva generale per l’Amministrazione dell’interno»8, ma sancisce comunque l’affermazione, nell’ambito delle politiche migratorie italiane, di un’idea di integrazione incentrata sulla cultura e sui valori della comunità italiana quali punti di riferimento nelle relazioni tra “autoctoni” e “nuovi arrivati”, come confermato anche dal richiamo esplicito alla cultura greco-romana e alle tradizioni cristiana ed ebraica9.
Ma l’adesione compiuta ai principi della civic integration, corredata dall’opzione in favore di una visione culturalista dei rapporti tra “autoctoni” e “nuovi arrivati”, arriva qualche anno più tardi, nel 2009, quando la legge 9410, parte del cosiddetto “Pacchetto sicurezza”, introduce nell’ordinamento italiano l’Accordo di integrazione, una sorta di “contratto” tra lo straniero e lo stato – presto soprannominato “permesso di soggiorno a punti” – che prevede l’obbligo di sottoscrivere, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, un documento vincolante articolato per crediti, la cui perdita integrale comporta la revoca del permesso e, quindi, il rischio di espulsione dal territorio italiano (o, comunque, l’introduzione di una serie di doveri e adempimenti aggiuntivi nei confronti di coloro che non riescono a onorare il “contratto”). I requisiti che un non cittadino deve soddisfare per dimostrare la propria integrazione sono stabiliti in maniera chiara successivamente, mediante un apposito Regolamento11, che fissa le modalità per la sottoscrizione dell’Accordo e disciplina i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione12. I firmatari13 sono tenuti ad acquisire un livello
6 Introdotta successivamente da un Decreto del Ministero dell’interno del 23 aprile 2007 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno dello stesso anno. 7 Elaborato da una Commissione di cinque esperti accademici nominati dal Ministero dell’interno dopo aver consultato le principali comunità di immigrati e associazioni religiose. 8 A riguardo, cfr. il sito del Ministero dell’interno: http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/altri_speciali/carta_dei_valori/. Quanto ai contenuti della Carta, cfr. Bova 2012; Colaianni 2007 e 2009; Ferrari 2008. Per una prospettiva critica su questi contenuti si rimanda a Cuttitta 2013 e Denaro 2014. 9 Il richiamo alle “radici” ebraico-cristiane dell’Italia in un documento quale la Carta è senza dubbio uno degli aspetti più critici del documento, in quanto tale richiamo, tra le altre cose, mette in discussione la laicità dello stato italiano (Zorzella 2011). 10 Aggiungendo al Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) l’art. 4-bis. 11 Emanato con il d.p.r. 179/2011 ed entrato in vigore il 10 marzo 2012. Successivamente, altri aspetti del contratto di integrazione sono stati disciplinati da alcune circolari, per un elenco abbastanza aggiornato delle quali si rimanda a Gargiulo 2014a. Per una disamina completa dei contenuti giuridici dell’Accordo cfr. Zorzella 2011. Per quanto riguarda invece il percorso di policy-making compiuto da questa politica si rimanda invece a Testore 2015. 12 L’Accordo si applica al non cittadino di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presenta un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Gli stranieri appartenenti ad alcune categorie sono esentati dalla sottoscrizione del documento, mentre coloro che dispongono di alcuni tipi di permesso di soggiorno, pur dovendo siglare il contratto di soggiorno, non possono essere espulsi in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti (per maggiori dettagli su questo punto cfr. Zorzella 2014). 13 Ogni firmatario riceve 16 punti, e deve raggiungere la soglia dei 30 punti entro i due anni di durata dell’Accordo partecipando a corsi e programmi educativi così come registrandosi e fruendo di alcuni servizi. I punti possono anche essere decurtati, qualora subentrino condanne penali o sanzioni amministrative.
sufficiente di conoscenza dell’italiano parlato, della Costituzione, delle istituzioni pubbliche e della vita civica – con particolare riferimento al settore sanitario, al sistema educativo, ai servizi sociali, al mercato del lavoro e alle questioni fiscali –, devono garantire il rispetto dell’obbligo scolastico per quanto riguarda i figli minori e aderire ai principi della Carta dei valori.
Con l’introduzione dell’Accordo, l’integrazione, da diritto, si trasforma in dovere (Biondi dal Monte e Vrenna 2013) – dimostrare di essere “integrati” diventa una condizione necessaria per il proseguimento del soggiorno legale –, mentre si registra una controversa intersezione tra politiche di ammissione e politiche di integrazione (Caponio 2012). L’Accordo, inoltre, provoca pericolose discriminazioni, simboliche e materiali, nei confronti dei non cittadini (Cuttitta 2013 e 2014). Questi ultimi, ad esempio, a differenza dei cittadini italiani, sono costretti ad aderire a un’interpretazione dei valori costituzionali e della storia italiana – quella contenuta nella Carta – piuttosto soggettiva e arbitraria. Inoltre, quegli stranieri che possono permettersi l’affitto legale di un alloggio sono favoriti rispetto a coloro che, al contrario, per ragioni materiali e non per scelte personali, non sono in grado di farlo14. Più in generale, i meccanismi contenuti nel Regolamento attuativo finiscono per colpire in misura maggiore soggetti che si trovano in condizioni economiche e lavorative svantaggiate o che sono meno qualificati sul piano educativo e/o professionale (Cuttitta 2013 e 2014).
Il passaggio a una visione marcatamente culturalista dell’integrazione è sancito in maniera ancora più compiuta circa un anno dopo l’introduzione dell’Accordo, ossia nel 2010, con la pubblicazione del Piano per l’integrazione nella sicurezza Identità e Incontro, il documento che riassume la strategia del Governo in materia di immigrazione15. All’interno del Piano, l’Italia è rappresentata come una comunità culturale compatta e unitaria, intessuta di valori condivisi che i nuovi arrivati sono tenuti a riconoscere, mentre le interazioni tra cittadini e non cittadini sono descritte come conflittuali, stante l’incapacità da parte dei secondi di inserirsi nel tessuto sociale della comunità ospitante16. Il documento del 2010, dunque, oltre a promuovere l’idea secondo cui l’immigrazione in Italia è un fenomeno temporaneo e non strutturale, esprime una visione marcatamente differenzialista dell’integrazione (Gargiulo 2012b), che presuppone un’asimmetria costitutiva e irriducibile nelle relazioni tra italiani e stranieri.
1.3 Quale filosofia dell’integrazione nel contesto italiano? L’introduzione dell’Accordo e l’emanazione del Piano – e prima ancora la
pubblicazione della Carta dei valori – sono passaggi centrali nel processo costitutivo di una più generale visione o “filosofia” dell’integrazione elaborata nell’ambito delle istituzioni pubbliche italiane. Questa visione o filosofia si configura come un approccio
14 Una delle azioni che consentono di guadagnare “punti”, infatti, è l’affitto in regola di un appartamento. 15 Il Piano, promosso dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno e dell’istruzione, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nel giugno del 2010. 16 Per maggiori dettagli e considerazioni critiche sul Piano e sui suoi contenuti si rimanda a Gargiulo 2012b, a Priori 2014 e a Russo Spena e Carbone 2014.
all’inclusione dei non cittadini dotato di caratteristiche ben precise, ma, tuttavia, non può essere considerata “il” modello di integrazione che caratterizza l’Italia nel suo complesso. In altre parole, non tutti gli attori che operano nell’ambito delle politiche di inclusione dei non cittadini e non tutti i livelli di governo e di amministrazione, nel loro agire, si ispirano ai principi della civic integration.
Definire un modello unico per l’intero territorio statale e per tutti i soggetti che lavorano nel settore è praticamente impossibile, per una serie di ragioni. In primo luogo, tra il quadro normativo e programmatico e le misure concretamente adottate sussiste uno scarto piuttosto ampio: nei singoli contesti locali, l’implementazione dell’Accordo sembra risentire di una certa frammentazione (Gargiulo 2014a).
In secondo luogo, le attività di indirizzo e programmazione che fanno capo al livello statale non esauriscono il ventaglio dei compiti in materia di integrazione: le regioni e gli enti locali, soprattutto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione attuata nel 2001, rivestono un ruolo importante, non soltanto nella gestione ma anche nella pianificazione degli interventi. Più in dettaglio, nell’ambito di un sistema fortemente localizzato come quello italiano, al livello centrale spettano compiti di indirizzo e ai livelli periferici compiti di programmazione operativa e di effettiva erogazione di misure e interventi in materia di inclusione dei non cittadini (Caponio 2009; Vivaldi 2013; Vrenna 2013).
In terzo luogo, la nozione di “integrazione” si presenta come un concetto polisemico – e quindi difficile da definire in maniera univoca – e denso di implicazioni politiche, nonostante sia spesso trattato come una categoria esclusivamente tecnica. Innanzitutto, tale nozione può essere letta in un’ottica materiale o, al contrario, da una prospettiva culturale17: detto diversamente, si può ragionare di relazioni tra “autoctoni” e “nuovi arrivati” in termini di disuguaglianze, di distribuzione di potere, di posizione all’interno della struttura sociale ed economica oppure lo si può fare in termini di disposizioni mentali o “tradizionali”, di schemi comportamentali dovuti al contesto di provenienza, ecc. Se si opta per la seconda via, non ci si trova di fronte a una prospettiva unitaria ma a una visione internamente articolata, che, per semplicità, può essere rappresentata come un continuum, ai cui estremi si trovano, rispettivamente, il differenzialismo essenzializzante e fissista – esistono culture radicalmente, “ontologicamente”, diverse – e l’idea di ibridazione/meticciato – le culture sono “oggetti” mutevoli e cangianti, mai identificabili e distinguibili l’una dall’altra in maniera completa, e frutto di continui miscugli e contaminazioni. L’integrazione, inoltre, può essere considerata un processo che coinvolge gli individui o, al contrario, i gruppi di cui questi fanno parte: nel primo caso l’attenzione si concentra sui percorsi che contraddistinguono i singoli immigrati, mentre nel secondo caso il discorso si focalizza sulle comunità, ponendo le scelte individuali e i meccanismi cognitivi che operano a livello degli attori in secondo piano.
17 Inoltre, se si fa propria una visione del secondo tipo, la trasmissione culturale, soprattutto intergenerazionale, può essere vista come un processo lineare e diretto oppure non lineare e indiretto. Nel primo caso, prevale una visione monocausale, basata su un’idea di influsso diretto: ad esempio, i genitori che trasmettono il proprio “patrimonio culturale” ai figli senza mediazioni; oppure “la comunità” che trasmette direttamente la propria cultura ai propri membri. Nel secondo caso, prevale l’idea del meccanismo e della mediazione (ad esempio, condizioni materiali che interagiscono con condizioni culturali; ruolo delle relazioni, dei gruppi dei pari; ruolo delle disuguaglianze economiche).
Nonostante le difficoltà terminologiche legate alla nozione di “integrazione” e l’impossibilità di identificare un modello di inclusione unitario valido per l’intero territorio italiano, l’analisi delle visioni generali relative a questo tema può rivelarsi utile, contribuendo a delineare un quadro complessivo dei frames e dei discorsi di cui sono portatori i decisori politici di livello centrale. Questa analisi, inoltre, se condotta in maniera diacronica – confrontando cioè le visioni attuali con quelle che si sono succedute negli anni precedenti –, può dare conto delle trasformazioni che, a livello politico, caratterizzano le logiche di intervento in materia di integrazione18.
La “filosofia” espressa dai governi italiani negli ultimi anni, a differenza delle visioni presenti nel periodo precedente, mette da parte qualsiasi considerazione materiale privilegiando una prospettiva esclusivamente culturale sul tema. Più in dettaglio, a partire dal 1998 – quando la legge Turco-Napolitano ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la nozione di “integrazione”, chiamando sostanzialmente i governi a esporre il proprio punto di vista sul tema nei Documenti programmatici triennali – fino grosso modo alla prima metà degli anni Duemila, i discorsi istituzionali mostravano una visione dei processi di inclusione dei non cittadini al contempo materiale e culturale. Nei Documenti triennali e nei Rapporti della commissione per le politiche di integrazione, il primo fattore considerato cruciale nei processi di inclusione era il riconoscimento dei diritti e il contrasto alle discriminazioni; parallelamente, una certa attenzione era dedicata alle disuguaglianze economiche e lavorative. La sfera culturale era ritenuta importante, ma, in questo ambito, i rapporti tra “autoctoni” e “nuovi arrivati” erano visti come tendenzialmente simmetrici, orientati alla contaminazione e non interpretati come una forma di contrapposizione tra gruppi “ontologicamente” diversi19. I contrasti tra comunità culturalmente connotate erano oggetto di interesse da parte degli estensori del documento, ma più nella prospettiva della prevenzione di eventuali dinamiche di scontro tra insiders e outsiders che in quella del “conflitto tra culture”20.
18 Per un’analisi di questo genere, e per un approfondimento metodologico circa l’utilità di questo tipo di approccio, si rimanda a Gargiulo 2014c. 19 Tranne in alcuni passaggi dedicati ai giovani stranieri nati in Italia, dove a tratti fa la sua comparsa una prospettiva più identitaria e incentrata sull’idea secondo cui questi soggetti si troverebbero divisi tra due culture – quella della famiglia di origine e quella del paese di arrivo – nettamente diverse e chiaramente identificabili. Sul tema delle seconde generazioni, estremamente rilevante dal punto di vista dei processi di integrazione ma non affrontato in questo paper per ragioni di spazio, si rimanda a Eve e Perino 2014. 20 Per questa ragione, in Gargiulo 2014c, la visione dell’integrazione presente nei primi due Documenti programmatici è stata definita come «potenzialmente inclusiva», soprattutto con riferimento alle visioni successive: la maggiore inclusività, nello specifico, risiederebbe nella centralità dei diritti, nell’attenzione alla dimensione materiale e nell’adozione di un approccio culturale che, oltre a non essere fissista ed essenzializzante, prescinde da riferimenti a una presunta identità nazionale, preesistente al contatto con i nuovi arrivati”, a cui affidare l’assimilazione di questi ultimi (riferimenti che invece saranno presenti nel Piano). Tale valutazione circa la maggiore inclusività della visione dell’integrazione presente nei primi Documenti programmatici e nei primi Rapporti della Commissione non deve intendersi come estesa all’intero impianto normativo della legge Turco-Napolitano: questa norma, che riserva buona parte delle misure di integrazione agli stranieri regolari – e in questo senso si caratterizza come «a inclusività limitata» (Gargiulo 2014c) – manifesta sul versante delle politiche di ingresso e su quello della gestione degli immigrati da identificare, un approccio decisamente meno inclusivo.
Con la pubblicazione del Piano21, la transizione a una nuova filosofia dell’integrazione – già iniziata con il terzo Documento programmatico (pubblicato nel 2005) e con la Carta dei valori – diventa del tutto evidente. La nuova visione dei processi di inclusione presenta tratti marcatamente assimilazionisti accanto a discorsi strumentalmente “multiculturalisti”22. Più in dettaglio, la richiesta di apprendere la lingua e i valori nazionali introdotta dall’Accordo e l’immagine compatta e monolitica della comunità culturale italiana promossa dal Piano – a cui gli stranieri sono chiamati a conformarsi – è accompagnata, come già anticipato, da una visione temporanea e non strutturale dell’immigrazione.
Questa visione è chiaramente riconducibile al “classico” modello del lavoratore-ospite, rappresentato paradigmaticamente dalla Germania, quantomeno in una sua fase storica. In un saggio di qualche anno fa, Giovanna Zincone ha definito tale modello multiculturalismo esclusivo statalista, sottolineando come al suo interno gli immigrati non siano invitati ad abbandonare la lingua madre né i propri tratti culturali in quanto si auspica un loro ritorno nel paese di origine (2009, 32). Il rispetto della “diversità” culturale, dunque, nel caso tedesco è finalizzato a rendere più probabile il ritorno dei non cittadini, e si pone perciò come una scelta strumentale e ben poco “progressista”. Passando al caso italiano, l’argomento contenuto nel Piano è emblematico di questa strategia e di questo atteggiamento: chi pensa di – o è fortemente incoraggiato a – rimpatriare non è chiamato ad adattarsi, mentre invece chi intende restare è costretto a farlo.
2. “Non importa se sei legale, qui non ci dovresti stare”: le discriminazioni
amministrative di livello comunale come strategie di esclusione di ultima istanza
2.1 La stagione delle ordinanze e il protagonismo municipale Nello stesso periodo in cui si va articolando il dibattito politico che, dalla presentazione
della Carta, porta all’emanazione dell’Accordo di integrazione, a livello locale numerose amministrazioni comunali iniziano a manifestare con evidenza la volontà di decidere autonomamente su diverse materie. Questa crescente rivendicazione di autonomia si inserisce senza dubbio in un quadro istituzionale in trasformazione: con l’introduzione dei nuovi Patti per la sicurezza di seconda generazione23 i prefetti sono autorizzati a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per la realizzazione di programmi straordinari, mentre il ministro dell’interno Giuliano Amato e il presidente dell’Anci Leonardo
21 In realtà, lo scenario comincia a cambiare già con la pubblicazione del terzo documento. Per maggiori dettagli a riguardo e per un approfondimento sul contenuto dei Documenti triennali e sul passaggio da questi al Piano si rimanda a Gargiulo 2014c. 22 Sulle nuove tendenze culturaliste delle politiche migratorie italiane una prospettiva interessante è fornita da Testai 2015. 23 Sulla base del comma 439 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, la cosiddetta “legge finanziaria” del 2007.
Dominici firmano un accordo-quadro per la sicurezza delle aree urbane con i sindaci delle città sedi di aree metropolitane (Calaresu 2010)24.
Il governo centrale, in altre parole, inizia a riconoscere ai comuni un potere decisionale più ampio in materia di sicurezza, anche se numerosi sindaci, già da qualche anno, manifestano una evidente volontà di protagonismo, ritagliandosi spesso ampi spazi di visibilità mediatica sia a livello locale sia a livello statale (Ricotta 2012). La stagione dei cosiddetti “sindaci sceriffo”, animata tanto da amministratori locali appartenenti alla Lega nord o a schieramenti di destra quanto a partiti di centro-sinistra, ha così inizio (Tondelli 2009).
I primi cittadini di area “progressista”, in particolare, attuano un rapido cambio di direzione da interventi di mediazione e di prevenzione, caratterizzati da una strategia adattiva e da una retorica di tipo inclusivo (Battistelli e Lucianetti 2010), a un approccio esplicitamente populista (Ricotta 2012), mossi soprattutto dal farsi “emergenza” del tema sicurezza in conseguenza di alcuni eventi di cronaca25 oggetto di un trattamento mediatico dai toni, in molti casi, apertamente xenofobi. La svolta securitaria del centro-sinistra si traduce nell’emanazione del Decreto-legge 181 del 2007, finalizzato a rendere realizzabile l’espulsione immediata dei cittadini comunitari e dei loro familiari per motivi di pubblica sicurezza.
La strategia emergenziale del centro-sinistra, tuttavia, non si rivela efficace sul piano elettorale: la sconfitta ottenuta alle consultazioni politiche tenutesi nella primavera del 2008, che fa seguito a quella conseguita alle amministrative di Roma di poco precedenti, fa sì che il “testimone” sul tema della sicurezza passi al centro-destra, che lo interpreta attraverso le proprie categorie, ossia cavalcando in maniera ancora più esplicita le paure espresse dall’opinione pubblica (Boccia 2008).
Il 2008, dunque, diventa un anno chiave per il tema della sicurezza: il Decreto-legge n. 92 emanato a maggio e convertito poi in legge (n. 125) a luglio, prima parte del cosiddetto «Pacchetto sicurezza», oltre a intervenire in numerosi ambiti delle politiche migratorie, introduce nell’ordinamento italiano la nozione giuridica di “sicurezza urbana”26 e modifica l’art. 54 del Testo unico degli enti locali, estendendo il potere di ordinanza dei sindaci anche al di fuori delle situazioni emergenziali (Stradella, 2010). A partire da questo momento, gli amministratori locali possono fare ricorso a tale strumento amministrativo senza dover richiamare situazioni emergenziali, presunte o reali che siano (Bedessi 2010). Il numero delle ordinanze emanate per regolamentare aspetti della vita sociale ritenuti potenzialmente lesivi della sicurezza urbana, prevedibilmente, aumenta enormemente
24 A cui fa seguito, nel settembre del 2008, un ulteriore accordo tra l’Associazione nazionale piccoli comuni (Anpci) e il Ministero dell’interno, tramite cui l’applicazione dei “piani coordinati di controllo del territorio” e il potenziamento della collaborazione logistica, strumentale e finanziaria tra stato ed enti locali previste dalla legge finanziaria 2007 è estesa anche alle realtà media-piccole. 25 Che hanno come teatro la città di Roma. 26 Quest’ultima nozione è definita da un successivo decreto ministeriale emanato il 5 agosto 2008, al cui interno l’“incolumità pubblica” equivale all’«integrità fisica della popolazione», mentre la “sicurezza urbana” è intesa come «un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale».
subito dopo l’emanazione del pacchetto sicurezza (Galantino e Giovannetti 2012; Giovannetti 2012).
Il potere di ordinanza, qualche anno dopo, subisce una forte limitazione: con la sentenza n. 115 del 2011, la Corte costituzionale giudica illegittima la norma che aveva modificato l’art. 54 del Tuel27 (Manfredi 2013). Nonostante la decisione della Consulta, la stagione delle ordinanze non può tuttavia dirsi conclusa: numerose amministrazioni locali continuano tuttora a impiegare il potere di ordinanza nel tentativo di regolare aspetti della vita sociale che ritengono rilevanti.
I contenuti dei provvedimenti impiegati dai sindaci sono decisamente variegati: come evidenziato da una ricerca della fondazione Cittalia, le ordinanze possono essere divise in tre gruppi differenti, che rispondono rispettivamente a una logica situazionale, qualora abbiano l’obiettivo di ripristinare il decoro28 in luoghi specifici della città o in occasioni particolari; comportamentale, quando sono finalizzate a indurre i cittadini a mantenere comportamenti civili e riguardosi nei confronti degli altri e della città stessa; rafforzativa, se orientate a intervenire su temi già considerati dalle leggi – come ad esempio il consumo di droghe, il commercio abusivo o lo sfruttamento dei minori per accattonaggio – introducendo nuove sanzioni di tipo amministrativo (Anci-Cittalia 2009).
Le ordinanze, dunque, hanno spesso come bersaglio le componenti povere e disagiate della popolazione, caratterizzandosi, più o meno esplicitamente, come strumenti di esclusione, ossia come dispositivi finalizzati a separare i cittadini locali pienamente accettati da coloro che, seppur presenti, non sono considerati come membri in senso pieno della comunità. Tramite questi dispositivi, più in dettaglio, è possibile ottenere diversi effetti di esclusione. Maurizio Ambrosini ne ha individuati cinque: civile, ossia da diritti civili; sociale, vale a dire da benefici e prestazioni sociali; culturale, come contrasto del pluralismo culturale; securitaria, dove vi è un richiamo alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, economica, qualora le misure vadano a incidere sulla libertà di iniziativa economica (Ambrosini 2012). Gli aspetti materiali e amministrativi su cui le ordinanze vanno a incidere, tuttavia, provocano in diversi casi effetti trasversali, rendendo decisamente più complesso e articolato il quadro dell’esclusione.
2.2 L’esclusione locale tra discriminazioni e stratificazione civica Se alcuni dispositivi di livello locale sono volti a impedire, direttamente o
indirettamente, l’esercizio effettivo di singoli diritti fondamentali riconosciuti dalle leggi statali, le iniziative in materia di residenza29 agiscono in maniera chiaramente trasversale. Emanate con il pretesto di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, queste misure
27 Specificando che l’illegittimità riguarda la parte della legge 125 in cui ai sindaci era conferito il potere di ordinanza «anche» in situazioni non contingibili e urgenti. 28 Sul concetto di “decoro” presente in molte ordinanze cfr. Pitch 2013 e Simone 2010. 29 Per una breve storia dei provvedimenti (ordinanze e non solo) in materia di residenza si rimanda a Gargiulo 2013; 2014b e 2014d. Per approfondimenti circa la vicenda dell’ordinanza di Cittadella (Pd) – uno dei primi, nonché più discussi e imitati, provvedimenti in materia di residenza –e per maggiori dettagli circa i contenuti del dispositivo amministrativo cfr. Campo 2007 e Paggi 2007. Per un’analisi di taglio sociologico riguardo alle caratteristiche, agli usi e agli effetti di questa ordinanza si rimanda a Gargiulo 2011a e 2012a.
agiscono esplicitamente sulla sfera civile, ma incidono anche sulle sfere economica, politica e sociale. Nell’ordinamento giuridico italiano, infatti, l’iscrizione anagrafica è il presupposto necessario per il godimento effettivo di numerosi diritti.
Dispositivi di questo genere sono in uso da diversi anni, ma è con la fine del 2007 che, soprattutto in alcune zone d’Italia, conoscono una diffusione particolare. Con l’entrata in Europa della Romania e della Bulgaria e dopo l’emanazione del decreto 30, avente lo scopo di disciplinare la circolazione e il soggiorno dei cittadini comunitari30, il “libero movimento” dei nuovi europei diventa un elemento di grande preoccupazione per alcune amministrazioni italiane, che viene utilizzato come pretesto per tentare di regolare anche la mobilità dei cittadini extra-comunitari e di alcune categorie di italiani.
Sostanzialmente, le ordinanze e gli altri tipi di provvedimento impongono a coloro che chiedono di essere iscritti nei registri anagrafici la dimostrazione del possesso di requisiti ulteriori e/o più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale: ad esempio, la disponibilità di un contratto di lavoro, la titolarità di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno almeno biennale, un reddito superiore a una certa soglia oppure la dimostrazione di non avere all’attivo pene detentive o restrittive (Guariso 2012; Usai 2011; Lorenzetti 2009). I requisiti introdotti o modificati dalle ordinanze possono essere differenziati con riferimento ai cittadini e ai non cittadini oppure possono essere indirizzati indistintamente agli uni e agli altri. In generale, comunque, a essere oggetto di esclusione sono soprattutto gli stranieri, i cittadini comunitari e quegli italiani che manifestano comportamenti o tratti poco graditi: ad esempio, persone senza fissa dimora o che vivono in alloggi ritenuti “indecorosi” (magari perché appartenenti alle popolazioni romanì).
Oltre alle ordinanze, alle circolari e alle delibere di giunta, il rifiuto della residenza è spesso attuato attraverso strumenti e meccanismi meno visibili e diretti: prassi burocratiche informali, uso indiretto e pretestuoso dei requisiti introdotti da provvedimenti amministrativi31. Il ricorso a strategie di questo tipo, di recente, è favorito da alcuni interventi normativi di livello statale che spostano l’attenzione delle amministrazioni comunali sulle condizioni materiali del luogo di dimora e sulla legalità dell’occupazione dell’immobile presso cui il richiedente l’iscrizione dichiara di risiedere. Più in dettaglio, la legge 94 del 2009, seconda parte del pacchetto sicurezza, modifica la normativa statale che regola il riconoscimento della residenza attribuendo ai comuni la possibilità, ma non l’obbligo, di effettuare una verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile presso cui si richiede l’iscrizione. Sebbene non sia istituito alcun nesso formale tra un eventuale esito negativo di tale verifica e il rifiuto della residenza, numerosi sindaci iniziano a emanare circolari interne o ordinanze tramite cui rendono obbligatori i controlli, con l’evidente intenzione di fare leva in maniera pretestuosa sulle condizioni mediamente
30 Come stabilito dal d.lgs. 30/2007 (che va ad attuare la Direttiva 2004/38/CE) e dai decreti e dalle circolari che lo hanno successivamente integrato e modificato, i cittadini comunitari non sono obbligati a disporre del permesso di soggiorno, ma sono tenuti, se intenzionati a soggiornare sul territorio italiano per più di tre mesi, a iscriversi all’anagrafe (dimostrando di possedere alcuni requisiti di carattere economico-lavorativo, diversificati sulla base delle ragioni del soggiorno in Italia). Per questa categoria di persone, la residenza, di fatto, ha sostituito il permesso di soggiorno quale strumento di controllo della regolarità della presenza nel territorio italiano. 31 Per approfondimenti a riguardo si rimanda a Gargiulo 2014b e 2014e.
peggiori in cui versano le abitazioni di alcune categorie di persone32. Successivamente, l’art. 5 del Decreto n. 47 (il cosiddetto «Decreto Lupi»), emanato e poi convertito in legge tra la primavera e l’estate del 2014, stabilisce che chi occupa abusivamente un immobile non può fissarvi la residenza né può chiedere l’allacciamento ai pubblici servizi. Nonostante il Ministero dell’interno, anche in questo caso, sia intervenuto con due circolari per chiarire alcuni aspetti critici del provvedimento33, numerose amministrazioni comunali stanno facendo leva sul “Piano casa” per giustificare l’introduzione di requisiti che, in alcuni casi, sembrano travalicarne anche la già rigida logica: ad esempio verificando il consenso di eventuali altri inquilini già presenti nello stesso appartamento presso cui l’iscrizione è richiesta.
Complessivamente, dunque, il controllo locale della residenza costituisce un aspetto importante delle politiche locali di esclusione condotte in nome della sicurezza urbana. Le iniziative volte a negare l’iscrizione anagrafica, infatti, minacciano – e spesso provocano concretamente – discriminazioni, dirette, indirette o dissimulate, nei confronti di non italiani o di italiani poco “graditi”. Queste iniziative, quando rimangono inattuate – in quanto i provvedimenti emanati, seppur altamente pubblicizzati, di fatto rimangono sulla carta – alimentano comunque un’esclusione di natura simbolica34, mentre quando sono effettive – perché i requisiti contenuti nel testo delle ordinanze o degli altri provvedimenti si traducono in richieste concrete nei confronti degli utenti, oppure perché sono messe in campo strategie indirette e informali – l’esclusione che prende forma è più complessa e articolata. Nello specifico, gli effetti escludenti possono essere di tipo sociale, economico e politico35, nonché, seppur soltanto indirettamente, spaziale36, soprattutto con riferimento ai cittadini comunitari37 o ai richiedenti asilo38.
32 Per una ricostruzione dettagliata e puntuale delle numerose proposte di legge che, negli ultimi anni, hanno provato – finora senza successo – a istituire un nesso esplicito tra le condizioni dell’alloggio e il diritto alla residenza cfr. Mariani 2010. 33 La prima (n. 14 del 6/8/2014) ha specificato che l’obiettivo del legislatore era quello di consentire «il ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti». In quest’ottica, il provvedimento mirerebbe a colpire soltanto le occupazioni abusive, vale a dire che avvengono contro la volontà del proprietario: dal punto di vista strettamente giuridico, infatti, un’occupazione non può essere considerata abusiva fino a che il proprietario dell’immobile, sia esso un soggetto pubblico o un attore privato, non decide di esercitare pienamente ed esplicitamente il suo diritto a rivendicare la disponibilità dello stesso, vale a dire prendendo provvedimenti esecutivi o avviando un iter giudiziario. La seconda (n. 633 del 24/02/2015), ha chiarito che chi dimora in un immobile occupato abusivamente ha comunque diritto a essere iscritto nell’anagrafe comunale e che «poiché il criterio generale e prevalente del “luogo di dimora abituale” non può essere applicato a coloro che abitino in un immobile occupato abusivamente, non è possibile individuare altra soluzione se non l’iscrizione “per domicilio”, in analogia con le persone senza fissa dimora». In precedenza, anche in occasione delle modifiche apportate alla normativa anagrafica dalla legge 94 del 2009, il Ministero era intervenuto, con alcune circolari, per sottolineare l’assenza di un qualsiasi nesso tra condizioni dell’abitazione e iscrizione anagrafica. 34 Regolando in maniera autonoma – e del tutto illegittima – i requisiti per l’iscrizione, gli amministratori locali tracciano un confine molto netto che, a livello locale, separa i “desiderati” e gli “indesiderati”. Un’esclusione di questo genere, oltre a produrre effetti di stigmatizzazione, può agire anche come deterrente al soggiorno nel territorio comunale, scoraggiando gli esclusi dal rimanere all’interno del perimetro dell’amministrazione che li etichetta come inaccettabili 35 A riguardo, cfr. Gargiulo 2011a e 2011b. 36 Sebbene non equivalga in nessun caso all’allontanamento dal territorio comunale, il rifiuto dell’iscrizione può interagire con le misure finalizzate all’espulsione dal perimetro locale o, addirittura, da quello statale, soprattutto con riferimento ai cittadini comunitari o ai richiedenti asilo. Per quanto riguarda i legami indiretti
Le iniziative richiamate in questo paper possono provocare un incremento della civic stratification (Morris 2003), causando una frammentazione degli status tramite cui la presenza in Italia dei non cittadini è riconosciuta39, oppure procurando uno scollamento tra gli statuti giuridici e i diritti loro associati dalle leggi italiane (Gargiulo 2014b, 2014e e 2015). Siccome questi effetti di discriminazione e di stratificazione coinvolgono spesso stranieri regolarmente presenti in Italia e cittadini comunitari, i dispositivi comunali agiscono come strumenti di esclusione “di ultima istanza” nei confronti di individui che è impossibile, o quantomeno molto difficile, espellere dal territorio italiano.
3. Gli ostacoli e le loro implicazioni, tra piano simbolico e piano materiale 3.1 Dalle policies alla polity Gli ostacoli qui analizzati agiscono come meccanismi selettivi, ossia come dispositivi
che operano una distinzione all’interno della popolazione migrante regolare. Nel caso dell’Accordo di integrazione, i meccanismi separano gli integrabili e accettabili dai non integrabili e non accettabili. Nel caso dell’esclusione dalla residenza i dispositivi selettivi mirano a distinguere tra residenti legittimi e illegittimi, nonché tra chi ha il “diritto ad avere diritti” e chi, invece, ne è privo.
In entrambi i casi, le politiche di selezione sembrano mirare a una riconfigurazione della popolazione. In altre parole, le policies messe in atto a livello centrale e a livello locale incidono, rispettivamente, su “una” polity di ambito nazionale40 e sulle polities comunali. Questa incidenza riguarda sia la forma delle comunità chiamate in causa – ossia i confini “formali” che separano gli appartenenti dai non appartenenti – sia la loro coesione. In questo caso, gli effetti delle politiche possono contribuire a rafforzare la compattezza della comunità degli inclusi, attraverso un meccanismo di identificazione per contrapposizione rispetto all’insieme degli esclusi, ma possono anche minarne le fondamenta, alimentando il conflitto sociale e destabilizzando l’ordine interno.
tra diniego della residenza e allontanamento si rimanda a Gargiulo 2014b e 2015. Quanto alle forme passate di allontanamento di persone prive della residenza, con particolare riferimento a periodi in cui erano in vigore le leggi contro l’urbanesimo, cfr. Gallo 2011. 37 Nel caso dei cittadini comunitari, i quali, come si è visto, non sono tenuti a disporre di un permesso di soggiorno ma sono obbligati a registrarsi, il rifiuto della residenza – tanto per carenza dei requisiti economici quanto per pericolosità sociale – viene a coincidere con una condizione di “irregolarità” piuttosto ambigua e rischiosa, dato che l’eventuale segnalazione alle autorità (prefetture e Ministero dell’interno) può innescare un provvedimento di allontanamento. 38 Alcune questure, ad esempio, rifiutano il rinnovo del permesso di soggiorno a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale sulla base della mancanza della residenza, come evidenziato da una circolare del Ministero dell’interno del 18 maggio del 2015, che esorta le questure a interrompere questa prassi e le prefetture a vigilare meglio sulle procedure di iscrizione anagrafica. Per quanto riguarda i problemi di iscrizione anagrafica e altri ostacoli legali e burocratici, legati soprattutto all’accesso alla casa, si rimanda a Bolzoni, Gargiulo e Manocchi 2015. 39 Su questo punto, con riferimento ai cittadini rumeni, cfr. anche Sacchetto e Vianello 2013. 40 Ossia, sulla comunità costituita da coloro che sono regolarmente presenti in Italia. Non – o, quantomeno, non direttamente – “sulla” polity nazionale, ossia sulla comunità dei cittadini italiani, come sarebbe invece se il test di integrazione fosse applicato a coloro che intendono ottenere la cittadinanza italiana.
Gli ostacoli che i migranti si trovano a fronteggiare, come già anticipato, in alcuni casi producono conseguenze materiali mentre in altri casi agiscono a livello esclusivamente simbolico. Tanto nel caso dell’Accordo quanto in quello dell’esclusione dalla residenza, la probabilità che gli effetti siano reali è direttamente proporzionale alla scarsa visibilità dei meccanismi selettivi interni ai due tipi di politica. Quanto al primo strumento, l’opacità è dovuta alle modalità con cui i dispositivi che determinano l’integrabilità sono stati istituiti. I contenuti del contratto di soggiorno, infatti, non sono delineati dalla legge del 2009, ma dal regolamento attuativo del 2011 e da alcune circolari emanate successivamente: in altre parole, sono introdotti per via amministrativa, ossia da norme secondarie e da strumenti para-normativi, non dalla legge, nonostante la Costituzione preveda che la condizione giuridica dello straniero possa essere disciplinata esclusivamente dal legislatore41 (Zorzella 2011). Ciò rende difficoltoso comprendere in dettaglio i vari passaggi del processo di valutazione dell’avvenuta integrazione, e produce incertezza circa i suoi esiti. Quanto all’esclusione dalla residenza, l’opacità è legata in alcuni casi all’invisibilità dei provvedimenti – non sempre le ordinanze, e soprattutto le circolari, sono visibili – e alla natura poco chiara dei meccanismi escludenti – i requisiti non sono necessariamente comprensibili; le ragioni del rifiuto sono spesso pretestuose; non sempre vengono prodotte tracce amministrative del diniego; ecc. – (Gargiulo 2014a e 2014d). Il che rende difficile ricostruire i vari passaggi che hanno portato alla negazione dell’iscrizione anagrafica.
Comunque, anche quando sono inefficaci, gli ostacoli non perdono la loro rilevanza. Se platealmente esibite, le barriere costituiscono la “messa in scena” del potere e della sovranità. L’accordo di integrazione e le ordinanze possiedono un elevato valore simbolico, impiegato per marcare e rimarcare distinzioni tra “noi” e “loro” in contesti in cui gli “autoctoni” e i “non-autoctoni” convivono di fatto nello stesso spazio. Questi dispositivi, nonostante le evidenti differenze, ricordano i “nuovi” muri di cui parla Wendy Brown42 (2013): la natura “teatrale” e spettacolarizzata di alcune iniziative comunali43, ad esempio, costituisce uno “sfoggio” muscolare di sovranità che va al di là della sua efficacia reale.
A differenza delle barriere di cui parla la studiosa americana, però, la sovranità che l’Accordo di integrazione e le politiche di esclusione locale esprimono non è necessariamente in declino. Nel caso dell’Accordo si tratta di una sovranità ambivalente, di tipo nuovo, considerata la recente introduzione in Italia della logica della civic integration, che si fa visibile sul piano dei discorsi e delle intenzioni proclamate pur non
41 Per interessanti considerazioni sull’uso delle circolari e degli strumenti para-normativi nelle politiche migratorie italiane si rimanda a Gjergji 2013. 42 Secondo Brown, i nuovi muri conservano le caratteristiche tipiche degli strumenti precedenti – ossia, una evidente valenza politica ed economica ma anche un elevato valore simbolico – potendo essere considerati, sulla scorta dei lavori di Edward Said, elementi centrali di una «geografia immaginaria» che «produce identità» (Brown 2013, 71), ma al contempo, distanziandosi dal passato, «producono un “noi” demarcato spazialmente, un’identità nazionale e una misura politica su scala nazionale, quando ormami questi elementi non possono più contare sulla pretesa di un’autonomia politica o economica nazionale, di una omogeneità demografica, o ancora di una condivisione di storia, cultura e valori» (ivi, 125). 43 Spesso ampiamente pubblicizzate nei quotidiani e nelle Tv locali (e anche nazionali), riprese da altre amministrazioni comunali attraverso la modalità del “copia e incolla” e diffuse attraverso siti internet di organizzazioni politiche e para-politiche.
essendo necessariamente produttiva – date le già citate incertezze sul processo di attuazione di questa policy – di conseguenze pratiche. Nel caso dell’esclusione locale, si tratta di una sovranità chiaramente illegittima, rivendicata pubblicamente se esibita attraverso ordinanze o altri provvedimenti o strappata surrettiziamente se praticata nell’ombra, che parla in maniera forte tanto ai poteri statali – governo centrale e magistratura – quanto alla comunità locale, inviando ambigui messaggi di autonomia e di protezione e facendosi strumento di attivazione di un senso di appartenenza distorto e ipertrofico, nonché di sentimenti xenofobi, anche in assenza di effetti diretti.
Da questa prospettiva, l’analisi delle iniziative qui considerate invita a un approccio allo studio delle discriminazioni amministrative che guardi sicuramente ai fini ma che, soprattutto, si concentri sui mezzi impiegati. In questo modo, l’analisi degli aspetti “tecnici” può far emergere in maniera ancora più evidente la posta in gioco “politica” dei dispositivi oggetto di attenzione. Detto diversamente, è necessario cercare di individuare la politica all’interno della tecnica.
A riguardo, in un interessante lavoro incentrato sulle implicazioni morali e politiche dell’uso dei droni – un argomento del tutto diverso da quello qui trattato ma che, tuttavia, presenta interessanti, e inquietanti, punti di contatto con i temi dell’esclusione dei non cittadini – Grégoire Chamayou rileva come a essere importante non sia «scoprire il funzionamento del mezzo in se stesso, ma individuare, a partire dalle sue caratteristiche, quali sono le implicazioni per l’azione di cui esso è il mezzo. L’idea è che i mezzi sono vincolanti e che a ogni tipo di mezzo sono associati specifici meccanismi che comportano degli obblighi» (Chamayou 2014, 16). Per questa ragione, lo studioso francese invita a «un’analitica delle armi, contemporaneamente tecnica e politica» (ibidem).
3.2 Una precarizzazione delle appartenenze Che siano considerate barriere simboliche, come tali ben visibili ed esibite, o che siano
pensate quali barriere di natura materiale, e dunque opache e complesse dal punto di vista amministrativo, le procedure previste dall’Accordo e le strategie di esclusione dalla residenza costituiscono un esempio di violenza strutturale. Questo concetto, che può essere efficacemente illustrato riprendendo Didier Fassin,
riguarda il modo in cui strutture sociali storicamente costituite interferiscono con i bisogni, le capacità e le aspirazioni delle persone. Combina in vari modi disuguaglianza economica, ingiustizia sociale, discriminazione razziale e diverse forme di negazione dei diritti umani e di cittadinanza. È più difficile da cogliere rispetto alla violenza politica. Il suo rapporto con lo Stato è più pernicioso, ma meno ovvio. La sua impronta sul corpo è più profonda, ma meno tangibile. La sua visibilità non è immediata – ma ci sono anche molti interessi in gioco per mantenerla invisibile, poiché un suo svelamento sistematico potrebbe avere conseguenze inaspettate sull’ordine sociale (Fassin 2014, 103).
Gli ostacoli qui illustrati, dunque, esercitano una coercizione non esplicitamente
violenta ma comunque fortemente condizionante i bisogni primari dei non cittadini. Più in
dettaglio, questi dispositivi possono produrre come conseguenza una sorta di precarizzazione delle appartenenze: le modalità con cui i non cittadini sono riconosciuti come membri – seppur parziali – della società italiana sono rese altamente instabili.
Nel caso dell’Accordo di integrazione, questa instabilità si traduce nel fatto che chi non riesce o non vuole adattarsi rischia di essere espulso, oppure è costretto ad adeguarsi a un modello di immigrazione temporaneo o rotatorio non necessariamente desiderato. Come già visto in precedenza, infatti, i non cittadini messi maggiormente a rischio dalla logica dell’Accordo sono soggetti già vulnerabili dal punto di vista socio-economico. Nei confronti di questi soggetti, viene attuata una sorta di inclusione differenziale (Cuttitta 2014) o, detto diversamente, stratificata. La regolarità del soggiorno è resa incerta: i non integrati – ossia coloro che rifiutano di firmare l’Accordo o che, pur firmandolo, non riescono a raggiungere i punti necessari – sono illegalizzati; la deportabilità44, estendendosi dagli stranieri “irregolari” a quelli “regolari”, diventa dunque lo strumento di disciplinamento principale (Cuttitta 2014).
La filosofia dell’integrazione promossa dai governi italiani, pertanto, costruisce a livello simbolico una grande formazione discorsiva orientata a istituire una demarcazione tra soggetti integrabili e soggetti non integrabili (Gargiulo 2012b). Questa demarcazione equivale a una selezione degli immigrati “meritevoli”, effettuata seguendo una logica culturalista: possono continuare a soggiornare nel territorio italiano quei non cittadini che soddisfano determinati requisiti, che sono cioè in grado di dimostrare – in particolar modo attraverso il superamento di corsi di lingua e di educazione civica e mediante l’accettazione dei principi contenuti nella Carta dei valori – la propria adesione a standard comportamentali ritenuti accettabili (Gargiulo 2014a). A livello materiale, la selezione qui descritta produce incertezza e precarietà in relazione agli status che legano i non cittadini allo stato italiano, alimentando la stratificazione civica e aumentando il grado di subordinazione e di dipendenza degli immigrati nel mercato del lavoro. L’integrazione, da diritto, si trasforma così in un percorso a ostacoli, in una sorta di “gioco dell’oca”, come affermato in maniera efficace da Iside Gjergji (2014).
Nel caso dell’esclusione dalla residenza, l’instabilità è legata allo scarto tra il riconoscimento giuridico fornito dallo stato e il mancato riconoscimento a livello locale, conseguenza di una selezione incentrata su criteri di tipo economico, legati al decoro e alla presentabilità sociale (Gargiulo 2014a). Effetti della discrasia tra la regolarità riconosciuta dallo stato e l’“illegittimità” affermata dalle amministrazioni locali sono la sottrazione di diritti, la produzione di distanza sul piano simbolico e la messa a rischio, seppur soltanto indiretta, della presenza sul territorio, comunale e nazionale.
La condizione esistenziale e amministrativa che ne deriva è frutto di un processo di gerarchizzazione e di “alterizzazione”: coloro che sono esclusi dalla residenza vedono peggiorare la propria posizione lungo la “scala” della stratificazione civica e sono trattati come “altri” nel momento in cui lo status di residenti è loro negato. Questa condizione,
44 Cuttitta riprende questa categoria da De Genova (2002 e 2013), il quale sottolinea come sia la “deportabilità”, e non la “deportazione” di per sé, a rendere i migranti forza-lavoro particolarmente disponibile e appetibile.
inoltre, è diseguale e incardinata in relazioni di dominio, essendo conseguenza delle scelte politiche di attori locali e, in alcuni casi, nazionali.
Il processo qui descritto ricorda la precarizzazione di cui parla Lorey (2015): nell’ambito delle trasformazioni neoliberiste, governare costruendo precarietà significa non soltanto creare incertezza attraverso il lavoro e la sua flessibilizzazione, ma anche destabilizzare le condotte di vita e destrutturare i soggetti. La negazione della residenza, in questo senso, equivale a una frammentazione dell’appartenenza alla comunità italiana – anche con riferimento agli stranieri lungo-soggiornanti, ai cosiddetti denizens45 – e, dunque, a una marginalizzazione o, comunque, a una forma di inclusione differenziale: la mancanza di diritti e la delegittimazione associata al diniego dello status di cittadino locale rendono gli esclusi maggiormente vulnerabili, anche sul piano lavorativo. A livello comunale, insomma, sono “costruiti” soggetti meglio predisposti, nell’ambito del mercato del lavoro, ad accettare regole del gioco e vincoli dettati da attori “autoctoni” che detengono un potere contrattuale decisamente più elevato.
Considerazioni conclusive Gli ostacoli qui analizzati riflettono una profonda trasformazione nella filosofia
dell’integrazione: l’inserimento dei non cittadini nella società italiana, da diritto (riservato però agli immigrati regolari), è diventato un dovere; al contempo l’idea che sia opportuno effettuare una selezione degli immigrati “meritevoli” di soggiornare nel territorio italiano si è diffusa sempre più. Questo cambiamento è esemplificato, a livello centrale, dall’adesione dei governi italiani alla logica della civic integration, che agisce soprattutto nei confronti di categorie economicamente e socialmente svantaggiate, mentre, a livello periferico, dalla “stagione delle ordinanze” che si è andata articolando a cavallo dell’emanazione dei vari provvedimenti componenti il Pacchetto sicurezza.
La trasformazione dell’idea di integrazione, oltre a tradursi in una visione differenzialista dell’inserimento dei non cittadini nella società italiana, è accompagnata da forme più o meno visibili ed esplicite di discriminazione istituzionale. Complessivamente, i dispositivi simbolici e materiali messi in campo a livello statale e a livello locale rischiano di provocare un aumento effettivo della stratificazione civica, innescando un meccanismo che, dalla delegittimazione, porta alla progressiva “irregolarizzazione” degli stranieri regolari, anche di quelli lungo-soggiornanti, contribuendo così alla costruzione di una vera e propria “precarizzazione” delle forme di appartenenza. Questa trasformazione non è rilevante soltanto sul piano politico e culturale, ma anche su quello economico: la condizione di vulnerabilità a cui molti non cittadini, nonostante il loro status di regolarità, sono ridotti dalle diverse barriere normative e burocratiche può contribuire infatti alla costruzione di soggetti lavoratori docili e malleabili.
45 In questo senso, il controllo locale della residenza si configura come uno strumento di esclusione di ultima istanza anche nei confronti dei “quasi-italiani”.
Riferimenti bibliografici Ambrosini M. (2012), Separati in città. Le politiche locali di esclusione degli
immigrati, in «La Rivista delle Politiche Sociali», 1, pp. 69-88. Anci-Cittalia (2009), Oltre le ordinanze. I sindaci e la sicurezza urbana, disponibile
all’indirizzo: www.anci.it. Andrisani P. e Naletto G. (2009), Cronache di ordinario razzismo, in Naletto G. (a cura
di), Rapporto sul razzismo. Antonsich M. e Matejskova T. (2015), Immigration Societies and the Question of the
National, in «Ethnicities», 15, 4, 495-508. Battistelli F. e Lucianetti L.F. (2010), La sicurezza tra politics e policy, in PAJNO A., a
cura di, La sicurezza urbana, Rimini, Maggioli,pp. 75-100. Bedessi S. e Desii E. (2010), Le ordinanze in materia di sicurezza urbana, Rimini,
Maggioli. Biondi Dal Monte F. e Vrenna M. (2013), L’accordo di integrazione ovvero
l’integrazione per legge. I riflessi sulle politiche regionali e locali, in Rossi, Biondi Dal Monte e Vrenna (a cura di), pp. 253-287.
Boccia M.L. (2008), Gli imprenditori politici della paura. Il paradigma della destra
per controllare le differenze, in «Quale Stato?», 3-4, pp. 184-201. Bolzoni M., Gargiulo E. e Manocchi M. (2015), The social consequences of the denied
access to housing for refugees in urban settings: the case of Turin, Italy, in « International Journal of Housing Policy», (doi: 10.1080/14616718.2015.1053337).
Bontempelli S. (2009), «Ordinanza pazza». I Sindaci e il versante grottesco del
razzismo, in Naletto G. (a cura di), Rapporto sul razzismo. Bova R. (2012), La Carta dei valori dell’integrazione e della cittadinanza quale
esempio di policy per gli stranieri in Italia, in «Studi emigrazione», 49, 187, pp. 412-429. Brown W. (2013), Stati murati, sovranità in declino, Roma-Bari, Laterza (ed. or.
2010).
Calaresu M. (2012), La politica di sicurezza urbana in Italia L’esperienza dei “patti per la sicurezza” nel triennio 2007-2009, in «Rivista italiana di politiche pubbliche», 3, pp. 387-418.
Campo G. (2007), Cittadella e dintorni, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», 4,
pp. 63-69. Caponio T. (2009), Le politiche per gli immigrati, in Ponzo I., a cura di, Conoscere
l’immigrazione. Una cassetta degli attrezzi, Roma, Carocci, pp. 23-43.
– (2012), Italia: una transizione incompiuta?, in Fieri, Dall’ammissione all’inclusione: verso un approccio integrato? Un percorso di approfondimento comparativo a partire da alcune recenti esperienze europee, rapporto di ricerca, http://www.cnel.it/271?shadow_documento_altri_organismi=3446.
Carrera S. (2006), A Comparison of Integration Programmes in the EU: Trends and Weaknesses, Ceps, www.ceps.eu/book/comparison-integration-programmes-eutrends-
and-weaknesses. Carrera S. e Wiesbrock A. (2009), Civic Integration of Third-Country Nationals.
Nationalism versus Europeanisation in the Common EU Immigration Policy, Enact, www.ceps.eu/book/civic-integration-third-country-nationals-nationalism-versuseuropeanisation-common-eu-immigrat.
Castles S. e Miller M.J. (1993), The Age of Migration: International Population
Movements in the Modern World, Basingstoke, Palgrave-Macmillan. Castles S. et al. (2003), Integration: Mapping the Field, UK, Home Office. Chamayou G. (2014), Teoria del drone. Principi filosofici del diritto di uccidere,
Roma, Derive-Approdi (ed. or. 2013). Colaianni N. (2007), Una “carta” post-costituzionale?, in «Stato, chiese e pluralismo
confessionale», www.statoechiese.it. – (2009), Alla ricerca di una politica del diritto sui rapporti con l’Islam (Carta dei
valori e Dichiarazione di intenti), in «Stato, chiese e pluralismo confessionale», www.statoechiese.it.
Cuttitta P. (2013), L’accordo di integrazione come caso di discriminazione istituzionale
in Italia, in Grasso M., a cura di, Razzismi, discriminazioni e confinamenti, Roma, Ediesse.
– (2014), Mandatory Integration Measures and Differential Inclusion: The Italian Case, in «Migration & Integration», DOI 10.1007/s12134-014-0410-0.
De Genova N. (2002), Migrant ‘illegality’ and deportability in everyday life, in
«Annual Review of Anthropology», 31, 419-447. – (2013), Spectacles of migrant ‘illegality’: the scene of exclusion, the obscene of
inclusion, in «Ethnic and Racial Studies», 36, 7, 1180-1198. Denaro R. (2014), La Costituzione spiegata ai migranti: un Muslim test tra le righe
della Carta dei valori, in Russo Spena e Carbone (a cura di), pp. 271-284. Eve M. e Perino M. (a cura di), 2014, Secondgen: Second Generations: Migration
Processes and Mechanisms of Integration of Foreigners and Italians, Rapporto finale, disponibile all’indirizzo http://secondgen.rs.unipmn.it/files/rapporti/completo.pdf.
Fassin D. (2014), Ripoliticizzare il mondo. Studi antropologici sulla vita, il corpo e la
morale, Verona, Ombre Corte. Ferrari S. (2008), La carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, in
Fondazione ISMU (a cura di), Tredicesimo rapporto sulle migrazioni: 2007, Milano, Franco Angeli.
Galantino M.R. e Giovannetti M. (2012), La stagione delle ordinanze sulla sicurezza. Il
punto di vista degli attori coinvolti, in «Studi sulla questione criminale», 2, pp. 52-82. Gallo S. (2011), Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall’Unità a
oggi, Roma-Bari, Laterza. Gargiulo E. (2008), L’inclusione esclusiva. Sociologia della cittadinanza sociale,
Milano, FrancoAngeli. – (2011a), Localizzazione dei diritti o localismo dell’appartenenza? Abbozzo di una
teoria della residenza, «SocietàMutamentoPolitica», 2, 3, pp. 241-261. – (2011b), Welfare locale o welfare localistico? La residenza anagrafica come
strumento di accesso ai, o di negazione dei, diritti sociali, paper presentato in occasione del Convegno ESPAnet Italia dal titolo Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa, (Milano, Politecnico di Milano).
– (2012a), L’“emergenza” dell’esclusione: populismo e controllo locale
dell’immigrazione nel contesto italiano, in «La rivista delle politiche sociali», 9, 1, pp. 89-116.
– (2012b), Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame sociale
nell’Accordo di integrazione, in «Rassegna italiana di sociologia», 52; 3, p. 497-523. – (2013), Le politiche di residenza in Italia: inclusione ed esclusione nelle nuove
cittadinanze locali, in Rossi E., Biondi Dal Monte F. e Vrenna M., La governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, Bologna, Il Mulino.
– (2014a), Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione degli immigrati tra
livello statale e livello locale, in «Diritto immigrazione e cittadinanza», n. 1, pp. 41-62. – (2014b), Residenza, anagrafe, cittadinanza: la migrazione interna come questione
socio-giuridica nell’Italia di oggi, in Colucci M. e Gallo S., Rapporto sulle migrazioni interne in Italia. Edizione 2014, Roma, Donzelli.
– (2014c), Dall’inclusione programmata alla selezione degli immigrati. Le visioni
dell’integrazione nei Documenti di programmazione del Governo italiano, in «Polis», 2, pp. 221-249.
– (2014d), Produzione di sicurezza a mezzo di insicurezza. Il controllo locale della
residenza tra retoriche securitarie e opacità decisionali, in «Studi sulla questione criminale», 1-2, pp. 45-63.
– (2014e), Una cittadinanza locale frammentata. La residenza tra conflitti e
stratificazione civica, paper presentato in occasione del Convegno ESPAnet Italia dal titolo Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni (Torino, Università di Torino).
– (2015), Dalla popolazione residente al popolo dei residenti: le ordinanze e la
costruzione dell’alterità, in «Rassegna italiana di sociologia», 56, 1, pp. 3-26. Giovannetti M. (2012), Le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana e
l’impatto sui territori, in Galdi A. e Pizzetti F., a cura di, I sindaci e la sicurezza urbana. Le ordinanze sindacali e i loro effetti, Roma, Donzelli, pp. 27-80.
Gjergji I. (2013), Circolari amministrative e immigrazione, Milano, FrancoAngeli. – (2014), Permesso di soggiorno a punti: l’integrazione secondo il gioco dell’oca,
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/31/permesso-di-soggiorno-a-punti-lintegrazione-secondo-il-gioco-delloca/931973/.
Goodman S.R. (2010), Integration Requirements for Integration's Sake? Identifying, Categorising and Comparing Civic Integration Policies, in «Journal of Ethnic and Migration Studies», 36, 5, pp.753-772.
Guariso A. (2012), a cura di, Senza distinzioni. Quattro anni di contrasto alle
discriminazioni nel Nord Italia, Associazione Avvocati per Niente Onlus, Milano. Joppke C. (2007), Beyond National Models: Civic Integration Policies for Immigrants
in Western Europe, in «West European Politics», 30, 1, pp. 1-22. Joppke C. e Morawska E. (2003), Towards Assimilation and Citizenship. Immigrants in
Liberal Nation-States, Basingstoke, Palgrave Macmillan. Jacobs D. e Rea A. (2007), The End of National Models? Integration Courses and
Citizenship Trajectories in Europe, in «International Journal of Multicultural Societies», 9, 2, pp. 264-283.
Kostakopoulou D. (2010), The Anatomy of Civic Integration, in «The Modern Law
Review», 73, 6, pp. 933-958. Lorenzetti A. (2009), Il difficile equilibrio fra diritti di libertà e diritto alla sicurezza,
in Lorenzetti A. e Rossi S., a cura di, Le ordinanze sindacali in materia di sicurezza pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti, Napoli, Jovene.
Lorey I. (2015), State of Insecurity. Government of the Precarious, London, Verso. Manfredi G. (2013), Poteri di ordinanza, legalità, “stato governativo”, in
«Amministrare», 43, 3, pp. 407-427. Mariani F. (2010), Iscrizione anagrafica e domiciliation: un breve confronto tra le
istanze di sicurezza italiane e le esigenze di coesione sociale francesi, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», 12, 1, pp. 78-97.
Morris L. (2003), Managing Contradiction: Civic Stratification and Migrants’ Rights,
in «International Migration Review», 37, 1, pp. 74-100. Paggi M. (2007), Il ricorso gerarchico contro l’Ordinanza del Sindaco di Cittadella
(PD), disponibile all’indirizzo: http://www.meltingpot.org/articolo11747.html. Pitch T. (2013), Contro il decoro. L’uso politico della pubblica decenza, Roma-Bari,
Laterza.
Priori A. (2014), Identità e credito: postculturalismo, politiche della sicurezza e welfare comunitario nel «modello italiano di integrazione», in Russo Spena e Carbone (a cura di), pp. 197-223.
Ricotta G. (2012), Sicurezza urbana e tolleranza zero, in «La Rivista delle Politiche
Sociali», 1, pp. 117-133. Rossi E., Biondi Dal Monte F. e Vrenna M., a cura di, (2013), La Governance
dell’Immigrazione. Diritti, politiche e competenze, Bologna, Il Mulino. Russo Spena M. e Carbone V. (2014), A misura di integrazione. L’Accordo ed il Piano
per l’integrazione nel sistema delle politiche migratorie, in Russo Spena e Carbone (a cura di), pp. 31-97.
Russo Spena M. e Carbone V., a cura di, (2014), Il dovere di integrarsi. Oltre il logos
multiculturalista, Roma, Armando. Sacchetto D. e Vianello F. (2013), Navigando a vista. Migranti nella crisi economica
tra lavoro e disoccupazione, Milano, Franco Angeli. Simone A. (2010), I corpi del reato. Sessualità e sicurezza nelle società del rischio,
Milano, Mimesis. Stradella E. (2010), Il potere di ordinanza dei sindaci e l’‘amministrazione
emergenziale, in «Rivista trimestrale di Scienza dell’Amministrazione», 3, pp. 101-121. Suvarierol S. (2012), Nation-freezing: Images of the Nation and the Migrant in
Citizenship Packages, in «Nations and Nationalism», 18, 2, pp. 210-229. Testai P. (2015), From the (e)migrant to the (im)migrant’: the Italian nation-state and
its migration rhetoric and history, in «Transnational Social Review», http://dx.doi.org/10.1080/21931674.2015.1016710.
Testore G. (2015), “In vogue” and “versatile” The spread of the civic integration
policies to Italy, Tesi di Dottorato in Scienza Politica E Relazioni Internazionali XXVI ciclo (Dipartimento Cultura Politica e Società, Università di Torino Unito – Faculté de Sciences Sociales et Politiques, Université Libre de Bruxelles).
Faculté de Sciences Sociales et Politiques Doctorat en Sciences politiques et sociale -
Université Libre de Bruxelles ULB (BELGIUM) Tondelli J. (2009), Sceriffi democratici. La metamorfosi della sinistra, Venezia,
Marsilio.
Usai A. (2011), Diritti sociali negati. Un’indagine sulle ordinanze comunali, in
Besozzi E., a cura di, Immigrazione e contesti locali, Milano, Vita e Pensiero, pp. 187-196.
Vivaldi E. (2013), Le politiche regionali di integrazione degli immigrati e la questione
dei centri di identificazione ed espulsione in Liguria, in Rossi E., Biondi Dal Monte F. e Vrenna M., a cura di, pp. 569-592.
Vrenna M. (2013) , Le regioni di fronte all’immigrazione. Linee di tendenza degli
ultimi anni, in Rossi E., Biondi Dal Monte F. e Vrenna M., a cura di, pp. 289-326. Zincone G. (2009), Il passaggio al primo piano, in Zincone G., a cura di,
Immigrazione: segnali di integrazione, Bologna, Il Mulino, pp. 7-67. Zorzella N. (2011), L’accordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo
cattivo?, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», 13, 4, pp. 59-71. – (2014), Il dovere di integrarsi secondo la legge, in Russo Spena e Carbone (a cura
di), pp. 121-144.