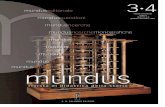Cronica di Venexia della Famiglia B e la costruzione di un’identità civica nel XIV secolo. Fra...
Transcript of Cronica di Venexia della Famiglia B e la costruzione di un’identità civica nel XIV secolo. Fra...
POLIDOROStudi offerti ad Antonio Carile
a cura di
GIORGIO VESPIGNANI
TOMO SECONDO
2013
FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDISULL’ALTO MEDIOEVO
SPOLETO
INDICE
GIORGIO VESPIGNANI, Una premessa: alle « opere ed aigiorni » .............................................................. pag. XI
I. TARDOANTICO CRISTIANO
CARMELO CRIMI, Nazianzenica XVII. Note al testo delcarme II,1,11 « de vita sua » ................................. » 3
MAR MARCOS, Portrait of a persecutor: the defeat and deathof Maximinus Daia in Christian Historiography ........... » 13
VALERIO NERI, L’imperatore e gli ebrei in età tardoantica:la testimonianza della storiografia pagana e cristiana ....... » 37
JUANA TORRES, Christiani contra paganos: la retórica dela persuasión en los discursos polémicos del s. IV ........... » 59
MARGARITA VALLEJO GIRVÉS, El patriarca Macedonio II yla aristocracia femenina de Constantinopla ................. » 79
RAMÓN TEJA, El milagro como medio de conversión del herejeen El prado espiritual de Juan Mosco ..................... » 105
II. IMMAGINI E MONUMENTI
JOSÉ M.A ÁLVAREZ MARTÍNEZ, El puente romano de Mérida:consideraciones generales sobre la fábrica y sus restaura-ciones ................................................................ » 119
INDICEVI
VINCENZO RUGGIERI, Quale Nicola? Un problematico cicloaffrescato su Gemile Adasi (Licia) ........................... pag. 133
EUGENIO RUSSO, Due colonnette del ciborio giustinianeo diS. Sofia di Costantinopoli? .................................... » 147
LETIZIA ERMINI PANI, Ancora sulle torri pentagonali: unfossile guida per le fortificazioni in Italia nell’età ditransizione ......................................................... » 153
SILVIA PASI †, L’incontro fra Abramo e Melchisedech nellapittura copta ....................................................... » 167
PAOLA PORTA, Immagini inedite di una pieve scomparsa delbolognese: S. Giovanni di Monte S. Giovanni .......... » 181
ROBERTA BUDRIESI, Da Ravenna a Mosca. Alcune osser-vazioni sui mosaici di Ravenna .............................. » 193
SILVANA CASARTELLI NOVELLI, I segni egizi ‘ka’ e ‘ba’; lamemoria ‘storiografica’ di Roma; la “solitudine dell’Occi-dente”. Qualche riflessione in tema (a passo di gambero) .. » 235
III. LA ROMÀNIA
TOMMASO GNOLI, Metrokomiai e comunità di villaggionell’Oriente antico e tardoantico .............................. » 273
MARTIN WALLRAFF, Santa Sofia – Sofia dell’imperatore.Note su Costantino e la sua nuova capitale sul Bosforo » 291
MARIA CRISTINA CARILE, Il Sacrum Palatium risplenden-te di luce: immagine e realtà del palazzo imperiale diCostantinopoli .................................................... » 305
GIORGIO VESPIGNANI, Appunti per lo studio della ideologiaimperiale nel secolo V. Il dittico di Halbertstadt .......... » 329
SALVATORE COSENTINO, La legislazione di Giustiniano suibanchieri e la carriera di Triboniano ......................... » 347
ENRICO MORINI, « Gratuitamente hanno ricevuto, gratuita-mente danno la guarigione ». I santi “anargiri” e Co-stantinopoli ......................................................... » 363
INDICE VII
ADRIANA PIGNANI, La Swfrosúnh e i giudizi della mente.Ancora in margine alla Catechesi – Epitafio per lamadre di Teodoro Studita ..................................... pag. 387
CONSTANTINOS G. PITSAKIS †, Megas kritès? ............... » 403
TIZIANA CREAZZO, Exempla di taxiv e meritocrazia a Bi-sanzio fra XI e XII secolo ..................................... » 409
MARIA DORA SPADARO, Giovanni l’Orfanotrofo dominusdella basileia del fratello? ...................................... » 425
GIOACCHINO STRANO, Ideologia, retorica e prassi di governonelle Muse di Alessio I ........................................ » 443
RENATA GENTILE MESSINA, Manuele Comneno e l’Italia(1157-1158) ........................................................ » 461
MARGHERITA ELENA POMERO, Santità militare e rivendica-zione della « basileia » nel Despotato di Tessalonica(prima metà del secolo XIII): nuove letture ................ » 493
JOHANNES KODER, Zur unterscheidung von Alter und neuerzeit aus Byzantinischer sicht .................................. » 507
CHRYSSA MALTEZOU, Il riuso di testi militari bizantini nelXVI secolo ......................................................... » 523
PEDRO BÁDENAS, De Bagdad a Toledo. Traducción y tran-sferencia del saber en la edad media ......................... » 537
MIGUEL CORTÉS ARRESE, La primera impresión de Con-stantinopla ......................................................... » 549
IV. LE ROMÀNIE: VENEZIA, GENOVA
EVANGELOS CHRYSOS, Venice, Byzantium and the Franks.A note on DAI, chapter 28, 37-43 .......................... » 565
SERGEJ P. KARPOV, Perché Tana? Motivazioni ufficiali perproteggere e mantenere un lontanissimo insediamento ve-neziano ............................................................. » 569
SANDRA ORIGONE, Il pregio e la rarità dell’esotismo: legemme d’Oriente e il mondo mercantile .................... » 577
M. MARCELLA FERRACCIOLI - GIANFRANCO GIRAUDO,Un documento veneziano ducentesco chiose secentesche ilmito perenne ....................................................... » 597
INDICEVIII
ANDREA NANETTI, Modern Greek national identity and la-te Byzantium: new evidence for the ‘Frankish’ tower onthe Acropolis of Athens as a case study .................... pag. 611
V. CAUCASO, IRAN, EUROASIA
GHERARDO GNOLI †, Aspetti antroposofici dello zoroastri-smo .................................................................. » 629
ANTONIO PANAINO, Il Basileúv stella dei Magi ed altrenugae bizantino-iraniche ....................................... » 651
ANDREA GARIBOLDI, Un solido bizantino da Pendzikent(Tagikistan) ........................................................ » 665
ANDREA PIRAS, Fromo Kesaro. Echi del prestigio di Bisan-zio in Asia centrale .............................................. » 671
PAOLO OGNIBENE, La battaglia sul fiume Kalka ............. » 691
RUSTAM SHUKUROV, Churches in the citadels of Ispir andBayburt: an evidence of ‘Harem Christianity’? .......... » 713
ISABELLE AUGÉ, Le catholicos arménien au regard d’un en-semble documentaire de la première moitié du XIVe siè-cle .................................................................... » 725
GAGA SHURGAIA, Antimoz d’Iberia (Antim Ivireanul) e lacultura letteraria dell’Oriente cristiano tra la fine delXVII e l’inizio del XVIII secolo ............................ » 741
VI. MEDIOEVO OCCIDENTALE
ROBERTO BERNACCHIA, La Bulgaria del basso Cesano tratarda antichità e alto medioevo ................................ » 773
FRANCESCA BOCCHI, Mutamenti e ricomposizione nelle cittàsarde ................................................................. » 797
MARIO MARCENARO, La cristianizzazione della maritimaed i metropliti milanesi a Genova ............................ » 811
LUIGI CANETTI, Dai Templari a Bisanzio o la falsa preisto-ria della Sindone di Torino .................................... » 827
RAFFAELE SAVIGNI, L’Impero carolingio e i popoli del Nord » 849
INDICE IX
ANNA FALCIONI, La crociata di Sigismondo Pandolfo Mala-testi in Morea dal carteggio sforzesco ........................ pag. 871
MAURO PERANI, La stele funeraria di Rivqah da Verona equella di Yeh
˙i’el Otolengo (1517-1567) da Lodi: un
poema ebraico perduto e il più antico epitaffio di un Ot-tolenghi ............................................................. » 893
VII. BIBLIOTECONOMIA, CODICOLOGIA, CRONACHISTICA
DONATELLA RESTANI, Ricerche sulle immagini musicali nel-le prime edizioni del Commento al sogno di Scipio-ne di Macrobio ................................................... » 915
ANTONELLA PARMEGGIANI, La Cronica di Venexia dellaFamiglia B e la costruzione di un’identità civica nelXIV secolo. Fra contaminazioni, stereotipi letterari edoriginalità stilistica ............................................... » 929
PAOLA DEGNI, Il ms. 126 della istituzione Biblioteca Clas-sense: uno Zibaldone del XV secolo ......................... » 945
LORENZO BALDACCHINI, Divagazioni bibliografiche su unviaggio da Venezia a Gerusalemme ......................... » 959
JOSÉ M. FLORISTÁN, Privilegio de nobleza Otorgado a Ma-nuel Accidas por Felipe II de España (4.VI.1574) ...... » 965
VIII. STORIA, STORIOGRAFIA, MEMORIA STORICA
ELEONORA CAVALLINI, La ‘spoglia immemore’ dell’eroe: daAchille a Garibaldi .............................................. » 977
NICOLA CUSUMANO, La morale della storia. Osservazionisul terzo libro di Diodoro ...................................... » 987
ENRICO MENESTÒ, « Rileggere e riscrivere il Lanzoni ». Se-conda puntata: la Colonia Iulia Fida Tuder (Todi) ..... » 1005
ALESSANDRO IANNUCCI, I letterati e il management. Ar-chetipi, etimologie e tradimenti ................................ » 1047
ANTONELLA PARMEGGIANI
LA CRONICA DI VENEXIA DELLA FAMIGLIA BE LA COSTRUZIONE DI UN’IDENTITÀ CIVICA
NEL XIV SECOLO.
FRA CONTAMINAZIONI, STEREOTIPI LETTERARIED ORIGINALITÀ STILISTICA
Secondo la classificazione delle cronache veneziane, propostadal Carile nel 1969 1, la famiglia B è costituita dalla tradizione diun testo, redatto in volgare veneziano, noto come Cronaca diEnrico Dandolo, tuttavia solo tre testimoni del sec. XVII, derivantida un più antico codice contariniano, ora perduto, citano EnricoDandolo nell’epigrafe, mentre il testimone più antico del 1362 ca.(H85inf) 2 lascia uno spazio bianco, colmato da mano diversa conN (nomen) nel luogo di Henrico Dandolo. Questa omissione ha per-suaso l’Editore della Cronica di Venexia detta di Enrico Dandolo aconsiderare anonimo il cronista, glissando sul problema, tutt’altroche marginale, dell’identificazione dell’Autore, il quale, comun-
1. A. CARILE, La cronachistica veneziana (secoli XIII-XVI) di fronte alla spartizione dellaRomania nel 1204, con una appendice di P. R.-J. Loenertz, Firenze, 1969. In questo la-voro, condotto con metodo critico filologico, il Carile ha proposto la classificazione del-le cronache veneziane in cinque famiglie, privilegiando l’analisi dell’episodio della IVcrociata, ponendo le basi imprescindibili per gli studi futuri.
2. Ibid., pp. 53-54. Le sigle dei codici sono quelle riferite dal Carile nel 1969, percui: H85inf = Cod. Ambr. H85inf. Questo testimone costituisce il manoscritto base (A)nella edizione della Cronica di Venexia del 2010, dove « lo stemma codicum non deve in-tendersi in senso filologico, ma storiografico e contenutistico » (sic!), cfr. Cronica di Ve-nexia detta di Enrico Dandolo. Origini 1362, a cura di R. PESCE, Venezia, 2010, p. XXXI.In realtà il nome dell’autore compare nelle epigrafi di quattro testimoni – di cui un co-dex descriptus – che fanno capo ad un codice perduto, appartenuto a Pietro Contarini,nel corso del XV secolo, e che, prima del rinvenimento degli altri testimoni da partedel Carile, si riteneva costituissero l’intera tradizione manoscritta di B. Si tratta dei codi-ci Ci 3423 (a. 1636), della sua copia Ci 3424, di M 102 (a. 1660) e di F 6580 (sec.XVII), che individuano il ramo recenziore e rielaborato della Cronica.
ANTONELLA PARMEGGIANI930
que, riferisce nel proemio le modalità di stesura della sua opera,affermando di avere consultato molte fonti, sia scritte che orali, edi avere proceduto ad una sorta di compendio, secondo un mo-dello metodologico, compositivo e retorico, che anche il filonevolgare di A – di poco anteriore a B – ci descrive 3:
(...) extraendo questa cronica de più croniche <et> istorie antige scripte per nostri boniet veraxi antixi, et aldidi eciamdio multi in senetute narar di quelli homini degni di fe-de, ho facto como colui che vol far hedifficio che primeramente à pariado li menbri diquello, possa lo mete adinsenbre 4.
La cronaca come “genere” costituisce il risultato dell’incontrodi scritture diverse come si può desumere dalla comparazione deitesti di cronache cittadine della prima metà del XIV secolo daMilano a Firenze 5, e si accompagna con l’ossequioso rispettoverso il prestigio dell’autore e dell’opera chiamati in causa. Nondi rado si tratta di citazioni di fonti scritte ma « non c’è corrispon-denza necessaria né immediata tra quanto si ricava dal testo di unautore e la frequenza dell’apparizione del suo nome; in certi casici troviamo di fronte a lunghi brani mutuati da una fonte di cui sitace l’identità, mentre in altre circostanze si ammette senza pudoriil debito contratto con un autore di cui si citano poche paro-le » 6. I moduli espressivi della prima cultura volgare sono spessomutuati dal linguaggio amministrativo, oltre che dallo stile del lin-guaggio parlato 7. I cronisti attingono il materiale anche da fonti
3. La versione latina di A fu completata tra il 1343 ed il 1350; vd., Cronaca « A latina ».Cronaca veneziana del 1343», ed. di C. NEGRI DI MONTENEGRO, Spoleto, 2004 (« Quadernidella Rivista di Bizantinistica », II). La traduzione in volgare veneziano di A latina risale al1350 ca. L’edizione di A volgare è in preparazione a cura di Giorgio Vespignani; per i braniche qui vengono citati si fa riferimento all’edizione parziale del testo in CARILE, La cronachisi-tica cit. (nota 1), p. 233: chomo io è trovado e lecto in le istorie antighe et imparado et aldido dali no-stri maçor et è tracto et tolto molte chosse da algune croniche che io è trovado.
4. Cronica di Venexia cit. (nota 2), p. 35. G. SPANI, Narrare, copiare, leggere la cronaca toscana nel Trecento, Indiana University,
2007, pp. 12-13.6. F. RANGONE, Giovanni Villani e i suoi continuatori. La scrittura delle cronache a Firen-
ze nel Trecento, Roma, 1998, p. 4.7. Ibid., p. 120. Soprattutto in area emiliano-romagnola tra il XIV e il XV secolo è
considerevole il numero di notai cronisti che caratterizzano i loro scritti sulla base dell’espe-rienza professionale maturata a livello amministrativo e legale. Si veda A. BARTOLI LANGELI,La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV; forme, organizzazione, personale, in Cultu-
LA CRONICA DI VENEXIA DELLA FAMIGLIA B 931
orali, a confermare la credibilità delle quali si invocano elementistrettamente dipendenti dal peso sociale degli informatori: così co-me il nostro Autore anche Giovanni Villani, nella sua opera su Fi-renze, riporta alcune notizie tramandate da antichi nostri cittadini,che i loro padri furono presenti a queste cose, e ne feciono loro ricordo ememoria 8. Su questa base si consolida il mito del cronista sincro-no, cioè di quell’autore che, essendo contemporaneo – se non ad-dirittura presente – alle vicende che narra, dovrebbe godere digrande autorevolezza, secondo un presupposto radicato nella cul-tura storiografica occidentale 9, poiché l’esperienza vissuta in pri-ma persona confluisce una maggiore credibilità. La formula dellecose correnti a’ tempi suoi, scelta da Dino Compagni 10 tra il 1310 edil 1312, individua un arco cronologico lungo il quale si snoda unanarrazione fondata sull’uso di fonti e corroborata dalla testimo-nianza diretta degli eventi descritti. Così il nostro Autore: et io cheal mio tempo ciò vidi, testemoniança veraxe de ciò posso mostrar 11.
Per il ramo più antico della tradizione testuale 12, la narrazionedei fatti si svolge dalle mitiche origini troiane di Venezia sino al1362. Almeno per la parte fino al 1342, l’Autore contamina da piùfiloni cronachistici, tra i quali sicuramente A 13. Per quel che ri-guarda il proemio la Cronica dimostra maggiore affinità con A vol-gare, piuttosto che con le famiglie di cronache latine, nelle qualil’incipit risulta più essenziale; tuttavia non sembra rivelare una di-retta dipendenza testuale da A volgare, almeno rispetto alla tradi-zione che a noi è giunta: nella Cronica compare una maggiore ric-
re et idéologie dans la genèse de l’Etat moderne, Roma, 1985 (Collection de l’Ecole Française deRome, 82), pp. 35-55; ID., A proposito di storia del notariato italiano: Appunti sull’istituto, il ceto el’ideologia notarile, in Il pensiero Politico, X/1 (1977), pp. 110-1017 ; sulla cronachistica notarilea Bologna cfr. G. ORTALLI, Notariato e storiografia in Bologna nei secoli XIII-XVI, in Notariatomedievale Bolognese, Roma, 1977, pp. 154-189. Nelle cronache del XIV secolo è possibile ri-conoscere elementi che avvicinano gli scritti dei notai ai libri di ricordanze; vd. M. ZABIA,Cronache e cronisti nelle città dell’Emilia Romagna, in « Ricerche storiche » XXIV, (1994), pp.174-187 e G. ARNALDI, Il notaio-cronista e le cronache cittadine in Italia, in La storia del diritto nelquadro delle scienze storiche, Firenze, 1966 (Atti del I Congresso internazionale della società ita-liana di storia del diritto), pp. 293-309.
8. GIOVANNI VILLANI, Nuova Cronica, a cura di G. PORTA, Parma, 1991, VII, 2.9. RANGONE, Giovanni Villani cit. (nota 5), p. 2.10. Ibid., pp. 6-7.11. Cronaca di Venexia, cit. (nota 2), p. 4.12. CARILE, La cronachistica cit. (nota 1), pp. 53-54.13. Ibid., p. 45.
ANTONELLA PARMEGGIANI932
chezza stilistica e letteraria, una personale ed evidente volontà dirielaborazione dei testi consultati. Valga ad esempio il brano quisopra riportato, dove l’Autore apporta innovazioni significative altesto, introducendo il paragone dell’edificio, mentre aderisce adun topos letterario consolidato quando adotta l’invocazione a Dionel proemio per esporre il suo proposito narrativo 14.
Un elemento di affinità tra la famiglia A volgare e la famiglia Bconsiste nell’uso letterario della narrazione in prima persona, se-condo un cliché adottato anche dai cronisti cittadini di area nonvenetica nel XIV secolo, che abbandonano di frequente lo stileimpersonale della narrazione per intromettervisi con la loro “pa-rola” e con la loro temporalità, poiché « ci troviamo, con la scrit-tura cronistica, di fronte ad una forma di comunicazione che tra-duce verbalmente quella coesistenza di passato e presente che per-corre tutta la sensibilità medievale » 15.
Il lavoro di redazione dei cronisti veneziani, che si accingono alracconto della storia di Venezia e che ci viene comunicato in sintesisia nella Cronica detta di Enrico Dandolo che in A volgare, consistenel procedere sulla base di alcuni stereotipi: narrazione delle origini,descrizione delle cause e delle modalità che hanno portato alla fonda-zione della città, ripartizione cronologica basata sull’avvicendamentodei dogadi, secondo un paradigma narrativo tutt’altro che innovativoche è riportato anche nelle cronache latine quali la Chronica brevis diAndrea Dandolo 16 e la Venetiarum Historia 17 e si rifà, presumibil-
14. Et Dio omnipotente, da cui tuti doni discende et sença lui alcona cossa non si pò far, sìme dia gracia che segondo l’intelecto mio quella possa dur ad effecto... cfr. Cronica di Venexiacit. (nota 2), p. 3. Sulle caratteristiche dell’incipit cfr. E. R. CURTIUS, La littérature euro-péenne et le Moyen Age latin, tr. fr., Paris, 1956, p. 158; ed anche B. GUENÈE, L’histoire en-tre l’éloquence et la science, Quelques remarques sur le prologue de Guillaume de Malmesbury àses Gesta Regum Anglorum, in Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, CXXVI (1982), pp.357-360.
15. RANGONE, Giovanni Villani cit. (nota 5), p. 179.16. Andreae Danduli ducis Venetiarum Chronica brevis: a.a. 46-1342, ed. a cura di E. PA-
STORELLO, Bologna, 1942 (Rerum Italicarum Scriptores, XII/1) pp. 331-373. Il doge AndreaDandolo racconta la storia di Venezia fino all’anno 1342.
17. Venetiarum Historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani filio adiudicata, a cura di R. CESSI
e F. BENNATO, Venezia 1964 (Monumenti Storici pubblicati dalla Deputazione di Storia Patriaper le Venezie, n.s. XVIII). La data di redazione di questa cronaca è da ipotizzarsi tra il1358 ed il 1360.
LA CRONICA DI VENEXIA DELLA FAMIGLIA B 933
mente, ad un comune archetipo circolante a Venezia verso la finedel XIII secolo 18.
Nel suo complesso lavoro compositivo, l’Autore, per alcuniaspetti, sembra attingere direttamente dalla Chronica brevis di An-drea Dandolo, che pur nella sintetica narrazione dei fatti, annun-ciata nel titolo, riferisce, in alcuni casi, maggiori dati rispetto allealtre cronache veneziane, ma bisogna accreditare l’Autore quandoafferma che la stesura dell’opera avviene dopo avere vagliato mol-te fonti ed avere proceduto, con metodo critico, ad una scelta trale versioni proposte nei diversi testi.
All’ampio lavoro di studio e di confronto delle fonti scritte,per addivenire alla composizione della Cronica, si affianca il lavorodi traduzione, come lo stesso autore ci comunica, con compiaciu-ta enfasi retorica:
(...) in per quelli che non sença grande fadiga tute quelle cosse che per mi de qui inavanti si scriverà ho traslatade et l’una con l’altra cronica molto aprovade 19.
Le tracce di una traduzione (cosse... traslatade) possono essereintuite considerando la persistenza di alcuni termini latini, che civengono tramandati soprattutto dal manoscritto ambrosianoH85inf, e che, solo in alcuni casi, sono effettivamente “tradotti”nel volgare 20 veneziano della lingua parlata, come testimoniano levarianti riferite in manoscritti più tardi, rivelate dalla collazionecon il testimone M89 21, del XV secolo.
18. A. CARILE, Aspetti della cronachistica veneziana nel XIII-XIV secolo, in La storiografiaveneziana fino al XVI secolo. Aspetti e problemi, a cura di A. PERTUSI, Firenze, 1970, p. 87.
19. Cronica di Venexia cit. (nota 2), p. 5.20. La lingua volgare corrispondeva ad una serie di comuni esigenze della società ci-
vile, caratterizzata in modo preponderante dal ceto emergente dei mercanti già sul finiredel secolo XIII, vd. A. CASTELLANI, La prosa italiana delle origini. Testi toscani di caratterepratico, vol. I, Bologna, 1982. A contribuire al successo e al prestigio del volgare, nonchéalla sua rapida espansione interviene la fortuna del poema dantesco e la sua ricezione inarea emiliano-veneta in seguito all’esilio del poeta, come testimoniano i più antichi co-dici della commedia databili o datati intorno alla metà del Trecento; M. BOSCHI ROTI-ROTI, Codicologia trecentesca della Commedia: entro e oltre l’antica vulgata, Roma 2004; e P.TROVATO, Nuove prospettive sulla tradizione della “Commedia”: una guida filologico-lingusisticaal poema dantesco, Firenze, 2007.
21. M89 = Cod. Marc. It. VII, 89 (8381). Il codice è descritto in CARILE, La cronachi-stica cit. (nota 1), p. 57; P. ZORZANELLO, Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia,LXXXI, Firenze, 1956, 29; F. THIRIET, Les chroniques vénitiennes de la Marcienne et leur im-
ANTONELLA PARMEGGIANI934
Il manoscritto H85inf riferisce ivi 22 laddove M89 riporta in lo ditoluogo. Altri esempi sono costituiti da: senectute] vechieza; venetici] veni-ziani; epistole] letre; essendo orta] nasé; lecticia magna] grandissima alegrezae festa. Inoltre H85inf riporta in molti casi la variante ecclesia (rara-mente eglexia) che è, come appare evidente, lessema latino che defi-nisce la chiesa e che, se non ci induce a ritenere probabile una acqui-sizione diretta del termine da una fonte latina, almeno ci indicaquanto l’autore usasse consapevolmente la lingua culta, letteraria; in-fatti, per definire la chiesa nei documenti notarili veneziani si hannoattestazioni del termine clesia o glesia già a partire dalla fine del Due-cento 23; ed anche il testimone più antico della tradizione di A volga-re, in cui l’anonimo estensore si compiace di scrivere nella lingua par-lata, considerando le tre parte del mondo tute chosse volgarmente scrite 24, ri-porta gliexia 25, così come riporta glexia M89, il cui testo viene adatta-to alle esigenze lessicali del XV secolo.
Alcuni termini che appartengono al lessico latino medievale eche compaiono in tutti i testimoni, permanendo invariati pur nel-la vasta diacronia della tradizone testuale di B, sono costituiti dagliavverbi personaliter (personalmente) ed annuatim (annualmente), edil sostantivo hoste per definire l’esercito. Più che della lingua latinasembra indicare la permanenza del lascito francese – la lingua auli-ca del XIII-XIV secolo usata anche dai primi cronisti veneziani 26
portance pour l’histoire de la Romanie gréco-vénitienne, Roma, 1954 (école Française de Ro-me, Mélanges d’Archéologie et d’Histoire, LXVI), p. 257.
22. Cronica di Venexia cit. (nota 2), p. 16.23. A. STUSSI, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, 1965, p. 219.24. A volgare (ed. Carile), p. 234, 18-19.25. Ibid., p. 236, 36 e 38.26. In particolare si fa riferimento a Martino da Canal che compone le Estoires de
Venise, a partire dal 1267, che diventano un modello storiografico. A questo proposito siveda la più recente edizione del testo: MARTINO DA CANAL, Les estoires de Venise. Crona-ca veneziana in lingua francese dalle origini al 1275, ed. da A. LIMENTANI, Firenze, 1973. Sirimanda, inoltre, a G. FASOLI, La Cronique des Veniciens di Martino da Canale, in StudiMedievali, Ser. 3a, II (1961). A. PERTUSI, Maistre Martino da Canal interprete cortese della cro-ciate e dell’ambiente veneziano nel secolo XIII, in Venezia dalla I Crociata alla conquista di Co-stantinopoli del 1204, Firenze, 1966, 103-135. A. LIMENTANI, Cinque note su Martino da Ca-nal, in Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, CXXIV (1965-1966), pp. 257-281. ID., Martino da Canal, la basilica di San Marco e le arti figurative, in Mélanges offerts àRené Crozet, Poitiers, 1966, pp. 1177-1190. G. CRACCO, Il pensiero storico di fronte ai pro-blemi del comune veneziano, in La storiografia veneziana fino al XVI secolo, Aspetti e problemi,a cura di A. PERTUSI, Firenze, 1970, pp. 50-56.
LA CRONICA DI VENEXIA DELLA FAMIGLIA B 935
– l’uso di aida (aiuto), se si considera che nei testi notarili vene-ziani già a partire dal XIII secolo compare aiutorio 27.
La tradizione di B ci restituisce un testo scritto da « un conser-vatore, lo si direbbe portavoce disincantato di una classe di aristo-cratici amministrativi » 28; sicuramente si tratta di una figura chepotremmo definire erudito, anche se in una accezione tutta voltaad esaltare il potere corroborante della civiltà mercantile venezia-na: dinamica, laboriosa, pacifica 29. L’ erudizione così come la ca-pacità retorica, è strumentale, serve, cioè, ad esaltare la funzionestorica della Repubblica, vocata a rappresentare l’esempio etico epolitico nel mondo allora conosciuto poiché
la paxe et tra<n>quilitade per essa più fa ad sua exaltacion et acressimento cha par al-guna altra <zitade> del mundo che si sepia 30
In questa ottica il racconto della storia di Venezia diviene emble-matico e l’Autore sembra essere particolarmente cosciente della pecu-liarità della sua funzione di esegeta, che estremizza nel momento incui confessa di avere bruciato tutte le cronache che ha consultato
a ciò che quele, vegnando ad man de’ letori fastidio, overo incredulitade, non produsese 31
Probabilmente il rogo dei fogli sgraditi costituisce un parados-so letterario, una sorta di adynaton da sommare ai non rari ele-
27. STUSSI, Testi veneziani cit. (nota 23), p. 186.28. CARILE, La cronachistica cit. (nota 1), p. 45.29. « Ricerche recenti hanno individuato le due correnti che si contendevano in Ve-
nezia il potere: quella dei “territoriali”, portati alla salvaguardia di interessi locali, cittadi-ni, a un miglior collegamento con l’economia e con la politica di terraferma; e quelladegli “orientali”, cioè dei rappresentanti delle grandi compagnie operanti in Oriente,che ai loro traffici tutto intendevano subordinare. L’atteggiamento di Enrico Dandolosulla questione dalmata indica che il cronista era legato alla corrente e alla mentalità“mercantile”, quella che identificava la fortuna dello stato con la fortuna dei traffici »,così riferisce S. COLLODO, Temi e caratteri della cronachistica veneziana in volgare del Tre-Quattrocento (Enrico Dandolo), in Studi Veneziani, IX (1967), pp. 143-144. Si veda a que-sto proposito G. SPANI, Narrare, copiare, leggere la cronaca toscana nel Trecento, Indiana Uni-versity, 2007, p. 12, in cui si dimostra il legame tra le cronache cittadine ed i mercantimedievali e come i “mercanti cronisti” determinino una nuova concezione del modellocronachistico caratterizzato da una peculiare brevitas testuale, tanto da arrivare a sostenerel’origine mercantile delle cronache cittadine compendiate.
30. Cronica di Venexia, cit. (nota 2), p. 4; mia l’integrazione <zitade>.31. Ibid., 5.
ANTONELLA PARMEGGIANI936
menti di originalità stilistica dell’Autore rispetto ai cronisti suoipredecessori – estensori di cronache sia il latino che in volgare –,che vengono palesati non solo dalla incisiva e personale narrazionedei fatti, ma anche dall’eccellenza della sua cultura letteraria.L’Autore sottolinea la sua dimestichezza con il francese, o, quan-tomeno, ci confida di conoscere la Vita di Attila in francesco 32,puntualizza di sapersi orientare non solo di fronte alle gesta epichedel testo dell’Eneide 33, ma anche di fronte al commento dantescodi Jacopo della Lana 34 ed infine stupisce con la promessa di narra-re le vicende della traslazione del corpo di San Marco – compiutada dui nobelli et grandi mercadanti l’uno nomado Tribuno di Torcelo etl’altro Rustico Trondonico di Mathamauco – non in prosa, bensì in ri-ma per altro libello 35. Unico tra i cronisti veneziani, ma omologoad altri non veneziani che adottarono l’uso dell’opus geminum nellecronache cittadine – rilevato soprattutto per il tardo medioevo –per cui alla cronaca in prosa veniva associato un componimentoin rima poiché la poesia, vincolata alle regole ed alle forme pro-prie, godeva di un maggiore prestigio rispetto alla prosa 36.
Una personalità complessa e poliedrica, dunque, quella del no-stro Autore, che si rivela persino boriosa nello stile letterario, ma
32. Cronica di Venexia cit. (nota 2), p. 7. A questo proposito si veda A. CARILE, Una“Vita di Attila” a Venezia nel XV secolo, in Venezia e Ungheria nel Rinascimento, a cura diV. BRANCA, Firenze, 1973, p. 371. Si tratta, in realtà di un testo non in francese bensì infranco-veneto, come ci viene tramandato in un codice della prima metà del XIV secolo:B.M.V., Cod. Marc. Lat. X, 96 (3530). Questo testo servì da base per la traduzione in la-tino e questa, a sua volta, venne tradotta in volgare nel 1421. L’Autore della Cronicadetta di Enrico Dandolo cita alcune vicende della vita di Attila nel suo testo, fornendouna sorta di suggerimento compositivo per la cronachistica quattrocentesca, che intro-durrà poi l’intera vita di Attila nel corpo delle cronache; vd. CARILE, Aspetti della Crona-chistica cit. (nota 18), pp. 104-105. Utile il confronto con S. COLLODO, Attila e le origini diVenezia nella cultura veneta tardomedievale, in Atti Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti.Cl. Scienze Morali, Lettere e Arti, CXXXI (1972-1973), pp. 531-567. Sulla teoria delleorigini di Venezia legate ad Attila e le implicazioni nelle Cronache, cfr. A. CARILE, Leorigini di Venezia nella tradizione storiografica, in Storia della cultura veneta, I, 1, Dalle originial Trecento, Vicenza 1976, pp. 152-157.
33. Cronica di Venexia, cit. (nota 2), p. 8: Adonca gli Troiani vegnudi per la destrucion de-la soa patria una gran parte in queste contrade, intro li qual fu el dux Enea et altri, come tractaVirgilio, andò a Roma.
34. Ibid., pp. 99-100.35. Ibid., p. 32.36. Cfr. ad es. Eulistea di Bonifacio da Verona analizzata da P. G. SCHMIDT, Colores
rhetorici nelle cronache cittadine, in Le cronache medievali di Milano, a cura di P. CHIESA, Mi-lano, 2001.
LA CRONICA DI VENEXIA DELLA FAMIGLIA B 937
pervicacemente ancorata alla tradizione nell’espressione della suaideologica. In questo senso non eccepisce rispetto ai cronisti chelo hanno preceduto, adottando nella sua Cronica il topos delle ori-gini troiane di Venezia, così come è suggerito dal cronista Marcogià a partire dal 1292 37. Il primato di Venezia è sottolineato nelmomento in cui la Repubblica risulta fondata dai troiani, dopo ladistruzione di Troia, nell’anno dalla creazione del mondo 4206:quasi mezzo millennio prima della fondazione di Roma 38.
Cronica di Ve-nexia(ed. Pesce)
Piero Giustinian(ed. Carile)
A latina(ed. Negri diMontenegro)
Venetiarum Hi-storia(ed. Cessi –Bennato)
A. Dandolo,Brevis(ed. Pastorello)
A volgare(ed. Carile)
5-6Segundo comonara et dise glimaor nostri anti-gi, el è stado dueVenexie: la pri-ma si fo quelladela qual si ra-giona in le ysto-rie antige, delaquale fu so prin-cipio Antenor, etquesto fu pocoda poy la destru-cion dela granTroia, la qualdestrucion fupoy la creaciondel mundo peranni quatromiliaduciento et sei.
253, 3-8Predecessorumnostrorum auc-toritate testanteequidem anteconstitutionempresentis urbisVeneciarum, al-tera Venecia fuitde qua stilloystoriographomemoriam facitantiquitas, et abAnthenore, sub-verssionis Troietemporibus pri-mordium descri-bitur assumpsisse.Troie autemcaptivitatemMMMMCCVIannis a creationemundi decurssisauctores veteresfuisse compo-nunt.
33, 1-6Predecessorumnostrorum auc-toritate testante,equidem anteconstitutionemurbis Venecia-rum presentis, al-tera Venetia fuit,de qua stilo hi-storiografo me-moria facit anti-quitas, et ab An-thenore, subver-sionis Troie tem-poribus, primor-dium describiturassumpsisse.Troie autemcaptivitatemIIIIM.CCVI an-nis a creationemundi decursisauctores veteresfuisse compo-nunt.
7, 1-5Iuxta nostrorumantiquorum nar-rationes duas re-peritus civitatesVenecie nuncu-patas, de quarumprima in ystoriisagitur antiquitatisfundamentum etprincipium abAnthenore as-sumpsisse tempo-re destructionismagne urbistroiane, currenti-bus anni a mundiconstitutioneMMMMXX.
351, 13-14Maiorum traditantiquitas Vene-tias duas fuisse:prima illa que invetustis ystorijscontinetur, que,tempore destruc-tionis magneTroie, ab Anthe-nore inicium ha-buit
235, 23-27Segondo che disee nara li nostrimaçori antigi elfo do Veniexie:la prima si foquella dela qualse raxona in leantighe istorie, laqual so principofo de Antenor equesto fo in lotenpo dela de-struçion delagrande Troia, laqual destruçionfo in IIIIMCCVIdela creaçion delmundo infinaquel tenpo.
Soltanto dopo la fondazione della prima Venezia – cioè della pro-vincia – i troiani sembrano accorgersi del resto del Mediterraneo e
37. CARILE, La cronachistica veneziana cit. (nota 1), pp. 90-91 e 121-126.38. La Venetiarum Historia riporta MMMMXX, ma si tratta evidentemente di una
svista del copista che ha trascritto solo parzialmente le cifre romane.
ANTONELLA PARMEGGIANI938
cominciano a colonizzare altri territori, oltre a dedicarsi compiuta-mente alla costruzione delle città di area venetica.
Cronica di Venexia(ed. Pesce)
Piero Giustinian(ed. Carile)
A latina(ed. Negri di Mon-tenegro)
Venetiarum Historia(ed. Cessi – Bennato)
A volgare(ed. Carile)
8 Adonca gli Troia-ni, vegnudi per ladestrucion dela soapatria una gran partein queste contrade,intro li qual fu eldux Enea et altri,come tracta Virgilio,andò a Roma, et al-tri in Cartagine, al’ixola de Sardigna,altri andò in Ceciliaet in tute queste par-te hedeficono molteet molte altre citade;dei quali el re Ante-nor he<di>ficò Pa-tavia (ad quela dapoy dicta Padua), deiquali molti nobelissi-mi homeni troiani siveneno nele parte deTrivixana. Et hedifi-cono Concordia, Al-tilia, Aquilegia, Ho-vederço, Belun, Am-sulo, Arre et moltealtre citade et luogi.
254, 43-46 Ad maio-rem etiam et plenio-rem noticiam dicen-dorum, inserendumesse proposui quod,destrutionis magneTroie temporibus,ipsa deletta insurexe-rit, causa per quamRomana urbs, quecaput est omnium,per troianos exulesfacta fuit vel promo-ta per Eneam255, 63 Et pluresnobiles troiani navi-bus, ut predixi, adpartes Hesperie tran-sf<r>etarunt, quo-rum aliqui in Sici-lia<m> alii in Carta-ginem nonnulli inSardiniam sunt pro-fecti. De quorumnumero dominumEneam fuisse narra-tur, qui postremo inmare adriaticum seuVeneciarum cul-phum adivit (...) Ci-vitas vero Altilie, cuihodie est nomenAntinum, a predictisnobilibus sumpssitexordium et idem deOpitergina civitate,Aquilegia, Concordiaet Asylo nec nonpluribus aliis civitati-bus atque castris ve-ridice dici potest.
35, 41-56 Ad maio-rem etiam et plenio-rem notitiam dicen-dorum, inserendumesse proposui quod,desctructionis Troietemporibus, pluresnobiles Troiani, na-vibus, ad partesExperie transfreta-runt, quorum aliquiin Sicilia<m>, qui-dam in paribus ubiRomana civitatis estfondata, nonnulli inSardineam et alii inCarthaginem suntprofecti; de quorumnumero Eneas fuissenarratur, qui postre-mo in mare Adriati-cum, seu culphumVeneciarum, adivit(...) nam dictus An-thenor Pataviam, cuihodie dicitur Padua,sua magnanimitateconstruxit (...) civitasvero Altilie, cui no-men ets hodie Alti-num, a predictis no-bilibus sumpsit exor-dium. Et idem deOpitergina civitate,Aquilegia, Concordiaet Asilo, nec non depluribus aliis civitati-bus atque castris, ve-ridici dici potest.
13, 16-20 (...) etplures nobiles troianinavibus ad partesHesperie trasfreta-runt, quorum aliqui,ut est dictum, in Si-ciliam, alii in Carta-ginem, alii in mareAdriaticum, nec bonnonulli in Sardiniamsunt proffecti.13, 7-8 Et primiti-vam Veneciam inha-bitavit ille troianusAnthenor, nec nonPataviam sive Pa-duam civitatem simi-liter hedificavit.13, 20-23 Civitas ve-ro Altilie, cui hodieest nomen Altinum,a predictis troianisnobilibus sumpsitexordium, et idemde oppitergino ca-stro, Aquilegia, Con-cordia et Asylo atqueetiam de pluribusaliis civitatibus et ca-stris veridice dici po-test13, 7-8 Et primiti-vam Veneciam inha-bitavit ille troianusAnthenor, nec nonPataviam sive Pa-duam civitatem simi-liter hedificavit.
237, 63 Anchora si èda savere che quan-do la çitade deTroia, la granda, fodestruta per li Grie-xi, molti nobelitroiani se partì chonnavillii e metesse inmar e alguni andè inçiçilia e alguni in leparte de Roma e al-tri in Chartaçine etaltri all’isola de Sar-degna. Intro li qualmiser Eneas venne inqueste parte. E algu-ni venne al colphoAdrian lo qual mo’se clama lo chofo deVeniexia, e de questifo miser Antenor etmadonna Verona(...). E miser Ante-nor hedifichà una çi-tade la qual se cla-mava Patafia, e mo’al prexente, se clamaPadova (...). E moltialtri nobelli hedifichàAntillia, e mo’ se di-xe Altin, lo qual èdestruto, e da po’questo li ditti hedifi-chà Ovederço, Asso-lo, Concordia, Aqui-legia
Il mito di fondazione della città si rivela come stereotipo fon-dante il genere cronachistico italiano del Trecento dove la pre-
LA CRONICA DI VENEXIA DELLA FAMIGLIA B 939
sunta origine troiana accomuna molte città che pur nell’esplicitarsidelle differenti autonomie cittadine si riferiscono, comunque, almodello della regia civitas. Le città si scoprono fondate « da Ro-molo o dai figli di Remo, discendenti di Enea, da vari fuggiaschida Troia, da una indovina figlia a sua volta di un indovino tebano,da una ninfa lasciatasi annegare per amore di Ulisse e così via » 39. Aldux Enea i veneziani devono l’istituzione del dogato, come vuoleun passo della Cronica:
Et lì elevono tra sì un signor et principo al qual disseno doxe, tolendo el dicto nome dalduxe Enea suo antigo passado et di Troia discexo; et questo ordenamento et dicreto per-petualmente osservando fino al dì d’ancoy in Venexia el si vede 40.
Nella proposizione delle origini troiane, più che in ogni altroepisodio, i cronisti veneziani, palesano l’intento didattico del loro« narrar favole » 41, affermando l’arcaica supremazia di Venezia co-me primo nucleo di irradiazione della civiltà ricostituita dai troia-ni, in un contesto geografico nel quale la Repubblica, ma la Re-pubblica del XIV secolo, risultava solamente una fra le tante po-tenze economiche e politiche. Una cronaca bolognese detta Ram-pona, propone già nel XIII secolo un elenco di potentes e nobiles vi-ri, fuggiti da Troia con Enea, eroi eponimi e fondatori di unaventina di città tra cui « Pisa fondata da Pisio, Marsiglia da Marsi-glio, Barbona da Nerbuto, Tolosa da Tolosio » 42. Dal 1150 ai pri-mi anni del Duecento vengono prodotte in area franca una seriedi opere letterarie che introducono il tema della storia di Troia: ilRoman de Troie di Benoît de Saint Maure, gli anonimi Eneas e Lifest de Romains che vennero rielaborate e tradotte in Italia nelleStorie di Troia e de Roma, nel Miracole de Roma, entrambi anonimi;nella Historia destructionis Troiae di Guido delle Colonne, nella Sto-
39. G. PICCINNI, Invenzioni dei padri e ambizioni del presente. Le città dell’Italia medievale,in Miti di città, a cura di M. BETTINI, M. BOLDRINI, O. CALABRESE, G. PICCINNI, Siena,2010, p. 47.
40. Cronica di Venexia cit. (nota 2), pp. 13-14.41. CARILE, Aspetti della cronachistica cit. (nota 18), p. 91.42. PICCINNI, Invenzioni dei padri cit (nota 39)., p. 48 e R. BORDONE, Il passato storico
come tempo mitico nel mondo cittadino italiano del medioevo, in Società e Storia, LI (1991), pp.1-22 anche in Reti Medievali, ID., Uno stato d’animo. Memoria del tempo e comportamentiurbani nel mondo comunale italiano, Reti Medievali, Firenze University Press, 2002.
ANTONELLA PARMEGGIANI940
ria di Troia in volgare di Binduccio dello Scelto 43. L’ipotesi chel’adozione delle origini troiane da parte delle città della Penisolasia dovuta ad una suggestione letteraria d’Oltralpe soddisfa solo inparte, mentre convince maggiormente l’implicita spiegazione delcronista Marco che nel 1224 vuole liberi i troiani che fondaronoVenezia 44. Le ragioni del grande successo dei modelli letterarifrancesi e il suo riversarsi nella cronache cittadine vanno ricercatenell’esperienza politica delle città italiane come luogo di autogo-verno e di autonomia urbana.
Nel caso di Venezia i primi fondatori sono seguiti da altri ri-fondatori ragione per cui ad una prima fondazione troiana dellaVenezia segue una colonizzazione della laguna legata alle invasio-ne degli Unni. Anche in questo caso si tratta di un topos che ac-comuna le cronache veneziane e ad altre cronache cittadine delXIV secolo. Marchionne di Coppo Stefani scrive la sua cronacadedicata a Firenze tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli an-ni ottanta del Trecento e descrive la distruzione della città adopera di Attila flagellum dei diversamente da Giovanni Villani -che Marchionne conosce e spesso parafrasa - che cita Totile Flagel-lum Dei. Anche nell’ editio secunda e nell’editio tertia dell’ Origo diVenezia, nel corso del XII secolo, la storia di Attila è fusa con laleggenda di S. Geminiano di Modena e con la leggenda dellamorte di Totila 45 .
La libertà originaria e la riconquistata autonomia di Venezia siflettono solamente di fronte alla potenza del messaggio cristiano,divulgato nelle laguna dall’evangelista san Marco, che dopo avere
43. D. CANZIAN, L’identità cittadina tra storia e leggenda: i miti fondativi, in La costruzionedella città comunale italiana, secolo XII-inizio XIV, Pistoia, 2009, pp. 260-261. Il Carile in-dividua cinque teorie dell’origine di Venezia nelle varie editiones dell’Origo. Alla coloniz-zazione troiana si devono gli insediamenti cittadini dell’antiqua Venecia. Il nome stessodei venetici deriva da quello di Enea: modo ab Enea nomine Andreatici Enetici nuncupantur.Enetici namque laudabiles dicuntur; vd. A. CARILE, Le origini di Venezia nelle più antiche cro-nache veneziane, in In memoria di Sofia Antoniadis, Venezia, 1974, pp. 33-35.
44. CARILE, Aspetti della cronachistica cit. (nota 18), pp. 90-91; ID., Le origini di Venezianelle più antiche cronache veneziane cit. (nota 43), p. 37.
45. RANGONE, Giovanni Villani cit. (nota 5), p. 15. La confusione tra Attila e Totilanegli storici di epoca medievale è spiegata e fatta risalire a Martino Polono, cfr. TH.MAISSEN, Attila, Totila e Carlo Magno fra Dante, Villani, Boccaccia e Malispini, in ArchivioStorico Italiano, CLII (1994), pp. 561-963. Per l’Origo, vd. CARILE, Le origini di Venezianelle più antiche cronache veneziane cit. (nota 43), p. 33.
LA CRONICA DI VENEXIA DELLA FAMIGLIA B 941
completato l’opera di conversione di tutta la popolazione conti-nuerà il suo pellegrinaggio a Roma e poi ad Alessandria 46. Du-rante il viaggio che san Marco intraprese verso Roma ebbe, nellalaguna di Venezia, il sogno profetico dell’angelo che gli indicavaessere quello il luogo della sua sepoltura. « Si provvede così a san-zionare miticamente la validità della traslazione del corpo del san-to che tanto alto significato politico e religioso aveva avuto nellastoria del ducato e nella formazione di una coscienza autonoma insenso veneziano » 47. Alla fondazione civile della città si accompa-gna il quadro della fondazione religiosa.
Cronica di Ve-nexia(ed. Pesce)
Piero Giustinian(ed. Carile)
A latina(ed. Negri diMontenegro)
Venetiarum Hi-storia(ed. Cessi –Bennato)
A. Dandolo,Brevis(ed. Pastorello)
A volgare(ed. Carile)
6 et in cavo dequesta provinciaera la cità grandede Aquilegia, ne-la quale el biadoevagnelista misersen Marco illu-minado dala di-vina gracia pre-dicò el nome deIhesu Christo,che tuti de quelaprovincia et cita-de riduse ala no-stra fede. Et delà per manda-mento de senPiero apostolosuo maistro andòa Roma et poyin Alexandria, làdove ricevé pas-sion di morteper la qual elaquistò sublimeseggio in cielo.
253, 10-15EtAquilegenssis ci-vitatis tunc illiusprovincie metro-pollis habebatur,ut hec om-nia inantiquis croni-cislucide declaran-tur. In dicta au-tem Aqui-le-genssi civitatebea-tus Marcusapposto-lus etevangelista, san-ctissimum ver-bum Dominievangelice predi-cavit, qui posteaiussu beati Petriappostoli Roma-nam urbem ac-cessit
33, 9-13 EtAquilegiensis ci-vitatis tunc illiusprovincie metro-polis habebatur,ut haec omnia inantiquis cronicisluci-de declaran-tur. In dicta au-tem Aquile-gien-si civitate beatusMarcus apostoluset avangelistasanctissi-mumverbum dominievangelice predi-cavit, qui posteaiussu beati Petriapostoli Roma-nam urbem ac-cessit
7, 5-12 (...) etAquilegensis ci-vitas tunc illiusprovincie metro-polis habebatur,ut hec omnia inantiquis cronicislucide declaratur.In dicta veroAquile-gensi ci-vitate beatusMarcus apposto-lus et evangelistasanctissi-mumverbum Dominievangelice predi-cavit, qui posteaiussu beati Petriappostoli Roma-nam urbem ac-cessit
351, 15-18 (...)cuius Aquilegiacivitas extitit ca-pud, in qua bea-tus Marcus evan-gelista, divinagratia perlustra-tus, Chistum Ie-sum Dominumpre-dicavit; quideinde beati Pe-tri iussu Romamaccedens, de he-difficatione se-cun-de Venetie,et sui ibidemcorporis re-quie,divinu notu, abangelo clarifica-tus fuit.
235, 29-32 E incavo de questaprovinçia era laçitade de Aquile-gia, in la qual elbiado evangelistamiser sen Mar-cho, inluminadodella divina gra-çia, predichà elnome de IHMXPO <intantoche tuti de quelaprovincia et cita-de prese la fè>.Et de là el separtì per cho-mandamento demiser santo Pieroapostollo elo an-dà a Roma [eprese la fe’]
46. La fonte della vicenda marciana è il cronista Marco, che si dilunga nella narrazio-ne, mentre le cronache riportano in sintesi i fatti salienti; vd. CARILE, Aspetti della crona-chistica cit. (nota 18), pp. 123-124.
47. CARILE, Le origini di Venezia nelle più antiche cronache veneziane cit. (nota 43), p. 38.
ANTONELLA PARMEGGIANI942
« Per dominare il tempo e la storia e per soddisfare le proprieaspirazioni alla felicità e alla giustizia o i timori di fronte al delu-dente o inquietante concatenarsi degli avvenimenti, le societàumane hanno immaginato l’esistenza di epoche eccezionalmentefelici » 48. In questo senso la società veneziana attraverso i miti difondazione, narrati nelle sue cronache, ha divulgato il sentimentodella sua età dell’oro, con una straordinaria adesione da parte delnostro Autore che travalica il mito e si avvicina alla storia recupe-rando dalla tradizione il termine patria 49, proponendolo come pa-trimonio civile di tutti i veneziani. Il concetto di patria, con tuttele implicazioni, giuridiche, religiose ed anche affettive che com-porta viene introdotto nella cronaca nel momento in cui gli abi-tanti di Malamocco affermano la loro fiera indipendenza dall’im-pero d’Occidente.
O infortunati et infelici homini mathamautesi, li quali de tante contrade sete stadi habi-tanti non haver possudo in quelle perdurar, ma hora de qua, hora de là, sete stadi con-streti de far nove stantie et morti et consumadi tante fiade et pur da recavo retornadi arefarve; veramente i volieri vostri era boni, el valor vostro fo oltra mesura. Et in per que-lo che lì era preelecto al luogo vostro, là dove queli alti et magnianimi dovesseno vegnir aquelo affecto lo qual tanto tempo aspettasse ancora. Lo re Carlo di França vi vene adossocon tanto sforço per subiugarvi et metervi soto el dominio del tirapno Hobeliero, ma vera-mente el saper et l’alto voler vostro, el qual sempre à regnado in lo cuor et animo de tutiquelli che de vuy sono descissi, i quali per da qui mo’ driedo nomeneremo venetici, overoveniciani, cotal subiugation non consentirano, anci volemo sempre libertade et amandocon tuto forço l’onor dela patria nostra tenerete tal modo che non curando solamentedel re Carlo che dampnificar vi possa, ma se quasi l’universo vi vol<e>se dapnigiar,non vi porano: in luogo tal sete situadi et de spaldi in dubitanti d’aqua circundadi. 50
48. J. LE GOFF, Storia e memoria, Torino, 1982, p. 227.49. La patria viene citata in più passi, oltre che nel proemio dove compare per la
prima volta come epiteto per definire Troia; Cronica di venexia cit. (nota 2): p. 8 e 26destrucion dela soa patria; p. 35 per honor et stado dela patria; p. 59 in tucto fidellissimo ala pa-tria sova. L’espressione di una patria Venecia si trova, nel 853, nel testamento di OrsoParticiaco, vescovo di Olivolo: forse la prima testimonianza di una autonoma coscienzacivica, cfr. CARILE, Le origini di Venezia nella tradizione storiografica, cit. (nota 32), p. 142.
50. Cronica di Venexia, cit. (nota 2), pp. 21-22. Sulla base della collazione dei testi-moni della tradizione, e per restituire un senso compiuto al periodo, ho apportato qual-che emendamento all’edizione del testo di Pesce che qui cito: aspettasse in luogo di affet-tasse; animo in luogo di sinnio; nomeneremo in luogo di nomano. L’Editore dichiara di se-guire il metodo proposto dalla Collodo a proposito dell’edizione di cronache venezianee cioè « Individuato un filone, si sceglie il codice che ne è all’origine o che ne segnauna svolta decisiva e si procede alla sua trascrizione, mentre gli altri manoscritti del
LA CRONICA DI VENEXIA DELLA FAMIGLIA B 943
L’eroica prova di resistenza contro Carlo Magno, nel raccontodella Cronica, è condotta in totale solitudine dalle popolazioni cherisiedono nella laguna, che in virtù del loro valore acquisisconol’epiteto di venetici, overo veniciani, divenendo a tutti gli effetti unpopolo unito che si riconosce nell’onore della patria. Un onorestrenuamente percepito, che si traduce politicamente nell’afferma-zione e nella difesa, protratta nel corso dei secoli, dell’indipenden-za giuridica ed amministrativa di Venezia. Vien da chiedersi, iro-nicamente, se l’Autore fosse cosciente dell’operazione di revisioni-smo storico condotta coerentemente nella sua cronaca, dove qual-siasi rapporto con l’impero d’Oriente viene sottaciuto 51 e dove iveniciani sembrano uscire magicamente vittoriosi dalle avversitàgrazie allo straordinario rapporto simbiotico con l’ambiente lagu-nare, che protegge dalle incursioni straniere.
La prevalenza della narrazione romanzata e favolistica, la scarsaattendibilità del racconto, soprattutto per quel che riguarda le ori-gini di Venezia, nulla tolgono al valore storiografico della Cronicadetta di Enrico Dandolo, che conobbe un gran successo e servì datrama per le rielaborazioni successive che costituirono la cronachi-stica del Quattrocento 52. L’opera va interpretata nel contesto diuna cultura civica, che si sviluppa a Venezia a cavallo del periodopreumanistico e si fa interprete di un ethos veneziano e di unaidentità comunale lentamente sedimentati dall’aristocrazia dellaRepubblica, che doveva affermare se stessa non solo di fronte aglialtri comuni della Penisola 53, ma anche di fronte ai grandi stati
gruppo serviranno di confronto e di aiuto per la ricostruzione del testo in casi di evi-denti corruzioni, lacune, errori, parole incomprensibili », S. COLLODO, Note di cronachisti-ca veneziana. A proposito di un recente volume, in Archivio Veneto Ser. 5a, XCI (1970), p.30, ma, in questo caso, si ha l’impressione di trovarsi di fronte ad una semplice trascri-zione acritica del manoscritto base.
51. L’aiuto della flotta bizantina fu fondamentale nel respingere le mire espansionisti-che di Carlo Magno su Venezia. Una breve rassegna dei rapporti storicamente rilevantitra Venezia e l’impero bizantino si può recuperare nel bellissimo saggio di CARILE, Leorigini di Venezia nella tradizione storiografica cit. (nota 32), pp. 135-141.
52. CARILE, Aspetti della cronachistica cit. (nota 18), p. 107.53. Le città, quando si sono costituite in organismi politici autonomi, coscienti del
loro prestigio, hanno voluto elevare questo prestigio esaltando la loro antichità, la gloriadelle loro origini e dei loro fondatori; cfr. LE GOFF, Storia e memoria cit. (nota 48), p. 55.Non sono pochi gli studi relativi a questo fenomeno diffuso nelle città: si vedano, soload es., per Padova, in particolare, G. ARNALDI, Studi sui cronisti della marca Trevigiana nel-l’età di Ezzelino da Romano, Roma, 1963 (Istituto Storico Italiano per il Medioevo); ID.,
ANTONELLA PARMEGGIANI944
europei. La storiografia veneziana delle cronache, infatti, si inseri-sce nello schema della storia universale e se ne serve, con intentoedificante, ad esaltazione del modello cittadino veneziano. In par-ticolare la Venezia della Cronica detta di Enrico Dandolo, fin dalleorigini, viene tratteggiata come l’allegoria dello stato perfetto, do-ve possono essere passibili di errori solamente i singoli dogi, poi-ché l’istituzione dogale rappresenta il sistema di governo ineccepi-bile.
Il suggestivo ricorso all’origine etimologa del termine Veneziasottolinea l’eccellenza e la munificenza della città. L’Autore sia affidaad un ardito tuto ve ne çia 54 (« tutto ve ne sia », ovvero « vi sia ognicosa ») che non ha eguali in nessun altra cronaca e non si individuaneppure nel più ampio panorama della letteratura e della poesia ve-neziana sia latina che volgare, dove Venetia può derivare da Venietiam e Vinegia da vien già. E si giunge a lambire la venerazione este-tizzante quando un anonimo, probabilmente del Cinquecento, insi-nua il dubbio che il nome di Venezia abbia dato origine a quello diVenere – Aut Venus a Venetis sibi fecit amabile nomen – oppure vice-versa – aut Veneti Veneris nomen et omen habent – 55.
Il notaio cronista cit. (nota 7), pp. 293-309. Per Firenze, N. RUBINSTEIN, The Beginning ofpolitical Tthought in Florence, in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, V (1942),pp. 198-227 e A. DEL MONTE, Istoriografia fiorentina dei secoli XII e XIII, in Bullettino dell’I-stituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, LXII (1950), pp. 175-282.Per Genova, G. BALBI, La storiografia genovese fino al secolo XV, in Studi sul Medioevo cri-stiano offerti a Raffaello Morghen, Roma, 1974. Per Milano, G. MARTINI, Lo spirito cittadinoe le origini della storiografia comunale lombarda, in Nuova Rivista Storica, LIV (1970), pp.1-22.
54. Cronica di Venexia cit. (nota 2), p. 30. Ma l’Editore non ha colto la necessità diseparazione delle parole ed ha trascritto tuto Venecia che non mi sembra significativo, di-versamente da tuto ve ne çia.
55. A. MEDIN, La storia della Repubblica di Venezia nella poesia, Milano, 1904, p. 8.