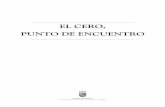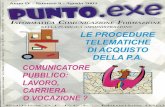La battaglia nelle corrispondenze diplomatiche: stereotipi lessicali e punto di vista degli...
Transcript of La battaglia nelle corrispondenze diplomatiche: stereotipi lessicali e punto di vista degli...
La battaglia nel Rinascimento meridionale
Moduli narrativi tra parole e immagini
a cura diGiancarlo Abbamonte, Joana Barreto, Teresa D’UrsoAlessandra Perriccioli Saggese e Francesco Senatore
viella
Copyright © 2011 - Viella s.r.l.Tutti i diritti riservatiPrima edizione: settembre 2011ISBN 978-88-8334-491-6
Il volume è pubblicato con il contributo delle seguenti istituzioni:
École Normale Supérieure de LyonÉquipe de Recherches sur les Aires Culturelles e U.F.R. de Lettres et Sciences Humaines dell’Université de RouenDipartimenti di Filologia Classica “Francesco Arnaldi” e di Discipline Storiche “Ettore Lepore” dell’Università degli Studi di Napoli Federico IIDipartimento di Studio delle Componenti Culturali del Territorio e Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università di NapoliParco Letterario “Pomponio Leto” di Teggiano
viellalibreria editricevia delle Alpi, 32I-00198 ROMAtel. 06 84 17 758fax 06 85 35 39 60www.viella.it
Indice
Prefazione 11
I. La premessa angioinaAlessAndrA Perriccioli sAggese
Dall’Histoire ancienne al Roman du roy Meliadus.L’illustrazione della battaglia nella miniatura napoletanadi età angioina 17
giAncArlo AlfAnoLe «aspre battaglie amorose».Boccaccio e il poema (da Marte a Venere) 29
PAolA VitoloMiles Christi: san Ladislao d’Ungheria tra mito cavalleresco e culto dinastico.Il ciclo pittorico all’Incoronata di Napoli 43
luciAnA MocciolALa presa di Napoli di Carlo III di Durazzonel pannello del Metropolitan Museum: nuove ipotesi 57
cristiAnA PAsquAlettiLe illustrazioni di battaglia nel ms. 3061 della Biblioteca Comunale Augusta di Perugia:alle origini dell’immagine della città dell’Aquila 69
6 La battaglia nel Rinascimento meridionale
II. Le battaglie di AlfonsofulVio delle donne
La presa di Marsiglia del 1423nel racconto di Gaspare Pellegrino 85
JoAn MolinA figuerAsContra Turcos. Alfonso d’Aragonae la retorica visiva della crociata 97
giusePPA Z. ZAnichelliLa battaglia delle imprese: araldica e chevalerietra Milano e Napoli al tempo di Ippolita Sforza 111
giAncArlo AbbAMonteI modelli classici nei racconti di guerra di Bartolomeo Facio 123
JAuMe torró torrentL’assedio di Bonifacio di Alfonso il Magnanimoe l’assedio di Rodi nel Tirant lo Blanc di Joanot Martorell 137
III. Le battaglie di FerranteclAudio buongioVAnni
Paradigmi storiografici classici in alcune allocuzioni militaridel De bello Neapolitano di Giovanni Pontano 153
MArc derAMAixTamquam in acie. Lexique de la bataille et critique euphoniquede la rencontre vocalique chez Virgile dans l’Actius de Pontano 169
guido cAPPelliLa sconfitta di Sarno nel pensiero politico aragonese 189
ArMAndo MirAndAUna “nuova vecchia” battaglia: Troia, 18 agosto 1462.Ricostruzione e analisi dell’evento militare 203
frAncesco senAtoreLa battaglia nelle corrispondenze diplomatiche:stereotipi lessicali e punto di vista degli scriventi 223
giusePPe gerMAnoRealtà e suggestioni classiche nel racconto pontanianodella battaglia di Troia (18 agosto 1462) 241
Indice 7
AntoniettA iAconoEpica e strategie celebrative nel De proelio apud Troiamdi Porcelio de’ Pandoni 269
lAurent VissièreRhodes et Otrante en 1480. Les leçons de sièges parallèles 291
nicolAs bockVedere, raccontare, immaginare. La percezione della battagliae le tappezzerie della Guerra di Troia nella collezionedi Ferdinando d’Aragona 305
IV. Gli ultimi Aragonesi e la discesa di Carlo VIIIbiAncA de diVitiis
I resoconti di guerra come fonte per la storia dell’architettura 321teresA d’urso
Il Trionfo all’antica nell’illustrazione librariaal tempo di Ferrante e Alfonso II d’Aragona 335
chiArA de cAPrioLe battaglie nella Cronaca di Ferraiolo:strutture narrative e lessico 349
JoAnA bArretoLe miroir exemplaire brisé: la première guerre d’Italiedans la Cronaca napoletana figurata de Ferraiolo 363
bruno figliuoloLa guerra lampo di Carlo VIII in Italia 377
ferdinAndo cAscone«Antivenire» la battaglia nelle lettere di Giovanni Pontano 395
gennAro MAriA bArbutoIl Gran Capitano nelle opere di Machiavelli e Guicciardini 407
JeAn-louis fournel, JeAn-clAude ZAncAriniI «fatti d’arme» nel Regno di Napoli (1495-1504):«disordini» o «battaglie»? 421
MAtteo PAluMboStoria e cronistoria della battaglia di Benevento 451
8 La battaglia nel Rinascimento meridionale
V. L’eredità aragoneseconcettA restAino
La congiura dei baroni nel Vallo di Dianoe i suoi riflessi sulla produzione artistica: l’Andata al Calvarioe il Compianto del convento della Pietà di Teggiano 465
enZo bentiVoglioLe battaglie di Seminara (1495 e 1503)nei bassorilievi del monumento di Carlo Spinelli 479
siMonettA VAltieriI pannelli del monumentodel duca Carlo Spinelli a Seminara 491
John nAssichukL’éloge du condottiere: Prosper Colonnadans les épigrammes de Pietro Gravina 499
AndreA ZeZZARaffigurazioni di battaglie nell’arte meridionale del XVI secolo 511
Indice delle fonti 525Indice dei nomi e dei luoghi 531Abstracts 553
Francesco senatore
La battaglia nelle corrispondenze diplomatiche: stereotipi lessicali e punto di vista degli scriventi
In questo intervento analizzo le descrizioni di tre battaglie campali presenti in lettere diplomatiche scritte immediatamente dopo l’evento o a distanza di pochi giorni: la vittoria a Sarno di Giovanni d’Angiò contro Ferrante d’Aragona (7 luglio 1460); la vittoria del condottiero angioino Giacomo Piccinino contro le truppe pontificio-sforzesche di Alessandro Sforza e Federico da Montefeltro a S. Flaviano (oggi Giulianova nelle Marche), nella battaglia detta anche del Tordino (22 luglio 1460); la vitto-ria a Troia di Ferrante contro il rivale (18 agosto 1462). Benché mi sia gio-vato delle ricostruzioni disponibili,1 ho effettuato uno spoglio diretto delle lettere, in parte inedite, individuandone le costanti lessicali. Lo spoglio, riportato nell’Appendice, riguarda 17 documenti per Sarno, 9 lettere per S. Flaviano, 8 per Troia. Questa documentazione, come è stato dimostrato, è fondamentale perché fu la fonte, talvolta insieme con l’esperienza diretta, di opere storiografiche, celebrazioni letterarie e artistiche.2
1. Per Sarno v. M. Squitieri, La battaglia di Sarno: 7 luglio 1460, in Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d’Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche, a cura di F. Senatore, F. Storti, Napoli 2011, pp. 15-40; le lettere relative sono state edite, senza criteri filologici ma con le foto degli originali, da M. Buchicchio, La battaglia di Sarno, Cava de’ Tirreni 2009. Per S. Flaviano, le cui fasi sono qui ricostruite, v. E. Nunziante, I primi anni di Ferdinando d’Aragona e l’invasione di Giovanni d’Angiò, in «ASPN», 17-23 (1892-1898), qui a 20 (1895), pp. 469-470. Per Troia v. A. Miranda, Una ‘nuova vecchia’ battaglia, in questo volume e le lettere in Dispacci sforzeschi da Napoli, vol. V, 1 gennaio 1462-31 dicembre 1463, a cura di E. Catone, A. Miranda, E. Vittozzi, Salerno 2009 [d’ora in poi Dispacci sforzeschi V], in part. pp. 186-195.
2. G. Ianziti, Humanistic Historiography under the Sforzas. Politics and Propaganda in Fifteenth-century Milan, Oxford 1988; F. Senatore, Pontano e la guerra di Napoli, in Condottieri e uomini d’arme nell’Italia del Rinascimento, a cura e con un saggio introdut-tivo di M. Del Treppo, Napoli 2001, pp. 279-309.
Francesco Senatore224
Per gli aspetti militari sono debitore dei lavori di Francesco Storti.3 Il suo metodo, adottato anche da Marialuisa Squitieri per la battaglia di Sarno, è basato sull’identificazione di una “grammatica” delle azioni mi-litari, scomposte in unità temporali e tattiche. In questa sede non interessa tanto la ricostruzione delle res gestae, che resta ovviamente imprescindi-bile, quanto la loro rappresentazione mediante il ricorso, come si vedrà, ad espressioni estremamente stereotipate (sostantivi, verbi, sintagmi), che consentivano di comunicare l’essenziale, riportando la complessità di cia-scun evento bellico e di ciascun teatro di guerra a un numero molto limitato di definizioni. Gli scriventi di questi resoconti della prima ora appartengo-no a due categorie: militari, come uomini d’arme e commissari; cancellieri, definizione sotto cui possiamo comprendere sia i segretari, redattori delle lettere delle autorità e scrittori in proprio, sia gli ambasciatori. Pur con significative differenze derivate dalla formazione e dall’origine geografica (aree diverse delle penisole iberica e italiana), tutti costoro erano addestrati alla comunicazione epistolare. Sono quasi tutti di parte aragonese, ma non mancano significative testimonianze della parte angioina.
Il racconto della battaglia si formava già durante l’azione, presso i comandi degli eserciti contrapposti, grazie alle staffette che percorrevano il campo di battaglia e all’osservazione diretta, se essa era possibile. Le lette-re documentano la notevole permeabilità tra i due schieramenti, attraversa-ti da spie e fuggitivi: per questo alcuni dati, come il numero delle squadre, circa 12, impegnate nell’assalto aragonese a Sarno, sono condivisi.4 A S. Flaviano, dove l’esito dello scontro è drammaticamente incerto, Alessan-dro Sforza invia due spie tra i nemici per appurare se questi abbandonano il combattimento («mandai doi a pede occultamente tra loro»).5 I condottieri sforzeschi Ugo da Sanseverino e Orlandino fanno lo stesso prima con un famiglio, poi con un trombettiere: essi riportano la falsa notizia della rotta pontificio-sforzesca, generando panico tra le truppe di riserva, che si danno alla fuga mentre gli altri ancora combattono.6
3. F. Storti, Per una grammatica militare della guerra di successione al trono napo-letano, in F. Senatore, F. Storti, Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno aragonese. L’itinerario militare di re Ferrante (1458-1465), Salerno 2002, pp. 59-92.
4. Cfr. Appendice, Sarno b, m. Si rinvia in forma abbreviata ai dispacci diplomatici (contrassegnati da lettere alfabetiche) e ai loro rispettivi passi (contrassegnati da numeri) così come repertoriati nell’Appendice, da consultarsi anche per una sintesi delle battaglie.
5. S. Flaviano g.6. S. Flaviano h.
La battaglia nelle corrispondenze diplomatiche 225
Raccontare la battaglia nel suo stesso farsi comporta il rischio di frain-tendimenti, specie quando le condizioni sono difficili, come nell’ingorgo di cavalieri e fanti all’entrata di Sarno, dove la pressione di chi rinculava per il contrattacco angioino scompigliò il resto dell’esercito; e a S. Flavia-no, dove l’esito del confronto, prolungatosi nelle ore notturne, fu oggetto di contestazione da parte dei testimoni dell’uno o dell’altro schieramento. Sul piano simbolico la vittoria fu qui dei filo-aragonesi, che lasciarono il campo per ultimi, ma sul piano sostanziale toccò a Piccinino, che era ri-uscito ad attirare in una trappola l’esercito avversario, danneggiandolo al punto che esso non fu più in grado di contrastare la sua avanzata.
La testimonianza oculare è tradotta immediatamente in testi, orali e scritti, le due modalità essendo alternative dato l’alto grado di condivi-sione del lessico bellico, dell’enciclopedia dei parlanti e la forte abitudine alla memorizzazione. Un nucleo narrativo essenziale si costituisce subito e circola rapidamente nei due fronti, negli accampamenti e nelle corti, anche se non erano ancora disponibili tutte le informazioni che sarebbero state necessarie, come avvertono gli scriventi:
e perché li nostri non sonno ancora recolti, non se nne po’ sapere el conto né delli morti né delli presi (Sarno b).
Li nostri mo’ intrano in campo: non posso dire lo numero de li prexuni né la loro particularità, ma è una infinita summa (Troia a).
Molti homini d’arme de li loro sono presi, il numero de li quali anchora non se sape, però non ne posso avisare vostra signoria (Troia b).
Anche l’elenco dei prigionieri e dei caduti più illustri è divulgato immediatamente (le insegne erano del resto ben riconoscibili), ma è in-completo e può essere soggetto a correzioni. Questo nucleo narrativo si concentra sugli elementi fondamentali dell’evento: luogo e fase decisiva dello scontro campale (il fatto d’arme in senso proprio) sono presenti nella maggior parte delle testimonianze, se non in tutte, come documenta lo spo-glio in Appendice. Si tratta del locus arctissimus all’interno di Sarno, dove il disperato contrattacco angioino capovolge le sorti della battaglia;7 di un avvallamento pieno d’acqua nel letto quasi secco del fiume Tordino, dove i combattimenti sono multipli e assai violenti;8 del letto del fiume Sannoro,
7. Sarno 4, 8.8. S. Flaviano 2, 6-7.
Francesco Senatore226
dove gli angioini sono battuti una prima volta, e del monte presso Troia, il cui controllo da parte dei filo-aragonesi determina il successo finale.9 Tranne che per Troia, che è descritta con dovizia di particolari da molti testimoni, negli altri due casi vi sono informazioni, pur assai importanti per comprendere la dinamica dello scontro, che sono assenti in diverse lettere, tanto che la ricostruzione di quelle battaglie richiede la sinossi di tutte le testimonianze e il loro confronto con la topografia locale.
Certo, non mancano le relazioni assai precise: si tratta di quelle che ven-gono preparate in un secondo momento, grazie ad interviste a uomini d’arme, mostre dei prigionieri, valutazione delle perdite. Esse sono fatte da addetti ai lavori e sono riservate a un circuito più ristretto di destinatari, comandanti e autorità politiche interessati ai nomi dei soldati, ai rispettivi torti e meriti, e – soprattutto – avidi di esperienze di cui far tesoro per il futuro. Mi riferisco alla lettera di Battista de Albeto, un militare sforzesco, che è fondamentale per Sarno,10 e alle relazioni a bocha di uomini di fiducia cui il sovrano affidò ambascerie riservate subito dopo quella sconfitta: Antoni Gaçó (a Firenze e a Milano), Joan de Liria (a Venezia), Simonot Bellprat, che, già a Milano, ricevette incarico di parlare con il duca.11 Così, per S. Flaviano sono preziose le missive di Alessandro Sforza e Simone da Spoleto, cinque giorni dopo i fatti,12 nonché le relazioni dei militari che Alessandro inviò subito a Milano: Belasio e Antonio del Senese, il quale «vide tutto dal principio fin alla fine».13 Per Troia, la lettera migliore è quella del commissario Antonio da Pesaro,14 mentre il nucleo comune a tutti i testimoni è identificabile nella breve comu-nicazione dell’ambasciatore da Trezzo alla duchessa di Milano: gli aragonesi e i loro alleati «se condussero fin nel piano de Troia, caciandoli [gli angioini] sempremai. Et facendose facto d’arme li ruppero et frachassarono caciandoli fin dentro le mura de Troia».15 Rispetto alle relazioni tecniche la gran parte delle lettere, pur prodotte nell’immediato, contengono sempre l’essenziale, secondo una selezione dei fatti che non tradisce la verità, ma che ne oblitera
9. Troia 3, 6, 9, 12.10. Sarno m.11. Per Gaçó: Sarno n; Ferrante a B.M. Visconti, Napoli 8 luglio, ASMi, Sforzesco,
203, 124, P. da Recanati a F. Sforza, Napoli 9 luglio, ibidem, 203, 129. Per de Liria: ibidem; per Bellprat v. la credenziale di Ferrante, 8 luglio, ibidem, 203, 126.
12. S. Flaviano g, i.13. Per il secondo: credenziale del 25 luglio, ibidem, 203, 9; per il primo: S. Flaviano b.14. Troia c.15. Troia f.
La battaglia nelle corrispondenze diplomatiche 227
molti particolari. Questa selezione – insisto – viene fatta nelle ore stesse della battaglia da chi la vive in prima persona.
Ma veniamo al lessico. I luoghi e le fasi del combattimento sono descritti con definizioni fisse e stereotipate, eppure inequivoche, perché richiamano situazioni tipiche della guerra rinascimentale. Le costanti della narrazione corrispondono insomma alle costanti della guerra, sono un’astrazione, nata dall’osservazione empirica (del resto canonizzata fin dai tempi di Vegezio), delle situazioni che si presentano, pur in contesti e con esiti differenti, in ciascuna battaglia. Gli elementi fisici – monti, pia-nure, colli, valli, corsi d’acqua, boschi – vengono considerati non nella loro individuale morfologia, ma nella loro funzione tattica. I toponimi sono generalmente assenti, al più i luoghi sono identificati sulla base delle co-noscenze condivise da mittente e destinatario,16 secondo un meccanismo psicologico ben conosciuto: la distanza è indicata con richiami a luoghi familiari,17 o parlando di «una balestrata»; il luogo della vittoria di Ferrante a Troia coincide con quello della vittoria del padre.18
A Sarno, il Saretto è detto semplicemente monte, montagna, col-lis, poggio: ciò che importa è che incombe sul borgo.19 Del rilievo detto Cerchio di Magliano (presso Troia), indicato variamente come collina, monte, quattro colli, eminens tumulus interessa il fatto che è «non mol-to forte»,20 tanto che viene tolto agli angioini senza difficoltà. Genera confusione, sempre nelle descrizioni della battaglia di Troia, la citazione dell’altro monte e di due ulteriori rilievi definiti nello stesso modo.21 Del resto, la Porta di Foce a Sarno, l’interno del borgo,22 lo spazio sotto le mura di Troia23 sono detti semplicemente uno loco, persino una certa parte,24 termini accompagnati da un’aggettivazione pregnante: essi sono forti, tali da renderne difficile la conquista e vantaggioso il possesso (il
16. Troia 5e.17. «La squatra della famiglia [di A. Sforza] fo messa denanti a tucte queste, le quale
erano de longo l’una dall’altra quasi quanto è lunga la vostra corte de Milano», «in tanto terreno quanto è lunga la guazza del castello de Milano»: S. Flaviano i.
18. Nell’ordine Troia 5d, 6b.19. Sarno 3e, 3h, 3m.20. Troia 1, e v. le carte nel saggio di Miranda, in questo volume.21. Sarno 2, 5, 6.22. Si tratta dei tre luoghi presi in successione dall’esercito aragonese: Sarno 1n, 4a,
4e, 4k, 4i, 4n.23. Troia 5b.24. Sarno 4f.
Francesco Senatore228
vantaggio del luogo a Sarno; il desavantagio e l’adscensus nobis ini-ini-quus.25 Così, l’aspetto del Tordino, che specialmente in estate si divide in più bracci (cart. 1), è sottintesa nei termini fosso, acqua, passo.26
Quando un testimone scrive fosso, chi legge la sua lettera sa che que-sta definizione corrisponde a luoghi apti ad fantarie, come del resto pre-cisano alcuni autori.27 Così, nell’enciclopedia condivisa dai corrispondenti – come si suol dire – è noto che il greto di un fiume si presta allo scontro tra cavalieri armati pesantemente, benché le irregolarità del paesaggio (av-vallamenti, macchie di vegetazione) possano rendere difficile i movimenti, come succede a S. Flaviano. Che poi queste irregolarità siano costituite da una «una strada con uno limite un pocho bassa», presso un ponticello, interessa soltanto qualcuno.28 Ancora, mittenti e destinatari sanno bene che la conquista di un’altura è il necessario preliminare alle operazioni nella pianura sottostante; al contrario, la sua perdita determina lo sconcerto di chi combatte in basso (come accade per il monte Saretto a Sarno e per il monte Verditolo a Troia). Monte o colle che sia (nel caso del Cerchio di Magliano la definizione si riferisce a più colline), un rilievo mette in po-sizione vantaggiosa chi lo controlla, è un punto di partenza o di arrivo per azioni aggressive, e per distinguere la maggiore o minore pendenza basta un aggettivo: non molto forte, forte o fortissimo.
Il luogo dove si concentra il combattimento è spesso detto il passo, una definizione che riassume in sé la difficoltà dell’azione (gli uomini d’ar-me, che sono a cavallo e che sono armati pesantemente, non manovrano bene in luoghi stretti) e il naturale scandirsi della battaglia nella difesa di posizioni favorite da qualche elemento naturale (un declivio, un guado, un accesso stretto). All’espressione corrispondono la Torre del Borgo e l’in-terno del borgo fortificato di Sarno, nel forte del passo,29 il letto del fiume Tordino,30 quello del Sannoro,31 un sentiero alternativo che permette una manovra di accerchiamento.32 Il passo diventa il forte de inimici, luogo morfologicamente adatto a creare un fronte di resistenza.33
25. Rispettivamente Sarno 4i e Troia 5e, 5h.26. S. Flaviano 2, 3, 4.27. S. Flaviano 2g, 4g.28. S. Flaviano 3i.29. Sarno 2e; 4b, 4d, 4e, 4f.30. S. Flaviano 2g, 4h.31. Troia 3b, c, 4c.32. Troia 4d.33. Sarno 4d; S. Flaviano 2i, 3i, 4i.
La battaglia nelle corrispondenze diplomatiche 229
Cart. 1. Foce del Tordino (1876), carta IGM edita in A. R. Staffa, Contributo per una ri-costruzione del quadro insediativo della Vallata del Tordino dall’antichità al Medioevo, in F. Aceto et a., Teramo e la valle del Tordino, (Documenti dell’Abruzzo teramano, vii, 1) Teramo 2006, pp. 187-247, qui a p. 224. La carta documenta la divisione del Tordino in due bracci, come nel Medioevo. Il sito 6/1 (località Bivio Bellocchio) corrisponde al Castrum S. Flaviani, occupato il 10 luglio dai pontificio-sforzeschi. Il sito 6/7 corrisponde al castello di origine altomedievale, se non bizantina, di Insula, abbandonato prima del XIV secolo: se quello era ancora nel 1460 il punto di passaggio del fiume, potrebbe essere identificato con il luogo della battaglia, dove si trovava il ponticello indicato nelle fonti diplomatiche.
Francesco Senatore230
Tale empirica semplificazione si incontra anche nelle definizioni delle azioni militari. Alcune espressioni sono tipiche:
ributtare il nemico (Sarno 8d, f; S. Flaviano 6g, 7h; Troia 7b, 10a, 10g);
ritrarsi, ridursi per «ritirarsi» (S. Flaviano 5g, 6g, 7c, 9g; Troia 10c);
prendere il monte o il passo (latino expugnare, occupare, Sarno 5a, 5b, 5c, 5h; Troia 7a, c, g, 8c), oppure spontare dal passo (Sarno 8d, 8f; S. Flaviano 7g; Troia 7d, 10b, 10d).
Va infine sottolineato che fare facto d’arme indica un’azione militare ben distinta da molte altre, come ha dimostrato Storti.34 Significa scontrarsi alla pari (dare battaglia, si direbbe oggi), ingaggiando un combattimento che ha una certa durata (latino pugnatum est, certamen instauratum est).35 Nelle nostre tre battaglie i fatti d’arme, che si appizzano (appizzare vale qui «accendere», «cominciare») e dai quali ci si despizza («disimpegnarsi»), sono ben riconosciuti da tutti i testimoni, che usano l’espressione consa-pevolmente, distinguendo il fatto d’arme dagli altri tipi di combattimento e dalle altre fasi della battaglia. In una battaglia possono anche esserci di-versi fatti d’arme.36 La battaglia nel suo complesso è chiamata fatto d’arme (mai battaglia), o definita con il suo esito (rotta, vittoria). A Sarno non ci fu, in senso proprio, un fatto d’arme, tanto che soltanto due testimoni usa-no questa definizione,37 mentre un altro commenta giustamente che gli ara-gonesi «fra loro medesimi se rompectero».38 Rompere, talora rinforzato da fracassare, significa provocare una ritirata scomposta e senza rimedio.39
Sarno, S. Flaviano, Troia non sono in verità le sole battaglie della guer-ra di successione,40 sono però quelle giudicate decisive dai contemporanei, i quali dunque ci condizionano in sede storiografica, perché caratterizzate dall’impiego di tutto il potenziale bellico dei contendenti (soprattutto in ter-
34. Secondo Storti, le azioni militari «complesse» sono di sei tipi, distinguibili in azio-ni contro un luogo forte (assalto, assedio), sul territorio (scontro, fatto d’arme o battaglia) e contro il territorio (cavalcata o scorreria, guasto), Storti, Per una grammatica, p. 63.
35. Troia 9h, 11h.36. S. Flaviano 6a, c, 7c, g; Troia 9b, 9c, 9d, 11a, 11b, 11c, 11e, 11g.37. Sarno 8b, 8d, ma cfr. 5m.38. Sarno 8g.39. Sarno 8; S. Flaviano 9e; Troia 11g, 12a, 12d.40. Storti, Per una grammatica, p. 75 conta 320 azioni militari complesse, tra cui 58
fatti d’arme, che Storti distingue in 54 «scontri» e 4 «battaglie» (le tre qui analizzate e la battaglia navale di Ischia).
La battaglia nelle corrispondenze diplomatiche 231
mini di cavalli), tanto che il soccombente viene costretto all’inazione dopo lo scontro, almeno per lo spazio di una campagna stagionale. Tutti sanno quali conseguenze può avere, per la guerra, l’esito positivo o negativo di uno scontro del genere, Tutti sanno che l’importante è giungere a questa resa dei conti nella migliore condizione possibile, altrimenti è preferibile rinun-ciare, evitando il confronto a costo di disonorarsi, come aveva invano racco-mandato il duca di Milano prima che arrivasse la notizia di S. Flaviano.41
Il giorno prima di questa battaglia si verificò un fatto d’arme identico: Piccinino fece scendere dalla collina, di nascosto, una grande quantità di fanti e alcune squadre di cavalleria. La guardia del campo filo-aragonese raccolse la provocazione, e «viene facto facto d’arme uno pezo». L’esito è lo stesso, ma limitato quantitativamente: gli uomini di Piccinino persero balestre e fanti, gli alleati cavalli, ma «li nostri remasero in lo piano fin che li suoi remontarono la collina».42
Questa essenzialità di riferimenti alla topografia e alle azioni militari si riscontra anche sul piano grafico: si veda, prestando attenzione alle didasca-lie, lo schizzo in cui l’ambasciatore sforzesco da Trezzo rappresentò la posi-zione degli accampamenti angioino e aragonese nel 1461 (fig. 89). Il re – si dice – potrebbe attaccare il nemico se passasse il bosco, ma «seria con molto desavantagio».43 Il disegno è accostabile a quello contenuto nei Diari di Cic-co Simonetta.44 La percezione dello spazio è certo approssimativa («uno gran bosco», «uno monte altissimo»), ma sufficiente per comunicare in un colpo
41. In caso estremo «sforzativi de conservarvi et vuy et le zente, perché salvando quelle l’honore se pò poi recuperare» F. Sforza a A. Sforza e F. da Montefeltro, Milano 26 luglio, ASMi, Sforzesco, 203, cc. 13-16.
42. F. da Montefeltro e A. Sforza a F. Sforza, campo presso S. Flaviano 21 luglio 1460, ibidem, 203, c. 226.
43. ASMi, Sforzesco, 207, 226. L’autore inserisce le seguenti didascalie (da sinistra a destra) «Terra Gesualdi. / Dalla terra fin suso questa colma aloza el re. / Terra Frigenti noviter adepta per regem. / Qua alozano le fantarie et el cavalero Orsino et Marcho Antonio Torello. / Qua è uno gran bosco. / Per questa colma se extendeno le squadre del re, volendo havere a ffare con inimici fin alla puncta del bosco, ma non lo passano perché seria con molto desavantagio. / [sotto] De qua al campo inimico sono cinque miglia. / [in verticale] Suso questo monte, che è altissimo, sono inimici, et hano la terra et la Guarda Lombarda alle spalle. Questa è la terra de Sanct’Angelo, distante dal campo inimico dua miglia». Una riproduzione parziale del doc. è sulla copertina di Dispacci sforzeschi da Napoli, IV, 1° gennaio-26 dicembre 1461, a cura di F. Storti, Salerno 1998.
44. I diari di Cicco Simonetta, a cura di A.R. Natale, I, Milano 1962, tavola tra le pp. 132-133.
Francesco Senatore232
d’occhio la situazione. Si noti che i due campi e i cinque miglia che li sepa-rano sono rappresentati dall’esterno, più precisamente da sud. Anche nelle nostre lettere la battaglia è descritta da un punto di vista esterno.
Nella narratologia, il punto di vista è da oltre un secolo al centro del-la ricerca, che ha raggiunto livelli di raffinatezza straordinari.45 Non tento neppure di applicare i modelli elaborati, oltretutto contrastanti, a narrazioni che non sono letterarie, e che fanno i conti con le effettive res gestae, ma tengo presente alcune suggestioni di quella produzione, perché utili a co-gliere l’atteggiamento dei nostri testimoni. Punto di vista ha due significati essenziali, quello fisico di «luogo da cui si guarda», prospettiva, potremmo anche dire, con il che si intende che ciascun osservatore vede gli eventi da un’angolatura personale, la quale gli impedisce di coglierne alcuni aspetti; e quello morale di «opinione, modo di considerare problemi e situazioni», ad indicare che la personalità e le intenzioni dell’osservatore influenzano naturalmente la percezione e il resoconto dei fatti.
Ora, gli autori delle nostre lettere hanno ovviamente punti di vista (nel secondo senso) molto differenti, a seconda del fronte cui appartengono o delle finalità comunicative. Il loro resoconto è però presentato come atten-dibile, condivisibile anche dal nemico (Giovanni d’Angiò su Sarno, tutti sull’asprezza di S. Flaviano).46 Si potrebbe ironizzare su questa pretesa di oggettività, dopo tanta insistenza della psicologia della percezione sull’in-sufficienza dei nostri sensi e della critica storiografica sui condizionamenti volontari e involontari di ogni nostro atto linguistico. I nostri autori non era-no così scettici sulla possibilità di aderire alla realtà, ma non erano neppure così ingenui da non sapere che essa poteva essere manipolata e da non mani-polarla essi stessi per i propri fini. La manipolazione era anzi immediata (per censura militare, per abitudine alla scrittura diplomatica) e mai eccessiva, perché la battaglia era un evento pubblico, e la sostanza non poteva essere negata, neppure in casi discutibili come quello di S. Flaviano.47
Il punto di vista fisico, invece, è tendenzialmente lo stesso, come se i testimoni volessero presentare una descrizione pittorica della battaglia,
45. A. Rabatel, �omo narrans. A. Rabatel, �omo narrans. Pour une analyse énonciative et interactionelle du récit, 1, Les points de vue et la logique de la narration, Limoges 2008.
46. «Non [è] ogi al mondo ricordo del più fero, aspero et terribile facto d’arme», «fac-to d’arme grande et crudelle», «mai veduto el più continuo né più fiero né più aspero facto d’arme»: rispettivamente S. Flaviano b, f, g.
47. F. Senatore, «Uno mundo de carta». Forme e strutture della diplomazia sforzesca, Napoli 1998, pp. 312-315.
La battaglia nelle corrispondenze diplomatiche 233
dall’esterno, grazie alla combinazione delle informazioni raccolte. È pro-prio quello che avviene nello schizzo del 1461 (fig. 89). Sia le lettere che lo schizzo si concentrano su pochi essenziali nuclei informativi, perché sulla base di essi bisognava prendere le conseguenti decisioni militari e politiche. Ecco dunque che l’esperienza personale, il vissuto di ciascuno, vengono messi da parte: i testimoni riferiscono raramente fatti che li han-no coinvolti direttamente, a meno che non siano rilevanti per la battaglia in generale, se non alla fine della lettera, per reclamare meriti personali o chiedere risarcimenti delle perdite subite.48
I resoconti epistolari e le rappresentazioni pittoriche e plastiche delle battaglie possono a buon diritto essere tra loro comparate, come si fa in questo volume, non solo perché i primi furono la fonte dei secondi (oltre che delle narrazioni storiografiche coeve),49 ma anche perché in entrambi i casi l’evento è drasticamente sintetizzato in una o due scene assunte come fondamentali. Penso al cavaliere ucciso nel fiume Sannoro, in uno dei ri-quadri delle porte bronzee di Castel Nuovo (fig. 101): si tratta del momento in cui gli angioni furono «spontati dal passo», durante il primo dei due fatti d’arme di Troia. Fatte salve – è persino superfluo sottolinearlo – le differenze, la scrittura pratica dei testimoni oculari, da un lato, la pittura e la scultura dall’altro sembrano condividere il carattere sintetico della rap-presentazione e il ricorso a un numero ridotto di moduli espressivi.
48. L’intervista di Antonio da Pesaro a Matticello a Troia (c), la punta di spada che quasi ferisce da Trezzo a Sarno (k).
49. V. supra, nota 2.
Francesco Senatore234
Appendice
Sono qui repertoriate le espressioni delle fonti diplomatiche. Di cia-scuna battaglia si forniscono una breve descrizione; l’elenco dei documen-ti, contrassegnati da lettere alfabetiche; le definizioni dei luoghi e delle fasi, contrassegnati da numeri. Le lettere si intendono originali e in volgare italiano, salvo indicazioni differenti. Per lo Sforzesco, il primo numero in-dica la cartella, il secondo la carta. S.n. = senza numerazione.
Battaglia di Sarno, 7 luglio 1460Sintesi dell’evento
All’alba del 7 luglio le truppe aragonesi entrano nel borgo fortificato di Sarno attraverso la Porta del Borgo, dopo aver occupato la torre in località Foce, alle loro spalle, e dopo che le fanterie si sono posizionate sul monte Saretto, alla loro sinistra, al di sopra del borgo. Pur avendo sorpreso nel sonno gli angioini, accampati nel bor-go, gli aragonesi ne subiscono il violento contrattacco, che riesce perché comprime in uno stretto passaggio gli aragonesi (tra la Porta del Borgo e Terravecchia), i quali volgono in fuga travolgendo il grosso dell’esercito. Contemporaneamente la fanteria angioina aveva ripreso il monte Saretto. Il campo aragonese viene saccheggiato.
Fonti
a. Ferrante d’Aragona (Panormita), Napoli 7 luglio, circolare in latino: a F. Sforza (ASMi, Sforzesco, 203, 117); a Firenze (copia ibidem, 203, 123 e registrazione in ASFi, Signori, Responsive, Copiari 1, f. 94r-95r); a Pio II (Città del Vaticano BAV, Vat. Lat. 3371, ed. in G.M. Saccente, Regis Ferdinandi et aliorum epistolae ac ora-tiones utriusque militiae, Vici Aequensi, apud Josephum Cacchium, 1586, p. 320).
b. Giovanni d’Angiò a Sigismondo Malatesta, presso Sarno 7 luglio, copie in ASMi, Sforzesco, 203, 103 e 116.
c. Giovanni d’Angiò a Angelo G., suo ambasciatore e G. A. Orsini, principe di Taranto, a Battista, 7 luglio (lettere riportate da A. Guidoboni, Venezia 20 lu-glio, ibidem, 347 s.n.).
d. A. da Trezzo a F. Sforza, Nocera 7 luglio, ibidem, 203, 113.e. Giovanni da Ventimiglia a F. Sforza, Napoli 7 luglio, ibidem, 203, 122, copia
a 118.f. Ferrante (Talamanca) a F. Sforza, Napoli 8 luglio, ibidem, 203, 117.g. P. da Recanati a F. Sforza, Napoli 9 luglio, ibidem, 203, 129.h. B. Roverella, arcivescovo di Ravenna, a F. Sforza, in latino, Benevento 9 lu-
glio, ibidem, 203, 128.i. B. Roverella a F. Sforza, Benevento 13 luglio, ibidem, 203, 158.
La battaglia nelle corrispondenze diplomatiche 235
j. I. e F. de Guevara, I. e A. d’Avalos a F. Sforza, Napoli 15 luglio, ibidem, 203, 169-170.
k. A. da Trezzo a F. Sforza, Napoli 16 luglio, ibidem, 203, 200-202, dec. a 203-204, copia interpolata a 192, 190-191.
l. Ferrante d’Aragona (G. Talamanca), lettera circolare a F. da Montefeltro e A. Sforza 16 luglio, ibidem, 203, 186 e 187.
m. Battista de Albeto a F. Sforza, Albeto 20 luglio, ibidem, 670, s.n. n. A. Gaçó, 18 luglio, orazione alla Signoria di Firenze, registrazione in latino in
ASFi, Signori, Risposte verbali di oratori, 1, f. 73r.o. Battista Volpino a F. Sforza, 21 luglio, ASMi, Sforzesco, 203, 233.p. Lorenzo da Bologna allo stesso, 23 luglio, ibidem, 203, 238-240.
Definizione dei luoghi
Passo di Foce: (a) suburbi porta; (b) passo; (c) alchuni passi de la montagna; (h) turris inter utrumque exercitum sita; (n) quidam medius locus.
Porta del Borgo: (c) oltre quello fiume del Sarno ad la foce; (e) presso lo ditto borgo […] una torretta et uno passo; (h) portae; (i) lo sportone; (m) el por-tone del dicto borgo.
Monte Saretto; (a) mons; (b) el monte; (e) una montagna che sta sopra lo preditto borgo; (h) collis qui Sarno imminet; (m) el poggio del dicto borgo.
Luogo dello scontro, nel borgo (tra la Porta del Borgo e Terravecchia, presso una delle fonti del Sarno): (a) intra suburbium / locus arctissimus; (b) nel forte del passo; (d) ad uno certo passo che gli era de uno fiume, tanto nel forte de inimici; (e) et uno passo, […] loco molto forte; (f) quasi allo burgo de Sarno […] uno certo passo / allo dicto passo / in certa parte delo burgo; (g) dentro el burgo; (h) in urbem / in suburbia; (i) gran vantaggio del luogo che haveno inimici; (j) nel burgo; (k) luogo forte […]. tra la foce del fiume che nasce lì et la terra; (n) ultra quam tutum.
Fasi della battaglia e loro definizione
Conquista aragonese del passo di Foce: (a) suburbi porta […] occupat[a]; (b) venne alla Foce et preize lo passo; (c) mandò la nocte li fanti sui per pigliare alchuni passi de la montagna; (h) turri expugnata; (m) de poi alcuni facti d’arme lezeri.
Assalto aragonese al borgo: (a) acies aggressi intra suburbium, tres […] fregi-mus ac cepimus; (b) intrò nel forte del passo; (b) esso re […] passò [il fiume] cum xii squadre; (d) se intrò nel dicto borgo; (f) essendo le fantarie nostre allo dicto passo et intrati in certa parte delo dicto burgo; (g) mezo dela gente era intrata den-tro el burgo; (h) equitatum partem irrumpere in urbem iussit; (j) essendo ja intrati nel burgo; (m) fé paxare dudici squadre; (n) hostes […] ex loco ex pulisse.
Saccheggio aragonese del campo angioino; (a) dum miles noster in diripien-dis et trahendis captivis occupatur; (e) intendeano a rubare et mettere a sacco; (f) se dedero tucti alla roba; (g) tucti se donarono ad mectere ad sacco; (h) suburbia
Francesco Senatore236
quasi victores repente diripere cepissent; (j) tanta fu la cupidità de le gendarme de sacchizare; (m) fo comenzato intrare fra li allozamenti et sacchizare.
Reazione angioina (fanti sul Saretto, schioppettieri, cerbottane e cavalieri nel borgo) e rotta aragonese: (a) [miles noster] maiore vi hostium ingruente cedere compulsus est et ex victore victus haberi; (b) Li nostri virilmente forono alle mani cum li loro et li fanti nostri ad uno medesimo tempo cum li loro. El facto d’arme se apiciò per sì facto modo che li havemo rotti et frascasati; (c) [I fanti aragonesi sul Saretto] forono urtati et rotti dali fanti [angioini]; […] parve ad essi ducha Johanne et principe [di Taranto] de apizarse cum essi, et così se apizorono et gli ropero et frachassarono; (d) montorono a cavallo et rebuttarono […] et qui […] fo facto aspero facto d’arme […] forono spontati et tandem rotti; (e) preponendo certi schiopeteri et zarbatane se refecero insieme et forono contra li nostri et ropperoli per modo che la gente nostra è stata rotta; (f) intanto che li dicti inimici spontaro li nostri; (g) uscirono con vii squatre et rebuctaronoli indereto, per modo che fra loro medesimi se rompectero; (h) hostes […] de improviso adoriuntur […] quo-rum impetum cum rex turbatis ordinibus egrius substineret […] ecce quod repente ex victis victores sunt effecti; (i) per lo gran vantaggio del luocho che haveno inimici et forsia per disordene de le genti del re […] forono rotti; (j) se restrinsero et unirosi in tal modo che finalmente ruppiro; (m) sopragionse el conte Urso et d. �ercules con dui squatroni et ferono da valenti homini in mantenire la furia […], et in questo li fanti erano sul poggio [Saretto] se lassarono buctare giù, in modo che le zenti de re cominzaro a dare volta; profligatum […] fuisse ab hostibus.
Battaglia di S. Flaviano, sul fiume Tordino, 22 luglio 1460Sintesi dell’evento
Reagendo ad una provocazione di un capitano di Piccinino, Giulio da Ca-merino, che durante la consueta sortita per accedere all’acqua aveva invaso con 70 cavalieri l’area controllata dall’esercito pontificio-sforzesco (il cui campo era presso S. Flaviano, protetto dal castello di Montone e da una palude), due squadre sforzesche attaccano battaglia nel letto del Tordino (cart. 1). Lo scontro, a seguito della ritirata di Giulio, coinvolge progressivamente quasi tutti gli effettivi dei due eserciti (Piccinino era accampato su un rilievo, un miglio a sud dal Tordino e quat-tro a nord del Vomano). Dopo un violento combattimento nell’area controllata da Piccinino, presso un ponte, gli uomini d’arme pontificio-sforzeschi arretrano al di qua del corso d’acqua, dove la battaglia si disarticola in più luoghi, e dove essi, pur tenendo a lungo la posizione, subiscono forti perdite a causa della difficoltà di manovra e della pressione di fanti e balestrieri nemici, posti in posizione leg-germente elevata lungo una strada. Con il calare della notte, la notizia falsa della rotta provoca la fuga di alcune squadre alleate. Il campo di battaglia è abbandonato prima dall’esercito di Piccinino, poi, con rituale suono di trombe, dall’altro.
La battaglia nelle corrispondenze diplomatiche 237
Fonti
a. A. Sforza e F. da Montefeltro a F. Sforza, presso S. Flaviano 23 luglio, ASMi, Sforzesco, 203, 241, copia (altra copia a 244).
b. A. Sforza allo stesso, ivi 23 luglio, ibidem, 203, 242. c. G. della Molara e G. Bianchi allo stesso, ivi 23 luglio, ibidem, 203, 243.d. Gli stessi allo stesso, ivi 23 luglio, ibidem, 203, 247 (in cifra). e. S. Malatesta al fratello, 23 luglio, riferita da A. Guidoboni, Venezia 28.VII,
ibidem, 347, s.n. f. A. Sforza a G. Agnesi, riferita da A. Guidoboni, ibidem.g. A. Sforza a F. Sforza, presso S. Flaviano 23 luglio, ibidem, 203, 242 (copie
interpolate a 24-26, 27-29 e in ASMn, Archivio Gonzaga, 2186, s.n.). h. G. della Molara allo stesso, ivi 27 luglio, ASMi, Sforzesco, 203, 49-50. i. S. da Spoleto allo stesso, ivi 27 luglio, ibidem, 203, 37/38-39/40, 41.
Definizione dei luoghi
Colle Magnone o colle Vraddo (posizione del campo di Piccinino): (g) de llà dal fiume in cima de uno monte molto alto; (i) il monte.
Letto asciutto del fiume Tordino: (a) uno fosso dove communamente se sole fare facto d’arme et che è termino a l’uno e a l’altro; (c) stando li inimici dal canto de uno fosso et li nostri da l’altro canto / in quattro luochi (g) nel piano […] pure gli sono alcuni fossi et machioni et lochi apti a fantarie / in doi et tri lochi […] nel mezo del piano dove è uno certo fosso, il quale ha però de molti passi da posserse passare, il quale fosso ne partì l’uno da l’altro, / quello passo; (i) uno fosso, che era quasi in mezo dal campo nostro, cioè dalla fortezza nostra.
“Territorio” di Piccinino nel letto del fiume Tordino: (c) dal canto de llà da l’aqua; (g) presso al fiume / de llà da uno fosso, chi è pure presso al campo nostro / de llà dal fosso; (i) al forte loro presso uno ponticello che gli è / una strada con uno limite un pocho bassa sotto la strada.
“Territorio” degli alleati nel letto del fiume Tordino: (c) de qua da l’aqua; (h) in su el passo dove fu mantenuta la pugna; (i) fora de le nostre fortezze, in una campagna presso a li inimici.
Fasi della battaglia e loro definizione
Reazione alla provocazione delle truppe di Piccinino: (g) Julio da Camerino […] [con] circa lxxx homini d’arme […] più volte temptò de farsi inanci più […], et così deliberassimo […] farce inanci […], che subito datagli una rebuf-fata et factoli fare indietro, li nostri se retrahessero […] Io ordinai fare venire quattro squadre, doe de llà da uno fosso […] et doe de qua; (i) passarono più oltre verso nui con buono numero de cavalli et de fanti assai, et per lo suo campo
Francesco Senatore238
se vedevano squatre armate alcune et calare il monte […] [Alessandro si lascia convincere] che andassero a darli una rebuffata.
Scontro nel letto del Tordino, in “territorio” di Piccinino, con iniziale suc-cesso degli alleati: (a) fo attaccato facto d’arme […] strectamente; (c) se apizò el facto d’arme […], li nostri passarono dal canto de l’inimici et li cazarono un gran-de pezo, et durò el facto d’arme dal canto de llà da l’aqua […]; tanto era el facto d’arme stricto; […] uno duro, aspro et crudele facto d’arme; (g) essendo rebutati quelli del signor Julio fin presso al fiume, li nostri non foreno sì prompti al redurse […]; fo forza fare inanci l’altre doe squadre che erano de llà dal fosso […]; et così fo necessario essere ale mano […]. Ma alcuno di nostri […] fece passare de llà dal fosso più squadre che non seria bisognato; (i) cacciaroli insino al forte loro presso uno ponticello che gli è.
Scontro nel letto del Tordino, in “territorio” degli alleati, che combattono in condizioni svantaggiose: (c) Li nostri se redussero poy de qua da l’aqua per ri-spetto dela fantaria de inimici […] et era tal volta che in quattro luochi se faceva facto d’arme; (g) [si faceva] facto d’arme in doi et in tri lochi, et ala fine l’una parte et l’altra se fermò nel mezo del piano dove è uno certo fosso, il quale ha però de molti passi da posserse passare, il quale fosso ne partì l’uno da l’altro, et benché loro facessero molte volte prova de volerce spontare da quello passo cum le fantarie loro, non gli fo mai possibile; (h) foreno rebutati li nostri in su el passo dove fu mantenuta la pugna; (i) dalla mani mancha era una strada con uno limite un pocho bassa sotto la strada, et da quella parte erano tucte o la maiore parte delle sole fantarie, le quali malagevolemente potevano essere offese da noi per respecto de quello limite.
Fuga di gente d’arme pontificio-sforzesche: (d) per uno disordine che cominciò dali ecclesiastici […] cominciorono ad caricare cariagi et mandarli via, et dreto ad loro molti deli nostri et de li altri fecero el simile; (g) de l’una parte et de l’altra fugi-rono con cariagi et cose loro, dubitando de non essere rotti; (h) credendose loro che la pugna non se potese mantenere, fugironno in campo, et fuzeresseno via.
Ritirata dei due eserciti, prima quello di Piccinino, poi quello pontificio-sfor-zesco: (a) loro partirono prima de nuy et a nuy remase la campagna. (c) poy se despizò l’una parte et l’altra; (e) rompé et frachassò el conte de Urbino e lo signore Alexandro; (f) et poy dispizate de nocte, et […] al conte Jacomo erano remaste le colline et ad nostri la campagna; (g) loro prima comentiarono a tirarse indietro et redurse. Noi deppoi anchora li stemmo lì per bon spatio, partendone poi cum soni de trombette, siché in conclusione el campo remase a noi.
Battaglia di Troia, 18 agosto 1462Sintesi dell’evento
Si veda il contributo di Armando Miranda in questo volume.
La battaglia nelle corrispondenze diplomatiche 239
Fonti
a. Autore non identificato a D. Carafa, presso Orsara 18 agosto, copia, Dispacci sforzeschi V, pp. 186-187.50
b. R. Sanseverino a F. Sforza, ivi 18 agosto, ibidem, pp. 187-188.c. A. da Pesaro allo stesso, ivi 18 agosto, ibidem, pp. 188-191.d. A. Sforza allo stesso, ivi 18 agosto, ibidem, 191-194.e. A. da Trezzo allo stesso, ivi 18 agosto, ASMi, Sforzesco, 209, 242-243.f. A. da Trezzo a B. M. Visconti, ivi 18 agosto, ibidem, 209, 240.g. T. di Girifalco a Isabella di Chiaromonte, ivi 18 agosto, copia, ibidem 209, 244.h. Ferrante a F. Sforza (A. Petrucci), ivi 19 agosto, in latino, Dispacci sforzeschi
V, pp. 194-195.
Definizione dei luoghi
Monte Cerchio di Magliano, sottratto agli angioini all’alba del 18 agosto: (a) una collina vicina al nostro campo; (b) uno monte fora del campo nostro circha doe miglia; (c) uno monte […] non molto forte; (d) a doi migli susi uno certo monte; (e) tre o vero quatro colli che intermediano de qua a Troia; (g) una collina vicina al nostro campo; (h) eminens quidam tumulus […] quod inter nostra illoru-mque castra medius interiacet.
Monte Verditolo, sottratto agli angioini dopo il primo attacco: (c) l’altro mon-te, più grande et forte; (h) mons qui post tumulum erat.
Luogo del primo scontro, nel letto asciutto del fiume Sannoro: (b) uno valone luntano dal dicto monte circha a uno miglio / uno valone fortissimo / quello passo; (c) passa[to] el fiume verso Troya / in dicto fiume / passo dove se facea il fatto d’arme; (d) de sotto al monte nel piano / de llà da una fiumara, che è fra Troya et questo tale monte / passo della fiumara […] assai strecto a passare; (e) uno fiume assucto che intermedia el piano de Troya / sul piano; (h) ad flumen quod planiciem interfluit / post ripam.
Luogo della prima manovra diversiva di Alessandro Sforza: (b) dui altri lochi; (c) da man senestra verso Troya, de lungo al passo […] circa mezzo miglo; (d) per un altro passo; (h) a superiore fluminis parte qua recto itinere […] ad Troiam itur.
Luogo del secondo scontro, sotto le mura di Troia: (a) appresso le mura; (b) soto el monte de Troya; (c) sotto Troya alla collina; (d) a meza la piaggia sotto Troya, […] salendo el monte […] suso alto al monte de Troya presso a la terra circha una balestrata et non più; (e) verso la terra, cioè verso Troya / cum desavantazo per lo sito montuoso de la terra, come vostra signoria sa; (g). al monte vicino ad Troya; (h) ad radices montis, ubi Troia sita est […] quo in loco nostris iniquus erat adscensus.
50. Nell’edizione si identifica erroneamente il Carafa come mittente, laddove si tratta del destinatario, come chiarisce la nota in calce, che va letta «Dirigitur domino Diomedi Carrafe». Dato il tenore della lettera, il mittente è senz’altro regnicolo.
Francesco Senatore240
Luogo della seconda manovra diversiva di Alessandro Sforza: (a) un monte alto davante Troya […] Questa ropta è stata in quello proprio loco et in quello modo che fo quella che dede lo signore re don Alfonso a li inimici suoi; (b) preso il monte chi sta contra la rocha de Troya […], il quale vostra signoria sa como sta; (c) quello monte che sta nante dicta porta de Troya; (d) monticello che è inanti la porta de la rocha de Troya […] inanti a la porta de Troya in cima del monte; (e) li furono strecti li passi intorno da ogni canto; (g) uno monte alto davante Troya; (h) e superiore loco dimicantes.
Fasi della battaglia e loro definizione
Conquista aragonese del Monte Cerchio di Magliano: (a) se conduxe nella dicta collina et tolsela; (b) li rebutamo giusa a schavizachollo (c) glelo tolsimo; (d) deliberamo spontareli […] presemo a furia el monte; (e) gli li tolsero tuti [i colli]; (g) tolsila [la collina]; (h) hostis ex tumulo deiectis.
Conquista aragonese del Monte Verditolo: (c) toglere l’altro monte; (h) ex monte hostes […] precipitatus […] fugere eos compulere.
Primo scontro, nel letto asciutto del fiume Sannoro: (b) fecimo uno bello facto d’arme; (c) se ruppeno de molte lanze, et durò lo dicto facto d’arme del fiume circa mezza hora; (d) fo facto uno gran facto d’arme; (g) de passo in passo facendose le nostre squadre innanti, et loro retrahendose; (h) aliquandum pugnatum est.
Gli angioini arretrano grazie alla prima manovra diversiva di Alessandro Sforza: (a) de passo in passo, facendose le nostre squadre inante et le loro re-trahendose, le rebuctaro; (b) li spontamo da quello passo; (c) inimici se voltarono indreto et se ritirarono come gente rotta; (d) forono spontati dal [p]asso della fiu-mara […] forono cacciati […]. togliendoli terreno, costegiandoli […] li strinsemo […] li redussemo; (e) se spinsero le battaglie nostre sul piano; (g) de passo in passo, facendose le nostre squadre innanti et le loro retrahendose, le rebuctaro; (h) compulere illorum equitatum terga.
Secondo scontro, sotto le mura di Troia: (a) fo facto un bon pezo facto d’ar-me; (b) fecero il suo perforzo et facessimo bellissimo facto d’arme; (c) se fece bellissimo facto d’arme, aspero et grande; (d) per loro se faceva una puncta mara-vigliosa; (e) facendose sempre facto d’arme cum loro et tollendoli continuamente terreno; (g) fo facto per un bon pezo facto d’arme; (h) certamen instauratum est.
Rotta angioina grazie alla seconda manovra diversiva di Alessandro Sforza: (a) quando vedero […] tutti se possero a rupta; (b) vedendo […] se missero in fuga; (c) como viddero […], se partirono più vilmente che se potesse dire; (d) gli callamo adosso […] li roppemo et fracassamoli tutti; (e) tanto li furono strecti li panni adosso da ogni canto che furono forzati intrarsene in la terra; (g) quando videro […] tutti se possero ad rutta; (h) facto impetu […] ex omni parte irruentes […] illos […] in fossas precipitavere.
Fig. 88. Atlante Geografico del Regno di Napoli di Rizzi e Zannoni, Napoli 1788, part.Fig. 89. Posizione degli accampamenti angioino e aragonese (schizzo del 26 ottobre 1461). Archivio di Stato di Milano, Sforzesco, 207, 226. Autorizzazione del 17/03/2011, prot. 1479/28.13.11, n. d’ordine 11/2011.
Figg. 98-101. Guglielmo Monaco, porta bronzea di Castel Nuovo. Napoli, Museo Civico di Castel Nuovo, pannelli: L’incontro di Ferrante con Marino Marzano presso Teano, Ferrante esce vittorioso dall’agguato di Teano, La battaglia di Troia: lo scontro sulle rive del torrente Sannoro, La battaglia di Troia: la presa della città.Fig. 102. Maestro del 1487 (Piero del Donzello?), La Partenza degli Argonauti. Hong Kong, The Mari-Cha Collection Ltd.