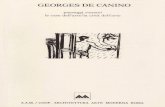A che punto è lo studio dell'arte rupestre della Valcamonica
Transcript of A che punto è lo studio dell'arte rupestre della Valcamonica
7Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19 ISSN 0393-0157© Museo delle Scienze, Trento 2012
A che punto è lo studio dell’arte rupestre della Valcamonica
Raffaele Carlo de MaRINIS1*, angelo FoSSaTI2**
1 Cattedra di Preistoria e Protostoria, dipartimento di Scienze dell’antichità, Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia
2 docente incaricato per l’insegnamento di Preistoria e Protostoria, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Via Trieste 17, 25121 Brescia, Italia
* e-mail dell’autore per la corrispondenza: [email protected]
RIaSSUNTo - A che punto è lo studio dell’arte rupestre della Valcamonica - Scopo di questo contributo è riassumere lo stato delle co-noscenze sull’arte rupestre della Valcamonica. La tradizione di arte rupestre della Valcamonica costituisce un patrimonio archeologico, artistico, etnografico e storico di inestimabile valore (dal 1979 inserito nella World Heritage List dell’UNESCO), non soltanto per la sua antichità ed ampia escursione cronologica, ma anche per la sua ricchezza tematica e iconografica. Le prime incisioni rupestri furono scoperte soltanto agli inizi del XX secolo, quando il geografo Walther Laeng segnalò i due massi di Cemmo, in seguito pubblicati da G. Marro e P. Graziosi. Molte scoperte di rocce con arte rupestre furono effettuate lungo entrambi i versanti della valle nel corso degli anni ’30 del XX secolo grazie all’opera di Raffaello Battaglia e di Giovanni Marro, quest’ultimo professore di antropologia all’università di To-rino, e in seguito anche da Franz altheim ed erika Trautmann (inviati in Italia dall’associazione culturale delle SS denominata Deutsches Ahnenerbe). Dopo la seconda guerra mondiale le ricerche sull’arte rupestre camuna furono riprese da W. Laeng coadiuvato da E. Süss. Tutti questi studiosi datavano erroneamente tutta l’arte rupestre della Val Camonica all’età del Ferro. Una svolta della ricerca si ebbe con l’arrivo in Valcamonica nel 1956 di emmanuel anati e con l’opera del Centro Camuno di Studi Preistorici fondato nel 1964. anati fu il primo ad avviare uno studio sistematico delle superfici rocciose istoriate, a delineare una classificazione stilistica delle figure, a utilizzare le sovrapposizioni per stabilire una cronologia relativa, ed infine a eseguire il rilievo manuale delle rocce con arte rupestre, applicando una metodologia che si perfezionerà nel corso della ricerca. altri studiosi, fra cui gli autori del presente contributo e i membri della Cooperativa archeologica “Le orme dell’Uomo”, in tempi più recenti hanno contribuito all’arricchimento della base documentaria con la scoperta di nuove rocce, al ripensamento delle metodologie di ricerca applicate all’arte rupestre, del sistema cronologico e del significato dell’arte rupestre. Purtroppo vi sono soltanto pochi casi di massi istoriati rinvenuti in situ nel corso di scavi scientificamente condotti o di superfici rocciose ricoperte da depositi archeologici in grado di fornire date ante quem per l’esecuzione delle incisioni. Inoltre, allo stato attuale non è possibile datare l’arte rupestre camuna mediante il radiocarbonio, come avviene in alcune regioni. La cronologia dell’arte rupestre camuna si basa su metodi puramente archeologici: lo studio delle sovrapposizioni tra figure di differente stile che consente di tracciare un quadro dell’evoluzione dell’arte rupestre e l’identificazione di armi riconducibili a tipi noti dai contesti archeologici come ad es. i pugnali tipo Remedello. La classificazione stilistica rimane uno strumento fondamentale e il contributo descrive e discute tutti gli stili riconoscibili nell’arte rupestre della Valcamonica, da quello geometrico lineare a quello naturalistico. Anche la presenza di alcuni temi particolari può contribuire a meglio definire la cronologia assoluta. Ad esempio, l’introduzione dell’arte del cavalcare in Italia agli inizi dell’età del Ferro costituisce un importante riferimento cronologico per l’inizio dello stile IV, quando per la prima volta compaiono figure di cavalieri armati di lance che inseguono un cervo. L’analisi delle armi dei guerrieri dello stile IV fornisce ulteriori elementi di chiarificazione cronologica: ad es., gli scudi sono costantemente rotondi od ovali nella prima età del Ferro, più o meno rettangolari nella seconda età del Ferro. Il con-tributo affronta anche il complesso problema del significato dell’arte rupestre camuna, con la consapevolezza che le motivazioni dell’arte rupestre possono essere differenti a seconda dei periodi cronologici presi in considerazione.
SUMMaRY - The state of the rock art research in Valcamonica, Italy - The aim of this paper is to resume the state of the rock art rese-arch in Valcamonica, a valley in the Central eastern alps. The rock art tradition of Valcamonica constitutes an archaeological, artistic, ethnographic and historical patrimony of inestimable value (from 1979 inscribed in the UNESCO World Heritage List), not only for its antiquity but, above all, for the thematic and iconographic wealth. The first engravings were discovered only at the beginning of the 20th century, when the geographer Walther Laeng pointed out the two Cemmo boulders, later on published by G. Marro and P. Graziosi. Most discoveries were made during the 1930s thanks to the archaeologist Raffaello Battaglia, the anthropologist Giovanni Marro, and the German scholars Franz Altheim and Erika Trautmann (sent in Italy by the SS cultural association called Deutsches Ahnenerbe). after the World War 2 the research work was again undertaken by W. Laeng helped by Emanuele Süss. All these scholars were (wrongly) dating all the rock art of Valcamonica to the Iron Age. A more scientific comprehension of the different phases appeared after the arrival in Valca-monica, in 1956, of emmanuel anati and the works of the Centro Camuno di Studi Preistorici. other scholars, among them the present authors and the members of the Cooperativa archeologica “Le orme dell’Uomo”, in recent times contributed to the enrichment of the discoveries, to the rethinking of the methodologies adopted, of the chronological system and of the interpretation of the art. Unfortunately very rarely engraved boulders or rocks have been found sealed by archaeological layers during scientific excavations. Moreover it is not yet possible to date the rock art of Valcamonica using the aMS techniques applied in desert areas elsewhere. So the chronology of the rock art of Valcamonica is still based mainly on the study of the superimpositions between figures of different styles and/or on the identification
8 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
1. BReVe PRoFILo dI SToRIa deLLe RICERCHE
1. 1. I pionieri
La prima segnalazione scritta relativa all’arte rupe-stre della Valcamonica risale al 1914, un brevissimo accen-no ai massi di Cemmo dovuto a Walter Laeng nella prima edizione del primo volume della Guida d’Italia del TCI, de-dicato a Piemonte, Lombardia e Canton Ticino. dopo aver descritto Cemmo e la pieve di S. Siro, il paragrafo sulle escursioni sul fianco destro della valle fra Breno e Capo di Ponte, così si conclude: “In un campo che si incontra pri-ma di giungere alla Pieve, due grossi trovanti con sculture e graffiti simili a quelli famosi del Lago delle Meraviglie nelle alpi Marittime”1.
Soltanto 15 anni dopo, nel 1929, Giovanni Marro, professore di antropologia all’università di Torino, studierà il primo masso di Cemmo, dando alle stampe l’anno suc-cessivo (1930) un articolo che apre la serie delle pubblica-zioni sull’arte rupestre camuna (Fig. 1). Nel frattempo nel corso del 1930 anche Paolo Graziosi si recherà in valle per studiare il primo masso di Cemmo, ma già nel novembre dello stesso anno Marro coadiuvato dal collega Squinabol porterà alla luce il secondo masso di Cemmo. dopo la sua pubblicazione del 1931 Graziosi non si interesserà più per lungo tempo dell’arte rupestre della Valcamonica, mentre nel corso del 1931 il Soprintendente Ettore Ghislanzoni e Raffaello Battaglia, insieme all’assistente antonio Nico-lussi, effettuarono una serie di sopralluoghi che portarono alla scoperta di numerose località con arte rupestre lungo entrambi i fianchi della valle nei dintorni di Capo di Ponte2.
1 L.V.Bertarelli, 1914 - Guida d’Italia del T.C.I., vol. I, Piemon-te, Lombardia, Canton Ticino, Milano: 595. Per la storia delle scoperte e ricerche di arte rupestre in Valcamonica cfr. abreu Simoes de, Fossati & Jaffe 1988; de Marinis 1988; Brunod 1994; Brunod & doro 1991; Mar-retta 2005 e 2007; abreu Simoes de 2007; Villa 2007; Tarantini 2009; La Valle delle incisioni 2009, con un’importante documentazione iconogra-fica di documenti d’archivio. Non si può non osservare in questo volume un certo squilibrio tra lo spazio dedicato all’opera di anati e del Centro Camuno di Studi Preistorici, decisamente ridotto, e il periodo dal 1929 al 1956 ed altri temi minori di storia della ricerca, per non parlare poi degli sviluppi più recenti della ricerca.2 Battaglia 1933 e 1934.
I protagonisti di questa fase pionieristica nell’esplo-razione e nello studio dell’arte rupestre camuna furono quindi Marro e Battaglia. Il primo fu attivo per tutti gli anni ’30 e scoprì un numero rilevante di rocce con superfici ric-che di arte rupestre, alcune delle quali non sono state più ri-trovate se non in anni recentissimi3 (Figg. 2 e 3). Tra Marro e Battaglia si scatenò una polemica, a volte piuttosto pesan-te, sulla priorità delle scoperte e sull’analisi e interpretazio-ne dell’arte rupestre. L’approccio più scientifico fu senza dubbio quello di Raffaello Battaglia, i cui lavori appaiono ricchi di osservazioni interessanti e pertinenti, spesso ancor oggi valide, sulla distribuzione delle rocce incise in rela-zione alle formazioni geologiche della valle, le patine, il raggruppamento delle incisioni in diversi gruppi topogra-ficamente distinti (gruppo di Cemmo, gruppo di Sellero, gruppo di Cimbergo, gruppo di Paspardo), i soggetti prin-cipali, lo stile delle figure, schematico o seminaturalistico, l’escursione cronologica di quest’arte, gli influssi culturali denotati da certe raffigurazioni, come i cavallini di Geni-cai (Bedolina) e di Sura Naquane (Coren del Valento), che mostravano la conoscenza dell’organicità dell’arte classica, almeno per quanto riguarda il primo caso. Sfortunatamente, due punti dell’analisi di Battaglia erano gravemente erra-ti: 1. che le incisioni fossero state eseguite con strumenti metallici e più in particolare di ferro4; 2. che le più antiche incisioni risalissero alla prima età del Ferro per la presen-za di pugnali a lama triangolare e pomo semilunato con-frontati con le daghe attualmente definite di tipo Ponteca-gnano5. L’errore di datazione ha nuociuto gravemente alla cronologia e all’interpretazione dell’arte rupestre camuna e persisterà a lungo. dello stesso parere saranno Marro, Pia Laviosa Zambotti6, Franz altheim ed erika Trautmann (1938), Ornella Acanfora (1954), Emanuele Süss (1958), e ancora nel 1970 ottavio Cornaggia Castiglioni7.
1. 2. Le ricerche di Franz Altheim ed Erika Trautmann
3 Come ad es. la roccia del carro a quattro ruote di Paspardo, ritrovata nel 1999 da angelo Fossati. Cfr. Fossati 2007: 30 e ss., Fig. 26.4 Cfr. Battaglia 1934: 24-25: “è probabile (per non dire certo) che venissero usati istrumenti di ferro”.5 Battaglia 1934: 29-31.6 Laviosa Zambotti 1938: colonne 52-69.7 Cfr. Cornaggia Castiglioni 1970: 247. Cfr. anche il dibattito a p. 249 e ss.
among the figures of weapons clearly recognizable, as, e.g., the so-called Remedello dagger. The authors, in fact, still consider important the stylistic classification for the construction of a chronological frame of the art. The paper describes and discusses all the different types of styles that occur in the rock engravings, from the linear geometric to the naturalistic styles. a part from the style, also the presence of particular themes in the rock art can contribute to better define the chronology. For example the introduction of horse riding in Italy has for sure a chronological value: this occurred only at the beginnings of the Iron age, in fact the rock art of Valcamonica shows the presence of horsemen in the engravings of the linear geometric styles, at the beginning of the 4th style. also the analysis of the weaponry provides elements of chronological value: the shields, constantly round in the first Iron Age and ovals-rectangular in the Second Iron Age, give clear indication for the chronology of the warriors that are holding them. The interpretation of the rock art of Valcamonica is also discussed in the paper, with the awareness that the significance of the art can be different in different periods.
Parole chiave: arte rupestre, storia degli studi, Valcamonica, LombardiaKey words: Rock art, State of research, Camonica Valley, Lombardy
9Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
La scoperta di arte rupestre in Valcamonica non pas-sò inosservata agli occhi di Leo Frobenius, direttore dell’In-stitut für Kulturmorphologie di Francoforte sul Meno, noto studioso di arte preistorica ed etnografica, in particola-re africana. Nel 1935 Frobenius inviò in Valcamonica la fotografa e disegnatrice dell’istituto erika Trautmann. Nell’agosto e settembre 1936 una seconda campagna vide la partecipazione di E. Trautmann, M. Wayersberg, Ch. Pauli, Franz altheim, e per qualche giorno anche di Károl Kerényi8. Una terza campagna si svolse nel 1937, ma senza la partecipazione di altheim e della Trautmann9, che prose-guirono le ricerche per conto proprio, con il sostegno finan-ziario dei due gerarchi nazisti Hermann Göring e Heinrich Himmler e della Deutsches Ahnenerbe10. L’istituto diretto da Frobenius raccolse una documentazione comprendente fotografie, frottages ed acquerelli e produsse un’unica pub-
8 Cfr. altheim, Trautmann 1937: 86 e nota 32.9 La Trautmann era una protegée di Göring, con cui probabil-mente ebbe una relazione.10 Cfr. il caldo ringraziamento al Feldmaresciallo Göring e al Reichsführer delle SS Himmler in Altheim & Trautmann 1938: 12. Su tutta la vicenda cfr. il documentato libro della giornalista canadese specia-lizzata in archeologia Heather Pringle 2006. Sulla figura di F. Altheim cfr. Casadio 2007.
blicazione a firma di Maria Weyersberg (1938). Altheim e la Trautmann si occuparono più a lungo delle incisioni ru-pestri della Valcamonica, pubblicando a firma congiunta tra il 1937 e il 1943 sei lavori, che saranno in parte ripresi tra il 1950 e il 196111.
F. altheim (1898-1978) era uno storico della reli-gione romana e dell’antichità, e coltivava anche interessi filologici. Dal 1937 professore all’università di Halle, di-venne membro, insieme alla Trautmann, della Forschung-sgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe (Società di ricerca dell’eredità ancestrale tedesca), una sorta di associazione culturale delle SS che aveva lo scopo di dimostrare l’origi-ne ariana, vale a dire indo-germanica, della civiltà, fu inol-tre amico di Julius evola, insieme al quale scrisse alcuni articoli. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, riotte-nuta nel 1948 la cattedra di Halle, passò due anni dopo alla libera università di Berlino come professore di Storia anti-ca, dove insegnò fino al 1965, anno del suo ritiro. Altheim è stato il primo a pubblicare una fotografia della roccia 70 di Naquane, interpretando il grande personaggio con due corna sul capo come il dio celtico Cernunnos. Sulla scia di
11 Sulle campagne in Valcamonica dell’Istituto diretto da Leo Frobenius e di F. altheim ed e. Trautmann cfr. oltre ai lavori citati in nota 1 anche Tarantini 2009: 35-38 e 101-106.
Fig. 1 - Il masso Cemmo 1 è la prima fotografia di arte rupestre della Valcamonica pubblicata (da Marro 1930).Fig. 1 - Rock No. 1 of Cemmo, the first published rock carving of Camonica Valley (after Marro 1930).
10 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
Battaglia cercò di individuare le diverse fasi cronologiche presenti nell’arte rupestre camuna: una fase romana, una fase celtica, una fase di età arcaica e classica e infine la fase più antica riconducibile alla prima età del Ferro. Le inci-sioni rupestri camune erano quindi più recenti di quelle sud scandinave, con le quali tuttavia presentavano molti motivi in comune. di conseguenza per altheim gli autori dell’arte rupestre della Valcamonica erano senza dubbio di origine
indo-germanica. I Camunni appartenevano agli euganei, che avrebbero costituito parte del popolo delle terramare, immigrato in area padana dall’europa centrale. Successi-vamente, secondo l nota teoria pigoriniana, una parte dei terramaricoli migrò verso il centro della penisola italiana dando origine ai Latini e ai Falisci, mentre sotto l’incalzare dei Veneti sopravvenuti, gli euganei si ritirarono nelle val-late alpine. euganei e Latini erano quindi strettamente im-
Fig. 2 - Fotografia del carro di Paspardo sco-perto e pubblicato da Marro nel 1934.Fig. 2 - The Paspardo Wagon published by Marro in 1934.
Fig. 3 - Il carro di Mar-ro riscoperto nel 1999 a Vite, roccia 55 (foto a. arcà).Fig. 3 - The four wheeled wagon discovered by Marro and discovered again in 1999, at Vite, Rock No. 55 (photo by A. Arcà).
11Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
parentati ed entrambi discendenti dagli Indo-Germani del Nord. Questa in sintesi la “ricostruzione storica” elaborata da Altheim. Egli si interessò in particolare alle iscrizioni presenti sulle rocce, affermando a più riprese12 che la lin-gua denotata da queste iscrizioni doveva essere considerata indo-europea e appartenere al gruppo latino-falisco, tesi ripresa in seguito da G. Radke (1962). Nessun autorevole studioso di linguistica antica ha mai aderito a una simile tesi13, essendoci unanimità nel ritenere la lingua camuna affine al retico o una varietà definibile come retico occiden-tale14. a Paul Jacobsthal, esule in Inghilterra, dobbiamo una pungente analisi di alcuni aspetti dell’articolo pubblicato nel 1937 da F. altheim ed e. Trautmann15.
e’ abbastanza comico osservare che mentre gli studiosi tedeschi legati al nazismo facevano discendere la civiltà, compresa quella romana, dal Nord, gli studiosi italiani legati al fascismo ed appartenenti alla cd. scuola mediterraneista, di cui Marro era un esponente di punta, avevano una visione opposta e sostenevano il primato del Sud. entrambe le visioni erano impregnate di razzismo se-condo la nota formula del Kossinna “un popolo, una cultu-ra, una razza”16.
1. 3. Süss e la creazione del Parco di Naquane
dopo la II guerra mondiale gli studi ripresero a cura di due gruppi differenti, Giovanni Marro (con la sua allie-va S. Fumagalli) e Gualtiero Laeng, coadiuvato da Ema-nuele Süss, allora direttore del Museo di Scienze Naturali di Brescia. Questi ultimi formavano il cosiddetto “gruppo bresciano” che si appoggerà per le ricerche in loco, almeno dal 1954, a Giovan Battista Maffessoli (il quale ricordava di non aver mai conosciuto il Marro, morto nel 1952). Nel 1954 Süss compilò la mappa dell’area Naquane-Ronchi di Zir segnalandovi un centinaio di rocce incise (Süss 1956), area che l’anno successivo (1955) diventerà Parco Nazio-nale delle Incisioni Rupestri. L’idea di costituire un Parco Nazionale era già stata avanzata dal Bonafini nel 1932, ma non si era mai concretizzata. Le ricerche di Laeng e Süss sfociarono in una grande mostra presentata al castello di Brescia nel 1954, visitata da circa 80.000 persone, un vero successo per l’epoca. Laeng e Süss scoprirono negli stessi
12 altheim & Trautmann 1937, 1938, 1939, da ultimo altheim 1961. Le letture di altheim sono sistematicamente errate, poiché legge “u” il segno per “a”.13 Secondo V. Pisani 1964: 327-329, si tratta di un tentativo “del tutto fantastico”.14 Di fronte alle difficoltà poste dalla lingua delle iscrizioni ca-mune l’ipotesi di una lingua indo-europea si ripresenta periodicamente (cfr. Morandi e Martinotti). da ultimo Martinotti 2009.15 Jacobsthal 1938. dopo aver scritto che lascia agli studiosi competenti valutare le pesanti conclusioni per la storia dell’antica euro-pa (l’arte rupestre nordica, le lingue pre-italiche, le rune, le terramare, ecc.), Jacobsthal prende in considerazione l’analisi condotta da altheim e Trautmann sulla figura di Cernunnos, sui due cavalli di Genicai e di Sura Naquane, sulla “girandola” di Genicai, mostrando l’assurdità della interpretazione di quest’ultima come la lotta tra ercole e l’Idra, e della derivazione del cavallino di Sura Naquane dalle figurazioni della ceramica corinzia. 16 Cfr. ad es. Marro 1939. Marro fu uno dei pochi professori universitari colpito dall’epurazione dopo la fine della seconda guerra mon-diale.
anni le incisioni rupestri di Luine e pubblicarono qualche iscrizione preromana (Laeng 1956; Süss 1954, 1955). A fronte della grande messe di figure rinvenute e in parte pub-blicate non si può certo sostenere che l’approccio di Süss e Laeng avesse aggiunto qualche novità all’impianto crono-logico ed interpretativo pensato da Battaglia. Per essi l’ar-te rupestre rimaneva un fenomeno circoscritto all’età del Ferro, opera di una popolazione di stirpe ligure. Il maggior lavoro di Süss è un volumetto fotografico pubblicato dalla casa editrice Il Milione (Süss 1958), libretto che avrà gran-de fortuna e che venne ristampato ancora sino alle soglie degli anni ’80. Con l’entrata in campo di Anati sia il Süss che il Laeng terminarono le loro ricerche in Valle, ufficial-mente Süss per sopraggiunti impegni di lavoro, e Laeng per l’età avanzata: in realtà è possibile che percepissero la novità del diverso approccio scientifico dell’Anati.
Fig. 4 - Naquane roccia 57, particolare della superficie roccio-sa trattata con il metodo neutro nel 1990. e’ possibile osservare come il metodo consente di decifrare il palinsesto delle sovrappo-sizione là dove figure e sovrapposizioni siano numerose (Foto di Ludwig Jaffe).Fig. 4 - Naquane, Rock No. 57, particular of the rock surface treated by applying the “neutro” method in 1990. One can see how this method allows us to decipher the palimpsest formed by complex superimpositions, whereas the figures and the superim-positions between them are too numerous.
12 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
1. 4. Emmanuel Anati
Nell’inverno 1956 arrivò per la prima volta in Val-camonica un giovane di 26 anni proveniente da Parigi, dove studiava l’arte rupestre del Monte Bego alla Sorbona sotto la guida dell’abate Breuil e di Raymond Vaufrey. em-manuel anati era alla ricerca di confronti per il Bego e gra-zie alla conoscenza fatta con Maffessoli riuscì a vedere un buon numero di rocce incise. Negli anni 1957-1959 anati tornerà in Valcamonica effettuando quattro campagne di ricerca e nel 1959 discuterà con André Leroi-Gourhan la sua tesi di dottorato sulla grande roccia di Naquane (anati 1961). Fin dal suo primo lavoro, pubblicato nel 1958 nel Bullettino di Paletnologia Italiana, anati, pur tra alcune cautele, inizia a discostarsi dalle vedute correnti e a porre le basi per lo studio scientifico dell’arte rupestre camuna. In pochissimo tempo il giovane studioso rivoluziona le nostre conoscenze e apre nuovi orizzonti di ricerca. I punti fonda-mentali della sua impostazione, già acquisiti in quei primi anni di ricerche, sono i seguenti: - la sistematicità delle ricerche e l’analisi esaustiva
delle singole rocce con incisioni, non una selezione di figure più o meno interessanti;
- il rilievo manuale delle superfici istoriate, che si af-fianca alla documentazione fotografica; la metodo-logia del rilievo avrà una sua evoluzione che verrà illustrata più avanti;
- la classificazione stilistica delle figure, con la defini-zione di quattro stili principali (I-IV);
- l’analisi delle sovrapposizioni, al fine di comprende-re l’evoluzione degli stili;
- la datazione effettuata attraverso la comparazione di figure di armi e ornamenti con manufatti archeolo-gici pertinenti a precisi contesti cronologici e cul-turali;
- l’interpretazione delle composizioni simboliche e delle scene di carattere narrativo-descrittivo.
Viene quindi abbandonata la cronologia tradizionale e respinta la datazione dei pugnali di Cemmo, Borno e Ca-pitello dei Due Pini alla prima età del Ferro. Classificazione stilistica e datazione verranno messe a fuoco sempre più dettagliatamente, con fasi e sottofasi (anati 1963, 1972), fino a una formulazione pressoché definitiva nel 1975. Con il lavoro di sintesi in occasione di una grande mostra alle-stita a Milano nel 1982 e la pubblicazione di un volume dedicato a Luine, sembra esaurirsi il carattere innovativo di un quarto di secolo di intense ricerche (anati 1982a, 1982b).
anati è stato ed è tuttora un grande organizzatore, a lui si deve la fondazione del Centro Camuno di Studi Prei-storici, la cui prima idea risale a Walter Laeng, che però non riuscì mai a realizzarla, ed inoltre l’istituzione dei Val-camonica Symposium. Grazie ad Anati, grande divulgato-re, l’arte rupestre della Valcamonica è diventata famosa in tutto il mondo. Per quanto possano esserci dissensi più o meno grandi, anche su punti molto importanti, nonostante diverse sue affermazioni possano oggi ritenersi del tutto su-perate, dobbiamo riconoscere che ci muoviamo ancora nel solco metodologico tracciato da anati e che lavoriamo in misura significativa all’interno di un mondo prodotto dalla sua opera.
Tralasciamo in questa sede di esaminare gli svilup-
pi successivi del pensiero di e. anati, poiché in buona parte esulano dal tema che stiamo trattando, concernendo soprat-tutto l’arte rupestre di tutti i continenti, in cui l’autore ri-tiene di poter individuare archetipi universali caratterizzati da un linguaggio organizzato in pittogrammi, ideogrammi e psicodrammi secondo una sintassi che è tipica dei diversi stadi dell’evoluzione socio-economica (Cacciatori arcaici, Raccoglitori, Cacciatori evoluti, Pastori e allevatori, popo-lazioni a economia complessa).
1. 5. Dal 1982 ad oggi
La mostra realizzata a Milano dal Centro Camuno nel 1982 rappresenta certamente un punto di arrivo del lavoro e del pensiero di anati e dei suoi collaboratori, e anche l’avvio di quella che sarà una stagione fortunata per la didattica dell’archeologia in Lombardia: si può dire che da allora quasi tutte le classi elementari e medie (ma an-che molte superiori) di tutte le scuole lombarde, soprattutto dai grandi centri urbani, siano giunte in Valcamonica per visitare il Parco di Naquane, contribuendo così alla cono-scenza dell’arte rupestre della Valcamonica presso il gran-
Fig. 5 - Un momento del rilievo della roccia 55 di Vite (Paspardo) con la figura del carro di Marro (Foto di A. Arcà).Fig. 5 - Tracing the Rock No. 55 of Vite (Paspardo), with the carv-ing of the wagon discovered by Marro (photo by Andrea Arcà).
13Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
de pubblico. La mostra ha anche evidenziato i limiti della ricerca di Anati, il quale non modifica il suo punto di vista dal 1975, cioè dal volume “evoluzione e stile”. Una delle critiche che qualcuno comincia a muovere anche dall’in-terno del Centro è la scarsa attenzione per il contesto cul-turale su cui si fonda la tradizione dell’arte rupestre della Valcamonica: in particolare suscita meraviglia il fatto che l’archeologia di campo abbia restituito pochi materiali dei periodi a cui dovrebbero far riferimento le incisioni rupe-stri: l’età del Ferro, il periodo a cui appartiene la maggior parte dell’arte rupestre della Valle o il Neolitico, a cui sono attribuite numerose figure di oranti schematici degli stili I e II. Sono gli anni in cui Francesco Fedele inizia gli scavi al Castello di Breno scoprendo un abitato neolitico riferi-bile alla terza fase della Cultura dei Vasi a Bocca Quadra-ta. altri collaboratori di anati quali Mila Simoes de abreu e Umberto Sansoni, a cui sono affidate le ricerche di arte rupestre in Valcamonica, decidono di istituire una sorta di Centro nel Centro, nasce così il dipartimento Valcamonica del CCSP (1987) che intende riportare più attenzione alle ricerche in Valle. durante la seconda metà degli anni ’80 è forte l’esigenza di considerare gli studi di arte rupestre come parte di una disciplina archeologica vera e propria. Si incontrano in quella occasione le esperienze di Raffaele de Marinis, da poco passato dalla Soprintendenza archeologi-ca della Lombardia alla cattedra di Preistoria e Protostoria dell’Università degli Studi di Milano e che aveva lavora-to soprattutto su due fasi dell’arte rupestre, lo stile III a e lo stile IV, con quelle di alcuni giovani studiosi che ormai consideravano conclusa l’esperienza al Centro Camuno di Studi Preistorici e che da lì a poco avrebbero costituito la Cooperativa archeologica “Le orme dell’Uomo”, sotto la guida di Angelo Fossati e Mila Simoes de Abreu. Si iniziò così un ripensamento critico sui metodi di studio, sulle tec-niche di analisi, catalogazione ed interpretazione dell’arte rupestre.
F. Fedele, conclusi gli scavi a Breno con un mostra ed una pubblicazione sul Castello (Fedele 1988, 2000), ini-ziò nuovi scavi nel sito di Anvòia di Ossimo, nei pressi del luogo dove nel 1955 era stato ritrovato il masso ossimo 1 (la baita d’asinino) e nel vicino sito di Pat. Inizialmen-te in concessione al Centro Camuno, lo scavo di Anvòia sarà poi affidato a Fedele, sempre in regime di concessione ministeriale, come cattedra di antropologia dell’Università di Napoli. Si tratta del primo scavo in cui monoliti istoria-ti dell’età del Rame sono stati rinvenuti in situ in Valca-monica (Fedele 1990, 1995, 2000, 2004, 2006). Mentre la Cooperativa Le orme dell’Uomo - tramite l’autorizzazione della Soprintendenza archeologica della Lombardia - ter-minava i lavori di rilievo già avviati da Mila Simoes de abreu a Capo di Ponte nel sito di Seradina a (roccia 12) e a Paspardo, In Valle (r. 1-3-4) e iniziava la lunga stagione di ricerche in questa importante area di arte rupestre, il dipar-timento Valcamonica, diretto da Umberto Sansoni, si de-dicava allo studio esaustivo dell’area istoriata di Pià d’ort (area attigua a quella di Sellero già studiata da Sansoni nei primi anni ’80), e quindi di Campanine di Cimbergo. at-tualmente questo gruppo di ricerca è impegnato nell’area di Pagherina-dos del Pater, in ideale collegamento con Cam-panine, dopo aver indagato negli scorsi anni anche le zone di Zurla e de I Verdi, non lontano da Naquane, area che resta ancora da studiare quasi integralmente. U. Sansoni e collaboratori si muovono all’interno dell’impianto cronolo-
gico ed interpretativo formulato da e. anati, senza grandi scostamenti. A nostro avviso ciò ha determinato un certo impasse nella ricerca, anche se è molto da apprezzare il fat-to che Sansoni e collaboratori non si siano limitati a imple-mentare il già ricco archivio del CCSP, ma si siano indiriz-zati a documentare e pubblicare in modo esaustivo i rilievi delle rocce dei vari siti studiati (Sansoni 1987; Sansoni & Gavaldo 1995, Sansoni & Gavaldo 2009). La cooperativa Le orme dell’Uomo, invece, aveva realizzato - su incarico della Soprintendenza archeologica della Lombardia - ol-tre al rilievo della Rupe Magna di Grosio in Valtellina, poi integralmente edita (arcà et al. 1995), il rilievo di alcune rocce di Naquane: cioè le r. 6, 11, 23, 27, 35, 50, 57, 70, 73, 99, rilievi depositati ovviamente presso la Soprintenden-za Archeologica. Purtroppo la fine del progetto ha portato all’interruzione del lavoro di rilievo di Naquane, che rima-ne la maggiore lacuna nel campo degli studi di arte rupestre della Valcamonica.
Nel 1987 venne discussa presso l’Università Catto-lica di Milano, relatore il prof. de Marinis, una tesi sulle scene di aratura nell’arte rupestre della Valcamonica (d. Piombardi). Seguiranno altre tesi presso l’Università degli Studi di Milano, alcune dal carattere monografico su temi quali le figure di guerriero, la rosa camuna, le raffigura-zioni architettoniche, gli oranti schematici, gli influssi del mondo etrusco, le figure ornitomorfe, altre su singole rocce integralmente rilevate e analizzate (sei rocce di Foppe di Nadro, tre di Naquane, una di dos Cui, due di Bedolina, una di Redondo e una di Pescarzo). Frutto di queste tesi sono una serie nutrita di articoli17.
Nel 1990, l’inizio dei lavori di costruzione della nuova strada della Deria, portò in primo piano la neces-sità di documentare scientificamente alcuni siti con inci-sioni rupestri in pericolo di conservazione. Molte erano le aree a rischio: si scelse quella di ‘al de Plaha (Valle del-lo spiazzo), nel territorio comunale di Paspardo, dove le ruspe avevano più pesantemente operato. Venne pertanto avviata dal Comune di Paspardo un’indagine sistematica in quest’area, oggi genericamente denominata Vite-deria. Il Comune, consapevole dell’importanza del proprio pa-trimonio rupestre, affidò la campagna di documentazione alla Cooperativa archeologica “Le orme dell’Uomo”, con l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni archeolo-gici della Lombardia e l’accordo della Riserva Regionale delle Incisioni Rupestri, nel cui territorio le zone sono inse-rite. Tra il 1990 ed il 2006 sono stati evidenziati i seguenti siti con gruppi di rocce istoriate: “La ‘It”, “’Al de Plaha”, “La Bosca”, ”Bröscaroeula del diavol”, “Bial do le Sca-le”, “Dos Baitì”, “Deria”, “Castagneto”, “Val de Fuos” e sono state sistematicamente rilevate le aree di Vite-deria, dos Sottolajolo, In Valle. da segnalare il ritrovamento, nel dicembre 1992, delle prime pitture rupestri note in Valca-monica, lungo il Bial do le Scale (Fossati 1994). al di fuori della Riserva importanti per ricchezza figurativa i siti di Dos Costapeta, Dos Sulif e Gras delle Pegore, per un totale di più di 100 rocce incise con alcune migliaia di incisioni rilevate.
17 Cfr. Piombardi 1994; Ferrario 1994; Turconi 1997; Marchi 1997 e 2007; Farina 1998; Chiodi & Masnata 2004; Mailland 2005; arcà 2005; Tognoni 2007.
14 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
Non si deve dimenticare l’operato di un ricercatore locale a. Priuli che ha soprattutto contribuito allo studio di un’importante area istoriata: quella delle incisioni graffite di Piancogno (Priuli 1993). Gli altri suoi lavori sono impor-tanti soprattutto per la documentazione prodotta, ma troppo spesso non si possono condividere né le proposte cronolo-giche né quelle interpretative.
Negli ultimi anni ha acquistato un peso crescente l’attività della Soprintendenza archeologica della Lombar-dia, che in passato era stata praticamente assente dall’arena della ricerca scientifica. Concluso il rilievo di alcune rocce di Naquane ed approntata una nuova planimetria del Par-co di Naquane, progetto che era stato avviato dall’allora ispettore Raffaele de Marinis18 e proseguito dall’attuale di-rettrice Raffaella Poggiani, il ruolo della Soprintendenza si è soprattutto concentrato sull’opera di conservazione delle rocce incise e sulla sperimentazione di nuove tecniche di rilievo (fotogrammetria, laser scanner). Si deve a angelo M. ardovino l’avvio di una campagna di ricerca sistema-tica al fine di individuare le cause del degrado delle rocce istoriate. A questa ricerca si è affiancata anche la cataloga-zione IRWEB: si tratta di una catalogazione di roccia che, nella descrizione generale della roccia, tiene soprattutto conto delle differenti tipologie di danno che si possono ri-scontrare sulla superficie. A fronte delle diverse centinaia di rocce che è scritto siano state catalogate con questo si-stema, purtroppo solo una decina è visitabile on line. Si deve, infine, ricordare che il Ministero dei Beni Culturali ha affidato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia la stesura del Piano di Gestione del sito Unesco. Inoltre, Raffaella Poggiani ha condotto e sta ancora condu-cendo campagne di scavo nell’area dei massi di Cemmo e
18 Con il rilievo integrale della roccia 44 di Naquane e una nuova planimetria dell’area del Parco di Naquane.
in quella di Pat e Passagrop a ossimo, dove è subentrata a F. Fedele, che ha dovuto rinunciare a proseguire le sue ricerche. Questi scavi hanno portato all’acquisizione di un numero rilevante di nuovi monumenti istoriati dello stile III a e di una serie importantissima di dati sulle vicende di questi luoghi di culto nel corso del tempo (Poggiani Keller 2000, 2002a, 2002b, 2006).
2. La doCUMeNTaZIoNe
Fin dall’inizio delle sue ricerche anati aveva intro-dotto il rilievo delle incisioni rupestri. La sua metodologia si è affinata nel corso degli anni. Dapprima ci si limitava a colorare di bianco le superfici picchiettate per meglio evi-denziare le figure, un procedimento ampiamente adottato da altri ricercatori e in altri paesi. Inizialmente il rilievo era ef-fettuato a vista, ma ben presto si passò al rilievo a contatto su fogli trasparenti. Un progresso decisivo fu realizzato con l’adozione del trattamento delle superfici rocciose a contra-sto, il cd. metodo neutro, che costituisce a tutt’oggi il metodo migliore per la lettura delle incisioni rupestri là dove ci siano palinsesti di figure di difficile comprensione (Fig. 4). Questo metodo è stato vietato dalle competenti autorità preposte alla tutela, poiché il bianco caseina utilizzato, contenendo sostan-ze organiche, favorirebbe la crescita dei licheni.
La base documentaria è fondata sull’accuratezza del rilievo, cioè il disegno archeologico delle incisioni rupestri (Fig. 5). Vi sono state in passato incomprensioni a questo riguardo. Si dice spesso che il rilievo non sarebbe una tec-nica obiettiva. Vogliamo citare qui le parole di un noto ar-cheologo, andrea Carandini, che nel volume Storie dalla Terra (1981) scrive:
“Il disegno archeologico presenta l’ineguagliabile vantaggio di essere un misto di rappresentazione oggetti-va e di selezione/interpretazione soggettiva della realtà...Il disegno archeologico non è una rappresentazione più o
Fig. 6 - Nell’arte rupestre della Valca-monica coesistono arte figurativa e arte non figurativa.Fig. 6 - Figurative art and abstract art coexist in the Camunian Rock Art.
15Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
meno realistica della realtà, ma una raffigurazione più o meno realistica della realtà interpretata nelle sue compo-nenti e nelle sue relazioni fra di esse. E’ dunque un disegno scientifico...”(p. 106).
Carandini difendeva il disegno archeologico dall’uso non sempre appropriato della fotogrammetria. Potremmo forse ricordare queste definizioni a chi ancora sostiene che la documentazione fotogrammetrica e la re-stituzione laser debbano soppiantare il rilievo a contatto in quanto tecniche obiettive. In realtà il rilievo a contatto sta all’arte rupestre come il disegno tecnico archeologico sta ai manufatti della cultura materiale.
Il miglior effetto si ottiene in condizioni di buona visibilità delle figure da rilevare. Occorre cioè sviluppa-re il contrasto procurando la migliore luce radente. Se il sole non basta, o è scomodo recarsi sulle rocce di notte con apparecchiature di illuminazione artificiale, può esse-re utile la tecnica dello specchio, già usata in passato ma poi soppiantata dall’uso del metodo neutro. Il materiale migliore per il rilievo è il PVC (polivinilcloruro) nella for-ma laminare trasparente plasticizzata (Cristal). Si utilizza-no fogli in squadratura standard (52 x 72 cm) che uniti tra loro coprono l’intera superficie della roccia. Nel rilievo è bene segnalare con precisione le sovrapposizioni per iden-tificare le sequenze di istoriazione della roccia: questa è la base metodologica per creare le fasi. Una volta completa-to il rilievo è fondamentale la restituzione: si deve seguire una catena operativa digitale costituita da: 1) acquisizione (scansione) dei singoli fogli; 2) montaggio; 3) riduzione. La prima esperienza di restituzione vettoriale di rilievi di arte rupestre (1993) è stata l’area con rocce a coppelle di
Chiomonte - La Maddalena (To), lavoro eseguito per conto della Soprintendenza archeologica del Piemonte19.
3. La CLaSSIFICaZIoNe STILISTICa
La classificazione è alla base di qualunque ricerca di carattere scientifico, ma anche nel caso di espressioni grafiche figurative, geometriche o astratte di età preistorica o protostorica, che convenzionalmente consideriamo arte, l’analisi formale e la classificazione stilistica svolgono un ruolo fondamentale.
Nella definizione di uno stile può intervenire una certo grado di soggettività, inoltre secondo alcuni è pos-sibile che si utilizzassero convenzioni stilistiche differenti nella stessa epoca e nella stessa regione, e ciò inficerebbe alla radice il valore cronologico da attribuire a un deter-minato stile. Le cautele sono necessarie, ma a nostro av-viso è da respingere la svalutazione completa del metodo di datazione stilistica, sostenuta negli ultimi anni da alcuni autori, al punto di parlare di Post-stylistic Era, titolo di un convegno sull’arte rupestre tenutosi nel 1992 (Lorblanchet & Bahn 1993).
Il concetto di stile ha sempre svolto un ruolo centrale nella storia dell’arte. Lo stile indica le caratteristiche ricor-
19 Sulla metodologia di costituzione della documentazione non ci soffermiamo ulteriormente, perché il tema è stato recentemente trattato in maniera esaustiva: cfr. arcà, Casini, de Marinis & Fossati 2008.
Fig. 7 - Stile IV 1 (geometrico lineare a struttura elementare): scena di duellanti sulla roccia 12 di Seradina (foto di a. Fossati).Fig. 7 - Style IVth 1 (linear geometric style with simple structure): scene of duellists (fighters), Seradina, Rock No. 12 (photo by Angelo Fossati).
16 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
renti delle espressioni formali non soltanto di un singolo arti-sta, ma anche di una scuola, di una determinata regione o di una intera epoca culturale. Già la scuola di storia dell’arte di Vienna, in particolare grazie all’opera di alois Riegl (1901), aveva dimostrato che ogni epoca esprime un proprio Kun-stwollen, un “gusto” formale che accomuna i singoli artisti e che è riconoscibile come lo stile tipico di una determinata epoca. Nessuno può pensare seriamente che nel corso dello scavo di un deposito archeologico del Paleolitico superio-re sia possibile ritrovare una statuetta con le caratteristiche stilistiche dell’arcaismo greco o che restaurando una chie-sa medievale possano venire alla luce affreschi di uno stile paragonabile a quello degli impressionisti francesi del XIX secolo. Ogni artista è figlio della propria epoca e gli elementi costitutivi delle forme artistiche che egli crea sono frutto del-la tradizione entro la quale si è formato e della maggiore o minore originalità con cui le rielabora e le modifica. L’opera d’arte è quindi un prodotto storicamente determinato.
Il concetto di stile deve, quindi, continuare a rima-nere un valore centrale nello studio di qualsiasi fenomeno artistico, compresa l’arte cd. primitiva20 e quella preistorica.
20 oggi l’espressione arte primitiva è spesso sostituita da quella di arte etnologica o tribale.
Tuttavia, per quanto riguarda l’arte rupestre bisogna essere coscienti del fatto che sopratutto nel caso delle espressio-ni formali schematiche lineari le classificazioni stilistiche sono difficili, per non dire problematiche, e che determinati grafemi proprio per la loro struttura elementare si possono ritrovare in epoche e regioni diverse. Quando non è possi-bile operare una classificazione stilistica precisa, anche la datazione diventa particolarmente ardua. e’ questo il caso del cd. orante, motivo ampiamente diffuso nel tempo e nel-lo spazio, dal Neolitico del Vicino oriente all’età del Ferro europea, nonché nell’arte rupestre di diversi continenti.
L’arte rupestre della Valcamonica comprende arte figurativa e arte simbolica, non figurativa, vale a dire moti-vi geometrici quali cerchi puntati, cerchi raggiati, coppelle, stelle a cinque punte, la cd. rosa camuna, le cd. figure to-pografiche, le cd. palette (Fig. 6). I motivi geometrici puri non possono essere oggetto di una classificazione stilistica, quindi l’unica possibilità di datazione rimane l’eventuale giustapposizione a figure stilisticamente classificabili, con le quali si possa ipotizzare una qualche sorta di relazione, oppure l’eventuale sovrapposizione con figure databili in grado di fornire alcune indicazioni di massima.
L’arte figurativa può essere schematica o naturali-stica. In Valcamonica l’arte rupestre è un’arte fondamen-talmente schematica, che solo in qualche momento della sua traiettoria evolutiva perviene a esiti di carattere natu-ralistico.
all’interno dell’arte schematica è possibile ricono-scere diversi stili:
1.Stile geometrico lineare a struttura elementareGli esempi più numerosi sono offerti dai motivi
dell’orante, attribuito da anati agli stili I e II, motivo che presenta una grande varietà in tutta una serie di dettagli, e delle figure di duellanti (Fig. 7) o di cavalieri degli inizi dello stile IV21. Sono figure di schema semplice, in cui l’as-semblaggio di linee o di piccole superfici geometriche, con-sente di identificare il soggetto. Anche le figure antropo-morfe dello stile III a hanno carattere geometrico lineare, mentre le figure animali dello stesso stile hanno un corpo meno lineare, con una superficie più ampia, pur essendo comunque ridotte a uno schema geometrico.
Nello stile III A vi è un contrasto tra figure umane e animali, che hanno carattere essenzialmente geometrico, e figure di armi, come pugnali, alabarde e asce, che sono rappresentate in maniera più realistica, a volte anche con indicazione dei dettagli, circostanza molto utile per convin-centi confronti con reperti archeologici e una precisa deter-minazione cronologica. Lo stesso contrasto si trova ancora nel corso delle successive fasi dello stile III, ad es. sulla roccia del Dos di Costapeta. Qui abbiamo figure di oran-ti eseguite secondo uno stile geometrico elementare, che
21 Continueremo a utilizzare la suddivisione in quattro stili ope-rata da anati (I-IV), pur discostandoci dalla loro suddivisione in fasi e dalla stessa sequenza da I a IV proposta. Questo almeno fino a quando non sarà fatta ulteriore chiarezza sugli stili I e II. Il problema di cambiare etichette è sempre molto delicato. La definizione di stile III A per l’età del Rame è ormai sanzionato dall’uso, così come l’etichetta stile IV per l’età del Ferro, ma è indubbio che tutto ciò che sta tra III A e IV andrebbe etichettato in maniera differente e non III B-C-d. a questo proposito cfr. Fedele infra.
Fig. 8 - Stile IV 2: figura di guerriero della roccia 50 di Naquane, un buon esempio di stile geometrico complesso a elementi giu-stapposti e di prospettiva biangolare.Fig. 8 - Style IVth 2, warrior figure from Naquane, Rock No. 50: a good example of complex geometric style characterised by juxta-posed elements and biangular perspective.
17Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
si alternano con figure di lance eseguite a solco continuo, la maggior parte delle quali sono raffigurazioni precise, di tipo realistico22.
2 Stile geometrico complesso, a elementi giustap-postiSiamo ancora nell’ambito di un’arte schematica,
ma lo stile delle figure umane e animali può essere defini-to geometrico a elementi giustapposti: le diverse parti che compongono la figura esprimono l’essenziale del sogget-to rappresentato mediante giustapposizione delle diverse parti senza riprodurre l’effettivo andamento del contorno delle figure reali. Inoltre, nella figura umana ciascuna parte è vista sotto un angolo differente, secondo una prospetti-va biangolare: busto in veduta frontale, braccia in veduta frontale, testa in veduta frontale o laterale, armi impugnate in veduta frontale o laterale, gambe in veduta laterale, pa-rallele e allineate, fallo in veduta laterale, cioè ribaltato di 90° rispetto al busto (Fig. 8). È un sistema figurativo alta-mente codificato, frequente nell’arte schematica, ma anche, per es., nell’arte egizia.
Questo stile si incontra in tre fasi, IV-2, definibile come fase proto-naturalistica o semi-naturalistica, IV-4, fase dell’incipiente decadenza, e IV-5, fase della decadenza dell’arte rupestre camuna.
22 a questo proposito cfr. de Marinis 1994a.
Qui possiamo toccare con mano alcuni limiti e pro-blematicità della classificazione stilistica dell’arte rupestre camuna. A volte è possibile attribuire una figura di guer-riero alla fase IV-2 o alla fase IV-4, perché i soggetti im-pugnano armi che consentono una cronologia sufficiente-mente precisa. Gli armati del Dos Cuì impugnano spade a lama foliata e scudi concavi con grossi umboni fusiformi23, il guerriero della roccia 4 di In Valle impugna un’ascia-ala-barda e uno scudo rettangolare24. L’ascia-alabarda è un tipo caratteristico dell’ambiente alpino, in particolare retico, a partire dall’età medio La Tène, siamo quindi nella seconda età del Ferro, come è dimostrato anche dallo scudo. Le armi dei guerrieri del dos Cuì sono certamente della prima età del Ferro. Se compariamo tra loro le figure private degli attributi, sarebbe imbarazzante, sopratutto per chi non ha grande familiarità con l’arte rupestre camuna, assegnarle a una delle due distinte fasi cronologiche. Tuttavia, con-frontando minuziosamente le figure del Dos Cuì e di In Valle si possono rilevare significative differenze, ad es. nel primo caso sono evidenziati i muscoli rigonfi delle braccia e l’atteggiamento è molto dinamico, mentre a In Valle la figura del guerriero è molto rigida, e inoltre non esibisce più il fallo (Figg. 9-10). Senza grandi problemi è invece la
23 Cfr. arcà 2005, Figg. 13-14 e rilievo allegato, settore d.24 Cfr. de Marinis 1988: 149 e ss., Fig. 140; Fossati 1991: 45 e ss., Fig. 75.
Fig. 9 - armati di stile IV 2 da dos Cui e di stile IV 4 da In Valle roccia 4.Fig. 9 - Warrior of Style IVth 2 at Dos Cuì, and warrior of Style IVth 4 at In Valle, Rock No. 4.
18 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
distinzione tra lo stile IV 4 e IV 5, poiché nel IV 5, oltre a un notevole impoverimento delle tematiche che caratteriz-za questa fase, le figure degli uomini non presentano più la campitura interna del corpo, ma solo la linea di contorno25.
Nell’arte camuna sono presenti figure di stile geo-metrico a elementi giustapposti con una prospettiva plu-ri-angolare, la più lontana dalla realtà ottica (Fig. 11). Le troviamo per la prima volta sul masso di Cemmo 226, a Campanine verso la fine del III stile sulla roccia 427, ma con maggior frequenza nello stile IV-2 (Naquane rocce 57 e 47) e IV-3 (Naquane rocce 23 e 62). Si tratta sempre di figure di carri (Van Berg osterrieth 1972). In questi casi il soggetto è raffigurato come se fosse visto contemporaneamente da quattro lati e le differenti parti possono presentare un ribal-tamento di 180°. Questa convenzione stilistica non è esclu-siva della Valcamonica, ma si ritrova costantemente sia nell’età del Bronzo che nell’età del Ferro nel caso di figure di carri a due o a quattro ruote: sarà sufficiente richiamare l’anfora della cultura di Suciu de Sus da Vel’ké Raškovce
25 La fase IV 5, già accennata da de Marinis 1988: 153 come fase terminale dello stile IV 4, è stata meglio definita da Fossati 1991: 54 e ss., Fossati 1998.26 Van Berg osterrieth 1972: 29 e ss., Figg. 8-9; de Marinis 1994 b: 160 e ss., Fig. 101; Fedele, infra. Vi sono anche raffigurazioni un poco più antiche, su ceramica, nell’ambito della Trichterbecherkultur: cfr. Pig-gott 1983: 41 e Figg. 10-11.27 Van Berg osterrieth 1972: 76 e ss., Figg. 33-34; Sansoni & Gavaldo 2009: 160, 264, 270 e ss.
in Slovacchia, databile alla media età del Bronzo28, le raf-figurazioni su ceramiche hallstattiane sia occidentali che orientali29, la spalliera del divano di Hochdorf, tomba prin-cipesca tardo hallstattiana della fine del VI secolo a.C. (Ha d 2) (Biel 1985: 92 e ss., Fig. 54, Tavv. 25-28).
3. Stile naturalisticoVi sono immagini dell’arte rupestre camuna che
certamente hanno le caratteristiche di uno stile figurativo naturalistico e che caratterizzano la terza fase dello stile IV (de Marinis 1988: 147 e ss.; Fossati 1991: 32 e ss.). In que-ste figure non si osserva più quella sorta di assemblaggio di parti diverse tipico degli altri stili, ma le linee di contorno tendono a riprodurre in maniera conforme alla morfologia naturale i soggetti raffigurati, uomini e animali. Le diverse parti che compongono la figura sono organicamente rap-presentate con una linea di contorno fluida e continua (Fig. 12). Ciò non significa che si tratti di riproduzioni fotogra-fiche della realtà, al contrario si tratta sempre di immagini stilizzate secondo certe convenzioni, ma che comunque su-perano o tendono a superare i limiti dell’arte schematica.
Gli stili di cui abbiamo finora parlato sono quelli
28 Furmánek, Veliačik, & Vladár 1999: 100-101 e Fig. 42 n. 13; Furmánek in Età oro Carpazi: 123 n. 193; 178 (foto a colori).29 Piggott 1983: 116, Fig. 69 (urna da Sublaines); 150-151, Figg. 91 (da Sopron) e 96 (da Rabensburg). Nel libro di Piggott è reperibile un’ampia documentazione relativa alle figure di carri nell’arte rupestre di diverse regioni.
Fig. 10 - Confronto tra le due figure precedenti priva-te delle armi.Fig. 10 - Comparison be-tween the foregoing figures of warriors without the weapons.
19Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
più facilmente identificabili e in un certo senso più impor-tanti, perché permettono di costruire l’impalcatura della evoluzione dell’arte rupestre camuna. Tuttavia, è bene non dimenticare che in Valcamonica vi è una quantità tutt’altro che trascurabile di figure che sfuggono alle classificazioni finora proposte e che a maggior ragione sono di ancor più problematica datazione. Vi sono figure miniaturistiche, fi-gure caricaturali, figure incomplete. Quest’ultimo caso è tra i più difficili da indagare. In Valcamonica non è raro incon-trare figure incomplete, ad es. un corpo senza braccia o un corpo senza gambe, una casa senza corpo centrale e senza tetto, come se l’antico artista avesse abbandonato il lavoro intrapreso. Non è facile capire se si tratti di un’interruzione casuale o intenzionale. In questi casi si può sconfinare nel campo delle congetture incontrollabili.
Ricordo a questo proposito l’esempio della roccia 35 di Naquane. Verso il centro della roccia che si allunga per molti metri in direzione nord-sud, si trova la famosa scena del fabbro. Un fabbro sembra intento a forgiare un manufatto, forse un’arma, su un’incudine. alle sue spalle una figura più piccola appare senza braccia e ancora più in-dietro un guerriero solleva le armi verso l’alto. Tra il guer-riero e l’antropomorfo senza braccia si trova un’altra figura, con testa, braccia aperte e alzate, un accenno di gambe ma senza quasi il tronco30. In lavori divulgativi, questa scena è commentata come se al centro si trovasse un garzone di bottega che aiuta nella lavorazione, mentre l’arma in cor-so di lavorazione sarebbe destinata al guerriero posto all’ estremità sinistra.
Un medico, studioso di storia della medicina, Mario Tabanelli (1976), ha interpretato le figure umane incomple-te come esempi di mutilazioni degli arti, proponendo due ipotesi: soggetti sottoposti a mutilazioni per cause trauma-tiche nel corso di incidenti, azioni di guerra o episodi di caccia, oppure scene rituali o magiche nelle quali le figure
30 Cfr. anati 1982a, Figg. 90-92.
di “amputati” avrebbero avuto un significato particolare che comunque ci sfugge. Poiché il numero dei presunti am-putati è piuttosto elevato e sopratutto le mutilazioni appa-iono troppo gravi, Tabanelli propende per la seconda inter-pretazione. Ma il punto irrisolto rimane: si tratta di uomini mutilati o più semplicemente di figure iniziate e non finite? L’interpretazione che si tratti di figure di “amputati” non appare convincente alla luce della considerazione che così come esistono figure umane incomplete, riscontriamo figu-re incomplete di animali, figure incomplete di manufatti, sopratutto costruzioni e armi, figure incomplete di simboli come la cd. rosa camuna. Quindi si tratta di figure lasciate incomplete, probabilmente intenzionalmente, e non di al-tro. Secondo un’ipotesi formulata da G. Ragazzi (1992) si tratterebbe di “apparizioni” di “esseri trascendenti” di tipo ctonio. emergendo dalle rocce o dal terreno comparireb-bero incompleti accanto alle figure complete31. del resto figure incomplete sono note nella ceramica attica nel caso di apparizioni di divinità di fronte ad eroi. In ogni caso que-sta ipotesi non spiega il significato di zoomorfi, manufatti e simboli incompleti32. Hanno il medesimo significato delle figure antropomorfe o si tratta d’altro? Erano completate usando il colore?
La traiettoria stilistica percorsa dall’arte rupestre camuna a nostro avviso ha inizio con uno stile geometrico elementare, di carattere lineare, in seguito perviene a uno
31 Nelle tradizioni locali esiste anche la credenza che esseri tra-scendenti vivano nelle rocce incise: è il caso della cosiddetta “Sciurina dai pé de cavra” di esine (descritta cioè come una aquana dalle leggende più recenti: ha perso le caratteristiche della sirena e ha acquisito quelle di una figura demoniaca). Questa signorina dai piedi caprini viveva in una roccia che aveva un’orma zoomorfa. Per entrare ed uscire dalla roccia usava le sue zampe.32 Un interessante studio sulle figure incomplete nell’arte rupe-stre camuna dello stile IV è stato appena pubblicato e non abbiamo potuto tenerne conto: Morello 2009.
Fig. 11 - Figura di carro a quattro ruote della roccia 23 di Na-quane, un esempio di prospettiva plurian-golare.Fig. 11 - Rock carv-ing of a four wheeled wagon, an example of many-angular per-spective. Naquane, Rock No. 23.
20 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
stile “protonaturalistico”, che rientra ancora nell’arte sche-matica, e infine a uno stile naturalistico, per poi ritornare a un’arte schematica e terminare con una lunga fase di de-cadenza, in cui si accentuano progressivamente i caratteri dello schematismo elementare.
Se analizziamo questa traiettoria da un altro punto di vista, non più formale ma contenutistico, vale a dire ca-rattere simbolico oppure narrativo-descrittivo delle espres-sioni grafiche, una vera e propria svolta avviene non con il passaggio dallo stile geometrico lineare (IV-1) a quello protonaturalistico (IV-2), ma con il passaggio da un’arte simbolica (stile III) a un’arte narrativo-descrittiva, che si verifica con l’inizio dello stile IV, la cui prima fase dal pun-to di vista stilistico è ancora di carattere geometrico ele-mentare. Cambia, quindi, prima il contenuto iconografico e soltanto più tardi il modulo stilistico.
Nello stile IV il carattere descrittivo-narrativo di-venta predominante, ma non dobbiamo dimenticare che fino alla fine del ciclo camuno persistono manifestazioni di arte simbolica. Si pensi ai motivi della rosa camuna33, delle impronte di piede (Fossati 1997), delle composizioni di asce-alabarde di tipo alpino34 o di altre armi, ai moduli di coppelle, alle palette, etc.
Le composizioni dello stile III a costituiscono, per molti aspetti, qualcosa di diverso rispetto a tutta la rima-nente arte rupestre della Valcamonica. Come è noto, l’arte rupestre camuna, al pari di tante altre manifestazioni artisti-
33 Su questo motivo cfr. Farina 1998.34 Cfr. Van Berg osterrieth 1974. Sulle asce-alabarde cfr. anche Nothdurfter 1979: 82-84 e 89 Fig. 19 carta di diffusione.
che preistoriche, compresa l’arte parietale paleolitica, pre-senta alcune caratteristiche generali comuni: innanzitutto manca una delimitazione del campo figurativo, per cui le figure appaiono come se fossero disperse casualmente sulla superficie rocciosa, senza un riferimento a un limite che circoscriva la rappresentazione, e inoltre senza uno sfondo, o meglio lo sfondo su cui si stagliano le figure coincide con la stessa nuda superficie rocciosa. L’assenza di delimita-zioni del campo figurativo trascina con sé inevitabilmente alcuni problemi di lettura delle incisioni rupestri, quali la corretta comprensione delle associazioni delle figure tra di loro. L’integrazione spaziale e temporale delle figure dell’arte rupestre è un compito particolarmente arduo. Le figure possono essere isolate, giustapposte o sovrapposte. Il caso più frequente è la giustapposizione, fatto che di per sé non garantisce la relazione tra le due figure. “How are we to know that inscription and picture are contemporary?” scri-veva nel 1938 Paul Jacobsthal a proposito dell’iscrizione al di sopra della figura di un cavaliere di Genicai (Bedoli-na). Solo in alcuni casi i rapporti sono evidenti, per es. una figura di cavaliere che brandisce una lancia e davanti a lui un cervo in fuga, oppure un branco di cervi inseguiti da un cane, oppure due duellanti simmetricamente contrapposti. a parte questi casi in cui è facile riconoscere una scena, sta-bilire un sicuro rapporto tra le figure è sempre un problema di non semplice soluzione.
Al contrario, nel caso dello stile III A le figure sono eseguite su superfici ristrette già naturalmente deli-mitate dalla forma stessa del supporto e quindi abbiamo un ragionevole grado di certezza che le figure formassero una composizione unitaria, fatto che non può che facilita-re l’analisi e l’interpretazione. In questo caso la scelta del supporto interviene in funzione delle immagini da eseguire e il supporto svolge una funzione attiva come cornice della
Fig. 12 - Foppe di Nadro, roccia 6, scene di duello e di pugilato, un esempio classico di stile naturalistico (IV 3).Fig. 12 - Foppe di Nadro, Rock No. 6: scenes of duel and boxing, a classical example of naturalistic Style (IVth 3).
21Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
composizione.Inoltre, nelle composizioni dello stile III a coesisto-
no aspetti figurativi come le armi, gli animali, gli antropo-morfi, per certi versi anche il disco solare con i suoi raggi, e aspetti non figurativi, vale a dire figure geometriche non identificabili - se non in via del tutto ipotetica - con un sog-getto reale, ad es. il fascio di linee ricurve a U, il fascio di linee orizzontali o leggermente ricurve, interpretate come cintura, il cd. rettangolo frangiato, probabile mantello indi-catore di status elevato, cerchi o serie di cerchi concentrici, i cd. motivi pettiniformi. Come abbiamo già detto in pre-cedenza, coesistono uno stile geometrico elementare per le figure di uomini e animali e la raffigurazione realistica del-le armi. Quindi differenti stati figurativi possono coesistere nell’arte rupestre camuna, un fenomeno ben conosciuto in altre manifestazioni artistiche preistoriche, ad es. nell’arte paleolitica parietale.
Le figure di animali dello stile III A2 hanno carat-teri meno schematici e più naturalistici, qualche volta di-namici. Forse si potrebbe parlare della ripetitività di uno schema o di una certa stilizzazione nella realizzazione di queste figure. Ad es., le figure di camosci a file nel masso ossimo 7 oppure i cinghiali dello stesso masso e di ossimo 8 sembrano avere caratteri naturalistici35. Certamente sono stilizzati. Lo stile delle figure degli animali di Ossimo 5 appare, invece, schematico e lineare36.
e’ possibile individuare dei “maestri” di arte rupe-stre? Nell’arte rupestre dell’età del Ferro molte scene di duello sembrano decisamente ripetere uno schema coreu-tico ben consolidato, come è possibile osservare frequente-mente nell’area di Paspardo. In realtà rappresentazioni che possono essere riferite stilisticamente a questa “scuola” o a un singolo artista si trovano anche a Naquane e a Foppe di Nadro, e in altre località ben note per la numerosa presenza di arte rupestre dell’età del Ferro. Si tratta di scene in cui duellanti con il caratteristico giro del braccio sono rappre-sentate secondo uno stile naturalistico che farebbe pensare all’opera di un singolo artista o a quella di una “scuola” che doveva essere attiva tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. Si osservano, in queste scene, due contendenti simmetricamente contrapposti impugnanti piccoli bastoni e paracolpi o minuscoli scudi. a volte essi sono accompagna-ti anche da un terzo personaggio armato allo stesso modo, forse un terzo duellante in attesa di combattere col vincito-re o pronto a supportare uno dei due contendenti. Spesso figure incomplete sono associate ai duellanti, si tratta dei cosiddetti “busti d’orante”, ossia antropomorfi di cui è stato inciso solo il busto con testa e collo, talvolta solo la testa, in altri casi la testa con collo e linea delle spalle. Spesso la testa ripete le fattezze di uno dei duellanti, come nella scena della roccia 15 di Vite-‘al de Plaha .
4. LA CRONOLOGIA
35 Le pietre degli dei, 1994: 188, Fig. 121 (P. Frontini); 189-192, Fig. 122 (a. Fossati).36 Casini & Fedele in Le pietre degli dei, 1994: 177 e ss., Fig. 109.
Come sempre in archeologia dobbiamo distinguere tra cronologia relativa e cronologia assoluta. La cronologia relativa dell’arte rupestre si costruisce mediante due proce-dimenti: la classificazione stilistica e l’analisi sistematica delle sovrapposizioni, che ci fornisce l’ordine secondo cui gli stili si sono succeduti gli uni agli altri. alla cronologia assoluta si perviene utilizzando tecniche di datazione scien-tifica, come per es. il radiocarbonio, o metodi puramente archeologici. Questi ultimi sono possibili quando ritrovia-mo un monumento di arte rupestre, per es. un masso inci-so, ancora in situ e accompagnato da un contesto culturale di datazione nota, oppure quando una superficie rocciosa istoriata è stata ricoperta da un deposito archeologico, che fornisce quindi una data ante quem per l’esecuzione delle incisioni.
Per l’arte rupestre della Valcamonica sono precluse molte possibilità di datazione che in altri casi di arte prei-storica vengono utilizzate. ad es., nessuna datazione diretta è possibile, trattandosi di figure eseguite a picchiettatura oppure a incisione a tratto sottile, filiforme, più raramen-te a solco continuo, a polissoir. Le datazioni dirette sono possibili soltanto nel caso di pitture realizzate con pigmenti contenenti sostanze di origine organica quali il carbone di legna, il sangue o collanti vegetali o animali. Come è noto, dal 1990 ad oggi le datazioni dirette tramite aMS si sono moltiplicate ed hanno apportato cambiamenti a volte mino-ri, a volte molto rilevanti al quadro cronologico dell’evolu-zione dell’arte paleolitica parietale.
R. Bednarik ed altri ricercatori hanno sperimentato nuovi metodi di datazione diretta delle incisioni rupestri, ad es. nella valle del Côa, come quello basato sulla data-zione radiocarbonica dei materiali organici contenuti nelle accrezioni minerali che si formano sulle superfici roccio-se, e quello che utilizza la tecnica dell’analisi della micro-erosione. I risultati indicavano un’età da recente a molto recente per le incisioni rupestri (Bednarik 1995, Watchman 1995), che su base stilistica gli archeologi avevano asse-gnato a circa 18000 BP. Le asserzioni di questi ricercatori sull’età delle incisioni rupestri del Côa sono state sistema-ticamente demolite da un documentato intervento di João Zilhão (1995), che ha dimostrato la completa infondatezza della pretesa scientificità di queste analisi. Inoltre, successi-ve analisi da parte di altri ricercatori hanno dimostrato che le accrezioni minerali delle incisioni rupestri e delle super-fici rocciose del Côa non costituivano un sistema chiuso ed erano quindi soggette ad assorbimento di materiali organici di età più recente (Philipps et al. 1997; dorn 1997). Tutta-via, bisogna riconoscere che se applicato correttamente il metodo di datazione radiocarbonica delle patine potrebbe fornire risultati significativi. Il metodo è stato applicato con successo nella datazione della fase più antica delle incisioni rupestri di El-Hosh, nell’alto Egitto, a questo studio, pub-blicato su Antiquity, ha partecipato elena Marchi, della co-operativa “Le orme dell’uomo”37.
Per la datazione delle patine sono necessarie analisi mineralogiche e geochimiche, che stabiliscano se la pati-na si è formata per segregazione in superficie di elementi presenti all’interno della roccia, oppure se si è formata per
37 Huyge D., A. Watchman, de Dapper M. & Marchi E. 2001; sulle incisioni rupestri di El-Hosh cfr. anche Huyge D. cds.
22 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
accrezione di particelle di origine eolica. In quest’ultimo caso nel corso della formazione della patina possono rima-nervi intrappolate microscopiche fibre di origine vegetale, suscettibili quindi di datazione radiocarbonica mediante aMS. Naturalmente non tutti i campioni possono contene-re sufficiente carbonio per una datazione, di conseguenza è necessario procedere a campionature molto abbondanti. In Valcamonica questo tipo di analisi non è mai stata tentata. Inoltre, è bene ricordare che il metodo fornisce una data ante quem per l’esecuzione delle incisioni rupestri.
R. Bednarik al Côa in realtà non ha utilizzato la da-tazione radiocarbonica delle patine, ma quella detta “mi-croerosione” (usando lenti speciali da geologo) a cui nes-suno crede seriamente. Le prime datazioni radiocarboniche AMS sono state fatte al Côa da Alan Watchmann (1995), lo stesso studioso che ha eseguito le datazioni a El Hosh in egitto.
Fino ad oggi non è possibile datare l’arte rupestre della Valcamonica in base a un determinato contesto cultu-rale e stratigrafico. A parte un’unica eccezione, di cui parle-remo fra poco, in nessun caso le raffigurazioni incise sulle superfici rocciose all’aperto inamovibili sono state ricoper-te da depositi archeologici ben databili, che possano quindi fornire un termine ante quem per l’esecuzione delle ope-re stesse. Questo è un fatto che si verifica a volte nell’ar-te paleolitica oppure nell’arte rupestre del Sahara. Tra i tanti possibili esempi, ricordiamo quello dell’arte rupestre all’aperto della valle del Côa. Nella località di Fariseu una
superficie rocciosa verticale situata nei pressi della riva del fiume Pocinho e riccamente istoriata con figure incise di cavalli e bovidi, era parzialmente ricoperta da un deposito pleistocenico comprendente livelli di deposizione fluviale alternati a livelli di origine colluviale e alla sommità limi lacustri e colluvii di età olocenica38. Il livello antropico più antico conteneva un’industria proto-solutreana o gravettia-na e ricopriva il pannello con le figure animali incise, che quindi sono state eseguite verso il 21000 BP o non molto tempo prima, in considerazione della loro freschezza e del-la mancanza di patina. Lo stile delle figure è quello tipico della maggior parte dell’arte paleolitica del Côa e richiama fortemente lo stile III dell’area franco-cantabrica.
Le superfici rocciose istoriate della Valcamoni-ca sono rimaste fino ad oggi esposte all’aria aperta op-pure sono state rinvenute asportando depositi colluviali di origine molto recente, che non risalgono più indietro del Medioevo. Tuttavia, abbiamo un’eccezione, il caso del dos dell’arca, integralmente scavato da e. anati nel 1962. L’asportazione del deposito archeologico stratificato
38 Per il riparo di Fariseu cfr. Zilhão 2003, Mercier et al. 2006, con bibliografia precedente. I colluvii pleistocenici contenevano resti di insediamenti del Paleolitico superiore. Il più recente, datato verso 10 000 BP, era caratterizzato da un’industria litica di una facies locale del Mad-daleniano finale ed ha restituito anche un ciottolo appiattito di schisto con incisi su entrambi i lati motivi animali stilizzati e geometrici, che ricorda-no l’arte aziliana della Francia.
Fig. 13 - Figure di ca-valieri armati di lancia che inseguono un cer-vo, Seradina settore III, roccia 18. Stile IV 1.Fig. 13 - Horse riders equipped with spear, pursuing a stag, Se-radina, sector III, rock No. 18. Style IVth 1.
23Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
ha portato alla luce in alcuni punti una serie di incisioni rupestri, che sono poi state studiate e pubblicate nel 1969 da Giuliana Sluga. E. Anati nel resoconto pubblicato sugli scavi del Dos dell’Arca specifica che “in tre differenti luo-ghi si trovano strati archeologici con reperti in situ che co-privano rocce sulle quali erano incise figure rupestri. Tale ritrovamento fornisce dati supplementari per la cronologia dell’arte rupestre” (anati 1968: 46), ma purtroppo non vie-ne fornita l’indicazione di quali siano questi tre luoghi. La Sluga ha analizzato dieci rocce incise del dos dell’arca e scrive che “parte delle rocce si trovavano alla superficie, altre furono scoperte durante gli scavi…” (Sluga 1969: 9), ma anche in questo caso non viene specificato quali rocce siano venute alla luce grazie allo scavo. Nella pianta del dos dell’arca pubblicata dalla Sluga sono indicati i dieci punti con arte rupestre che cadono all’interno di quadrati di 25 m2 l’uno. Il materiale archeologico proveniente dal-lo scavo del dos dell’arca comprende essenzialmente due fasi cronologiche pre-romane, la media età del Bronzo e la seconda età del Ferro. Purtroppo lo scavo è stato condotto per tagli artificiali e non esistono sezioni verticali e neppure planimetrie di fase. La maggior parte dell’arte rupestre del dos dell’arca è costituita da maculae e mappe topografi-che, di una tipologia che si pone all’inizio dell’arte rupestre camuna, ma in alcuni casi vi sono figure di stile IV 2 (qua-drati 6N Z, 4N E-D) e nel quadrato 3S Z una figura di oran-te39. da quest’ultimo quadrato non sembra provenire mate-riale archeologico, probabilmente le incisioni si trovavano già esposte. diverso è il caso del quadrato 6N Z, dal quale provengono materiali dell’età del Bronzo e del Ferro40. Le due figure di duellanti di stile IV 2 occupano una super-ficie di 32 x 24 cm, mentre il quadrato è di 25 m2, quindi non avendo sezioni e planimetrie non possiamo sapere se queste figure fossero coperte soltanto dagli strati della se-conda età del Ferro o anche da quelli dell’età del Bronzo, ipotesi quest’ultima alquanto improbabile41. In questo caso possiamo asserire con un buon margine di probabilità che i duellanti di stile IV 2 sono anteriori al V secolo a.C.
La possibilità di una datazione in base al contesto archeologico può verificarsi nel caso dei massi incisi dello stile III a, quando siano stati rinvenuti in situ, come nel-lo scavo Fedele nel sito di asinino-anvoia ad ossimo, e successivamente nella vicina località di Pat. Non è stato possibile, almeno per quanto finora edito, ottenere datazio-ni da materiale archeologico accompagnante, mentre a Pat gli scavi condotti da R. Poggiani hanno portato alla luce un allineamento di una trentina di massi istoriati, alcuni abbattuti, altri ancora eretti in situ, e poco a sud tre cairns o tumuli, uno dei quali ha restituito materiale archeologi-co. Nella sua costruzione erano stati utilizzate due pietre
39 Cfr. Sluga 1969, Figg. 5, 15 e 16. La roccia più estesa, la n. 1, con molte figure di costruzioni e alcune figure di duellanti e cavalieri è al di fuori del castelliere.40 Cfr. anati 1968 per i disegni di parte del materiale. Uno degli autori (R.C. de Marinis) ha esaminato tutto il materiale dello scavo, allora conservato presso il Centro Camuno di Studi Preistorici, negli anni 1973-1974.41 Lo stesso Anati nella didascalia a una fotografia dello scavo di questo punto scrive “ritrovamento di arte rupestre sotto a uno strato di età del Ferro”. Cfr. anati 1982a: 61, Fig. 40 e didascalia a p. 60.
con incise una serie di mappe topografiche. La datazione è compresa tra 4820 ± 40 BP, data pertinente a un livello anteriore alla costruzione, e 3400 ± 70 BP, data ottenuta da un focolare posteriore alla costruzione. Il range cronologi-co che ne deriva è piuttosto ampio, da un minimo di 600 a un massimo di 1200 anni42, tuttavia i dati di scavo indicano che la costruzione di questi cairns o tumuli deve essere di non molto posteriore alla data più antica.
La stratificazione dell’area con l’allineamento di una trentina di massi comprende diverse fasi, pertinenti a numerosi focolari dell’età del Ferro (su base radiocarbo-nica), un colluvio con inclusa industria litica dell’età del Bronzo, un piano di frequentazione che ha restituito cera-mica a fori non passanti e una semiluna, e il piano di cal-pestio databile all’età del Rame (Poggiani Keller 2006). Lo scavo di Pat ha quindi fornito una conferma sostanziale alla cronologia dello stile III a già stabilita in base all’analisi delle raffigurazioni di armi (pugnali, alabarde, asce)43: - stile III a 1 - Remedello 2 (età del Rame II, ca.
2900-2500 BC) - stile III a 2 - Vaso Campaniforme (età del Rame III,
ca. 2500-2200 BC)Questa cronologia è in buona armonia con i dati pro-
venienti da altri complessi di monumenti eneolitici, come il Petit-Chasseur di Sion e St. Martin de Corléans44.
Preclusi, quindi, i metodi di datazione archeologica e radiometrica, per collocare nel tempo la maggior parte delle fasi dell’arte rupestre della Valcamonica, che non sia-no lo stile III a, dobbiamo utilizzare criteri esclusivamen-te stilistici. Il metodo stilistico consiste nel riconoscere i diversi stili presenti, determinarne la successione relativa in base alle sovrapposizioni, e poi datare le singole fasi in base all’analisi del contenuto stesso delle raffigurazioni.
Lo studio delle sovrapposizioni è stato condotto su una parte limitata della sterminata ricchezza documentaria dell’arte rupestre camuna. Basandoci su quanto finora pub-blicato e su una serie di dati inediti provenienti da un buon numero di tesi di laurea che hanno rilevato integralmente singole rocce, nonché dalla consistente documentazione frutto delle annuali campagne di rilevamento condotte dal-la cooperativa “Le orme dell’uomo”, è possibile affermare che le sovrapposizioni confermano la seguente sequenza cronologica degli stili:1. prime mappe topografiche2. stile III a 13. stile III a 24. stile III B-d (ingloba anche gran parte dello stile I-II
42 Le date calibrate a 2σ (95,4 % di probabilità) risultano rispetti-vamente 3700-3510 - data post quem - e 1890-1520 a.C. - data ante quem.43 a questo proposito cfr. i diversi contributi in Le pietre degli dei; Casini, de Marinis & Fossati 1995; de Marinis 2000.44 Cfr. de Marinis 2000: 185 e ss. e tabelle di calibrazione delle date 14C alle figure 22a e 22b.
24 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
secondo anati)5. stile IV-16. stile IV-27. stile IV-38. stile IV-49. stile IV-5
a queste fasi stilistiche bisogna assegnare una cro-nologia assoluta e come abbiamo già detto è possibile farlo soltanto ricorrendo allo studio dell’iconografia stessa, cer-cando di inserire le immagini nel contesto culturale di una determinata epoca45.
Per quanto riguarda lo stile IV, che globalmente corrisponde all’età del Ferro, i problemi cronologici sono più complessi rispetto a quelli dello stile III a. I punti si-curi sembrano sostanzialmente due. Il primo è la presenza di figure di cavalieri nello stile IV-1 (Fig. 13). Poiché la diffusione della cavalleria in Italia, nella regione alpina e nell’europa centrale avviene agli inizi dell’età del Ferro, non sembra possibile far risalire questo stile più indietro del IX-VIII secolo a.C.46.
Nello stile IV-4 abbiamo figure di guerrieri armati di asce-alabarde di tipo alpino e di scudo rettangolare di tipo celtico. Questi due elementi ci consentono di stabilire che lo stile IV-4 non può risalire più indietro della metà del IV secolo a.C.
Lo spazio cronologico disponibile per gli stili proto-naturalistico (IV 2) e naturalistico (IV 3) abbraccia quindi il VII-VI-V secolo a.C. Tutti gli elementi disponibili - spade a lama foliata, scudi a pelle di bue concavi verso l’esterno, elmi con grande lophos, alcuni confronti con il divano di Hochdorf e con l’arte delle situle - confermano questa cro-nologia, anche se la ricerca futura dovrà mettere a fuoco con maggiore precisione quando si sia verificato il passag-gio dallo stile IV 2 allo stile IV 3.
Bisogna riconoscere che nella maggior parte dei casi le figure di armi o strumenti, di elmi, di scudi non sono sufficientemente fedeli e precise da consentire una classifi-cazione di carattere tipologico e un confronto con gli ogget-ti reali noti dai contesti archeologici, a differenza di quanto si verifica nel caso dello stile III A, ad es. con i pugnali tipo Remedello o le alabarde tipo Villafranca. Quello che manca nelle figure dello stile IV è la precisione del dettaglio. A volte, però, ci sono eccezioni che permettono importanti puntualizzazioni di ordine cronologico. Ci riferiamo alla famosa scena di aratura della roccia 17 di Bedolina, attri-buita da e. anati al suo stile IV-C e datata agli inizi dell’età del Ferro, intorno all’850-700 a.C. (Fig. 14). In questa sce-na, in cui appare un nuovo tipo di aratro, l’aratro-vanga con bure ricurva perforata, tirato da una coppia di cavalli, è distintamente raffigurato il vomere, di dimensioni dilata-te rispetto al ceppo e a forma di vanga, di conseguenza si tratta di un vomere di metallo e necessariamente di ferro, essendo il bronzo inadatto alla bisogna. L’aratore è seguito da un gruppo di contadini che erpicano il terreno appena
45 In questo contributo non possiamo analizzare nel dettaglio tut-ti gli aspetti della cronologia assoluta dello stile IV, per cui rinviamo a de Marinis 1988 e Fossati 1991.46 Sulla diffusione dell’arte del cavalcare e della cavalleria cfr. la breve trattazione in appendice.
seminato con la zappa47. I più antichi vomeri in ferro in Italia sono stati ritrovati in due santuari del VI secolo a.C., Gravisca, l’emporio greco-etrusco di Tarquinia, e Bitalemi presso Gela in Sicilia, si tratta di due coppie di vomeri di aratro in ferro acciaioso, i più antichi finora conosciuti in Italia. L’estensione dell’impiego del ferro a tutti i settori dell’economia primaria, e certamente anche all’artigianato del legno e delle pelli, in Italia - e a maggior ragione nella regione alpina - non è anteriore al periodo orientalizzante, vale a dire al VII secolo a.C. Non solo, tutta la documenta-zione archeologica disponibile per la diffusione della me-tallurgia del ferro in Italia dimostra che la metallurgia del ferro si è diffusa progressivamente da sud verso nord con un certo décalage cronologico (de Marinis 2004). deve es-sere tenuto presente che nell’VIII secolo a.C. conosciamo ancora pochissimi manufatti di ferro sia a Bologna che a Este e a Golasecca. In conclusione la scena di Bedolina ha un termine post quem del 700 a.C., ma naturalmente po-trebbe essere più recente anche di qualche secolo. Soltan-to coniugando il dato di carattere generale sulla diffusione della metallurgia del ferro in Italia con lo stile della scena di aratura di Bedolina possiamo circoscrivere la datazione al VII-VI secolo a.C., tenendo anche presente che nell’arte rupestre camuna le scene di aratura sembrano mancare del tutto nelle fasi più recenti.
La cronologia assoluta dello stile IV che è possibile proporre alla luce delle conoscenze attuali è la seguente: - fase IV 1, IX-VIII secolo a.C. - fase IV 2, VII-VI secolo a.C. - fase IV 3, V - prima metà del IV secolo a.C. - fase IV-4, seconda metà IV - III secolo a.C. - fase IV-5, II - I secolo a.C.
5. IL SIGNIFICATO DELL’ARTE RUPESTRE deLLa VaLCaMoNICa
L’arte rupestre della Valcamonica è certamente uno strumento prezioso per penetrare nel mondo ideologico e spirituale degli uomini della preistoria, ma le conclusioni a cui attualmente possiamo pervenire sono del tutto provvi-sorie e molto cammino deve ancora essere percorso dagli studi in materia. a complicare ulteriormente gli sforzi inter-pretativi è l’estremo schematismo di certe composizioni in alcuni periodi. Ci riferiamo ad esempio alle figure topogra-fiche più antiche, incise in una fase tra la fine del Neolitico e gli inizi dell’età del Rame. Se anche esse sono “leggibili”, nel senso che vi riconosciamo una rappresentazione più o meno schematica di territori, resta da comprendere perché siano state eseguite sulle rocce e cosa siano questi terri-tori. Sono descrizioni di luoghi veri e propri oppure sono rappresentazioni immaginarie di territori cosmologici? Se, come sostenuto da C. Renfrew (1976), i monumenti me-galitici attestano una nuova organizzazione del territorio, anche le figure topografiche incise sui massi-menhir della Valcamonica potrebbero assumere il medesimo significato, con funzioni rituali, a carattere sacro oppure pratico, cioè come un’attestazione di confini e di proprietà.
L’interpretazione data al fenomeno delle statue-
47 Cfr. anati 1982a: 303, Fig. 321.
25Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
stele, realizzate durante l’età del Rame in molte regioni dell’arco alpino e nella Lunigiana e Garfagnana, varia gran-demente a seconda delle scuole di pensiero: secondo alcuni studiosi i monoliti raffigurano capi viventi, per altri, invece, antenati illustri che nel tempo hanno acquisito valenza di-vina; alcuni vi leggono eroi divinizzati, mentre per altri si tratta di immagini di divinità vere e proprie. e’ quest’ultima l’ipotesi da noi sostenuta per l’interpretazione delle stele della Valcamonica48. L’idea che possa trattarsi di divinità è supportata, in particolare, dall’apparire di simbologie ben precise che attribuiscono alla divinità armata un carattere
48 Cfr. Le pietre degli dei 1994; Casini, de Marinis & Fossati 1995; de Marinis 1999 e 2000.
solare. Queste composizioni sono veri e propri mitogram-mi, secondo l’espressione felicemente coniata da andré Leroi-Gourhan, vale a dire un insieme strutturato di simboli (de Marinis 2000: 179 e ss). Nella fase datata all’orizzonte cronologico del Vaso Campaniforme (III a2) la simbologia solare assume più chiare sembianze antropomorfe, essendo raffigurata come un uomo con le braccia aperte ed il capo coronato dal cerchio solare raggiato, e spesso associato a figure di armi. Ciò significa che se il sole esprime una con-cezione di “sovranità cosmico-biologica”, nello stesso tem-po comincia a essere in relazione con la sovranità terrena nel momento in cui la società si avvia verso forme di mag-giore complessità e articolazione, con l’emergere in primo piano della figura del guerriero e l’affermarsi delle prime élites sociali. In seguito, nel corso dell’età del Bronzo le
Fig. 14 - Scena di aratura sulla roccia 17 di Bedolina (da anati 1982).Fig. 14 - Scene of ploughing. Bedolina, Rock No. 17 (after Anati 1982).
26 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
composizioni di armi, prevalentemente asce, sembrano rin-viare a una divinità celeste della folgore e della tempesta, mentre l’immagine del sole si trasforma nel motivo geome-trico della ruota raggiata, oggetto di adorazione. a partire dal Bronzo Finale è la cosiddetta rosa camuna, derivata dal motivo della svastica, il simbolo solare più diffuso, in fre-quente congiunzione con figure di guerrieri (Farina 1998). Il complesso di simboli che caratterizza un po’ in tutta eu-ropa l’età dei Campi di Urne e in cui dominano le protomi degli uccelli acquatici e la barca solare con prua e poppa ornitomorfe, sembra arrivare piuttosto tardi in Valcamonica (ad esempio sulla roccia 50 di Naquane) (Fossati 1991), ma vi rimarrà a lungo, fino alle soglie dei tempi storici, come dimostra il recente rinvenimento di un pendaglio bronzeo nel santuario di Minerva a Breno (Rossi 2005). Per tornare all’interpretazione delle raffigurazioni di armi incise sulle rocce inamovibili, durante l’età del Rame e l’età del Bron-zo, si è ancora lontani da una comprensione precisa: queste composizioni potrebbero anche rappresentare delle offerte sostitutive di oggetti reali, alla stregua di depositi votivi de-dicati alle divinità del luogo. e’ forse interessante notare come sia Foppe di Nadro che Luine siano in qualche modo collegate alla presenza dell’acqua, alla stregua dei depositi votivi veri e propri, spesso rinvenuti in laghi, sorgenti, fiu-mi. Le rocce 4, 21, 22, 23 di Foppe di Nadro, si collocano, infatti, lungo il corso di un piccolo torrente. anche Luine, in Valcamonica, si trova non solo nelle vicinanze di corsi d’acqua, ma anche delle sorgenti termali di Boario, il cui valore terapeutico probabilmente era conosciuto fin dai tempi preistorici. Una differente lettura potrebbe associa-re queste armi ai rituali iniziatici della gioventù maschile delle genti che vivono nell’area. Se, infatti, si ragiona dal punto di vista dei “generi” nell’arte rupestre, è spesso pos-sibile notare come sulle rocce si trovano segni maschili o femminili ben distinguibili tra loro, anche dal punto di vista della collocazione geografica. Per restare in Valcamonica, per esempio, l’area di Naquane (oggi Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri) durante l’età del Bronzo appare pregna di figure e simbologie femminili (ad es. i telai e le palette sulla Roccia 1; le scene cosiddette “funerarie” delle rocce 1, 32, 44; le palette sulle rocce 50 e 35), mentre Foppe di Nadro con gruppi di armi sulle rocce 4, 21, 22, 23, può essere letta come un’area omogenea e contigua di significa-to maschile. I medesimi ragionamenti si possono applicare anche ad altre zone dell’area alpina, per esempio la Valtelli-na, dove Tresivio può essere definita un’area maschile per la frequenza di figure di armi dell’età del Bronzo49, mentre a Grosio compaiono numerose raffigurazioni di carattere femminile.
Gli studi condotti negli ultimi anni nell’area di Pa-spardo hanno dimostrato che in realtà vi sono aree a presen-za “mista”, è il caso, ad es., della roccia 1 di dos Costapeta dove assistiamo al continuo sovrapporsi di figure femminili (oranti e palette) a figurazioni dal carattere eminentemente maschile (lance e armati schematici) e viceversa.
Tra le raffigurazioni del IV stile si riconoscono sce-ne di caccia, duelli rituali, sfilate di guerrieri, corse e dan-
49 Su Tresivio cfr. Sansoni, Gavaldo & Gastaldi 1999: 14 e ss., in particolare le rocce 1 e 2.
ze armate, case, carri, armi, strumenti musicali, scene di agricoltura, figure con forte valore simbolico (impronte di piedi, coppelle, rose camune, stelle, palette), immagini di divinità (assimilabili a Cernunnos, Esus e Taranis) e raffi-gurazioni topografiche. Come già detto più sopra in questo periodo prevale uno stile figurativo tendenzialmente rea-listico, pur nell’ambito di un’arte schematica, tanto che si può a ben ragione parlare di un’arte dal carattere descrittivo e quasi narrativo. Come ha scritto uno degli autori “nell’ar-te rupestre degli antichi Camuni appaiono dominanti alcuni temi che rivestono un ruolo centrale: la figura del guer-riero e quella del cervo” (de Marinis 1988). Tuttavia, se è vero che le figure di guerriero sono il tema dominante, è altrettanto vero che sono piuttosto rare le scene in cui gli armati sono impegnati in combattimenti veri e propri. Un’arte guerriera che, quindi, solo raramente rappresenta la “guerra”. I guerrieri forniti di armi pesanti sono più spesso raffigurati con le armi alzate in segno di esultanza, mentre nelle numerose scene di duello i contendenti si affrontano armati alla leggera, come per un evento sportivo; il loro ar-mamento consiste infatti in un bastone o una piccola spada e probabilmente in una piccola borsa di cuoio a protezione del braccio. Nelle scene i duellanti e gli arbitri (o istruttori) sono raffigurati vicini, i primi hanno una taglia inferiore rispetto ai secondi, elemento che induce a desumere che si tratti di individui di giovane età. anche le impronte e le calzature con lacci sembrano appartenere a ragazzi, essen-do di dimensioni inferiori rispetto a quelle di un adulto. Questi ed altri particolari hanno indotto a pensare che l’arte rupestre della Valcamonica durante l’età del Ferro possa essere considerata un insieme di immagini votive, incise in occasione di rituali di iniziazione, attraverso i quali la gioventù dell’aristocrazia guerriera locale accedeva alla so-cietà degli adulti50. Un altro segnale che mostra l’esistenza di differenze sociali proviene anche dalle incisioni rupestri in cui i cavalieri vengono scortati da scudieri, come quelle sulla roccia 27 di Foppe di Nadro (Ceto) e sulla roccia 60 di Naquane (Capo di Ponte). alcune scene sembrano illu-strare le prove a cui i giovani erano sottoposti: i duelli, le gare e le prove di equilibrio sul cavallo, le corse armate, le danze con la spada e la caccia al cervo erano probabilmente concepite come vere e proprie prove iniziatiche.
I Romani giunsero nella valle nel 16 a.C.; una le-gione (circa 6.000 soldati) guidata dal console Publio Silio Nerva, sottomise i Trumplini, i Camunni e i Vennonetes e cioè rispettivamente gli abitanti della Valtrompia, Valca-monica e (probabilmente) Valtellina, in un’unica rapida campagna militare. Questa notizia è attestata dal Tropaeum Alpium, un monumento costruito dall’imperatore augusto nel 6-7 d.C. a La Turbie (Francia), che ricorda il nome di tutte le popolazioni alpine vinte. L’interruzione della seco-lare tradizione incisoria della Valcamonica è causata forse dal processo di assimilazione alla cultura romana avvenu-to durante la seconda metà del I sec. d.C. (età Flavia). La perdita del potere da parte delle classi aristocratiche locali, i cui motivi tradizionali (rituali e non) avevano costituito
50 de Marinis R.C. 1988; de Marinis R.C. & Fossati a. 2004, “armi ed armati nell’arte rupestre della Valcamonica e della zona alpina”, in Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio ed il Po dalla Preistoria all’Alto Medioevo, a cura di Marzatico F. & Gleirscher P., Trento: 355-365.
27Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
il patrimonio iconografico delle incisioni rupestri, perdita dovuta alla crescente influenza economica, culturale e reli-giosa esercitata dagli insediamenti romani, in particolare da Civitas Camunnorum (odierna Cividate Camuno, una città di grande importanza con anfiteatro, teatro, terme e resti di numerosi edifici pubblici e privati di grandi dimensioni, come il tempio di Minerva, in cui è stata anche rinvenuta una statua della dea, copia di un originale greco del V seco-lo a.C.), determinò l’abbandono delle millenarie tradizioni locali tra cui anche l’uso di incidere sulle rocce levigate dai ghiacciai pleistocenici.
6. aPPeNdICe
Raffaele C. de MaRINIS
La dIFFUSIoNe deLL’aRTe deL CaVaLCaRe e deLLa CaVaLLeRIa IN ITaLIa e IN eURoPa CeNTRaLe
Poiché la comparsa di figure di cavalieri all’inizio dello stile IV costituisce un marker fondamentale nella cronologia relativa dell’arte rupestre camuna, la data della prima diffusione dell’arte del cavalcare e della cavalleria in europa centrale e in Italia diventa uno spartiacque cro-
nologico fondamentale anche per l’arte rupestre della Val-camonica.
Lo sviluppo dell’arte del cavalcare è stato certamen-te un fenomeno di grande rilevanza storica, poiché ha avuto un forte impatto sulle tecniche del combattimento grazie alla nascita della cavalleria, sull’economia rendendo possi-bile il nomadismo pastorale tipico del mondo delle steppe, sulla velocità dei trasporti e delle comunicazioni, sull’orga-nizzazione della società con la formazione di un’elite so-ciale caratterizzata dalla capacità economica di mantenere uno o più cavalli.
Mentre la domesticazione di capra, pecora, uro e cinghiale ha avuto origine nel Vicino oriente, al pari di quella del grano e dell’orzo, non è chiaro quando e dove sia stato domesticato per la prima volta il cavallo, se nelle steppe nordpontiche o in quelle dell’asia centrale.
Il cavallo domestico discende dal tarpan, che si è estinto in Ucraina verso il 1918, e dal takhi o Pony del-la Mongolia (Equus przewalski), il cui ultimo esemplare allo stato brado è stato avvistato in Mongolia nel 196951.
51 Secondo le ricerche basate sull’analisi del dNa mitocondriale il Pony della Mongolia non sarebbe all’origine del cavallo domestico: cfr. T. Jansen et al., Mitochondrial dNa and the origins of the domestic horse, PNAS, 99, 2002: 10905-10910. e’ un tema che, oltre a esulare dalla nostra
Fig. 15 - Figura di armato in stile IV 5 sovrap-posto a fodero di coltello tipo Introbio, che a sua volta si sovrappone a figure di armati ed animali in stile naturalistico IV 3. Roccia 24 di Pià d’ort (da Sansoni 1987).Fig. 15 - Warrior figure dating to the Style IVth 5. It overlaps a knife sheath of type Introbio, which covers warriors and animals dating to the naturalistic Style IVth 3. Pià d’Ort, Rock No. 24 (after Sansoni 1987).
28 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
agli inizi del ’900 quindici esemplari di Takhi furono al-levati negli zoo e nei parchi naturali e la loro discendenza assomma attualmente a un migliaio di unità. Le incertezze che concernono la prima domesticazione del cavallo sono causate dal fatto che la distinzione tra le ossa della specie selvatica e quelle della specie domestica è difficile e pro-blematica. a questo proposito sono stati formulati pareri contrastanti.
La datazione della domesticazione del cavallo e del suo uso come cavalcatura ad età molto antica è stata so-stenuta da molti autori, in particolare da d. Telegin e M. Gimbutas fino a D. W. Anthony e D.R. Brown52, che basan-dosi sul cranio di uno stallone di ca. 7-8 anni rinvenuto a dereivka, i cui due primi premolari mostravano chiari se-gni di usura dovuti all’utilizzo di un morso, hanno ribadito la tesi di guerrieri a cavallo nell’area delle steppe fin dal V-IV millennio a.C. Secondo questi autori i cavalli della cultura Sredny Stog, a cui appartiene il sito di dereivka (ca. 4400-4000 a.C.), non solo erano già domestici e costituiva-no la principale fonte di carne per quelle popolazioni, ma venivano anche cavalcati. Queste tesi sono state criticate da Marsha A. Levine (1999), che ha innanzitutto affinato gli aspetti metodologici del problema. La sua analisi dei resti faunistici di dereivka in Ucraina e del più recente sito di Botai nel Kazakhistan settentrionale (ca. 3600-2900 a.C.) ha condotto alla conclusione che i cavalli erano cacciati e non domestici. Inoltre, successive datazioni radiocarboni-che del grande cranio di dereivka, seppellito in una buca con i resti di due cani, ceramica e un frammento di corno di cervo interpretato in precedenza come un frammento di montante per un morso, hanno fornito un’età nettamen-te posteriore a quella del sito di dereivka, collocandolo nell’età del Ferro. Il pozzetto era stata scavato in età scitica, tagliando la stratificazione eneolitica53. Tuttavia, anthony e Brown continuano a sostenere che nelle steppe euro-asia-tiche il cavallo sia stato domesticato e venisse cavalcato almeno a partire dal 3500-3000 a.C. e questo in base a nuo-ve evidenze da Botai, dove sarebbe stata osservata l’usura dei premolari inferiori prodotta dall’uso prolungato di un morso�.
In questa sede ci interessa non tanto il problema di dove e quando sia stato domesticato per la prima volta il cavallo, quanto dove e quando si siano perfezionate le arti del cavalcare e utilizzate in campo militare formazioni di arcieri e lancieri a cavallo.
Le più antiche raffigurazioni di uomini che montano equidi provengono dal Vicino oriente, spesso si tratta di asini o onagri, a volte di cavalli. Sigilli, figurine, placchette fittili con queste raffigurazioni compaiono dalla fine del III millennio e sono relativamente frequenti nei primi secoli del secondo millennio a.C. Gli uomini che cavalcano sono sempre privi di armi e nudi, questa iconografia documenta uno stadio molto primitivo dell’arte del cavalcare, senza possibilità di applicazione pratica in campo militare o per la caccia, essendo del tutto insufficienti i mezzi di controllo del cavallo54. Il fatto che nella stessa epoca non vi siano
competenza, non ha attinenza con il problema di cui stiamo trattando.52 Cfr. anthony & Brown 1991. Per una storia del dibattito fra tesi contrapposte cfr. drews 2004: 1 e ss.; 31 e ss.53 Cfr. anthony & Brown 2000: 75 e tabella I.54 Su tutto questo aspetto cfr. drews 2004: 31 e ss.
raffigurazioni del genere nell’ Egeo, nell’area delle steppe, in egitto, in India e in Cina, rende improbabile che simili esperimenti fossero fatti anche in europa, anzi suona come conferma che si tratta di un fenomeno circoscritto al Vicino oriente. L’aggiogamento del cavallo è attestato con sicu-rezza solo a partire dal 2000 a.C. circa. Tutte le raffigura-zioni di carri a quattro ruote conosciute nel IV e III millen-nio a.C. (Bronocice, Bytyn, Boleraz, Züschen, Cemmo 2), mostrano carri trainati da una coppia di buoi dalle grandi corna, al pari dei carri delle tombe reali di Ur in Mesopota-mia (ca. 2600-2500 a.C.)55.
Il carro a due ruote trainato da una coppia di cavalli è documentato per la prima volta nella tomba di Krivoe ezero, in Ucraina, intorno al 2000-1900 a.C.56, e in seguito sulle stele delle tombe a fossa di Micene (XVII-XVI secolo a.C.) e sull’anfora di Vel’ke Raškovce in Slovacchia, data-bile alla media età del Bronzo (cultura di Suciu de Sus, cfr. nota 28). Con la diffusione del carro leggero da combatti-mento tirato da due cavalli compaiono per la prima volta anche i morsi e i sostegni laterali dei morsi. Iniziò allora “the age of chariot warfare” (drews 2004: 49), mentre le raffigurazioni di uomini a cavallo sembrano scomparire dall’area medio-orientale e si trovano sporadicamente solo in egitto. Nel Vicino oriente all’epoca della XVIII dinastia (XVI-XIV secolo a.C.) è presente una nuova razza di caval-li, di maggiori dimensioni, utilizzati per il tiro dei carri da combattimento. occasionalmente i cavalli potevano anche essere cavalcati, come dimostrano alcune raffigurazioni dell’antico egitto: se ne conoscono almeno undici, risalenti all’epoca di Horemheb, Sethos I e Ramses II57. Ricordiamo alcuni esempi: un rilievo del tempio di Karnak mostra una battaglia di Sethos I contro gli Hittiti, in cui alcuni nemici fuggono a cavallo58, i rilievi del Ramesseo, del tempio di Luxor e di quello di Abu Simbel concernenti la battaglia di Kadesh59 e i bassorilievi della tomba di Horemheb a Saq-qarah60. Inoltre, vi è la statuetta di un uomo a cavallo, in legno dipinto, conservata al Metropolitan Museum61. Tut-tavia, nell’età del Bronzo in europa, nell’area delle step-pe euro-asiatiche e nel Vicino oriente, non vi sono prove dell’esistenza di formazioni militari a cavallo, l’arma di prestigio per eccellenza era il carro da guerra leggero, di cui si trovano innumerevoli raffigurazioni e nell’area delle steppe anche sepolture. Non esiste quindi una cavalleria e le battaglie sono scontri di fanterie e di formazioni di carri leggeri a due ruote con auriga ed arciere. La stessa situa-zione si ritrova nella Grecia micenea. Il quadro si rovescia completamente con il passaggio all’età del Ferro, quando compaiono centinaia e centinaia di raffigurazioni di guer-
55 Per la documentazione cfr. Piggott 1983.56 Cfr. Cattani 2007: 88 e ss. e Fig. 6.57 Cfr. l’elenco in Hood 1953: 87 con relativa bibliografia.58 Cfr. drews 1993: 23, tav. I.59 Un messaggero egiziano armato di arco e faretra corre ad av-visare dell’attacco hittita, spronando il cavallo con un frustino: cfr. desro-ches Noblecourt 1997: 127, Fig. in basso.60 Martin 1991: 56 e ss., Fig. 23; cfr. anche Museo Bologna; 127, in basso (rilievo parietale KS 1889).61 Hayes 1959: 313, Fig. 195, datata alla tarda XVIII dinastia; de Rachewiltz 1958, tav. C foto a colori), datata all’inizio della XVIII dina-stia. La statuetta non ha contesto, sembra preferibile la datazione proposta da Hayes.
29Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
rieri a cavallo che attestano la diffusione dell’arte del ca-valcare e il declino dell’uso militare del carro a due ruote.
La più antica raffigurazione di un guerriero a caval-lo è su una stele di confine babilonese databile alla fine del XIII secolo a.C. Si tratta di un centauro alato raffigurato nel momento di scoccare la freccia (Sulimirski 1970: 395 e Fig. 90). L’immagine del centauro alato capace di tirare con l’arco mentre il cavallo è lanciato al galoppo può essersi formata soltanto in seguito alla conoscenza di popolazioni di nomadi a cavallo della regione delle steppe. e’ qui che si sono formate le arti del cavalcare e del combattimento a cavallo e il nomadismo ha potuto svilupparsi solo grazie al perfezionarsi della cavalcatura.
Le arti del cavalcare e le nuove tattiche militari del combattimento a cavallo si sono diffuse gradualmente dalle steppe verso il Vicino Oriente, la Grecia e l’Europa centra-le. La cavalleria compare fin dal XII secolo a.C. in Assiria, mentre arcieri a cavallo diventano frequenti nel IX secolo e poco dopo anche cavalieri armati di lancia62. In Grecia le più antiche immagini di cavalieri risalgono al XIII-XI secolo a.C.63. Dalla Grecia l’arte del cavalcare si è diffusa in Italia.
In Italia il cavallo compare come animale domestico a partire dagli inizi della media età del Bronzo. L’unico caso sicuro anteriore a questa età è quello di Querciola, un sito campaniforme o epi-campaniforme64, e questa attestazione è in accordo con quanto si verifica in molte regioni europee in cui il cavallo compare per la prima volta in età campa-niforme65. Tuttavia, per il lungo periodo dell’antica età del Bronzo non si hanno ulteriori attestazioni66. Nell’area delle palafitte benacensi e delle terramare si trovano anche so-stegni laterali in corno di cervo, che dipendono da modelli diffusi nel bacino carpatico già nell’antica età del Bronzo.
62 Cfr. i rilievi di Nabucodonosor I (1125-1104 a.C.), assurnasir-pal II (883-859 a.C.) e assurbanipal (668-631 a.C.). date secondo Livera-ni 1988, tabelle XX e XXI.63 Una figurina fittile di cavaliere è stata rinvenuta a Micene in un contesto, non chiuso, con molta ceramica del TE III B. Cfr. Hood 1953. Su un cratere da una tomba a tholos di Mouliana, nella Creta orien-tale vi è la figura di un cavaliere, mentre una statuetta fittile di uomo a cavallo proviene da Asine nell’Argolide: cfr. Müller-Karpe 1980, tav. 219 a 6-7 e d.64 Corridi 1997, Sarti 1997 e 1998.65 Per la diffusione del cavallo in Europa cfr. Bökönyi 1988: 230-296. In europa il cavallo domestico comincia a trovarsi in maniera significativa a Černavoda III, a Vučedol e nei contesti campaniformi, per poi diffondersi ampiamente nel corso dell’età del Bronzo.66 In Italia non sono state trovate ossa di cavallo in contesti del Bronzo antico. Il cranio di cavallo proveniente da Barche di Solferino, riportato spesso in letteratura come Bronzo antico, proviene da un sito che ha una lunga sequenza stratigrafica comprendente il Bronzo Antico ma anche il Bronzo Medio e il materiale non è conservato in associazione. Un pozzetto con resti di cavallo e due cuccioli di cane scoperto a Maccarese (Roma), sito appartenente al primo periodo dell’età del Rame, è molto probabile che sia nettamente posteriore all’abitato eneolitico. Infatti, il cavallo di Maccarese ha un’altezza al garrese intorno a 135,9 cm, che lo avvicina ai cavalli dell’età del Ferro (Curci & Tagliacozzo 2002). Inoltre, le tre datazioni eseguite a Oxford hanno dato un’età calibrata di 920-540 a.C. (95,4 %), 850-380 a.C. (95,4 %), 780-390 a.C. (95,4 %). Queste date sono state considerate errate (Carboni et al. 2002). La data di un carbone di Prunus dal pozzetto non fa testo, perché se nell’età del Ferro è stato sca-vato un pozzetto, ha intercettato e tagliato il livello archeologico dell’età del Rame.
I cavalli dell’area padana dovevano essere utilizzati per il traino di carri a due e a quattro ruote. Le raffigurazioni della roccia 4 di Campanine e della roccia 94 di Naquane, data-bili verso la fine dell’età del Bronzo, documentano l’aggio-gamento del cavallo per la trazione di carri leggeri a due ruote (Van Berg osterrieth 1972). Recentemente gli studi condotti sui resti scheletrici della necropoli dell’olmo di Nogara (VR) hanno prospettato l’ipotesi che nella media età del Bronzo fosse già praticata la cavalcatura. Secondo a. Canci lo studio degli attacchi muscolari mostrerebbe che i portatori di spada dell’olmo montavano regolarmente a cavallo (Salzani 2005: 304). Inoltre, lo studio delle tracce di ferite indica colpi di spada inferti dall’alto verso il basso. da qui a parlare di cavalleria nel Bronzo Medio il passo è breve. Per prima cosa dobbiamo osservare che le spade dell’olmo per la quasi totalità non sono spade adatte a me-nare fendenti dall’alto di un cavallo, bensì spade da stocco, adatte al combattimento individuale (cfr. de Marinis & Sal-zani 2005: 413-415). I colpi inferti dall’alto verso il basso possono essere stati inferti all’avversario caduto a terra, es-sendo già stato ferito nel corso del duello, oppure possono essere stati inferti dall’alto di un carro da combattimento a due ruote, la cui esistenza è documentata con sicurezza nella media età del Bronzo. Per quanto riguarda la prova che sarebbe fornita dall’ipertrofia muscolare a carico dei glutei e degli adduttori come conseguenza dell’uso prolun-gato del cavalcare, è preferibile sospendere il giudizio in attesa della pubblicazione, ma possiamo dire fin d’ora che l’ipotesi è completamente in contrasto con il quadro storico generale europeo, mediterraneo e vicino orientale. a que-sto proposito si può vedere quanto ribadito recentemente da drews 2004, basandosi sulla documentazione archeolo-gica, sull’iconografia e sulle fonti scritte, e cioè che soltan-to a partire da circa il 900 a.C. sia nel Vicino oriente che nell’egeo o nelle steppe dell’asia gli uomini diventarono abbastanza abili da maneggiare un arco, una spada o una lancia stando a cavallo67.
Le prime sicure attestazioni di armati a cavallo in Italia risalgono alle fasi antiche dell’età del Ferro. L’askos della tomba Benacci 525 di Bologna, a forma di toro, pre-senta sul dorso la figura di un cavaliere con elmo e scudo gettato sulle spalle. La tomba si data all’VIII secolo a.C.68. Alla stessa epoca risale una fibula in bronzo con arco confi-gurato a forma di cavaliere, dalla tomba Benacci 67 (Mon-telius 1895, Tav. 79: 5). a este il corredo della tomba Ran-di 14, databile all’VIII secolo a.C., ha un solo morso (cfr. Frey 1969, Tavv. 2-3.), si tratta quindi della tomba di un cavaliere, mentre nel coevo mondo villanoviano troviamo di norma una coppia di morsi, che indicano il possesso del carro e sono deposti come pars pro toto69.
La diffusione dell’ arte del cavalcare in europa si verificò intorno al IX-VIII secolo a.C. Nell’ Europa centra-le, nell’ area interessata dalla cultura hallstattiana, hanno giocato un importante ruolo in questo fenomeno gli influssi provenienti dalle steppe euro-asiatiche. Verso la metà dell’
67 Cfr. anche Liverani 1988: 651, e la recente messa a punto della questione da parte di Cattani 2007.68 Montelius 1895, tav. 81: 2; Museo Bologna, Fig. a p. 240. Gli spilloni di questa tomba sono pubblicati da Carancini 1975, nn. 2914, 3011, 3113.69 Cfr. la documentazione in von Hase 1969.
30 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
VIII secolo, nel corso del periodo Ha C 1, si registra la com-parsa di interi gruppi di nuovi oggetti metallici per i morsi, le briglie e i finimenti equini, la cui origine è da ricercare nel territorio dei Cimmeri, una popolazione stanziata a nord del Mar Nero e del Caucaso. Questi nuovi tipi di morsi non servivano per i piccoli cavalli della steppa, i tarpan, ma per cavalli di una nuova razza, di maggiori dimensioni. I nuovi tipi di morsi e finimenti equini, denominati tracio-cimmeri, hanno un’ampiezza in genere di 9-11 cm contro i 7 cm dei modelli precedenti e presuppongono quindi l’introduzione della nuova razza equina. Le analisi osteologiche, in parti-colare quelle effettuate da S. Bököny per l’Europa centrale e orientale, hanno confermato la comparsa di una nuova razza equina adatta alla cavalcatura nella prima età del Ferro (Bökönyi 1988: 250 e ss). I cavalli delle popolazioni scitiche della Russia meridionale e del bacino carpatico, i cavalli ritrovati nei kurgan (tombe a tumulo) della regione degli altai, quelli delle popolazioni tracie della prima età del Ferro in Bulgaria e in Romania e delle genti hallstattia-ne orientali della Slovenia erano di maggiori dimensioni e maggiore robustezza rispetto ai cavalli dell’età del Bron-zo e ai cavalli dell’età del Ferro diffusi nelle regioni più occidentali (Germania, Austria, Svizzera). La differenza di altezza al garrese era in media di 10 cm (Bököny 1988).
Se i resti di cavallo scoperti negli abitati apparten-gono sopratutto al tipo tarpan di dimensioni piccole, nel-le tombe dei personaggi di rango i cavalli, quando sono presenti, appartengono a una razza di grandi dimensioni. anche nelle tombe di Pazyrik negli altai i cavalli di mag-giori dimensioni erano riservati alle sepolture dei capi e dei personaggi di rango elevato, mentre in tombe di carattere più comune si trovano cavalli di razza piccola. In realtà le due razze equine sono convissute anche nell’asia centrale e nell’europa orientale.
dalle fonti antiche appare chiaro che le regioni originarie dei cavalli di razza grande sono quelle scitiche. Nella stessa Grecia i cavalli erano in origine piccoli, come appare dalla sepoltura con carro e cavalli di Cipro e dalle statuette di età geometrica, che per la maggior parte mo-strano tipi piccoli. Ma a partire dalla fine dell’ VIII - inizi del VII secolo vengono importati in gran numero i caval-li sciti, che danno luogo anche a un incrocio con i cavalli locali. La corsa a cavallo è introdotta nei giochi olimpici soltanto nel 648 a.C. Nel periodo arcaico e classico le rap-presentazioni figurate sulla ceramica e le sculture mostrano sempre cavalli di grandi dimensioni70.
In conclusione, riteniamo che non essendoci prove dell’esistenza di guerrieri a cavallo nell’età del Bronzo, le figure di cavalieri armati di lunga lancia dello stile IV 1 della Valcamonica non possano risalire più indietro del IX-VIII secolo a.C.
70 I migliori cavalli erano allevati in Tessaglia, come ricorda Simonide, autore di un trattato di ippologia. Comunque, nel mondo gre-co rimaneva alta la fama dei cavalli orientali e di quelli veneti. I cavalli veneti sono ricordati già in omero (Iliade, II, 851-852) e celebrati da al-cmane (partenio per agido, fr. 1, 46-51), Pindaro ed euripide (Ippolito, 231). Strabone (V,1, 4) ricorda che dionigi di Siracusa aveva fatto venire dal Veneto i suoi cavalli da corsa, tanto che i Greci conobbero la fama degli allevatori veneti e questa razza divenne per lungo tempo celebre presso di loro.
BIBLIOGRAFIA
abreu Simoes de M., 2007 - L’arte rupestre di Paspardo, una sto-ria delle ricerche. In: Fossati a. e. (a cura di), La castagna della Vallecamonica. Paspardo, arte rupestre e castanicoltu-ra. Paspardo: 3-16.
abreu Simoes de M., Fossati a. & Jaffe L., 1988 - Bibliografia sulle incisioni rupestri della Valcamonica e storia delle ri-cerche. Nadro: 1-32.
altheim F., 1961 - Neufunde aus der Valcamonica. In: altheim, F. (a cura di), Untersuchungen zur römischen Geschichte, I. Frankfurt am Main: 3-16.
altheim F. & Trautmann e., 1937 - Nordische und italische Fels-bildkunst. In: Die Welt als Geschichte, 3: 83-118, Figg. 1-33.
altheim F. & Trautmann e., 1938 - Neue Felsbilder aus der Valca-monica: die Sonne in Kult und Mythos. Wörter und Sachen. Zeitschrift für indogermanische Sprachwissenschaft, Volks-forschung und Kulturgeschichte, 19, N.F., I: 12-45.
anati e., 1957 - Nuove incisioni preistoriche nella zona di Pa-spardo in Valcamonica. Bullettino di Paletnologia Italiana, 66: 189-220.
anati e., 1960 - La civilisation du Val Camonica. arthaud, Paris (trad. ital. La civiltà preistorica della Valcamonica, Il Sag-giatore, Milano 1964), 245 pp.
anati e., 1961 - La grande roche de Naquane. archives de l’Ins-titut de Paléontologie Humaine, 31, Paris: 1-189.
anati e., 1963 - La datazione dell’arte preistorica camuna. Studi Camuni, II, Breno, 87 pp.
anati e., 1968 - Origini della civiltà camuna. Studi Camuni, III, Capo di Ponte, 76 pp.
anati e., 1972 - I pugnali nell’arte rupestre e nelle statue-stele dell’Italia settentrionale. archivi 4, Capo di Ponte, 107 pp.
anati e., 1975 - Evoluzione e stile nell’arte rupestre camuna. ar-chivi 6, Capo di Ponte, 147 pp.
anati e., 1982a - I Camuni alle radici della civiltà europea. Jaca Book, Milano, 32 pp.
anati e., 1982b - Luine collina sacra. archivi 8, Capo di Ponte, 235 pp.
Anthony D.W. & Brown D.R., 1991 - The origins of horseback riding. Antiquity, 65, 246: 22-38.
Anthony D.W. & Brown D.R., 2000 - Eneolithic horse exploita-tion in the eurasian steppes: diet, ritual and riding. Antiquity, 74, 283: 75-86.
Arcà A., 2005 - Archeologia rupestre in Valcamonica: Dos Cüi, un caso di studio. Rivista di Scienze Preistoriche, LV: 323-384.
arcà a., Fossati a., Marchi e. & Tognoni e., 1995 - Rupe Magna. La roccia incisa più grande delle Alpi. Parco delle Incisioni rupestri di Grosio, Sondrio, 2 voll.
arcà a., Casini S., de Marinis R.C., Fossati a. & de Marinis R.C., 2008 - arte rupestre, metodi di documentazione: storia, pro-blematiche e nuove prospettive. Rivista di Scienze Preistori-che, LVIII: 351-383.
Battaglia R., 1933 - Capo di Ponte. Nuove ricerche sulle rocce incise della Valcamonica. Notizie degli Scavi, IX: 201-239.
Battaglia R., 1934 - Ricerche etnografiche sui petroglifi della cer-chia alpina. Studi Etruschi, VIII: 11-48, tavv. I-XXII.
Bednarik R.G., 1995 - The Côa petroglyphs: an obituary to the stylistic dating of Palaeolithic rock-art. Antiquity, 69, 1995: 877-883.
Biel J., 1985 - Der Keltenfürst von Hochdorf. K. Theiss, Stuttgart, 172 pp.
Bökönyi S., 1988 - History of Domestic Mammals in Central and Eastern Europe. Budapest (2a ed., 1a ed. 1974), 596 pp.
31Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
Brunod G., 1994 - L’archeologia camuna e le scoperte di G. Marro attraverso la stampa dell’epoca. Notizie Archeologiche Ber-gomensi, 2: 121-128.
Brunod G. & Doro T., 1991 - Contributi per la storia della sco-perta delle incisioni rupestri della Valcamonica. Savigliano, 28 pp.
Carancini G.L., 1975 - Die Nadeln in Italien/Gli spilloni nell’Ita-lia continentale, Prähistorische Bronzefunde, XIII, 2, Mün-chen, 399 pp.
Carboni G. et al., 2002 - datazioni radiometriche e correlazio-ni con l’eneolitico dell’Italia centrale. In: Manfredini a. (a cura di), Le dune, il lago, il mare. Una comunità di villaggio dell’età del Rame a Maccarese: 255-260.
Casadio G., 2007 - Franz altheim: dalla storia di Roma alla storia universale. In: altheim F., Deus invictus. Le religioni e la fine del mondo antico. edizioni mediterranee, Roma: 7-47.
Casini S. (a cura di), 1994 - Le pietre degli dei. Menhir e stele dell’età del Rame in Valcamonica e Valtellina. Bergamo, 224 pp.
Casini S., de Marinis R.C. & Fossati a., 1995 - Stele e massi incisi della Valcamonica e Valtellina. Notizie Archeologiche Ber-gomensi, 3: 221-249.
Cattani M., 2007 - L’impiego del cavallo nelle steppe eurasiati-che, in ori dei cavalieri delle steppe. Collezioni dai musei dell’Ucraina. In: Bonora G.L. & Marzatico F. (a cura di), Ori dei cavalieri delle steppe: collezioni dai Musei dell’Ucraina, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo: 84-89.
Chiodi C. & Masnata e., 2004 - Incisioni rupestri tra età del Rame ed età del Bronzo sulle rocce 4 e 22 di Foppe di Nadro. Noti-zie Archeologiche Bergomensi, 12: 301-312.
Cornaggia Castiglioni o., 1970 - La datazione assoluta delle inci-sioni rupestri camune: precisazioni. In: anati e. (a cura di), Valcamonica Symposium, Capo di Ponte: 241-248.
Corridi C., 1997 - Archeozoologia. In: Sarti L. (a cura di), Quer-ciola. Insediamento campaniforme a Sesto Fiorentino. Mon-tespertoli: 21-32.
Curci a., Tagliacozzo a., 2002 - Il pozzetto rituale con schele-tro di cavallo dell’abitato eneolitico di Le Cerquete-Fianello (Maccarese, Fiumicino). In: Manfredini A. (a cura di), Le dune, il lago, il mare. Una comunità di villaggio dell’età del Rame a Maccarese. Firenze: 238-245.
de Marinis R.C., 1988 - Le popolazioni alpine di stirpe retica. In: aa.VV., Italia omnium terrarum alumna. Collana antica Madre, Milano: 105-155.
de Marinis R.C., 1994a - Problèmes de chronologie de l’art ru-pestre du Valcamonica. Notizie Archeologiche Bergomensi, 2: 99-120.
de Marinis R.C., 1994b - I massi di Cemmo. In: Casini S. (a cura di), Le pietre degli dei. Bergamo: 160-174.
de Marinis R.C., 1998 - Rapporti culturali tra Reti, etruria padana e Celti golasecchiani. In: Ciurletti G. & Marzatico F. (a cura di), I Reti. atti del simposio 23-25 settembre 1993, Trento: 603-635.
de Marinis R.C., 1999 - Chalcolithic Stele-Statues in the alpine Region. In: Gods and Herpes of the European Bronze Age. Thames & Hudson, London: 145-152.
de Marinis R.C., 2000 - Statue-stele, stele antropomorfe e massi istoriati dell’età del Rame nella regione alpina. In: Mailland F. (a cura di), Dei nella pietra. Arte e concettualità delle statue-stele. Quaderni di archeologia Lombarda, Milano: 161-196.
de Marinis R.C., 2004 - La metallurgia del ferro nella protostoria italiana. In: Nicodemi W. (a cura di), La civiltà del ferro,
dalla Preistoria al III millennio. Milano: 63-82.de Marinis R.C. & Fossati a., 2004 - armi ed armati nell’arte
rupestre della Valcamonica e della zona alpina, in Guerrie-ri, Principi ed Eroi tra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’alto Medioevo, a c. di F. Marzatico e P. Gleirscher, Trento 2004, pp. 355-365.
de Marinis R.C. & Salzani L., 2005 - Tipologia e cronologia dei materiali. In: Salzani L. (a cura di), La necropoli dell’età del Bronzo all’Olmo di Nogara. Memorie museo civico di storia naturale, Verona: 391-448.
de Rachewiltz B., 1958 - Incontro con l’arte egiziana. Martello, Milano, 209 pp.
desroches Noblecourt C., 1997 - Ramsete II il figlio del Sole. (ediz. originale Ramsès II, la Veritable Histoire, Paris, 1996), Milano, 360 pp.
dorn R.I., 1997 - Constraining the age of the Côa valley (Portu-gal) engravings with radiocarbon dating. Antiquity, 71, 1997: 105-115.
drews R., 1993 - The End of the Bronze Age. Changes in War-fare and the Catastrophe ca. 1200 BC. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 264 pp.
drews R., 2004 - Early Riders. The beginnings of mounted war-fare in Asia and Europe. Routledge, New York-London, 232 pp.
Farina P., 1998 - La “rosa camuna” nell’arte rupestre della Valca-monica. Notizie Archeologiche Bergomensi, 6: 185-206.
Fedele F., 1988 - L’uomo, le Alpi, la Valcamonica. 20 000 anni al Castello di Breno. La Cittadina, Boario Terme, 267 pp.
Fedele F. (a cura di), 1990 - L’altopiano di Ossimo-Borno nella preistoria. Ricerche 1988-90. edizioni del Centro, Capo di Ponte (1a ed. Bollettino del Centro Camuno di Studi Preisto-rici, 25-26: 173-359), 359 pp.
Fedele F., 1995 - Ossimo 1. Il contesto rituale delle stele calco-litiche e notizie sugli scavi 1988-95. La Cittadina, Gianico (BS), 82 pp.
Fedele F. (a cura di), 2000 - Ricerche archeologiche al Castello di Breno, Valcamonica. I: Notizie generali. Ceramica neolitica e calcolitica. Notizie Archeologiche Bergomensi, 8: 1-432.
Fedele F., 2004 - Monoliths and human skeletal remains: ritual manipulation at the Anvòia ceremonial site, Ossimo (Val Camonica, Italy). Notizie Archeologiche Bergomensi, 12: 49-66.
Fedele F., 2006 - Asinino-Anvòia: il Parco archeologico (con un contributo di a. Fossati), Cooperativa archeologica Le orme dell’Uomo, Cerveno, 67 pp.
Ferrario C., 1994 - Nuove ipotesi di datazione per gli oranti sche-matici dell’arte rupestre camuna. Notizie Archeologiche Ber-gomensi, 2: 223-234.
Fossati a., 1991 - L’età del Ferro nelle incisioni rupestri della Val-camonica. In: aa.VV., Immagini di una aristocrazia dell’età del Ferro nell’arte rupestre camuna, Milano: 11-71.
Fossati a., 1994 - Paspardo (BS), località Scale di Paspardo. Pit-ture preistoriche. Notiziario della Soprintendenza Archeolo-gica della Lombardia 1994: 67-68.
Fossati A., 1997 - Cronologia ed interpretazione di alcune figure simboliche dell’arte rupestre del IV periodo camuno. Notizie Archeologiche Bergomensi, 5: 53-64.
Fossati A., 1998 - La fase IV 5 e la fine della tradizione rupestre in Valcamonica. Notizie Archeologiche Bergomensi, 6: 207-225.
Fossati a., 2007 - L’arte rupestre a Paspardo, una panoramica te-matica e cronologica. In: Fossati a.e. (a cura di), La casta-gna della Vallecamonica. Paspardo arte rupestre e castano cultura. Paspardo: 17-33.
32 de Marinis & Fossati arte rupestre in Valcamonica
Furmánek V., Veliačik L. & Vladár J., 1999 - Die Bronzezeit im slowakischem Raum. M. Leidorf, Rahden, 203 pp.
Graziosi P., 1931 - Le incisioni preistoriche di Val Camonica. Ar-chivio per l’Antropologia e l’Etnologia, LIX, 1929: 105-112, tavv. I-IX.
Hayes W.C., 1959 - The Scepter of Egypt. A Background for the Study of the Egyptian Antiquities in the Metropolitan Mu-seum of Art. Part II, Cambridge, Mass, 416 pp.
Hood M.S.F., 1953 - A Mycenaean Cavalryman. British School of Archaeology at Athens, XLVIII: 84-91.
Huyge D., A. Watchman, de Dapper M. & Marchi E., 2001 - Da-ting egypt’s oldest art. aMS 14C age determinations of Rock Varnishes Covering Petroglyphs at El-Hosh (Upper egypt). Antiquity, 75: 68-72.
Huyge D., cds - The Fish Hunters of El-Hosh: Prehistoric Rock art of the Upper egyptian Nile Valley, Brepols Publishers, Turnhout (Belgio).
Jacobsthal P., 1938 - Celtic rock-carvings in Northern Italy and Yorkshire. The Journal of Roman Studies, XVIII: 65-69, tavv. IX-XI.
Kruta V. & Furmanek V. (a cura di), 2002 - L’età d’oro dei Carpa-zi. Ceramiche e metalli dell’età del Bronzo della Slovacchia. Fiorano Modenese, 184 pp.
Laeng G., 1956 - Una nuova zona di incisioni rupestri a Boario Terme. Commentari dell’Ateneo di Brescia, 1955: 207-226.
Laviosa Zambotti P., 1938 - Le civiltà preistoriche e protostori-che nell’alto adige. Monumenti dell’Accademia dei Lincei, XXXVII, I, n. pp.
Levine M. A., 1999 - Botai and the Origins of Horse Domestica-tion. Journal of Anthropological Archaeology, 18: 29-78.
Liverani M., 1988 - Antico Oriente. Storia, società, economia. Laterza, Roma-Bari, 1031 pp.
Lorblanchet M. & Bahn P. (eds.),1993 - Rock Art Studies: The Post Stylistic Era or Where do we go from here? Oxbow Mo-nograph 35, Oxford, 220 pp.
Manfredini a. (a cura di), 2002 - Le dune, il lago, il mare. Una comunità di villaggio dell’età del Rame a Maccarese. Firen-ze, 292 pp.
Marchi e., 1997 - La roccia 20 di Ridondo (Capo di Ponte, Valca-monica). Notizie Archeologiche Bergomensi, 5: 65-83.
Marchi E., 2007 - I grandi guerrieri e le figure di vasi nelle in-cisioni rupestri di Paspardo. In: Fossati a.e. (a cura di), La castagna della Vallecamonica. Paspardo arte rupestre e ca-stanocultura, Paspardo: 73-84.
Marretta a., 2005 - Una breve storia delle ricerche archeologiche alle Foppe di Nadro. In: Marretta a. (a cura di), Foppe di Nadro sconosciuta. Monza: 13-24.
Marretta A., 2007 - In cerca di “graffiti” alle Scale di Cimbergo. In: Marretta a. (a cura di), Sentieri del tempo. L’arte rupestre di Campanine fra Storia e Preistoria. Monza: 13-32.
Marro G., 1930a - Arte rupestre zoomorfica in Val Camonica. Ri-vista di Antropologia, XXIX: 3-36, tavv. I-VII.
Marro G., 1930b - La nuova scoperta di incisioni preistoriche in Valcamonica, Nota prima. Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, LXVI: 3-43.
Marro G., 1931 - La nuova scoperta di incisioni preistoriche in Valcamonica, Nota seconda. atti della Reale Accademia del-le Scienze di Torino, LXVI: 3-43.
Marro G., 1939 - Caratteri fisici e spirituali della razza italiana. Supplemento a Civiltà fascista, n. 4, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, Roma, 62 pp.
Martin G.T., 1991 - The Hidden Tombs of Memphis. Thames & Hudson, London, 216 pp.
Martinotti a., 2009 - Le iscrizioni preromane. In: Sansoni U. & Gavaldo S. (a cura di), Lucus Rupestris. Sei millenni d’ar-te rupestre a Campanine di Cimbergo. archivi 18, Capo di Ponte: 324-337.
Mercier N., Valladas H., Aubry T., Zilhão J., Joron J.L., Reyss J.L. & Sellami F., 2006 - Fariseu: first confirmed open-air Palae-olithic parietal art site in the Côa Valley (Portugal). Antiquity, 80, No 310, december 2006, 310 pp.
Montelius o., 1895 - La civilisation primitive en Italie. I. Italie septentrionale. Stockholm, n. pp.
Morello F., 2009 - Le figure incomplete nello stile IV di Valca-monica (età del Ferro). Studio preliminare. Bulletin d’Etudes Préhistoriques et Archéologiques Alpines: 167-183.
Müller-Karpe H., 1980 - Handbuch der Vorgeschichte, IV, Bron-zezeit. München, 3 voll.
Morigi Govi C. & Vitali D. (a cura di),1982 - Il Museo civico archeologico di Bologna. Bologna, 343 pp.
Nothdurfter H., 1979 - Die Eisenfunde von Sanzeno im Nonsberg. RGF 38, Mainz, 166 pp.
outram a.K., Stear N.a., Bendrey R., olsen S., Kasparov a., Zaibert V., Thorpe N. & evershed R. P., 2009 - The earliest Horse Harnessing and Milking. Science, vol. 232, no. 5919: 1332-1335.
Philipps F.M. et al., 1997 - Maximum ages of the Côa valley (Por-tugal) engravings measured with Chlorine-36. Antiquity, 71. 100-104.
Piggott S., 1983 - The Earliest Wheeled Transport from the Atlan-tic Coast to the Caspian Sea. Thames & Hudson, London, 272 pp.
Piombardi d., 1994 - Cinque nuove scene di aratura nelle incisio-ni rupestri della Valcamonica. Notizie Archeologiche Bergo-mensi, 2: 217-222.
Pisani V., 1964 - Le lingue dell’Italia antica oltre il latino. Rosen-berg & Sellier, Torino, 2a edizione, 378 pp.
Poggiani Keller R., 2000 - Il sito cultuale di Cemmo (Valcamoni-ca): scoperta di nuove stele. Rivista di Scienze Preistoriche, L: pp. 229-259.
Poggiani Keller R., 2002a - Capo di Ponte (BS), frazione Cem-mo. Pian delle Greppe: santuario preistorico dei Massi di Cemmo. Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, 1999-2000: 34-39.
Poggiani Keller R., 2002b - ossimo (BS), località Pat: area ceri-moniale e funeraria megalitica dell’età del Rame e insedia-mento dei Camunni. Notiziario della Soprintendenza Arche-ologica della Lombardia 1999-2000: 44-46.
Poggiani Keller R., 2006 - Santuari megalitici nelle valli lom-barde. In Pessina a. & Visentini P. (a cura di), Preistoria dell’Italia settentrionale. Studi in ricordo di Bernardino Ba-golini, Udine: 243-266.
Poggiani Keller R. (a cura di), 2009 - La Valle delle incisioni. 1909-2009 cento anni di scoperte, 1979 trenta anni con l’Unesco, Brescia, 298 pp.
Pringle H., 2006 - The Master Plan: Himmler’s Scholars and the Holocaust. (Trad. italiana Il piano occulto. La setta segre-ta delle SS e la ricerca della razza ariana, Landau, Torino, 2007), Hyperion, 480 pp.
Renfrew C., 1976 - Megaliths, territories and population. IV Col-loque Atlantique, 1975, Gand, n. pp.
Rossi F., 2005 - La dea sconosciuta e la barca solare. Una plac-chetta votiva del santuario protostorico di Breno in Valle Camonica, eT, Milano.
Salzani L. (a cura di), 2005 - La necropoli dell’età del Bronzo all’Olmo di Nogara. Memorie museo civico di storia natu-
33Preistoria Alpina, 46 (2012): 7-19
rale, Verona, 539 pp.Sansoni U., 1987 - L’arte rupestre di Sellero. Studi Camuni, 9,
Capo di Ponte, 112 pp.Sansoni U. & Gavaldo S., 1995 - L’arte rupestre del Pià d’Ort.
archivi 10, Capo di Ponte, 197 pp.Sansoni U. & Gavaldo S. (a cura di), 2009 - Lucus Rupestris. Sei
millenni d’arte rupestre a Campanine di Cimbergo. archivi 18, Capo di Ponte, 399 pp.
Sansoni U., Gavaldo S. & Gastaldi C., 1999 - Simboli sulla roc-cia. L’arte rupestre della Valtellina centrale dalle armi del Bronzo ai segni cristiani. archivi 12, Capo di Ponte, 212 pp.
Sarti L. (a cura di), 1997 - Querciola. Insediamento campaniforme a Sesto Fiorentino. Garlatti e Razzai, Montespertoli, 393 pp.
Sarti L., 1998 - Aspetti insediativi del Campaniforme nell’Italia centrale. In: Nicolis F. & Mottes e. (a cura di), Simbolo ed enigma. Il bicchiere campaniforme e l’Italia nella preistoria europea del III millennio a.C. Trento: 137-153.
Sluga G., 1969 - Le incisioni rupestri di Dos dell’Arca. Pubblica-zioni del CCSP, IV, Capo di Ponte, 74 pp.
Sulimirski T., 1970 - Prehistoric Russia. An Outline. J. Baker, London, 449 pp.
Süss E., 1954 - Nuove iscrizioni nord-etrusche a Capo di Ponte. Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1954: 191-197.
Süss E., 1955 - Nuove iscrizioni protostoriche in Valcamonica. Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1955: 247-259.
Süss E., 1956 - La mappa delle incisioni rupestri della zona Na-quane-Ronchi di Zir (Capo di Ponte, Valcamonica). Com-mentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1955: 261-266.
Süss E., 1958 - Le incisioni rupestri della Valcamonica. Milano, 62 pp.
Tabanelli M., 1976 - Figurazioni mediche nelle incisioni rupestri della Valcamonica. Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici, 13-14: 127-138.
Tarantini M., 2009 - Le ricerche sull’arte rupestre della Valcamo-
nica. Le vicende e il contesto. In: Poggiani Keller R. (a cura di), La Valle delle Incisioni. Brescia: 23-48; 77-92; 101-125.
Tognoni e., 2007 - Le raffigurazioni architettoniche nell’arte ru-pestre camusa e i ritrovamenti di Paspardo. In: Fossati a.e. (a cura di), La castagna della Vallecamonica. Paspardo arte rupestre e castanocultura, Paspardo: 85-96.
Turconi C., 1997 - La mappa di Bedolina nel quadro dell’arte ru-pestre della Valcamonica. Notizie Archeologiche Bergomen-si, 6: 85-113.
Van Berg osterrieth M., 1972 - Les chars préhistoriques du Val-camonica. archivi 3, Capo di Ponte, 127 pp .
Van Berg Osterrieth M., 1974 - Haches de la fin du deuxième âge du Fer à Naquane (Valcamonica): représentations filiformes de roches n. 62 et 44. Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici, 11: 85-117.
Villa B., 2007 - I primi anni della ricerca: l’area di Campanine di Cimbergo negli scritti di Raffaello Battaglia. In: Marretta a. (a cura di), Sentieri del tempo. L’arte rupestre di Campanine fra Storia e Preistoria. Monza: 33-42.
von Hase F., 1969 - Die Trensen der Früheisenzeit in Italien. PBF XVI, 1, München, 63 pp.
Watchman A., 1995 - Recent petroglyths, Foz Côa, Portugal. Rock Art Research 12 (2): 104-108.
Weyersberg M., 1938 - Felsbilder im Valcamonica. Mitteilungen des Forschungs-Institut für Kulturmorphologie, Frankfurt am Main, n. pp.
Zilhão J., 1995 - The age of the Côa valley (Portugal) rock-art: validation of archaeological dating to the Palaeolithic and refutation of ‘scientific’ dating to historic or proto-historic times. Antiquity, 69, 1995: 883-901.
Zilhão J., 2003 - Vers une chronologie plus fine du cycle ancien de I’art paléolithique de la Côa : quelques hypothèses de tra-vail. In Balbin R. & Bueno P. (eds.), El Arte Prehistorico desde los inicios del siglo XXI. asociacion Cultural amigos de Ribadesella, Primer Symposium Internacional de arte Prehistorico de Ribadesella, Ribadesella, 2003: 75-90.































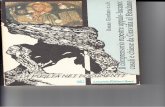







![10.000 ans avant “L’Art du contour” [art rupestre Qurta/Qurta rock art]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63126d9dc32ab5e46f0bf782/10000-ans-avant-lart-du-contour-art-rupestre-qurtaqurta-rock-art.jpg)