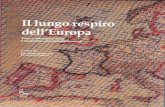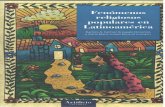Natura, artificio e meraviglioso nei testi figurativi e letterari dell'Europa medievale
Transcript of Natura, artificio e meraviglioso nei testi figurativi e letterari dell'Europa medievale
ORIZZONTI MEDIEVALI
COLLANA DI FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA
Dalla critica testuale alle analisi metriche, dalla ricerca etimo-logica al folklore, dall’antropologia letteraria allo studio del-la spiritualità: la grande tradizione, nata in epoca romantica,che nei momenti più alti ha fatto della filologia romanza unadisciplina–guida, potrà essere continuata e rappresentata in tuttii suoi aspetti, con lo sguardo rivolto ora verso il centro deinostri studi ora verso la periferia e al di là dei confini.
La collana adotta un sistema di valutazione basato sulla revi-sione paritaria e anonima (peer review). I criteri di valutazioneriguardano la coerenza teorica, l’originalità e la significativitàdel tema proposto, la chiarezza argomentativa, la compiutezzadell’analisi e la congruenza con l’ambito di ricerca proprio dellacollana.
Il presente volume e le ricerche che lo hanno preparato sono stati realizzaticon fondi assegnati dalla Università degli Studi di Genova, Progetti di Ricercadi Ateneo (PRA ).
Natura, artificio e meravigliosonei testi figurativi e letterari
dell’Europa medievale
a cura di
Clario Di Fabio
Contributi diGianluca Ameri, Sonia Maura Barillari, Marco Berisso
Rita Caprini, Lia Raffaella Cresci, Clario Di FabioMartina Di Febo, Margherita Lecco, Adelaide Ricci
Giordano Rodda, Claudia Rossi
Copyright © MMXIVAracne editrice int.le S.r.l.
via Quarto Negroni, Ariccia (RM)
()
----
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: dicembre
Indice
Premessadi Clario Di Fabio
Naturalia, mirabilia e acheropita. Il Sacro Catino delDuomo di Genova tra humana arte e divina virtutenella Chronica civitatis Ianuensis di Iacopo da VarazzeGianluca Ameri
Il lessico del “fantastico”. Prime ricognizioni: le Nugaedi Walter MapSonia Maura Barillari
Due schede per la storia della tradizione del Tesorettodi Brunetto LatiniMarco Berisso
Le illustrazioni di Olao MagnoRita Caprini
Natura e δίμορφος. Sull’inesistenza dell’androgino(tra Diodoro e Fozio)Lia Raffaella Cresci
Fazio degli Uberti: l’occhio che “cerne e divide”. ‘Na-tura’ e ‘artificio’ nella facciata gotica della Cattedraledi GenovaClario Di Fabio
Indice
Phantasia e mirabilia. Oscillazioni del meraviglioso inalcuni testi mediolatini dei secoli XII–XIIIMartina Di Febo
Le redazioni della Naissance le Chevalier au Cygne. Va-riazioni di racconto, prospettiva mitopoietica e storica(con una Nota Iconografica)Margherita Lecco
«Mirum est». Parole e meraviglia: dall’effetto alla causaAdelaide Ricci
Neutrumque et utrumque videtur. Androgini ed erma-froditi letterari verso il neoplatonismoGiordano Rodda
Anatomia di un pesce. Lo storione nella Manekine diPhilippe de Remi alla prova dell’interpretazioneClaudia Rossi
Natura, artificio e meraviglioso nei testi figurativi e letterari dell’Europa medievaleISBN 978-88-548-7677-4DOI 10.4399/97888548767741pag. 9–10 (dicembre 2014)
Premessa
I saggi raccolti in questo volume costituiscono il “prodotto”scientifico — come oggi si usa dire — di uno dei gruppi costi-tuiti presso l’Università degli Studi di Genova per concorrereall’assegnazione dei fondi dei Progetti di Ricerca di Ateneonel . Ne hanno fatto parte dodici studiosi, fra docenti edottorati, appartenenti a due Dipartimenti diversi (quello di Ita-lianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo e quellodi Lingue e Culture Moderne), l’uno e l’altro afferenti però allaScuola di Scienze Umanistiche.
Le competenze scientifiche e disciplinari erano piuttostovariegate, all’interno del gruppo: filologi classici, italiani eromanzi, storici dell’arte, italianisti, glottologi.
Il tema concordemente individuato, Natura, artificio e mera-viglioso nei testi figurativi e letterari dell’Europa medievale, che dàil titolo a questo volume, si è dimostrato efficace, alla prova deifatti: ha funzionato, in effetti, come fil rouge di un percorso diricerca i cui elementi in comune non sono risultati né pretestuosi,né marginali. Diverse le ragioni, peraltro di carattere — per cosìdire — “strutturale”. Due sono da rimarcare: il concetto di ‘testo’,da un lato, fondante al massimo grado per tutte le discipline egli specialismi coinvolti; e una delimitazione di ambito, dall’altro,che, pur insita nell’aggettivo ‘medievale’, non è stata intesa comeconnotazione burocratica o rigidamente cronologica ma cultu-rale: una definizione che si addice a qualificare un approccio diricerca e degli esiti di studio che si confrontano con fenomeni dilunga durata, di continuità, di dialettica fra tradizione e “scarto”,eccezione, innovazione. Fra naturale e mirabile, appunto.
Il tema ha funzionato anche in quanto ha sollecitato tutti
Premessa
a “mescolare le carte”: se gli storici dell’arte, infatti, hannoletto i manufatti pertinenti la loro disciplina anche sulla scortadi testi letterari, i filologi, i glottologi e gli italianisti hannoanalizzato questi ultimi con l’ausilio, o nella prospettiva di testifigurativi o di immagini, di varia natura. Un dato da rilevare,questo, ma senza giustificazionismid’ occasione e di maniera,poiché proprio la condivisa sensibilità dei singoli partecipantiper questo tipo di intersezioni (o l’affinità di approccio) erastato forse il principale fra i prerequisiti che avevano favorito laformazione stessa del gruppo. Ma non si tratta di cosa di cui cisi debba rimproverare, ovviamente.
Alla prova dei fatti — ricalco consapevolmente la formulaun po’ vieta utilizzata sopra —, si può dunque riscontrare chequel che era stato posto come obiettivo di metodo in sede diformulazione progettuale — provare a sviluppare qualcosa dinon solo pluri–, ma inter–disciplinare — si è inverato, almenoin larga misura. Ognuno potrà constatarlo leggendo questaserie sfaccettata di contributi. E questa è la ragione per cui hocreduto giusto disporli in semplice ordine alfabetico, secondo ilcognome dell’autore: a studiare fittizie articolazioni tematicheci sarebbe stato più arbitrio, e ancor più burocrazia (della quale,almeno in quest’ambito, il bisogno non si avverte).
Chi scorra il sommario di questo volume e poi, filologica-mente, lo confronti con l’“Inventario” e con le “Fonti e serbatoidel meraviglioso medievale” da Jacques Le Goff messi in ap-pendice al primo dei saggi tradotti in italiano e raccolti nel sotto il titolo Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medie-vale, non potrà non cogliervi tangenze plurime coi titoli e ilcontenuto degli scritti qui raccolti, e con gli oggetti, i luoghi,gli esseri, gli animali, i testi e i “serbatoi” in esso richiamati oanalizzati. Coincidenza? Un precipitato culturale che riaffiora?Comunque, non certo un caso.
Natura, artificio e meraviglioso nei testi figurativi e letterari dell’Europa medievaleISBN 978-88-548-7677-4DOI 10.4399/97888548767742pag. 11–51 (dicembre 2014)
Naturalia, mirabilia e acheropita∗
Il Sacro Catino del Duomo di Genovatra humana arte e divina virtute
nella Chronica civitatis Ianuensis di Iacopo da Varazze
G A
Il Museo del Tesoro del Duomo di Genova, realizzato tra il e il su progetto di Franco Albini e ordinamento di CaterinaMarcenaro sotto il cortile dell’arivescovado, e subito impostosicome capolavoro della museografia contemporanea, si articolain quattro camere circolari (thòloi), impostate ai lati della salaesagona centrale per custodire le opere, di cui sono tuttoraproprietari il Comune, il Capitolo dei Canonici, la Protettoriadella Cappella del Battista. In questo spazio ipogeo dall’artico-lazione policentrica i singoli ambienti, ispirati a modelli antichi
∗ Devo un ringraziamento ai colleghi e agli amici che, a vario titolo, mi hannosupportato con utili suggerimenti per la stesura e la revisione di questo saggio: LiaRaffaella Cresci, Francesco D’Aiuto, Clario Di Fabio, Luca Patrizi, Natale Spineto.
. Sulle vicende istituzionali del tesoro genovese cfr. C. Di Fabio, Il Tesorodella Cattedrale di Genova. Le origini (XII–XIV secolo), in Tessuti, oreficerie, miniaturein Liguria. XIII–XV secolo, Atti del Convegno Internazionale (Genova–Bordighera,– maggio ), a cura di A.R. Calderoni Masetti, C. Di Fabio, M. Marcenaro,Bordighera , pp. –. Sulle sue vicende in età medievale, segnalo almeno: C.Altavista, Dalla città alla cattedrale e ritorno: il Tesoro del Duomo di San Lorenzo e Genovadall’XI al XVI secolo, in I luoghi del sacro. Il sacro e la città fra Medioevo ed Età moderna,Atti del Convegno (Fiesole, – giugno ), a cura di F. Ricciardelli, Firenze, pp. –; G. Ameri, Il tesoro di San Lorenzo nel Medioevo, in La Cattedrale di SanLorenzo a Genova. I. Testi, a cura di A.R. Calderoni Masetti, G. Wolf, Modena ,pp. –. Per gli aspetti progettuali rimando, nel medesimo volume, al saggiodi A. Capitanio, Un capolavoro di Franco Albini: il Museo del Tesoro nella Cattedrale diGenova, pp. – (con blibliografia precedente).
Gianluca Ameri
di profonda suggestione, sono occupati da incombenti zoned’ombra scavate dalla luce, in un nesso tra architettura e scelteilluminotecniche che, creando un coinvolgente effetto emo-tivo, sollecita il confronto diretto con gli oggetti — in speciecon quelli esposti in modo da esaltarne l’unicità e l’importanzastorica.
Il caso forse più eloquente in tal senso riguarda l’opera cheoccupa la prima thòlos: il Catino in vetro color smeraldo, cheuna lunghissima tradizione vuole “sacro” in quanto reliquiadell’Ultima Cena, e di cui è stata più volte ricordata la capacità diriassumere in sé fortissime valenze simboliche, tanto nella sferacultuale quanto in quella civica (fig. ). Lo statuto specialissimodell’oggetto è suggerito in modo sintomatico dall’allestimento:il suo isolamento all’inizio del percorso espositivo ne riaffermail ruolo primario e in certa misura fondativo per la formazionedel tesoro, quindi anche — per precise ragioni contestuali — lacentralità per la storia cittadina; mentre la retroilluminazione,concentrata e non diffusa, attenua il lucore della sua materiapastosa e traslucida, che in tal modo sembra assorbire la lucee restituirla in toni più bassi e densi, come farebbe una gem-ma. Tali accorgimenti, che volutamente filtrano la visione delCatino offrendone una percezione non immediata né davveronitida, sembrano sottilmente riproporre allo spettatore moder-no il dilemma sulla reale composizione materica del vaso, chetanto affascinò i viaggiatori e gli eruditi medievali, alludendoa una stratificazione di significati risultante in parte dalla storiae dalla natura stessa dell’opera, in parte da un lungo processodi “costruzione di senso”, che appunto l’ha riguardata già nelMedioevo.
Le circostanze che avevano portato in città il Catino, oltrealla sua stessa alterità tipologica e culturale, motivano il pas-saggio dal mero interesse cronachistico a una vera e propria
. È stato più volte opportunamente ricordato che il termine “tholoi” comparivanella relazione di accompagnamento al progetto definitivo di Albini: A. Dagnino, C.Di Fabio, San Lorenzo e il Museo del Tesoro, Genova , p. ; A. Capitanio, op. cit.,p. .
Naturalia, mirabilia e acheropita
rilettura mitografica, che ha il suo punto d’arrivo e, insieme, ilmomento più significante nell’opera del maggiore agiografodell’Europa bassomedievale: il domenicano Iacopo da Varaz-ze, arcivescovo di Genova dal al , che identificandoil “vas smaragdinum” con il Graal nella sua Chronica civitatisIanuensis pone un punto fermo dell’identità civica e religiosagenovese, difeso da tutta la storiografia locale ancora alla finedel Settecento. Come vedremo, la qualifica di eminentissimareliquia cristologica non può dirsi inedita al tempo di Iacopo;e la lunga disamina che egli dedica al Catino valorizza questoaspetto ricorrendo a diverse tradizioni, scritte e orali, evocandogiustificazioni teologiche accanto alla communis opinio dei suoitempi. Tuttavia, il presule genovese fa trapelare, in forma diallusione colta, tanto abbreviata quanto suggestiva, un’ipotesiche assegna il vaso a una classe di oggetti ancor più ristretta,dal prestigio superiore a quello riconosciuto alle stesse reliquie,o ai cimeli più rari custoditi nei tesori chiesastici, come gliesotici naturalia (dall’ovum struthionis alle unghie di grifone), oai mirabilia visibili in luoghi speciali dell’ecumene cristiana (tracui i monumenti di Roma additati ai pellegrini negli Itineraria,e i cimeli di personalità eroiche). L’autore della Legenda Aurea,infatti, non si fa solo interprete della devozione cittadina per ilvaso che vuole divulgare come una delle più sacre reliquie dellaPassione, tanto più mirabile perché ritenuto, per secolare tradi-zione, uno smeraldo di straordinaria grandezza e compiutezzaformale: con una serie di motivazioni l’arcivescovo genovesepresenta il Catino — per lui davvero sacro in sommo grado —come un oggetto “non fatto da mano umana”, attingendo aun concetto che nel mondo bizantino aveva trovato la sua piùcoerente formulazione. Seppure espressa con cautela — comealtre inerenti la reliquia nel medesimo testo — tale ipotesi sem-
. Rimando alle fonti citate da D. Calcagno, Il mistero del “Sacro Catino”, Genova; Id., Il Sacro Catino specchio dell’identità genovese, “Xenia Antiqua”, X, , pp.–; Id., Il Sacro Catino: impianto e sviluppo del “culto”, in Il Santo Graal. Un mitosenza tempo dal Medioevo al cinema, Atti del Convegno (Genova, – giugno ), acura di M. Macconi, M. Montesano, Genova , pp. –.
Gianluca Ameri
bra conseguente non tanto e non solo all’identificazione conil Graal, ma anche e soprattutto alla percezione della natura“altra” del vaso, e una volta di più sollecita un’indagine sullacultura di Iacopo da Varazze, apparentemente non limitata —come vedremo — alle fonti della cristianità latina e greca.
Con la sua testimonianza, che aggrega temi diversi e di di-versa provenienza — alcuni di tipo storico–cronachistico, altridi genere teologico, altri ancora di derivazione romanzesca —il presule “fonda”, di fatto, una tradizione, fornendo alla cittàl’esegesi “ufficiale” del Catino come oggetto storico e comereliquia. Per un apparente paradosso, tale ufficializzazione, san-cita dall’autorità episcopale di Iacopo, contiene anche lo scartopiù forte nella trattazione scritta e orale di ambito genovese— e non solo — sulla “scutella sancti Laurentii”. Ma c’è di più.Con il suo testo, il domenicano offre anche un punto di vistaprivilegiato sui modi e le possibilità di “leggere” manufatti per-cepiti ai suoi tempi come esotici e rari: caratteristiche, queste,spesso strumentalizzate per attribuire a tali pezzi un valore sa-crale, tanto più laddove — come in questo caso — essi eranogià circondati da una forte ammirazione collettiva. Dalle righedella Chronica dedicate al Catino esce dunque una riflessionestratificata, che apre una prospettiva più sottile, e un più ampioorizzonte di riferimenti, alla canonica opposizione fra ciò cheè riconosciuto come prodotto della natura e ciò che, invece,pertiene all’artificio umano.
. Il Catino nella Chronica civitatis Ianuensis: un altro “mitodelle origini”
Nella “pars duodecima” della Chronica civitatis Ianuensis, chepercorre la storia genovese seguendo l’avvicendarsi degli ar-civescovi cittadini, Iacopo da Varazze riporta le circostanzedella sua elezione. Già priore della provincia domenicana diLombardia dal al , poi dal al , anni in cui è
Naturalia, mirabilia e acheropita
anche reggente dell’ordine dei Predicatori, viene nominatoarcivescovo di Genova da Nicolò IV pochi giorni prima del aprile , quando il pontefice, ormai gravemente ammalato,si spegne. Il Sacro Collegio, riunito in concistoro nei giornidell’ottava di Pasqua, con la Sede vacante, conviene di ratificarecelermente l’atto “propter honorem Communis Ianue”: il aprile(domenica in albis) Iacopo riceve il pallio da Latino Malabran-ca, cardinale di San Paolo Fuori le Mura e vescovo di Ostia eVelletri. L’arcidiocesi genovese veniva, allora, da un periodo diamministrazione apostolica, essendo stata affidata nel dallostesso papa Masci a Opizzo Fieschi, patriarca di Antiochia; mase tale scelta era stata vista come una diminutio dagli organi delgoverno cittadino, che avevano manifestato per iscritto il loro di-sappunto associandovi il “populus” (“potestas, capitanei, populuset Comune Ianue”), il disagio si trasformò in aperta ostilità dopoche il presule, direttamente coinvolto nelle lotte tra le fazioniguelfa (di cui era esponente primaria la sua potentissima fami-glia) e ghibellina (allora al governo della città), fu sospettato diaver avuto un ruolo protagonistico nella congiura del primogennaio contro i capitani del popolo, quando persino ilpalazzo arcivescovile e la torre di San Lorenzo divennero teatrodegli scontri. L’esacerbato clima di contrapposizione, cui dun-que non sembravano estranei neppure il seggio episcopale e icanonici del Duomo, non pare davvero mitigato quando Iaco-
. Per un profilo biografico rimando a C. Casagrande, Iacopo da Varazze, inDizionario Biografico degli Italiani, vol. , Roma , pp. –.
. Per il passo si veda I. da Varagine, Cronaca della città di Genova dalle origini al, a cura di S. Bertini Guidetti, Genova , p. .
. Les Registres de Nicolas IV, vol. I, a cura di E. Langlois, Paris , p. , nn.–.
. A. Sisto, Genova nel Duecento. Il Capitolo di San Lorenzo, Genova , p. ,nota ; Calcagno, Il mistero, cit., p. .
. Sisto, op. cit., pp. –; S. Bertini Guidetti, Potere e propaganda a Genova nelDuecento, Genova , pp. –.
. Si è ipotizzato che le effettive responsabilità di Opizzo siano state artatamenteesagerate nella dura lettera di rimostranze inviata al papa dal governo cittadino perchiedere la nomina di un nuovo arcivescovo: cfr. D. Calcagno, Il patriarca di Antiochia
Gianluca Ameri
po si insedia nel ; e alla luce di questo scenario è stato lettoil suo primo intervento pubblico compiuto in veste ufficiale:il Concilio provinciale tenuto in Duomo nel , durante ilquale si dà luogo a una duplice e solenne “rifondazione” dellastessa dignitas arcidiocesana. In un lungo e dettagliato passodella Chronica si narra che, alla presenza di tutto il clero dellagiurisdizione genovese, vengono emanate nuove costituzioniper consolidare gli assetti del governo ecclesiastico; mentre,davanti alle autorità civili e religiose prima, a tutto il popolo deifedeli poi, vengono mostrate le reliquie di san Siro sul “magnumpulpitum” della Cattedrale, a dimostrazione e tutela della suaprimazialità.
Marcato dalla volontaristica iniziativa di Iacopo, l’episodioè in sé perfettamente coerente sia con la forte consapevolezzadel nesso che, per antica tradizione, esiste in tutta Europa tra ilruolo episcopale e la stessa identità cittadina; sia con la pienacoscienza che, a Genova, il potere vescovile e quello comunalesono profondamente interconnessi almeno dal , quandoil vescovo Airaldo Guaraco, con l’adesione alla prima Compa-gna, aveva guadagnato nuove prerogative tipiche del governocittadino, mentre il Comune — è la tesi esposta nella Chronica— avrebbe patrocinato al tempo del suo successore, OttoneGhilini, la riedificazione della Cattedrale, “opus tam sumptuosumet nobile” destinato a funzioni civiche oltre che religiose. Il
Opizzo Fieschi, diplomatico di spicco per la Santa Sede fra Polonia, Oriente latino edItalia nel XIII secolo, in I Fieschi tra papato ed Impero, Atti del Convegno (Lavagna, dicembre ), a cura di D. Calcagno, Lavagna , pp. –.
. I. da Varagine, Cronaca, cit., pp. –.. Sul nesso vescovo–città in Iacopo cfr. C.D. Fonseca, «Episcopali honore de-
corata... archiepiscopali sublimata»: vescovo e città, in Il Paradiso e la Terra. Iacopo daVarazze e il suo tempo, Atti del Convegno internazionale, (Varazze, – settembre), a cura di S. Bertini Guidetti, Firenze , pp. –. Sulla “rifondazione” dellaCattedrale genovese si veda: C. Di Fabio, La Cattedrale di Genova nel Medioevo. SecoliVI–XIV, Cinisello Balsamo , pp. –; Id., La chiesa di un Comune senza “palazzo”:uso civico e decorazione “politica” della Cattedrale di Genova fra XII e XIV secolo, in Me-dioevo: la chiesa e il palazzo, Atti del Convegno (Parma, – settembre ), a curadi A.C. Quintavalle, Milano , pp. –; Id., Specchio del Comune, immagine dellaRiforma Gregoriana: la Cattedrale di Genova fra XI e XII secolo, in Il restauro dell’altare
Naturalia, mirabilia e acheropita
significato del Concilio è, dunque, simbolico; tanto più perché,in un momento di crisi, vale a dichiarare la volontà del nuo-vo arcivescovo — da tutti riconosciuto come uomo di pace edi dialogo — di ridefinire i lineamenti dell’identità cittadina,partendo non a caso dalla valorizzazione cultuale del santo ve-scovo locale per eccellenza, Siro. Lo stesso intento “rifondativo”presiede alla stesura della Chronica civitatis Ianuensis: fonte diinformazioni storiche, certo, ma anche autorevole cantiere di“miti delle origini” (a partire da quello sul nome di Genova,e sulla sua fondazione più antica di quella della stessa Roma),funzionalmente inquadrati nella medesima cornice di storio-grafia teocentrica, e dichiaratamente orientata “ad instructionemlegentium”, cui rispondono anche gli ammaestramenti di eti-ca personale e famigliare, i richiami alla pubblica concordia,il recupero della storia passata per il governo del presente.Non a caso, dopo il rovinoso incendio della Cattedrale del ,originato ancora da “graves dissentiones et bellicosa discrimina”tra le fazioni cittadine, si attingerà dalla Chronica per formula-re il programma del nuovo corredo pittorico e scultoreo, conl’intento di dare la massima evidenza figurativa, e il più alto ri-conoscimento di veridicità pubblica, al tema delle origini civilie religiose della città; sicché alle immagini corrisponderannole due monumentali epigrafi con passi del testo di Iacopo daVarazze, che corrono sul lato interno dei muri–diaframma dellanavata centrale, tra il primo e il secondo ordine di arcate (fig.).
maggiore della Cattedrale di San Lorenzo in Genova, a cura di C. Montagni, Genova, pp. –.
. Sulla cultura di Iacopo e le sue intenzioni nello scrivere la Chronica cfr.: A.Boureau, Le prêcheur et les marchands. Ordre divin et désordres du siècle dans la Chroniquede Gênes de Jacques de Voragine (), “Médiévales”, , , pp. –; G. Airaldi,Iacopo da Varagine: tra santi e mercanti, Milano ; I. da Varagine, Cronaca, cit., pp.–.
. Les Registres de Boniface VIII, a cura di G. Digard, M. Faucon, A. Thomas, vol.I, Paris , col. , n. .
. Rimando al saggio di Clario Di Fabio in questo volume. Si vedano inoltre: C.Di Fabio, La Cattedrale di Genova, cit., pp. –; R.P. Novello, La ricostruzione dopo
Gianluca Ameri
Alla luce di queste premesse andrà esaminato il lungo passag-gio della Chronica dedicato al Catino. Se la sua fama, al tempodi Iacopo, travalica ampiamente i confini genovesi, il vaso nonha ancora trovato in ambito locale un’adeguata cornice esegeti-ca, né una divulgazione che vada al di là della mitografia; unalegittimazione testuale, insomma, che a quel cimelio assegniun luogo e un ruolo precisi nell’identità e nella storia cittadina,in primis agli occhi degli stessi genovesi. È per rispondere aquesta esigenza che l’arcivescovo interpreta il ruolo di cronistaed esegeta–mediatore della tradizione — quella locale, orale, ele fonti che vedremo — come strumento per la costruzione diuna memoria collettiva, e “definitiva”, centrata su un oggetto— il Catino — di cui si rivelano la provenienza storica e la naturasacrale, insistendo infine sulle qualità fisiche (ma non sarebbeerrato dire “metafisiche”). Con uno sforzo di sistematizzazioneIacopo allestisce, dunque, un dispositivo testuale complesso,certo organico e funzionale al progetto di ricostruzione iden-titaria che presiede all’intera opera, e perciò rivolto anzituttoalla comunità cittadina in tempi di profonda crisi; tuttavia, sediverse argomentazioni lasciano intendere che il Catino è ormaicelebre al di fuori di Genova, le molte sfaccettature del testopaiono pensate per un pubblico di lettori colti, che guardanoalla città dall’intera ecumene cristiana. Il lungo passo dedicato al“vas smaragdinum” occupa, si può dire per intero, la narrazionedei fatti genovesi al tempo di Airaldo Guaraco, diciassettesimodei vescovi di cui è riportata la sequenza, in forma annalisti-ca, nella “undecima pars” della Chronica. Il testo mi sembrascomponibile in almeno sei blocchi tematici, di ampiezza di-seguale. Il primo è di carattere storico, e in esso l’autore rievoca
l’incendio del , in La Cattedrale di San Lorenzo a Genova, cit., pp. –.. I. da Varagine, Cronaca, cit., pp. –.. Stefania Bertini Guidetti ne identifica, invece, quattro, nel suo saggio Con-
trastare la crisi della chiesa cattedrale: Iacopo da Varagine e la costruzione di un’ideologiapropagandistica, in Le vie del Mediterraneo: idee, uomini, oggetti (secoli XI–XVI), Atti delConvegno (Genova, – aprile ), a cura di G. Airaldi, Genova , pp. –:–.
Naturalia, mirabilia e acheropita
le circostanze del ritrovamento del Catino (vedremo con qua-le grado di originalità). Nel secondo, che definirei di natura“esperienziale”, Iacopo affronta subito l’argomento della naturasmeraldina del vaso, la cui veridicità è attestata, appunto, dallasua disamina da parte di “gemmarij” e dalla constatazione chele sue qualità fisiche producono una luminescenza — tradottacon i termini “fulgor” e “claritas” — tale da oscurare le altregemme postegli accanto, come il sole nascente fa con gli astriminori. A questa fresca immagine letteraria, che accompagnagli esiti dell’expertise degli ignoti specialisti chiamati a valutarel’oggetto, segue il terzo blocco di testo dalla fisionomia identifi-cabile: breve ma fondamentale nel quadro della trattazione, visi riporta l’opinione diffusa a Genova (“vulgariter dicitur”) chela “scutella sancti Laurentii” sia quella in cui il Cristo consumòl’Ultima Cena. Da questo punto–chiave — su cui il cronistalascia al lettore libertà di valutazione — discendono il quartonucleo tematico, dove si precisa che “in quibusdam libris An-glorum” il piatto della Coena Domini è denominato “Sangraal”,fondando la tradizione che identifica il Catino con il Graal; e ilquinto, di carattere teologico, in cui la natura smeraldina dellaparasside genovese diviene argomento della disputa sulla po-vertà di Cristo, il quale se ne sarebbe servito non per una “notavanitatis”, o per “pompa”, ma per “devocio et reverencia magna”verso l’Eucarestia. Il sesto e ultimo passaggio rilegge in chiaveteologica un insieme di nozioni sulla natura e tipologia dellegemme, distinguendo le qualità di quelle naturali e di quelleartificiali, mai tanto perfette quanto quelle create dalla virtùdivina — come il Catino.
La disamina puntuale di ciascun passo, specie per l’identifi-cazione delle fonti, andrà lasciata a più specifiche competenze;non senza, però, fermarsi brevemente su alcuni punti.
Gianluca Ameri
. Tempore enim stoli Cesarie: osservazioni sulle fonti stori-che
Iacopo da Varazze affronta subito, da cronista, il tema dellaricostruzione storica, evocando lo scenario ferrigno della pri-ma crociata, le galee genovesi oltremare, le conquiste (su tutte,Sidone e Beirut), i privilegi concessi da re Baldovino e inscrittia lettere d’oro sulla tribuna del Santo Sepolcro... Ma dopo leprime righe di sintesi viene identificato il vero fulcro del raccon-to, poiché si specifica che al tempo di Airaldo viene portato aGenova il vaso, “quod vulgariter dicitur scutella sancti Laurentii”:da lì in poi la disamina dell’oggetto assorbe ogni attenzione, ela storia dei genovesi alle crociate diventa la storia del rinveni-mento del Catino a Cesarea, conquistata grazie all’ardimentodi Guglielmo Embriaco. Per la stesura di questo primo bloccotestuale, di ambientazione storica, Iacopo usa e assembla alme-no due fonti ben note, non senza legare all’orizzonte dilatatodell’epopea crociata il “vulgariter dicitur” della dimensione loca-le, dove il vaso, evidentemente, è da tempo divenuto oggettodi mitopoiesi collettiva. La fonte più antica sono gli AnnalesIanuenses di Caffaro, e pour cause: prima storia cittadina delMedioevo italiano scritta da un laico, il testo ha non solo uncontenuto, ma anche una validità “civica”, poiché nel vieneinserito tra i documenti ufficiali del Comune, di cui raccoglie eorganizza le memorie storiche in quanto entità politica giuri-dicamente organizzata con lo strumento della Compagna, chesta costruendosi una forte identità come nuova potenza medi-terranea. Gli Annales si aprono appunto con l’istituzione della
. Per il testo mi rifaccio a: Annali Genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori dalMXCIX al MCCXCVIII, a cura di L.T. Belgrano, vol. I, Genova , pp. –. Sulpersonaggio e la sua opera, specie in rapporto alla partecipazione genovese allaprima crociata, cfr.: G. Petti Balbi, Caffaro e la cronachistica genovese, Genova ; A.Placanica, L’opera storiografica di Caffaro, Spoleto ; Gli Annali di Caffaro –,a cura di G. Airaldi, Genova ; E. Bellomo, A servizio di Dio e del Santo Sepolcro:Caffaro e l’Oriente latino, Padova ; G. Airaldi, Blu come il mare. Guglielmo e la sagadegli Embriaci, Genova ; M. Hall, J. Phillip, Caffaro, Genoa and the Twelfth–CenturyCrusades, London .