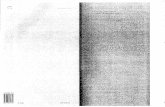Stati e sistemi politici dell'età moderna, in G. FOSCARI-E. PARISE (a cura di), Il lungo respiro...
Transcript of Stati e sistemi politici dell'età moderna, in G. FOSCARI-E. PARISE (a cura di), Il lungo respiro...
Introduzione
L'Europa è stata, ed è, una straordinaria"ptazza" di popoli, culture,storia, linguaggi, religioni, musica, una grande agora con infiniti var-chi di accesso - il Mediterraneo, i Balcani, il Baltico, l'Est dalle vastelande, per citarne alcuni -, un insieme complesso con decine, centinaia,di sistemi e sottosistemi. Essa ci appare sempre più come una strutturacomplicnta e correlata.
"il pensiero europeo - ha scritto Le Goff nel suo Il Medioeuo - è fattodi materiali ereditati'>, felice espressione che, oltre ad indurci a ricerca-re talune origini dell'identità europea nell'età medievale, come sembrasensato fare, racchiude mirabilmente il senso delle contaminazioni chehanno forgiato la sua storia e ci restituiscono l'idea di un continenteche ha stratificato le culture e se n'è nutrito, seruatrascurarie.
Tanto I'idea derla piazza che quella della logica sistemica rimanda-no, per l'appunto, alle relazioni e ai multiformi contagi culturali chel'hanno caratterizzato, sino a rendere il suo respiro secolare. Di qui iltitolo del libro, che va interpretato come una metafora della vitalità edegli impulsi irrefrenabili che l'hanno percorso.
Questa immagine di un'Europa vivente, anche oltre le sue originimitologiche, ci rimanda alla celebre cartografia allegorica cinquecente-sca di Heinrich Bùnting, in cui essa è tratteggiata come una donna fine-mente vestita, ornata di gioielli e preziosi, cinta dalla corona spagnola,capace di allungare i tentacoli sull'intero Continente. Certo, dietro quellarappresentazione e que11a allegoria si cela tutta la carica politica degliAsburgo, il simbolismo della maestosità di una civiltà, di una cultuia,di un esercito, ma anche il sogno di una coesione, di una grande aggre-gazione poiitica.
Quantevoltei,Europa,ineffetti,l.rafinitoperessereoggettodipote-re e di dilanianti bramosie dei potenti d'i iurno (si pensi' oltre agii
Asburgo, a Luigi XIV' a Napoleone' a Hitler.ed.ai loro te^ntativi di con-
'ertire l'Europa i" "í".i.Jpaese
dominato) " u :i:::liro'
per conti-
nuare a usale la metafora' è àiventato affannoso e ansimante' ed è stata
quasi sul punto di crollare' e quante volte' pur tra comprensibili esita-
ziofi,sono esplose le insofferenze verso questi prepotenti'
In fondo,l'Europa ha avuto'"-p'" plianime e l;idea dl unaredr'tctio
ad unum.h" pot"Jre tacitare tutti nori ha rnai funzionato' Un allena-
rrLento a difender;rt*;t specificità te*itoriali che può aver conttr-
buitoafarlecoltivareilgustodiunafortelibertàstatuale'ancorchécondizionata, essa 'i"""'"a"
desideri Tpansio-nis:T:1 che l'hanno por-
tata a quelia "rp";;;;coloniale di cui ancora oggi porta i segni e le
ttî"":ff Îlu1t"'*'u*o con f or za'l' Europ a' a] aili a;[e-sue debolezze'
è stata, ed è ancor a, patrra'crocevra " f"ì1'" d'iflelab-orazione di cultu-
re, perché t-tu ,upJtà u"tnt riadattarù' mutarle' E qu'esti sono alcuni
dei suoi modi di ;;;; ài manifestarsi tra i più proficui'
Laricettaidentitariachepuò'"""'"""ltiilNordalSud,l,Estal-i,ovest è ubicata ìr-, J.rrrri dei tratti comuni che hanno sorretto questa
immensat",,up"',".ori,nellevicissitudinichehannocondizionatol'agire e le modalitJtti t'i"tt" d"i "'oi
popoli' ma molto più nelle con-
traddizioni che si è portata dietro ""iiJ"i'" piu che millenaria vicenda
storica, nelle diver'ì'a th" 'o'-'o 'tut"
(e sono) vero volano della sua
sfaccettata ed eclettica natura' - r^.*,iranliràIl crogiuol, a"ri" al"ersità come trama dell'identità, potremmo sln-
tettzzare.
Questolibrorrascedaunfortunatoincontrodiesperienzeumaneeprofession^li' L;;;;-di""1i31i ;;"'-;;;;"re il filo conduttore de1le
diversità, delie originalità e clelle J"*,t"aauioni dell'E"J"fli ::Îttbtdi idee e di metodo che han19 rnotivato l'equipe e ispirato i saggi'
La sfida rr"uu rriau era collegar:e il saperà accademico a figure pro-
fessionali non incar<Linate, per 1o pù ."tla"ite da giovani studiosi' de-
diti alla ricerca e all'approfondimento" , -'-1^-1Lasceltaccaduta,.,t"*icheneld.ibattitostoriograficocontinuano
10
a tenere banco (la cristianità, gli stati, le rivolte, le rivoluzioni, il pacifi-smo, le nazioni,ra globalizzazione), prediligendo l'ottica storico-politi-ca di iungo periodo, ben consapevoli che siano molte le questioni rima-ste fuori, inevitabilmente, dagli interessi del gruppo di ravoro.
I problemi sono disparati e anche l'affrontarli annovera idee diffe-renti. Non c'è solo una diversa idea di cosa sia l'Europa, ma anche disentirsi europeo e idee diverse anche su come trattare gli argomentiprescelti.
La vicenda dell'Europa tracciata in questo libro ha probabilmenteuna sua centralità nella forma più originale che essa ha saputo svilup-pare: gli stati. il sentimento di cristianità, il pacifismo, le guerre, le ii-volte, le rivoluzioni, sono in qualche modo riconducibili alla vicendadella nascita, del consolidamento e delle trasformazioni delle formestatuali. Anche nazionalismo e globahzzazione ci rimandano alle na-zioni del XX secolo, e le nazioni non sono che evoluzioni moderne eacleguate ai tempi degli stati. La nazione è come un'anima data alloStato freddo, distaccato e burocr atrzzato.
Anche per questo ci premeva una retrospettiva dell'Europa con aper-ture verso l'età contemporanea, per ia evidente continuità dei temi eperché ci è parso non concepibile un ragionamento sull'Europa che fossecondizionato da convenzionali ma poco funzionali iimiti temporali che,se hanno una ragione di esistere per ragioni di organizzazione didatti-ca, n"la1 si conciliano con le esigenze degli studenti, spesso attenti alleproiezioni delle questioni nell'attualità e attratti dalle dinarniche di lun-go periodo, e con le esigenze di noi docenti, altrettantointeressati a fornirenostre riflessioni sulle prospettive cli determinati processi storici.
E ci interessa-,za anche non 1'esaltazione europea/ bensì l'attento esa-me delle sue singolarità storiche e delle incoerenze che esse iner.itabil-mente racchiudono. Non c'è mai stata nel gruppo cli ricerca l'idea che1'occidente avesse una missione civilizzatrice t1a compiere per esaltar-ne la sua pretesa superiorità a discapito di altre culture, o il desideriodi accentuare uno spirito di apparteÍrenza culturale. c'è stato, invece,oltre che ii senso del rispetto massimo per tutte le diversità, la volontàdi occuparci di ciò che l'Europa ha in fondo prodotto, senza che questofacesse passare una prospettiva eurocentrica.
Per nr-ri l'Europa resta un'unione di genti e nazioni, un insieme, un
tt
nome collettivo, ma anche, e soprattutto, una relazione tra diversità'
un discorso che vale per i rappoiti con f islam eIe cultwre altre, rna che
riguarda anche gli steSsi Statiche hanno contribuito a costruirla e stan-
nA cercando di consolidarne il processo integrativo'
Ma c'è altro nel libro, qualcoìa di non dichiarato. Il processo di cre-
scita dell'Europa potràbbe presupporre una chiave di lettura
interculturale (cioè come viene put.upitu la differenza culturale, il di-
verso da noi), che parta dalla sua storia passata e sviluppi un metodo
che consid"ri q.r"tù che vi è di relativo in ogni produzione culturale, a
partire .dalla produzione dell'Europa stessa. La ricerca di un nuovo
universalismo, un lavoro di riflessione sulle culture alla ricerca di ciò
che le differisce e le distanzia, ma anche e soprattutto di ciò che le acco-
muna, quindi alla ricerca di queilo che di universale ciascuna cultura
esprime.
Salerno, 29 settembre 2006
Giusspps Fosc,q'nl
EucpNie PeRtss
12
CAPITOLO II
Stati e sistemi politici dell'etù moderna o
di Crusnppn FoscaRt
L'organtzzazione politica che definiamo "Stato moderno" si è svi-
_rppata sul Vecchio continente a partire dal XIII-XIV secolo, mosttan-
-ro una migliore capacità organizzaliva rispetto alle molteplici giuri-;lizioni feudali, signorili, urbane ed ecclesiastiche che avevano segna-
:r 1o scorrere della vita nelle comunità nei secoli precedenti.lnvero, non sono pochi gli storici a ritenere che già tra il 1100 ed il
-100 si sia registrata ir-l Europa la presenza dt una forma statuale più:':,e abbozzata, per effetto di un forte slancio teso ad assestare e unifica-:: 11 territorio, retrodatandone, quindi, l'origine.
La contrapposizior-re storiografica tra quanti sostengono f idea che
- Stato si sia andato costituendo in alcuni suoi elementi basilari già in
=:a medievale e coloro che rimandano all'epoca storica successiva (l'età
:".rderna) 1'effettiva consistenza e propagazione del fenomeno, è con-
-:'rtata da ragionamenti plausibili. I primi, tra le varie argomentazioni. -it1otte, hanno sottolineato come in età medievale il rapporto tra auto-
: -:a e sudditi, ovvero, I'attjtudine all'obbed ler1za da parte dei sudditi e
-, capacità di esercitare ii comando da parte del "principe", fossero
..=:lenti riscontrabili già ne1 XIII secoio nel regno di Sicilia, nei territori,-:ila Chiesa e nel1'espelienza comunale al nord dell'Italia. Fattori suf-
.::enti per individuare in queile esperienze ed in quella epoca storica- :mazioni proto-statali già degne di rilievo.
i .'secondi, invece, hanno soffermato 1'attenzione sui caratteri "mo-
- ::iú" degli Stati, - fattori la cui filessa a punto è apparsa ora favorita,:: rallentata, da peculiari meccanisrni endogeni -, e, segnatamente:la
Dedico questo saggio alla memoria cìel compianto Paolo Viola
55
divisione tra la titoiarità del potere che spettava la sovrano e il suoesercizio che veniva delegato dal re aila burocrazia-; un apparato buro-cratico più o meno permanente e tendente alla razíonalizzazione dellesue funzioni; la presenza di ministri; un esercito professionale; un si-stema di leggi valido sull'intero territorio; la conseguente imposizionedi tasse abbastanza uniformi su tutto il territorio dello Stato; una di-plomaziar.
La aexnta qunestío relativa ai tempi di forrnazione, consolidamento e
sviiuppo dello Stato, può essere in qualche misura superata dalf ideache i suoi fattori costitutivi abbiano avuto una forma embrionale ed unsuccessivo sviluppo più sistematico a cavallo tra la fine dell'età rnedie-vale e f inizio dell'età moderna, sostenendo, così, la continuità di unprocesso, poco lirreare e, tuttavia, incontrastabile, che ha interessatol'ultimo scorcio dell'età medievale er per intero, l'età moderna.
LIn dato seml-rra certo: la necessità di assicurare ai sudditi sicttrezza,difesa e giustizia ha prodotto una marcata tenclenza alla organizzazíonedi "governi" nei rnolteplici territori presenti in Europa, e, per questo, "go-vernare il territorio" , s\tl piano politico, sociaie, econornico, ha finito peressere la cifra più erzidente del processo di trasformazione in atto.
Lo Stato moderno ha rappresentato, come detto, il palese superamentodel mondo feudale nel quale coesistevano varie forme di potere organiz-zato: rfeudi, le città, i dornini ecclesiastici, al punto che su uno stesso terri-torio e sulle stesse persone si verificavano la sovrapposizione e la concor-renza fra più poteri. Inoltre, quel sistema feudale era stato carattertzzatoda una gerarchia di rapporti personali e ciientelari, per cui ii potere politi-co dei laici aveva dovuto misurarsi con quelio della Chiesa, mentre il pote-
re economico dei nobili feudatari, a sua voita, aveva dovuto cotnpeterecon quello dei vescovi e delf imperatore.
Con la nascita di questo nuovo e più intrigante soggeito politico si
andava a ridisegnare la mappa del potere e delle ieadership sia nel piùampio sistema geo-politico europeo che netr1e stesse realtà regionali e
pre-statali che su di esso avevano trovato spazio.Per 1a sua peculiare ed originale matrice costitutiva si potrebbe ra-
gionevolmente parlare di uno Stata eurolJeo rnoderflo, - soprattuttoper diversificarne le caratteristiche rispetto ad altre realtà statuali (opara-statuali) extraeuropee (si pensi alf impero persiano o a quello ci-
56
::!el - al punto che all'inizio degii anni Ottanta E.L. jones ebbe a defi-:-:l.r "The European mrracle" , "il miracolo europeo". {.Jna tesi che, come:: scriito Poggi, "tradisce forse un residuo di arrogante eurocentrismo,r,:-.-i ;he, probabilmente, rende ragione alla tipologia e alle pectlliarità::>unte dagli Stati delle monarchie occidentali rispetto a quelli dell'Eu-: -:a centrale.
Certo, 1a iogica eurocentrica che accompagna larga parte del ragio-:.::rento sullo Stato moderno sembra un pretesto per rivendicare un::rmato del Vecchio Continente. Ciò non toglie che si devono fare sfor-:: rnterpretativi maggiori per ampliare l'ottica prospettica e presentare
- Stato moderno esattamente per quello che è, valutandone la sua
-, :lubitabile portata innovativa rispetto al passato, osservandone le
: :lamiche, ma tenendo ben presente le sue molteplici (e, per molti aspet-
- rrrisolte) contraddizioni.La tipicità europea dello Stato è quella che ha finito per prevalere,
-=:.;he in quei contesti in cui essa ha subito trasformazioni che ne hanno
' -:erato talune peculiarità senzaperò che se ne perdessero i fattori strut-:--;:a1i. D'altra parte, gli adattamenii piu vicini a noi delle forme statuali,- Stato di diritto" o "Stato costituzionale" , "Stati liberali o democrati-:- - fanno indubbiamente riferimento a quella esperienza originaria::e chiamiamo, per I'appunto, Stato moderno.
t. Definizione
La parola Stato deriva dal latino stntu(m), condizione, posizione, a.::a volta proveniente da stare, con il significato di "rirnaner dritto",rssere immobile". Il vocabolo presenta legami con la formula respublica
-r\-\-ero, ciò che per noi oggi è un sistema politico), rendendo plausibi-
-e i'iclea di una persona giuridica territoriale e della ricerca di un siste-
:ra politico stabile e duraturo.Riprendendo una datata, ma efficace, definizione redatta da Anto-
::1.r Basso nel suo Dizionario di culturapolitica, si intende per Stato ,.ul-l'or-
:arizzazíone unitaria, politica e giuridica di un popolo stanziato su di:n dato territorio, costituente una persona giuridica collettiva, diversa. superiore agli individui che lo coinpongonoo munita di un potere;'imperio, supremo ed originario". La storiografia ha recepito proprio
57
dalla prassi giuridica i tre pilastri costitutivi dello Stato: un territario
unito) un polpob che insistL su quel territorio, rTrta sorranità, ovvero,
per l'appunto, un potere cf impeiio verso i'interno ed un potere di rap-^presentanza
deil'unità statale verso 1'esterno'
Sipuòimmaginarequale.abbiapotutoesselel,impattodelieforma-zioniìtatali che si andavano costruendo sulla obsoleta società eulopea
umanistico-rinascimentale, per via della spiccata carica di centralismo
e per il progressivo (ed ineluttabile) riconoscimento del potere del so-
,rrur-to, " .oil" gli Stati siano risultati decisivi per regolare in modo di-
verso i rapporti all'interno della società stessa. Si sarebbero aperte esi-
geîzedeitutto nuove che avrebbero necessitato, come sarebbe poi.re-
fiolarmente accaduto, di una efficiente ràzionayzzazione burocratica'
di risorse finanziarie sempfe più cospicue e stabili, e si sarebbero pre-
sentate questioni rilevanti chÀ avrebbero comportato una progressiva
affermazione di strumenti di interpretazione clella prassi politica più
evoluti e sofisticati. senza considerare, poi, il nuovo e piu complesso
rapporto che si andava dipanando tra il potere centrale e la periferia,la
pitr esposta a1la forte ed oppressiva autorità feudale''
Dunque, un elemento determinante consiste, senza dubbio, nelpro-
gressiaoaccentramentodelpotere,cu|siSOnoConnessesfaccettatureal-trettanto importanti e decisive, quali 1'affermazione del principio delia
territorialità dell'impegno politico del sovrano e l'impersonalità detr suo
comando. sono altri tiatti fondamentali di questa nuova forma e mo-
dalità dr or gantzzaziane politica'
tr piu moderni costituzipnalisti indugiano su tali questioni Î.1"9i.strano la trasformazione nel governo dei territori in Europa, agli intzi
dell'età mod,elna, sulla base di questi presupposti:
1) la prese nza dt' un signore che esercita in modo piu o meno consl-
stente i poteri d'imperitnn, ovvefo organizzare la giustizia, esigere im-
poste, reclutare soldati;2)lapresenzadtun,nssenlblearappresentatiun_Parliaments,Cortes,
stati Generali, ecc. - che, pef un velso, pone dei limiti all',autorità del so-
vrano, per altro verso, coliabora con lui' sino a diventarne funzionale;
3)lapresenzadtregole,soventedinaturaconsuetud:tîarla|cheten-dono a diventare unaiorta di contratto tra il signore e le forze presenti
sul territorio.
5B
- ..rigine e il{ondamento della sovranita, il rapporto fra diritto na-
-- : -- -e "
airitto positivo, la natura e i limiti dell'obbligo politictr' 1? gl::tu'r :,..-e e le relazioni tra stati sovrani, queste alcune delle più significa-
i questioni politiche ccllegate alla modernità della forma statuale'
_: nascita "
il prngr"ssirzc consolidamento degii stati ha comporta-
-;r^, implicito ed allrettanto gracluale rafforzamento delle istituzioni
. ,,.rche, che si è reso r-r".urruìio per due evidenti motivi: riclurre aila
-.::ì_rn€ proprio i feudatari e i signorotti locaii, limitandone fortemente
: --:ere di contrapposizione nei confronti del sovrano e la capacità di
_--,-.rare o fomentaie processi di ribellione nei confronti del potere
- .-:.:-rale; rafÍorzareil dominio patrimoniale dello Stato, ed anzi, espan-
-:.:.1ì con gli strumenti tipici del tempo: la guerra o la politica matri--r rale.
Da ciò si evince che 1o Stato vada percepito come una sorta di neces-
,_-: storica, tanto piu impellente in quella vasta'area el-lropea in cui le
. --ecitazioni a unificare i territori, a darsi un assetto razionale e fun-
: _ , :rante, apparivano piu forti e penetranti e in cui scattavano molle di
,,:.:aqonismo tra popoii vicini, tali da stimolare l'esigenza dt utlltzzate
; -:ioghe e più modlrne forme organrzzative' Processo' questo ultimo'
,:e.. o'íato dàfia progressiva d.iffusione dei testi "classici" di Machiavelli
= I rdin e, quindi, di una piu cliff usa percezione del fenomeno in atto e
-:=.ie sue più evidenti ricadute.
l" -{ffermazione e limiti del principe
Se lo Stato poteva rappresentare, per un suddito del XV o del XVI
:É-trlo, una fred-da, distante e ingombrante preser\za, - soprattutto per
=.ingerenZe,,inmateriaclitassazionechetantaparteavevanonelle; -1.'rni di resisten za Íeudale e popolare - , ben diversa era la forza del
l:rncipe,la cui graduale affermazione si imponeva anche come figura
,,.i.amente riconoscibile, da ossequiare e da rispettare'
Il principe ha rappresentato, diiatti, il presupposto basilare dell'esi-
: ".,-r_ru e dei consolidamento stesso dello stato. ,.Era questa una conce-
:. --ne patrimoniale e dinastica dello stato - ha scritto shennan j che fu
,-..nto importante nel sedicesimo secolo quanto sarebbe divenuta irrile-. :nte nel diciannovesimo. secondo tale concezione un sovrano eredi-
tava lo stato così come il figlio di un proprietario terriero ereditava i
suoi possessi paterni. Vi era una sola differenza: 1'autorità del principe
si iraÀava sul potere di agire piuttosto che sul possesso della terra (ad
eccezione ovviamente di quelle terre che costituivano entro i confini
dello stato i suoi possessi personali)".Dunque, la sovranità finiva pef essere intesa come patrimonio ere-
clitario, di cui diventava garante Ia dinnstitr,l'altro anello forte deli'au-
torità clel principe" Il cui dovere, naturalmente, era assicurare la prote-
zione dello Stato e quella stabilità politica che potesse garantire la con-
servazione del potere. ,,Il re - ha scritto infatti Eiliott - doveva "lavofa-
re" per i1 popolo - trnbajar pnrn el pueblo. - che era stato affidato alle sue
.rrtò. Etu suo dovere proteggere il popolo dai nemici esterni e ammini-
strare al popolo la giustizia, perché l'essenza dei buongoverno consi-
steva nell'attuazione di un govelno giusto e cioè in quel tipo di govelno
in cui il re ricompensava i buoni, puniva i malvagi e faceva in modo
che tutti, quali che fosse il loro rango e ia loro condizione, restassero intranquillo possesso dei loro diritti e dei loro beni".
Ma, nel quadro della società di antico regirne, con le sue ben deline-
ate regole, il principe doveva districarsi tra due delicate questioni stret-
tamente connesse, di particolare rilevanza.'Laprima era decisiva per ilconseguimento cli quel fondamentale equilihrio tra dorLirtio e consenso
che doveva essere oilu b^t" del suo potere: rispettare e farsi garante di
quella rete di diritti e priailegi consuetudinnri dt cui erano beneficiari isuoi sudditi, e che costituivano un limite oggettivo al|'azione assoluta
e imperiosa della sovranità. Era..1'ossetvarrza deile buone leggi e buo-
ni ordini> per dirla con il Guicciardini, una prerogativa etl una necessi-
tà che impedivano al sovrano di diventare un tiranno autocfate e pre-
potente e to obbligavano, in misura sostanziale, a rispettare il popolo'
La seconda, - che era più rilevante sul piano strategico nella gestione
dello Stato, anche per non subire condizionamenti che potevano len-
dere precatial'azione del sovrano -, consisteva nella necessità di co-
struire mediazioni con i poteri forti (la feudalità, il clero e, più avanti, tra
la fine del XVI e iI XVII secolo, i poteri finanziari), tutelando quei bene-
fici che efano alla base di una società ancofa fortemente diseguale e
basata sulla discriminazione giuridica.Naturalmente, il colnpromesso con ta feudalità, - il più necessario sul
6A
--'Jolitico - dirrentava comunque una spina nei fianco del sovrano,,'.::uito in quegli Stati in cui essa rivelava la piu sorprendente capa--i, controllo sociale ec1 economico, mirando ad erodere con ii suo:Ìiarnento sovrrersivo una larga fetta del potere sovrano e aìiriirnarne, più o menc! consapevolmente, l'operato.i,:cl'uavelli, che ha piiì volte delineato f imprescindibile con:rpito per
ntollerabile ruiolenza, ma con ii favore delli altri suoi cittadini di-.... plin.lp* della sua patria (..), dico che si ascende a questo princi-
,. .on il favore elei populo o con quello de' grandi. Foiché in ogni,: si trorrono questi dua umori diversi; e nasce da questo, che il populo,..J.Èra non essere comandato né oppresso da' grandi, e li grandi desi-.;:Ìo comandare e opprimere il populo; e da questi dua appetiti diversi
' -'--e nelle città uno de' tre effetti, o principato o liirertà o licenzia" .
ì,'"lnque, il go-,rerno del re doveva prefigurarsi come modalità per--:ie le vistose prevaricazioni dei cetii ceti potentii potenti e arrogantii, pena ia
',--.-ltà del suo stesso governo. "Colui che viene al principato conla, - -,- rle' grarrdi - scrive ancora Machiavelii - si mantiene con più" -..:iiltà che quello che diventa con Io aiuto del popurlo; perché si truova. " ::ipe con di rnolti intorno, che li paiano essere sua equali, e per que-: r-.oll ii può né comandare né maneggiare a suo modor, e, poco oltre,l.:1.e, pertanto, uno che diventi principe mediante il favore del
- :,..1o, rnantenerselo amico; ii ctr"le li fia facile, non domandando lui se
t- ',ji non essere oppresso>.
-er-rtralità del popolo, pertanto; un ragionamento che lo stesso
,.'::riai.e1li, con persuasivo pragmatism.o, tende così a sintetizzare '.a- - :rirrcipe è necessario avere el populo amico; altrimenti non ha nel-
. -,-.-r-ersità rimedio". trl consenso popolare si rir,.elava decisivo per ren-- .,: i1 sovrano quasi impeccabile nella sua funzione di galante delf in-':::sse generale del paese, concorreva a rassicurarlo e a sostenerlo nel-. -r'equenti avr.ersità politiche.
-- richiarno a Machiavelli segna una tappa fondamentale nel ptoces-- ;ulturale che sta alla base dell'affermazione dello Stato, al pari di: -irrr. Per íl quale occorre cogliere f incipit del iibro I della sua opera,
, :.i governare nella piena- considerazione del popolo, ha messo in.:-- r-u-i altro aspetto che è da collegare alle dinarniche del governo-:r.clriccr:
"Quando una privato cittadino, non per scelleratezza o
61
divenuta un classico del pensiero politico: ,.Per Stato si intende il go-verno giusto che si esercita con potere sovrano su diverse famigiie e sututto ciò che esse hanno in comune tra loro'r.
La sovranità cui fa cenno Bodin è perpetua,ossia non può essere limi-tata nel tempo,'ed è assoluta, cioè non sottoposta acl alcun potere supe-riore, ad eccezione clel potere divino (sulla base del principio delsup erior em non r e co gno s cens) .
Con la crescita ed il consolidarsi degli Stati i sovrani si trovavano aimporre decisioni su strutture amrninistrative sempre più complesse, po-tendo disporre di risorse finanziarie anche cospicue, e rivelando capacitàdi organizzazione degli eserciti, sino a progettare vere e proprie campa-gne di intervento militare. La guerra, infatti, da affare quasi privato e loca-le tendeva a ridiventare un affare di Stato, e da esso veniva monopolizzata.
Certo, a monte delia maggiore clisponibilità delle risorse per il so-vrano vi era la tassazione e ciò generava problematiche altrettantocompiicate, in uno all'articolato sforzo amministrativo e dirazionalíz-zazione burocratica che puntava, tra le varie altre aspettative, a regge-re l'urto di guerre in cui il numero degli Stati impegnati finiva per cre-scere notevolmente.
I conflitti si arricchivano di prospettive differenti: dalle guerre me-dievali, pur distruttive ma limitate, si passava alle guerre di religione,sino alla decisiva guerra dei Trent'anni (1618-48), che, di fatto, ha co-struito un nuovo ordine politico europeo e condizionato le vicende delContinente ben oitre la metà del Settecento..Essa, come è ben risaputo,avrebbe rappre'sentato il trionfo dell'equilibrio politico e della diplo-rnazia, nonché della esigenza di trovare alleanze, di costruire reti direiazioni politiche, decisive per le nuove, possibili, vicende belliche eper intrecciare accordi politici ed economici.
3. I caratteri comuni degli Stati nelle diversità locali
Lo Stato moderno ha assunto forme diverse da paese a paese, comeabbiamo avuto già modo di sottolineare, per cui la schematrzzazioneconcettuale dei suoi caratteri potrebbe rivelarsi troppo rigida e non ren-dere ragione alla varietà delle esperienze registratesi nel contesto euro-peo. Non a caso, pur non rinunciando, come abbiamo fatto sinora, a
62
-:.:-r.iificare caratteristiche generali comuni, ci si atterrà in questa sede
: - ::r.lividuazione di modelli più specifici, da quello francese a quello;::5rolo, da quello ingiese a quello tedesco, a quello polacco e via di-."- ::rendo. D'altra parte, non è pensabile che un processo così cornples-
-- ecl articolato non abbia subito inevitabili influenze dalle peculiarità
-,-...ii, dalle tradizionali forme di potere sviluppatesi, dalla specitica
-: -r'!ensione politica.
. Il cnso franceseC'è chi ritiene che la Francia sia diventata una potenza europea già
::L inizi del Trecento, sulla base di due fattori ritenuti decisivi in que-
::-: tlirezione: le ascendenze imperiali e la legittimazione religiosa. Il:rlrno eiemento si ricava dalla considerazione che, dopo aver sconfitto. -:rperatore Ottone IV a Bouvines nel 17-14, iI re Filippo si fosse appro-::;ato del titolo imperiale, al punto che la successiva storiografia.::r-.alpina avrebbe considerato quella battaglia come un fondamento:=-la propria storia nazionale.
li secondo elemento deriva dal fatto che agli inizi del secolo XIV la
- :mcia aveva accolto sul territc''rio di Avignone il papa e la sua corte,
.-,'ento che ne consaclava una visibilità nell'immaginario collettivo ed
-:. irnportanza quasi indiscutibile in Europa. Ma va anche consideraio
:--.e ia famiglia reale avev a ramificazioni regnanti a ì\iapoli, in Proven-
-: ecl in Ungheria, ciò ne accerta una dinamica di potele meno locaie e
.ra dignità già in via di ampia acquisizione su varie aree non certo
:;.ondarie dell'Europa.Tuttavia, ciò che probabilmente ha permesso alla monarchia france-
.e li diventare più forte accreditandone il ruolo sullo scacchiere euro-
::c fu il ritiro graduale degli inglesi dal proprio suolo tra il1435 ed il-=t 1. L'unificazione territoriale della Francia siteahzzò comunque nel
,1S1, con la conquista deila Borgogna da parte di Luigi XI. E, come
.:L'riamo già avuto modo di rimarcare, l'unità territoriale è stato uno
-tei fattori emblematici che ha concorso alla costitqzione di formazioni::-i lu ali.
\ella nuova tipologia statale le caratteristiche medievali, che si rifa-
--È',-ano ad un rispetto sostanziale della complessa rete di giurisdizioni:.ali, persistevano ed elano affiancate dalla formazioni di nuove isti-
tuzioni. Sostanzialmente, il modello francese di Stato moderno presen-tava una sovrapposizione tra vecchio e nuovo. Il rispetto degli ordina-menti particolari esigeva che in rnolti territori conquistati o riconquistatisi continuassero a convocare assembiee locali. Si trattava, quindi, di unsistema di rappreserttanza autonomo basato su Parlamenti e Stati pro-vinciali, i quali trattavano con il sovrano le modalità clella tassazione,goclevano anche di contraiti in cui erano precisati i privilegi concessi e
le consuetudini vigenti.Il re, altro fattore di stampo medievale, eta ancora al vertice di una
gerarchia di vassalli e continuava a conseîvare l'idea di un legarne per-sonale e contrattuale con lo Stato. L'elemento di modernità era basatosulle nuove funzioni rivestite dal sovrano: il re diventava il garantedeli'unità territoriale e predisponeva le leggi, tutti i clecreti erano re-datti in suo nome. Ambiti di competenza reaie diventavano I'ammini-strazione, lafinanzae la giustizia; in alcuni casi tr'autorità sovrana esten-deva la sua giurisdizione anche nel campo del diritto privato.
11 forte mutamento significativo rispetto al passato è determinatodalla tendenza alI'accentramento del potere nelie mani del sovrano. Ilre diventava il perno deltr'ordinamento politico, il rappresentante del-i'unità e dell'integrita dello Stato. Egli però non era piu in grado diesercitare da solo tutte le funzioni connesse all'attività politica, delega-va così il potere a consigli e corti"
L'organo che coadiuvava il Monarca nelle sue decisioni, rafforzan-done il monopolio delle funzioni era il Consiglio del Re,la piu importan-te istituzione dello Stato francese, formato dai grandi dignitari, dai parie dagli ufficiali della Corona. Si tratta di un organismo di origine me-dievale che aveva trasformato le sue peculiarità in senso moderno. Sinda1la sua genesi i consiglieri erano legati al sovrano da un vincoio dinatura personale, rappresentavano un'estensione della sua prestigiosafigura, ma nello stesso tempo riproclucevano gli interessi delle assen'l-blee dei sudditi del regno. Il cancelliere, che stava a capo del Consiglio,era collegato con gli ufficiali giudiziari e fiscali presenti nelle province;in questo modo il Consiglio poteva vigiiare sulle periferie.
Nel Trecento i funzionari itineranti nelle province esercitavano po-teri molto arnpi e netr secolo successivo iniziavano a occuparsi di mate-rie meno generiche. Fu grazie a questa qualificazione, alla divisione
/^t-)4
r:,ie competenze, che alf inizio del Cinquecento il consiglio clel ìLe si. ,::rlrvise in tre parti costitutive:la sezíone di stnto, ir consigtio cles parties- -: ri Conslglio delle Finanze. Non esisteva ancora una vera e propria ri-: ''rtizione delle materie, ciascuna componente seguitava à srrolger"-.r--zioni differenti e molteplici, ma ia monarchìa francese si era
, :-fissata un obiettivo: riuscire a separare ie mansioni tra gli uffici per. '=11ire le procedure in un sisterrra che continuava ad essere contrasse--, iato dalla confusiclne dei poteri e delle giurisdizioni.
Cooperavano con iì consiglio del Re i maîtres des requétes, dei com-- -ssari fidati del so'u'rano che percorrevano le prorrince, controllando-= e.l intervenivano alle riunioni der Consiglio. sarebbe stato Luigi Xf.{,=, Seicento, a risolvere il problema deiie province creando la-tigura
" . iii intendenti, interfaccia tra il potere centrale e le rivendicazioni della.': -te f icl.
. n altro rilevante strumento di governo, nato con Francesco I, era i1- -;iglio tlegli Affari, u'a sorta di consigrio privato del sovrano, compo-'. - .lai r.roiintiÀi consiglieri. Il re riuniva spesso i suoi consulenti per'- --. are la soluzione a questioni di tipo politico, finanziaúo, militare o' :'"mìnistrati.ro.
\el 1542 poi, la Monarchia aveva dato vita alle figure dei quattro' - : :tnri del re, responsabili clei quattro dipartimenti in cui era diviso lo::,iO.
La Francia aveva concepito un programma cli massima'--^.lrarizzazi{:ne, tutto dipendeva dal re, cialla sua volontà; come
- . -rtraltare si sviluppava la tendenza dei ceti ad assicurarsi un certo-::-1o di rappresentanza. Aspirazione che si mani{estava negli stati. - -:rnlí,1'assemblea dei rappresentanti clella società francese (nobiltà,. :r.o e terzo stato). il loro compito precipuo era il voto delle imposte,---. in alcuni frangenti ostentavano anche una forte opposizione politi--' :'onendosi in antitesi con l'accentramento statale. per questo motivo,:o il1614 non sarebbero stati più convocati, sino al maggio del1zg9.E;anc, però, soprattutto i Psrlamenti a disporre della facoltà di resi-
'',=rtzà, perché ricoprivano il ruolo di massima istituzione giudiziaria e' -- -gevano f incarico di registrare i provvedimenti giurisdizionali ema-,,:r dal re; in teoria essi potevano bloccare le ordinanze ritenute. im-
, =:';ette, privandole della registrazione. su questo cavillo si basava l,osti-
65
lità tra il re ed i Parlamenti: il sovrano riteneva Iaregistrazrone solo unaformalità, qualificata poi dalla pubblicazione, sostÀendo, per bocca diCharles Loyseau, giurista francese del XVII secolo, che ,,dove il re èpresente, laforza dei magistrati si oscura, cosi come il sole fa impallidi-re le stelle,>. I Parlamenti, invece, pretendevano di esercitare un vero eproprio potere di consultazione e valutazione del merito.
In sostanza,lo stato moderno francese può essere configurato comeuno stato-apparato che si è dato una sua struttura ed una forte ed effi-ciente organizzazione burocratica che tendeva alla specializzazione.Larga parte del successo della Francia nello scacchiere politico euro-peo, dal XVI secoìo in poi, sarebbe dipesa da questa potente macchinadi coordinamento amministrativo e politico; ,rl" turrd"r"rze centripetedel sistema amministrativo e giudiziario e dell'esercito regio - ha scrit-to Reinhard - si mostrarono utili tanto quanto il controllo da parte delsovrano di una "società di corte'{ decisiva per la corona,,.
va detto, tuttavia, che se la prospettiva cenkalista ha finito per esseredecisiva nel sistema francese, trovando in Luigi xIV il suo maggiore inter-prete, i sovrani dovettero attuare una politica di negoziazione con i poterilocali, soprattutto quando questi erano chiamati ad un cospicuo onere tri-butario, perché il,loro sbarramento o qualsiasi tecnica osfruzionistica sisarebbe potuta rivelare dannosa per lo stato. pertanto, in Francia, come iniarga parte degli stati europei, soprattutto nella fase di maggiore maturitàe consolidamento politico, <i1più efficace mezzo di potere non consistevanell'occasionale uso della forza, misurabile soio dagli effetti, ma neli'usocalcolato delpatronage, allo scopo di costruire unfidato suppo di sosteni-tori e di neutralizzare i fattori di opposizione>.
obbedienza dei sudditi e riceica del patronage sarebbero state duemodalità fondamentali del sistema politico transalpino per saldare unaparte importante del corpo sociale con il corpo politico, rappresentatodal sovrano.
b) L'InghilterraTroviamo similitudini e diversità nell'anarisi dell'Inghilterra.Lo stato inglese aveva rinsaldato le fondamenta del suo potere alla
fine della Guerra delle Due Rose, una sanguinosa guerra civile tra lacasa di York e quella di Lancaster.
66
Durante la. guerra dei Cent'anni combattuta contro ia Francia, gli
,-gt.ri ^r,"rrur-rJfinito
per perdere il controllo del territorio transalpino,
,-.;r à\r€Vaflo conqurstito .rr"ru forte consapevolezza della propria iden-
..:a e di essere una comunità dalle potenzialità enormi'
La Monarchia, con Enrico vII Ttrdor, aveva affermato la sua autorità
.," L1n complesso statale unitario, formato da Inghilterra, Galles e parte
-- =11'Irlanda, divenuto tale mediante tappe ben precise con le quali si
.:.e. sbatazzato di molti suoi nemici, aveva concluso la pace con la Sco-
--a e stretto con rI re scozzese un patto matrimoniale' Non a caso' la
.:oriografia tardo ottocentesca ha parlato di un 'fudor dispotism e di un
:oltúeSoaerneffienf,propriopersottolineareimeritidelsovrano(eì-.Èno da"parte dei suài pì.: a"Uoti successori) nella formazrone di un
:-..,derno Stato.La forzadel sovrano era esaltata dal ridimensionamento del potere
:clitico delle grandi famiglie feudali, graziegnch.e alf istituzione della
,;.,tera Stellata,una sorta Ai tribunale straordin aúo ultlízzato finanche
::ntro i feudatari ribelli, ai quali spesso'7 come pena' venivano
=spropriati i beni Posseduti.oltre alla camera ste1lata, che consisteva nella riunione del consi-
:'ro privato del re che si attribuiva specifiche competenze in campo
...,i", preposte alla tutela degli interéssi della Corona,l'organico del-
e corti di giustizia era arric.hito .or", Ia fotmazione del1a Corte delle
.:ltieste,che aveva un suo ruolo nelle rimostranze dei soggetti più po-
.eri, e Ia Corte degli incrementi, che aveva autorità sulle questioni ine-
:enti 1a confisca dei beni ecclesiastici' r
Peculiarità del regno di Enrico vII era anche la partecipazione di
=lementi non titolàtiiella società agli affari pirbblici e giudiziari'"i;;;;; sarebbe stato Enrico vI11 a mostrare un iper attivismo in
Europa, stringendo alleanze e partecipando a varie guerre strategiche'
Egli avrebbe rinsaldato " ,tot'i"'satoìapporti a se.conda delle proprie
'o-,.'.r"r-riur-rre politiche, mantenendo buòni legami con la Santa Sede'
\onavrebbeesitatoasconfessareancheLutero,ponendosiinopposi-zione al movimento riformatore, al punto da essere considerato dal papa
-eone X difensore della fede'
Con il nuovo SoVIano 1l primo segretnrio ed, tI Consiglio priaato sa_rebj
:.ero d.iventati il fulcro dell'amministrazione, mentre l'Ufficio dello Scac-
67
chiere (organismo politico) avrebbe guadagnato l'autorità indiscussasulie altre istituzioni. Allo stesso tempo il re aboliva le disuguaglianzecostituzionali e gli eventuali privilegi in vigore all'interno dello Stato.
Bisogna ricordare che la storia inglese è stata segnata da due impor-tanti vicende storiche che l"hanno resa singolare nel contesto degii Statieuropei: la concessione della Magna Charta, nel1215, da parte di Gio-vanni Senzaterra ai baroni inglesi, = considerata il fondamento dellelibertà costituzionali dello Stato -, e la nascita del Parlamento, alla finedel Duecento, che da organo di consultazione si era andato trasformandoprima in strumento di controllo, poi assumendo vere e proprie funzics-ni legislative.
La struttura parlamentare dell'Inghilterra era totalmente differenteda quella delle assemblee operanti nel resto degli Stati moderni. Il Par-lamento inglese godeva di una connotazione bicamerale, sicontraddistingueva per la presenza di una Camera dei Lord ed una Ca-mera dei Comuni, rappresentanti due componenti diverse della società.La Camera dei Lord era ereditaria, vi sedeva la grande nobiltà che tute-lava i suoi interessi. La Camera dei Comuni era elettiva, costituiva unluogo di rappresentanza più ampia; ne facevano parte la gentry, picco-la nobiltà proprietaria di terre, gh yeomen, coltivatori diretti, ed i cetinon aristocratici; non era rilevante avere un titolo nobiliare per farneparte, bastava essere provvisti di una consistente capacità monetaria.
Il Parlamento, poi, godeva della funzione legislativa, fondata sulcoftm'Ion lazo,la legge della comunità, svincolata dal volere sovrano.
Un'altra nota distintiva del sistema politico inglese era costituitadall'autogoverno delle contee, affidato, in forma non retribuita, aglisceriffi, di stirpe nobiliare, ed ai giudici di pace, non nobili ma legatiagli interessi dei territori. Si verificava questo tipo di situazione perchél'Inghilterra difettava di un diritto amministrativo formahzzato, IaMonarchia cosÌ prediligeva far governare le periferie dalle particostitutive della società.' Delineati questi caratteri dello Stato moderno ingiese si può facil-mente notare come esso si sviluppasse sotto la forma del particolarismo,tanto che a difendere i diritti della Corona da eventuali pretese inter-vennero le teorie giuridiche. Fu proprio in Inghilterra che si sviluppò,con Kantórowtcz,la teoria dei due corpi del Re. Egli sosteneva che il
68
I
- "raiìo fosse dotato di due corpi, Lllr corpo naturale, che si ammalava,-''=,:chiava e moriva, ed un corpo politico incorruttibile, indeteriorabile,r-::r.ottale, nel quale confluiva l'essenza stessa deila sovranità che si:sierir.a da un sovrano tell'altro alf infinito.Era il trionfo deltra dinastia, la cui longevità e persistenza rassicura-
,: ;'animc di un popolo fedele alle sue tradizioni e inorgoglito dalla.:r1o.l;ia inusuale di sviluppo di una forrna statuale non assimilabite
.' aitre in Europa e basata sul ruolo altrettanto nodale del Parlamento. -: frnirra per delineare la rnonarchia anglosassone come costituzionale.
.' L' esperienza spagnolaPer quanto riguarda Io sviluppo dello Stato moderno spagnolo, le
' )zze tra Ferdinando d'Aragona ed Isabella di Castiglia, celebrate il19:fobre 1469, avevano sancito le premesse per l'unificazione della Spa-
.-ra, portata a termine nel 1512 con tr'annessione della parte spagnola-'.=-11a Navarra. Quel mosaico turbinoso e litigioso di Stati aveva smesso--.i essere iormalmente taie e si avviava ad assurgere a ruolo-guida dei-Fuiopa.Tuttavia, come più volte sottolineato, l'unione della Corona
,::agonese con quella castigliana poneva in relazione due popoli, con--.ue stili di vita differenti sia dal punto di vista sociale, che negli aspetti:.onomici e politici. Il matrimonio tra i due sovrani non portò alia fu-.:one di questi due popoli, ma solo a quella delle due famiglie reaii.- iatto, questo, che si sarebbe rivelato decisivo nel destino futuro dellaSirag"a, condizionandone la vicenda politica.
Ferdinando e isabella, come ha scritto Kamen, ,.furono sovrani tut-: altro che "moderni", risolsero in modo schiettamente feudale le loroiifficoltà alleandosi con le élite nobiliali e municipaii; ma ir.r seguito la--ondizione dei monarchi europei divenne più complessa, e se da un.ato vennero in loro aiuto alcuni fatti nuovi, daii'aitro essi furono co-siretti ad agire con cautela verso la nobiltà. La formazione di corti sta-ri1i, con ii loro cerimoniale e il loro fascino cavalleresco, diede all'auto-lità regia un centro visibile; la riorganizzazione delle leggi e del siste-ma giudiziario confermò il principio che il diritto era un'emanazionelel sovrano; dalle facoltà di giurisprudenza delle università, sempre
i,riù nurnerose, uscì una nutrita classe di burocrati; le milizie feudaii
69
furono sostituite cl;r nioclerni esercitj r.lipenric,nti clai govenri centraliz-zati' fr'{a, in pratica (..) i sovrani sigr.rarrlavano ir"r".,r-. .lall'intraprenclcrequalsiasi azione sellzcr il sostegno c'lei ceti r-lotati cl'influenza politic:r.La rnonarchia assoluta era ancora soltantc un'aspirazione, uno schernilicieale con cui i pensatori polìtici cercavar-ro cli orgar-rizz;rre il cass che Iicircondava,,.
Esami'ando nel dettaglio gli aspetti clei paesi clie f'rnravano la spa-gna si nota che l'estensione della regione castìgliana fosse. quasi t1e voltequella del territorio dell'Aragona, la popolazione pl.esLrntilva una den-sità elevata, ma la sua società era ancor:a p;rstorale, connotata c-ranomadisrno e dedita erlla guerra. L'Aracc'a, che i'gìobava anche lacatalogna e Valenza, invece, aveva clató vita nel ta;cio Meclioevo algrande impero cornmerciale catalano-aragonese cli tessuti e spezie. Imercanti ectr i patrizi cielle citià, poi, avevano collaborato alla for.rnazio_ne di un singolare sistetna costituzionale, costruito sull'iclea cli contrat-to, vale a dire tra il sovrano ed i suclditi esisteva una reciproca fc-rrmir difiducia, basata sul riconoscimento cla ambec{ue ie partì che ciascunc-raveva i suoi obblighi e che esistevano clei limiti al potere. euesto pattotra re e sudditi era stato prirna sperimentato nellaioncluzione cleil,in-pero commerciale, per poi confluir.e nell'arnbitc'r clella gestione politica.
In Aragona, ancor più che in castigria, il sistemu ruppr"r"ntativo sifondava sulle Cortes, l'assemblea clei ieti o degii stati, i" i.rro mansionierano l'esame delle lagnanze,la proposizio,,rò .1i .in.,"cli, la votazionedi sussidi per i1 ,orrro,-rl, riuscirono ur'rcr-r" acl acquistare un potere legi-slativo. Nel Medioe.vo le Cortes castigliane
"ror-ro formate clallà granúe
nobiltà, dal clero e dagli esponenti deile città clernaniali; all,inizio clel-l'età moclerna la composiziòne sì era alterata in se.guito al sensibile au-mento di potere degli aristocratici, ne derirrava un ciisinteresse clellagrande nobiltà che riusciva a difendere i propri privilegi senza ricorre-re alle Cartes. L'assemblea diventava una sempìice riunione clei r.ap-presentanti delle città demaniali, non riuscenclo a conquistarsi la parte_cipazione al potere legislativo; per quest'orcli.e cli moti',i i sovra'icastigliani si trovavano ad essere svincolati clalltr.convocazione a sca-derÌze. fisse e regolari delle Corfus.
Al contrario, in Aragona si ricorreva spesso alla riunione clelle Cortesed esse funger,'ano da sostegno al "1ttúlistlk) orilgone.se". 1 Re Cattolici
70
-r1l presero alcuna iniziativa per uniformare ie amininistrazioni delle
=gióni formanti 1o Stato iberico, al contrario i sovrani spagnoii si com---'-rrtavano come assoluti in ambito castigliano, mentre governavàno in
:-,or1o costltuzionale in Aragona. con questo suo atteggiamento la
Ionarchia rispettava f individualità dei regni, le loro autonomie e le
- igi tradizionaii.La novità di rilievo introclotta dalla Corona nel complesso dei domi-
:..r ela i'istituzione di numerosi Consiglí(polisinodla) che affiancavano iliJYfano, alcuni con competenze specifiche, altri con autorità.trritorialmente definita, dividendo in questo modo per rnateria e per
,,rnbiti geografici l'attività di consulenza dei collaboratori reali' I Con-
.igli territoiiali che si occupavano del1a gestione dei domini erano: i,-.ìirslgll di Cnstigtia, dr Aragona, d'Itslin (1555), di Portognllo (1580), di
- .,r.nìie e delle Indie.Consigli dipartimentali erano: 1l Consiglio d'Azien-
,.2, il più importante perché gestiva le finanze statatri, rl Consiglio di Stn-
. e quello dlGtfetaassistevano il sovrano nella politica interna ed estera,
a Stiprerna Inqttisizione si interessava dell'ambito religioso, doveva pre-
:elvare lapurezzadella fede, ma finì per trasformarsi in uno strumen-
:.', politico. Tutti avevano sede a Madrid e servivano, naturalmente, a
-avorire 1'accentramento del potere nelle mani delsovrano'C.ome funzionali al potere del re andavano considerati i ministri.
Emblematiche, in tàl senso, le parole con cui un intellettuale spa-
guolo di grande rilievo, Diego de saavedra, ne delineava il ruolo e la
:unzione a beneficio del governo del principe:,,Un príncipe que ha de ver y oír tantas cosasr todo había de ser ojos
,. orejas. Y, ya que no puede serlo, ha menester valerse de los ajenos' De
esta necesidad nace ò1 no haber príncipe, por entendido y prudente
que sea, que no se sujete a sus ministros, y sean sus olos/ sus ples y slls
Ttanos. Con que vendré a ver y oír con los ojos y orejas de muchos, y
.icertarà con los consejos de todos".Ma la spagna, oltre ad essere una compagine statale di primissimo
piano, potàva sciorinare, per così dire, una ben più complessa ed intri-
gante orgun t"uzione politi.u. La Spagna imperiale, che Elliott ha
.ror-rologicamente condensato tra il 1469, anno del matrimonio tra Fer-
,-linanclo e Isabella, ed. rI171,6, data della Nueun Plnnta, catalterrzzata
rlalla trasformazione della Spagna ,,da un coacervo di province
71
semialltonome in Stato centraltzzatorr, si prospetterà, come vedremo
tra breve, in un "destino" politico di straordinaria valenza per 1a cultu-
ra e la politìca europea.
d) Il mutantento politico in GermsniaUna tipologia statuale a sé stante era 1'Impero germanico, che, come
ha scritto Reinhard, (non era una monarchia né una semplice alleanza
di principi, ma un sisterna di dorninio nuovo a due livelli,'"
I dr-re livelli erano g1i Stati territoriali e l'Impero'Per quanto riguarda gli stati territoriali, il processo di formazione e
consoliclamento mutava a seconda della zona considerata e de1 rap-
porto tra principe e ceti. Per ciò che concerne I'In"tpero, è ancora Reinhard
à sottoiinìutt-r* il prestigio, .a partire dal X secolo I'asptazione all'in-
coronazione imperial" ,r"r-rr-r" collegata proprio alla dignità regia di
questo impero. Da qui nacque la particolare possibilità di scegliere
durante la vita delf imperatore un <re fomano" aggiunto come succes-
sore clesignato>, che si prefigurava come "una statrilrzzaziot:re dinastica
della monarchia elettiva>'oggi si tende a rimarcare la peculiarità tedesca, come forma politica
alterniti,ra allo stato di potenza, ma ancora Ileinhard e Krieger hanno
sottolineato, con apprezzabile chiarezza, che talune strutture origina-
rie delf impero e l'estinzione delle dinastie, hanno procurato più svan-
taggi che vantaggi ai monarchi tedeschi rispetto agli altri re europei.
ia cliffusione in Germania de11a piena proprietà della nobiltà aveva
comportato una sorta di piena indipenclenza dei nobili dalla corona; "i1
tentativo di una politica pianificata del patrimonio delf impero con l',am-
ministrazione da parte dài servitori del re (i ministeriatri) fallì a causa della
fragile continuità dinasticao; i vari <tentativi di introdurre il diritto eredi-
tarIo, [furono] abbandonati del XIil secolo a favore del libero diritto di
elezione. Vari canrbiamenti dinastici lasciarono agli Asburgo, eletti a par-
tire da11a metà del XV secolo, soltanto la possibilità di una monarchia fon-
data sul potere patrimoniale,,; f impero fu percolso "da tensioni dualistiche,
imperatàre -papa, impero-potere patrimoniale, re-principi elettivi, re-ceti
imperiali. Il coliegio dei principi elettori continuò semple a pretendere per
sé,iltre all'elezione detr sovrano e a particolari privilegi per i loro territori,
la coreggenza accanto al re', (Reinhard).
72
L'impero, dunque, fini per essere affidato agli Asburgo ma, malgra-
-,,. il pràstigio di Óarlo V,ìisultava alquanto esiguo il potere che f im-
::ratore riuscirra ad esercitare sui principi territoriali, che assomiglia-: :no più a signorie feudali che agli Stati moderni che stavano nascen-
. ,.. .,iIot c'è [uindi da meravigliarsi - è ancora Reinhard a sottoiinear-
-- - se la sovranità territoriale in Germania si formò attraverso la rac-
:,:.lta e l'unione di diritti sovrani di diversa specie, attraverso 1'acqui-
::.ì, lo scarnbio, l',eredità, il matrimonio, la donazione o anche la con-
::ista>.Lo Stato moderno tedesco si basava su un'orgartizzazione politica-
.:itlitare altamente qualificata. 11 ceto amministrativo doveva risponde-
e a criteri di obbedienza, disciplina e fedeltà tipici dell'esercito' La
:uova burocrazia si innestava sulla vecchia e si integrava con essa me-
:iante una scelta meritocratica dei funzionari, chiaramente con la pre-
::inenza per i funzionari di ceto feudaìe.
,,Chiamiamo formazione moderna dello stato e strutturazione della so-
:ietà moderna clei sudditi questo sowersivo mutamento politico e sociale'
-e sue origini risalgono al tardo medioevo, ma la legislazione augustana
jel1555 urru,ru tuttavia fornito tanto dal punto di vista giuridico quanto
"1a queltro politico mlovi impulsi che accelerafono radicalmente questo
..roà"rror^ ma furono soprattutto le imponenti energie della
:onfessionaltzzazioneche spinsero conpotenzale trasformazioninella stes-
,a direzione. Nella seconda metà del XVI secolo due processi fondamen-
:ali delia nascente età moderna si incrociarono e si sovrapposero al punto
che le loro dinamiche si solrrnarono: il dinamismo teologico-religioso che
t1a Trento e Ginevra stava irrompendo nell'impero incontrò il dinamismo
.ecolare dello stato moderno che alf inizio dell'ultimo terzo del secolo in
Germania ricevette nuovo slancio"'il passo di Schilling rende ragione detla via tedesca allo Stato mo-
.1erno, condizionata, cJme appare evidente, dalla legislazione augustana
del 1555, la prima esposizione ufficiale dei principi del protestantesi-
rno. In effetti, la pace di Augusta segnò una sorta di pax religiosa tra
cattolici e protestanti, sulla base del principio dei territori confessionali'
Risoita in buona pafte la questione religiosa, la molteplicità dei ter-
ritori che formavano 7'ateagertnanica potevano essele sottoposti, ora-
mai, ad una profonda trasformazione interna dello stato e della socie-
73
tà. Si registra un arnpliamento dei campi di attività pubblica,la forma-zione di una burocrazia più rnoderna tanto a livello centrale che a livel-lo locale, con funzionari non pitì dipenclenti dalla feudalità ma legati a
doppio mandato con il detentore del supremo potere statale, i principi,il tentativo di erigere una .,società dei sudditi discipiinata e unitaria,,.
e) Il caso polaccoAbbiamo esaminato quattro tipologie di Stati. Ognuno di essi ha
sviluppato un suo percorso nella realizzazione e nel consoiiclamentodella modernità, ma in tutti, come visto, gli orgarri di governo serviva-no a rafforzarel'autorità, il monopolio del potere sovrano. La Francia,I'Inghilterra, la Spagna avevano in comune l'essenza della figura reale,la sua caratteristica divina, il potere che discendeva direttamente daDio: il sovrano incarnava l'unità statale. Erano anche monarchie eredi-tarie, la regalità si tramandava da padre in figlio, la legittimità dinasticadiventava un fattore della modernità che rendeva più forte 1o Stato.
Infatti,,negli Stati in cui mancava l'elemento dinastico la monarchia era
debole e le conseguenze per il suo prestigio europeo erano piuttosto evidenti.Ne è un esempio emblematico la Poionia.
. Lo Siato moderno polacco era stato costruito grazie alla dinastia
Jagellone, ma, alla sua estinzione nel 1572,la monarchia si era trasfor-mata da ereditaria in elettiva, si era bloccato 1o sviluppo statale e sierano sgretolate le sue strutture. trl sovrano eletto dai feudatari non rap-presentava l'unità dello Stato, norl accentrava il potere nelle sue mani,ma veniva spesso bloccato nelle sue decisioni dal veto dei feudatari. IlGrsn Consiglio eIaDieta, clominati dai nobili locali, non lavoravano perf interesse generale, bensì per quello dei propri feudi.
Debolezza economica e politica erano le due facce della stessa me-daglia. In particolar modo nel corso del XVtrI secolo, a seguito di unaguerra per controllarne il territorio, la Polonia conobbe una crisidemografica e di esportazione cerealicola di vaste proporzioni, dallequali non si sarebbe ripresa.
fl fl ginepraio italianoL'ultima area oggetto della nostra pur succinta analisi è I'italia, che
non era unita nei Tre-Quattrocento (e per moiti altri secoli ancora), di-
74
-ettava, quindi, c1i un territorio d.elineato, ed era formata da diversi sta-
:i regionàli, ciascuno dei quali presentava vie differenti alio sviluppo
-lel1o Stato moderno.Le diversità erano riscontrabili innanzitutto nella forma del gover-
:ro, in quanto vi erano Repubbliche e Monarchie' Le Repubbliche' anti-
:hi Staii cittadini che avevano conquistato il territorio circostante, era-
no caratter rzzatesostanzialmente da un governo oligarchico e dal pre-
-lominio della città dominante sul resto dello Stato. La partecipazione
all'amministrazione statale mutava a seconda della Repubblica consi-
lerata, tutte avevano dei Consigli i cui membri ne facevano parte per
liritto di nascita o per cooptazione.Per quanto riguarcla le Monarchie erano di tre tipi: indigena/
linastica, pontifìcia, esterna/dinastica. La monarchia indigena/
dinastica pàr eccelle nza era quella che faceva capo ai Savoia, gli altri
stati regionali erano retti da principi che non erano sempre in grado di
aYere una dinastia capace di perpetuarsi nel tempo. Lo Stato Pontificio
può essere considerato come una monarchia e il papa' che assemblava
potere spirituale e temporale, governava su un territorio con gli stessi
poteri e le stesse funzioni di qualunque altro sovrano'
Per monarchia esterna/dinastica si fa riferimento a quegli stati sog-
getti ad un regnante straniero, tipico esempio è il regno di Napoli. Que-
Ito Stuto ,ugr-rirru una slra specifica 'ia alla modernità connotata da com-
promessi cón i feudatari e dal forte accentramento di funzioni urbane
c1etrla capitale' ^-ì;,--1; i+oriani rrr ni burocratici,Tutti g1i Stati regibnali italiani avevano proprl orgar
simili nelle competJnze ma con denominazioni diverse, tribunali, corti
e corrsigli.
-1. li sisterna Potritico sPagnolo
SinquigliStati,cotrleloropiùapprezzabilidir:ramicheo,comenel.uro prlu..o
"pp"r-ru esaminato, con malcati fattori di decadimento.
Mà l'Europaàeil'età moderna è stata caratlertzzata anche da alcuni
importanti si-qtemi politici, che hanno avuto un ruolo decisivo per la
paiticolarltà ct'rn cui si andavano configurando. Si tratta di meccanismi
politici piu cornplessi che saldavano f interesse dello stato leader per
eccellenza con i suoi dornini, prefigurando un lirzello di azione politicaassai più articolato e tendente alla lazionabzzazlane. La rilevanza diquesti sistemi andava ben"oltre i confini del singolo Stato, in quantoavevano ricadute evidentissime su tutta la geografia politica dell'Europa.
Portogallo, Inghilterra, Olanda, in diversi momenti dell'età modetna,avrebbero costruito sistemi politici complessi che avrebbero fatto leva suipossessi coloniali e su indubitabili capacità comnrerciali e di gestione poli-tica. Ma, più di tutti gli Stati, tocca alla Spagna ii primato di un sistemapolitico che, pur annoverando una ciimensione atlantica, in virtù dei pos-sedimenti "arnericani", fu europeo per i Suoi lineamenti geopolitici.
La Spagna, infatti, ha dato origine, nella seconda metà del Cinque-cento, ad una nuova ed originale tipologia di organizzazione del pote-re politico, definita dalla storiografia siste.mn imyterinle spagnoLo.
Osserviamone i caratteri fondamentali, non senza far riferimento aglieventi che favorirono un processo politico e culturale chadall'universalismo sarebbe progressivamente scemato verso formulemeno arnbiziose ma, non per questo, meno efficaci.
Con I'abdicazione di Carlo V nel 1556 e con la divisione dei suoieterogenei domini tra il figlio Filippo II, che ereditava le Corone diCastiglia, d'Aragona; borgognona e rnilanese, ed il fratello Ferdinan-do, che gli'succedeva nel titolo imperiale acquistando i territorigermanici, crollava in moCo definitivo il sogno della Monnrchin tLniaer-
snle cristisna, un ideale medievale che aveva trovato in Carlo Magno ilsuo degno assertore, e la casata d'Asburgo si divideva in due rami: gliAsburgo di Spagna e quellì d'Austria.
La corona aragonese era la più composita, cornprendeva l'Aragona,la Catalogna, con Barcellona, Valencia, Murcia e le Baleari, ed i dominiitaliani, i Regni di Napoli, Siciiia, Sardegna e lo Stato dei Presidi; queltra
castigiiana includeva i territori americani. Filippo I{ diventar.a così so-
vrano di Stati con differenti tradizioni storiche, leggi, costuttti, iingua,che richiedevano un' articola la or ganizzazione arnministra ti va e politi-ca, dove l'unico fattore coagulante era costituito dalla dinastia, iL mo-narca era l'unico elemento di coesione tra i eiomini, risultanti hu
"rr-,naturale processo di successione ereclitaria, in quanto fur"cno i matri-rnoni più che ie conquiste rnilitari actr innalzare la dirrastia degti Asburgo.
Il sovrano era il signore, i sudditi doverrano al re fedeità, sastegno e
76
:.ì1tà e ricevevano in cambio la sua protezione. Non esisteva tra i do-
:-"iru una gerarchia, avevano piena personalità giuridica, eccetto le ter-
:L àmericane perché non cristiane. Ii monarca efa impegnato con cia-
i:un dominio, ciò che poteva essere diverso era il cc'ntenuto della so-
:anità, cire dipendeva dai poteli riconosciuti al sovrano e dai dirittiìrrailtiti ai sudditi, dai diversi privilegi ed immunità'
La storio grafiaha cercato di spiegare nel modo piu opportuno la parti-
-,.are formà di gestione dei territori soggetti a Filippo LI, el rey pruilente.
Elliott ha definito 1'assetto territoriale dominato da551i Spagnoli come
*:ra monarchia composita, un/aggregazione politica tra più province e
::qioni, che si reggeva e fondava su tre principi guicla: f idea di una
:r-.issione globale; f iclentificazione tra il trono e i'altare; la combinazio-
:,e di una pluralità di statuti e di costituzioni locali con l'autorità di un
:.-.;[o sovrano.Per quanto riguarda I'idea di una missione globale, i sovrani spa-
:noli, che si fregiavano del titolo di Re Cattolici per concessione papa-
-e, giustificavano il loro predomirrio sugli Stati non cristiani sostenen-
"o.h" il loro principale compito era di difendere e diffondere la parola
li Dio. La legittimuiion" dell'egemonia spagnola si fondava sulla diffu-
.ione del cristianesimo,.che diventava la vera missione da compiere pef ilso\rtano. Queslidea era frutto detrf identi{icazione tra il trono e l'altare'
Pur governando su territori aventi normative e consuetudini diffe-
renti, g1i Asburgo non annullarong le leggi in vigore, le mantennero
anzi inalterate e vi affiancarono quelle spagnole, conservando così le
neculiarità 1oca1i. In riferimento all'assetto istituziomale, l'apparatb
arnministrativo imposto negli Stati europei sottoposti era sostanzial-
mente uguale per tutti i domini.Maravall è stato il primo storico a dare una definizione compiuta
.1e11a nozione di sistema imperiale evidenziandone i caratteri:
I'interclipendenza politica ed econornica tra le parti delf impero; una
lete di ràiazioni tra tra Spagna ed ogni suo dominio;la ristrutturazione
politica dello spazio interno di ciascuno Stato e di quello interstatale'
Amalizziamo questi aspetti. trnterdipendenza significa che qualun-
que dominio degil Asburgo era collegato nella gestione economica, ire
iarticolar mocto nella tassazione, e politico, sopfattutto trell'azione di-
iensiva nel corso di una gllerra, agii altri territori' Tutti i domini dipen-
devano dalla spagna, dal governo centrale di Madrid; la ristruttu razio-ne politica è inerente le nuove figure istituzionali create dagli spagnoli.Per Maravall un sistema politico acquistava un maggior valore.se riu-sciva a condizionare anche gli Stati che non ne facevano parte, riuscen-do ad allargare il quadro delle alleanze.
Galasso, prima, e Musi, poi, in modo dettagliato, hanno sviluppatoil concetto di sistema imperiale spagnolo, basato sulla centr alizzazioneamministrativa, e descrivendone tutte le caratteristiche.^ scomponiamo ed esaminiamo i termini. Innanzitutto la parola im-
pero.Essanon va intesa nel suo significato giuridico-formale; in quantoFilippo II non aveva ereditato la corona imperiale. L'impero è tale inriferimento all'estensione territoriale, sebbene non fosse presente lacontinuità geografica tra i territori. Con l'espressione sistemnsi fa riferi-mento ad una stretta rete di relazioni che coliegava i domini con il cen-tro della Monarchia,la Castiglia.
Le peculiarità del sistema imperiale, cosÌ come delineate da Musi,sono: l'unità dinastica; il ruolo della Castiglia; il sistema di reiazioni; lapresenza di sottosistemi.
I domini spagnoli erano differenti tra di loro sotto molti aspetti,l'uni-co elemento di coesione era rappresentato dalla dinastia, dal potereregale del sovrano. L'unità dinastica, insieme al fattore religioso, eral'unico riferimento unitario del sistema; i sudditi dei diversi territorisoggetti alla spagna si riconoscevano tutti in uno stesso signore ed inun solo Dio, nella fede cristiana. Il sovrano era l'unico detentore delpotere, ii solo punto cii unione per il suo vasto complesso imperiale.
Per quanto riguarda il ruolo della Castiglia, quando Filippo Itr tornò inspagna dai Paesi Bassi siabilì la sua dimora a Madrid, facendovi anchecostruire la reggia dell'Escoriai ed innalzando la città a capitale dei suoiRegni. Il rapporto tra il sovrano e la Castiglia era di tipo priviÌegiato, laCastiglia aveva un ruolo di gran lunga più significativo rispetto agli alh.iRegni, non dai punto di vista dell'egemonia politica, ma perché era l'uni-co paese in grado di sostenere demograficamente e finanziariamente laMonarchia: era il cuore dell'impero, il centro dell'economia del sistema,laregione*guida, tanto che al suo declino economico corrisponderà f iniziodella decadenza della dinastia e del sistema imperiale
Ogni Stato, poi, era in stretta relazione con gli altri e con la stessa
78
::-,agna, vi era interclipendenza.tra.le parti' vigeva una sorta di mutuo
: --.corso, cioè in .o'o ài attacchi ester'i' d'i guerre' tutti i sudditi erano
::-"iamatiadifenderelaMonarchia'Tuttiidominidelsovranoeratenu-,- ad aiutatlo se egli fosse stato personalmente in pericolo o se una par-
:: rlei suoi territoii fosse stata attaccata dall'esterno'
Per spiegare quest'ultimo aspetto Riley ha delineato Ia teorin dei
.;:tioni..gli stati esterni difendevano quelliinterni ed in cambio riceve-
.. ano un altro tipo di sostegno' econonrico e militare' Il regno di Napoli
. quello di Sicilia difendeiano se stessi e la Spagna dalle invasioni dei
- urchi, ii ducato di Milano proteggeva Napolidagli attacchi francesi
=J "ru un centrQ di smistarnànto per i Paesi Bassi'
Infine, il concett o d't' sottisistemn che si lega al principio
.le1l'interclipendenza: tutti i domini della Spagna inseriti nel vasto com-
:resso del sistema erano dei sottosistemi' peiche avevano una serie di
:ompiti,chetradilorosicompletu"u''t''LoeranogliStatiregionali-:a1iani, i Paesi g"tti, il Portogailo dopo il 1580' i.d3mili oltreoceano'
Permegliocomprendereilconcettodisottosistemapossiamoesa-núnare due stati regionali italiani, soggetti aillspagnli appartenenti al
sottosistema italian'o: il '"g'-'o di'NapJi ed il ducato di Milano'
Questi due Stati erano éntrati per vie ed in tempi diversi a far parte
.1ei domini a"i s"t'iu^i 'pug'-'ofi'
Napoli apparteneva-a Ferdinando il
Cattolico come eredità dei sovrani àrugor"r"r1 ed egli aveva sancito
lefinitivamente ilsuo potere sulRegno dàpo hbattaglia del Qarigliano'
re1 1503. s"*p'";";;" ereditarú era giunto- nelle mani del nipote '
Carlo V ed in quelie dei suoi'disceridenti diretti'
Milano,lr'to'"tu,oustataconquistatarnilitarmentenel1535'dopolecontinue guerre contro la Francia'
.
I due domini svolgevano tunzroni diverse' ma complementari al-
l,internod.elsistenra.Napoliebbeunruolocliprimopianonellapoliti-.a internazionale as'burgica' u'u tr'uou*post9 Lel Meditelraneo per la
iotta contro i Turchi, difendendo se stesJa d'ifencleva arLche gli altri Re-
*ni.Dcrpola".u,.,o,aellaCastigliadiventeràancheilcentroprincipaledelprelievofiscaled'ellaMonaihiu'soggettaafortitassazionipersop-perireaibisognifinanziarid.urantelediversecampagnemilitari,so-prattutto t"ifo "'oìgl;ento
del1a Guerra dei Trent'anni'
L,aconquistadiMilanoavevaportatoalcontrollomilitared.egliSta-79
ti che si affacciavano sulla Pianura Padana: controliare la parte setten-trionale dell'Italia era essenziale per proteggere Napoli e la Repubblicadi Genova da influenze esterne. trl Ducato fungeva da collegamentocon i Faesi Bassi e da retrovia durante Je azioni di guerra contro i Fran-cesi, i'unico collegamento tra i domini mediterranei e quelli dell'Euro-pa centro-settentrionale.
Gli spagnoli mantennero inalterate le normative vigenti in questiterritori affiancandovi però quelle spagnole, collocarono, poi, accantoai funzionari locali nella gestione del governo amministratori apparte-nenti alla nobiltà castigliana. Al vertice del regno di Napoli c'era il vicerè,nel ducato di Milano il governatore, ambedue castigliani. Essi rappre-sentavano ii sovrano, sempre assente, tranne brevi perio,Ji di visita,perché con fissa dimora a Madrid.
Il vicerè era affiancato nelle sue mansioni dal Consiglio Collateralenapoletano, organo con competenze legislative, amministrative egiudiziarie in cui si. rispecchiavano gli equilibri politico-sociali del Re-gno; il governatore dal senato mitranese, in cui aveva unruolo egemonicoil patriziato cittadino di origine rnercantile. Il vicerè ed il governatoresvolgevano una duplice funzione: erano nominati rappresentanti delsovrano ed esecutori dei suoi ordini, n:ia erano anche tenuti a clifenderele popolazioni soggette alla loro giurisdizione.
Nel regno di Napoli i feudatari, con l'avvento della dominazioneasburgica, avevano perso il loro potere politico in riferimento alla ge-stione dello staio, allo stesso tempo era cresciuta, in modo smisurato,la loro giurisdizione sui territori, sui feudi, a loro sottoposti. si era svi-luppata una "via napoletana allo Stato moderno", caratterizzata dacompromessi e mediazioni tra Napoli e Madrid che condizionaronofortemente la vita sociale, burocral.ica, amministrativa e politica delILegno.
Napoli, poi, era l'unico soggetto-città a godere di un forte potere dicontrattazione con la Corona; coffìe ha evidenziato Galasso essa inglo-bava tutte le funzioni urbane nel contesto di un Regno formato esclusi-vamente da città medie e piccole. In tal modo essa riuscì a ottenere ilriconoscimento di privilegi ed immunità e ad opporsi a qualsiasi tenta-tivo di introdurre nel Regno strumenti di controllo e di coercizione,quali il Tribunale dell'Inquisizione.
BO
IlgovernocliMitanoeradiversodaquellod.iNapclii'Ilcetopoliticoiombardogod'evaa.ttu.upu.itàcliassumereiniziativapoliticaautono-:na,lacosiddetta"*to'.'o"tiadelleélite"rivisitataneliasuaaccezione:orr il termine integrazione, la tendenza cioè da parte degli Spagnoli di
:oncedere *r-ru a"r"gu foriii.o ai milanesi. Il pesó della popolazione del
:ontadoeranotevole,tantod'afarsentireiasua{atzasullacittàesulìo\zernocentrale,iaMonarchiacercòdiridimensionarequestopotere:ntroducen do tl mensunle, un,imposta diretta emanata per colpire la ric-
:hezzamobiiiare ed immobiliare' . , , :-L^'. :'
Un altro el"*"r't Ji raccordo e di gestione deJ.sistema da tenere rn
;orrsiderazione è ;;;;-;tato dalla p fesenza di un3 molteplicità di
;onsigli.PerElliotti'o'gun"'"azioneamministrativafondatasuiCon-sigli corrispor-td""u utt'""'lg"'-"a d'i gestire un impero rzasto e cornposito'
lotrevano servlr:e;;t;""o*t'u'" f op"'ato del sovlano' Lo storico in-
qlese tri ha descrittisuddividendoli in due tipologie: i consigli diparti-
rrrerrtaliequelliterritoriali'Iprimieranoconrpetentipermaterie:laSuprema Inquisizione, ii Consiglio di Stato' il Consiglio di Cuerra e
quellodelleFinanze;q'uest,ultimoerailpiùimportanteperchésioccu-l.ava della g"rtiot"'fi* nziana delf impero' mentre- c1uelli territoriali
\-enneroistituitip"ttg"tclominio(ilConsigliod'Italia'delleIndie'.1'Aragona, di P";;gJilo' dellq Fiandre)' ciascuno gestiva 1'amrnini-
straziJne deilo Stato corrispondente"
11 sottosistema itatriano era sottoposto alle cornpetenze de1 Consigiic
.1'Italia, istituito nei 1555' Tutti i Consigli u1'u-"u'lo.t:9" " Madrid ed
erano composti, per la maggior parte' da nobiti castigliani'
Nel sistem" p:il;;;Íirr"rJ a".irirr" "ro la centra!ità della Casti-
g1ia, alfa " o*"g";-J"i pft""'" uubt"gito' ma. anche p-otenziale anello
debole di un m"écanismo politico ch! necessitava comunque di conti-
nue risorse " di i"'""'ti*"'-"i' "Xutt'insieme -
ha scritto jairne Vicens
\-ives - il compito uJaoruutosi daila castiglia è assillante' Per attuare la
sua missione neÌ mondou essa si rru po,ur"ró dei virgulti più fiorentì che
le sbocciano ir-r r*", iiJeale rro.gh"r", ne[a guerrà delle cornunità;le
ramificazioni erasmiane e rinascentiste, neil'Jstinata battagiia in difesa
dell,ortodossia.Ildurosacrificiotrovailsuocompensoneiprofondiacquistispirituaiifattinell,ambito6"112fhiesa,laqualeriesceadat-tuarelasintesitralosplendoredelladinastiaeilcollettivismo
81
democraticizzante del popolo. Teologi e missionari, mistici ed asceticostellano il periodo aureo della vita ecclesiastica spagnola. L"assolutodrsprezzo per i beni terreni, l'ideale di missione ecumenica della Spa-
gna seppelliscono definitivamente qualunque programma di risorgi-mento economico della Castiglia".
Il crollo della Spagna e del suo sistema politico parte inesorabilmen-te dal cedimento del suo epicentro, la Castiglia, <<11on c'è nel paese - è
ancora Vives a scrivere - un solo investimento di capitali in bonificheagrarie, in società commerciali per lo sfruttamento del mondo oceanica(..) . Questa incomprensione del mondo capitalista lasciò la Castigliadisarmata di fronte all'Europa".
Segnali vivissimi di una crisi che con il Seicento sarebbe diventataancora più evidente e tangibile, minando dalle fondamenta tutto l'ap-parato politico ed organizzativo del sistema ispanico.
82
Bmr-rocneplA GENERALE
P. ANppnsoN , Lo Stnto assoluto, Milano, Mondadori' 1980'
-\. BAsso (a cura di),Dizionario di culturnpolitica, alla voce ,'Stato,,, Milano,
Antas, 1946.
[. BootN, Six liztres de Ia Repubtique,\576, (Paris, Fayard' 1986)'
'[.H.Errtorr,Laspagnneilsuomondo'L50A-1'700'Torino'Einaudi'1996'
Ì-H.Err-torl,AEuropeafCompositeMonarchies,in,,PastandPresent,,,n.l3T,1992, pp.48-71.
E. F.qs,\No Guaruru (a cura di), Poterc c società negli stati regionali italinni del'504
e' 600,Bologna, I1 Mulino, 1997'
G. Gllesso, Storia d' Europa, Roma-B ari, Later za' 1996'
O. Hwrzn, Stato e società, Bologna, Zanichelli' 1980'
H. K.a,rarN, L'Europa dnl L500 sI 1700, Roma-Bari' Laletza'1987 '
H.A.Lroyo,LannscitadellostntomodernonellnFrnncíndelCínquecento,BoTogna,ll Mulino,1986.
N. M,qccHra vllrt;, Il P r in cip e, Milano, Rizzoli' 197 5'
Ì.A.Manavxrt,stntomodernoementttlitàsocinle'Bologna'IlMulino'1991'A. Must, L'Itnlia dei Viceré, Cava de' Tirreni' Avagliano' 2000'
G. Pocct, Lo Stato' Naturn, suiluppo, prospettíae' Boiogna' 11 Mulino' 1992'
\V. Rrtruenn o, Storin del pctere pclitico in Europa' Bologna' I1 Mulino' 2001'
Sr,tvEon.r F,t1eRoo, Diego de,Iden de un principe cristinno' Valencia' S' Faulì' 1786'
H. Surrrrnc, Ascesn eírisi. L,n Germntún dnl L517 sI7648, Bologna, 11 Mulino,
1997.
J. H. Sr-iExr,raN, Le origitti rxello stata modento itt Ettropa (L45A-1725), Bologna' Il
Mulino,1976.A. TeNnNrr, stato: tLyr'iden, rntalogica. Dal conrune itnlinno nll'assalutislno fruncese'
Boiogna, Il \4ulino, l-987'
Ch. Trr-rv (a cura di), L:n fornmzione degli stnti nttzionsli nell'Europa occitlentale'
Boiogna, Il Mulino, 1984'
P. Vtor't, L'Ettropa motletnn' storin di un'identitù' Torino' Einaudi' 2004
i. V. Vrvns, Profilo delltt storin di Spngnn' Torino' Einaudi' 1966'