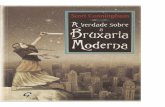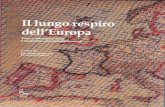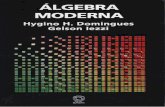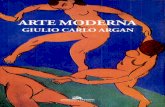Storia dell'Europa moderna
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Storia dell'Europa moderna
I LEZIONEPROGRAMMA: STORIA DELLE UNIVERSITA’Insieme alla Chiesa, è la più plurisecolare istituzione in Europa, cheinventa l’Università nel Medioevo.MURATORI (AIMA)Dissertazioni su: no rapporto diretto fra chiese religiose e istruzione(universitaria, e (novità) si mette in discussione l’usanza (da luiritenuta mito) di considerare l’Università come risalente a Carlo Magno.E’ un elemento di modernità: non più come invece, ad esempio, lemitologia dinastiche fondative come la gens Iulia. Finisce l’ “imperialismodella Storia”: si pensava, allora, che la Storia in quanto tale è favola(mito), mentre (Rivoluzione scientifica) è più importante la scienza;allora, come riscatto per la Storia c’è l’erudizione (che aumenta lascientificità); l’agiografia, per esempio, non è più solo ‘leggenda’ ma‘vera’ biografia. Eppure, nella Storia delle Università, fin (quasi) aigiorni nostri: le Università sono cariche di significati mitologici(accento sul Medioevo) e politici; del resto, è solo dopo il 1700 che ilMedioevo è rivalutato: non più “decadenza”, ma “declino”, nel trattarequest’epoca e l’Antico regime in generale. In quest’ultimo periodo, insostanza, si ha: Università ‘pensata’ per quel contesto: aristocrazia(meglio, patriziato urbano) egemone grazie ai rapporti con la società(Chiesa, popolo). Al vertice della società è (1600-1700) il “sovranoilluminato”: la componente religiosa, come nel Medioevo, è ancorapresente, ma (qui sta il moderno) in veste secolarizzata. [VD. CARTINAMOSTRATA IN CLASSE] Molte Università, si badi, sono nate in seguito amigrazioni. [LIBRO: The rise of Universities, Huskins (americano), 1923, poidivenuto Le origini delle Università nel ’74 a cura del medievista Arnaldi cheraccoglie saggi]. Il libro appena citato parla della storiografia finoagli anni Venti: trovare le origini europee che poi sono ‘migrate’ nelNuovo mondo.ALCUNI FATTI SIGNIFICATIVINel 1888 c’è l’anniversario (tondo) dell’Università di Bologna, le cuiorigini (1088) sono ‘suggerite’ da Carducci (motivi politici eideologici). Nel 1907 (frutto tardivo di quanto sopra) nasce l’Istitutodi Storia dell’Università di Bologna, il cui pregio è l’apertura nonlimitata al Medioevo. Il 1922 è l’anniversario (vero) dell’Università diPadova, nata da migrazioni Bologna-Padova (provate, e così la data 1222).Nel 1939 Botta promuove un’iniziativa, il Comitato per lo studio dellaStoria della Università, con sfondo ancora politico e ideologico (ilDuce) eppure non come ‘unico’ aspetto. Egli nel ’42 (anniversario dellamarcia su Roma) vuole (invano, per la guerra) che si tengano eventi
speciali a Roma sulle Università. Anche se il conflitto mondiale fuproblema, il seme era tratto, come mostrano date importanti quali il1956, inclusa la Storia dell’Università di Pavia che permette scritturadi più monografie e dove punto di riferimento rimane Vaccàri, anche se dalui in poi (metodi, letture, tipo di documenti) grandi sono i passi.Dagli anni Sessanta, infatti, tante sono le pubblicazioni sul tutto:specie (anni Sessanta) sull’Università di Padova, il cui centro nel ’94fece un importante convegno. Ciò che si ha in Italia è parte di un piùgrande processo (sull’Europa): si pensi all’Università di Stoccolma. Varibadito: gli stessi storici, come tutti, fanno Storia anzitutto perchémossi dal presente (in quel caso, in anni ’60-’70: crisi Università;rivolte studentesche; Università non più elitaria). Da questi centri c’èun po’ la stessa solfa di Centri per la Resistenza e simili: una speciedi parallelo fra Storia universitaria (Atenei singoli) e Storia delleistituzioni universitarie; anche fra: Storia italiana (generale) e Storiadegli Stati italiani (singoli). Insomma sono necessariecontestualizzazioni e comparazioni. Esempio [SLIDE]: insegna delleorigini dell’Università di Bologna. Vedi anche: la rivista monografica“History Universities”; “Annali di Storia delle Università italiane”, volume 1anno 1, 1997; “Storia delle Università in Italia”, Ferraresi (raccolta disaggi, di cui uno di lei). E’ importante il contesto delle Università:urbano, economico, politico, religioso, sociale, ideologico… E anche laStoria di determinate epoche: i viaggi, specie Erasmo da Rotterdam che‘inizia’ il progetto “Erasmus”. Vedi anche: “Almum studium papiense”.LA STORIA CULTURALEIn senso stretto, si diversifica dalla “Storia della cultura” ed è unamoda attuale. Nasce nel secondo Novecento sulla scia degli Annales.Importante fonte (Settembre 2011): “Imago Universitatis”, vol. 1, sotto ladirezione di Brizzi e con la collaborazione di AAVV. Non è solo dastorici: è interdisciplinare; Ginzburg è caso celebre [SLIDE]; altro casosimile [SLIDE] è Geerz Clifford; cultura qui non è ciò che si sa, ma ciòche si trasmette (simboli ecc.) e che costituiscono il mio essere (in ciòdiverso dalla Storia sociale, che si riferisce a cose più esteriori inrapporto con gli altri). A ciò si lega quando oggi si dice “l’uomo dioggi è in crisi perché non riesce a narrare sé”. Di qui, elementi come illinguaggio del corpo. Fonti (a parte l’archivio dell’istituzione; cfr. “Capire il Medioevo” di Tramontana, per classifica)- Seriali: in teoria, ci dovrebbero essere, e invece no (perdite esimili)- libri amicorum: di ricordi [SLIDE]- Archivi, che però non sempre sono ‘in casa’
- L’edificio: importante specie da fine ‘700 (antiquariato) quando‘coniato’ il “cimelio”- BibliotecheCasi celebri“Codex diplomaticus” della Società pavese di Storia patria: (sull’Universitàpavese) documenti dalla nascita dell’Università di Pavia (1361). Progettoripreso da un filologo (Sottili) morto circa 10 anni fa, che studiaval’Umanesimo lombardo in rapporto al mondo tedesco riscoprendo studentiche dalla Germania venivano a studiare a Pavia.Una fonte importante[DAGLI MGH]: la vita del Barbarossa, nonché “Privilegium scholasticum” contrad., e “Parens Sciantiarum” di Papa Gregorio IX (1231). Importanti anche:[SLIDES, CARTINA] le ‘ultime’ Università in Europa nascono in centro(Paesi Bassi) prima dell’avvento degli Orange e in parallelo allaRiforma. Morale: più politica (e religione) voglion dire più istruzione.Nota poi che le Università sono sì ‘internazionali’ma sono comunquelegati alla rinascita medievale e anche a una nazione. Il Clero minore èvitale cerniera sociale, termine che viene da clerus, “eletto” (percultura e dote).COSA E’ LA UNIVERSITAS?Dal Latino: “insieme di persone, cose, entità. Dal 1200 è “corporazione”,collegata a “libertas” (che allora era “privilegium”). Questo concettoduecentesco è un gruppo di persone riunite intorno a un lavoro comune econ organi rappresentativi (e privilegi); ecco come un concetto sitrasforma. D’altra parte studium generale nasce (1200-1300) in riferimentoai “poteri universali”; è una scuola di insegnamento superiore checonferisce titoli validi ovunque (licantia ubique docendi) e il cui valoregenerale è confermato dall’approvazione di autorità universali(successivamente anche il re). Nota che “generale” non è “aperto atutti”, ma “autorizzato alla potestas generalis (poteri universali)”. Anche“facoltà” è diverso: viene dal latino, “capacità, libertà”, ma dal 1100 èpiù specifico (Arte,Scienza, disciplina) significando (nel sistemauniversitario) ciò che (tecnico) conserva tuttora, cioè insieme(istituzionalizzato) di docenti di una certa disciplina (o meglio di unsuo gruppo). Fonte vitale: [SLIDE] Filippo di Gréve (1216-1236),cancelliere di Nòtre Dame [CIT.IN VERGER, “LE UNIVERSITA’ NEL MEDIOEVO”,1982, P. 64]; dice: dopo la battaglia di Pavia (1525), problemi perdiminuzione del corpus universitario (docenti, studenti), eppure ancoraalta la possibilità di seguire tutte le materie fondamentali. Gli esamidi fine anno sono un’invenzione del 1700 (come di fine corso), speciesotto Napoleone e dopo il Congresso di Vienna (poi aboliti, tranne quellidi Laurea, per ‘imitare’ il Medioevo).
BIBLIOGRAFIA[- Slides]- “The rise of Universities”, Huskins, 1923- “History Universities” (rivista monografica)- “Annales di Storia delle Università italiane”, vol. 1, anno 1, 1997- “Storia delle Università”, Ferraresi (raccolta di saggli)- “Almum studium papiense”, a c. di Dario Mantovani- “Imago Universitatis”, vol. 1, sotto la direzione di Brezzi ecollaborazione di AAVV- Capire il Medioevo, Tramontana (manuale; classificazione fonti)- MGH
II LEZIONECARLO IV 1361: UNIVERSITÀ DI PAVIATipologie istituzionali di Università
- Spontanee: Parigi, Londra, Oxford, Montpellier - Nate per secessione/migrazione: Cambrifge, Padova, Siena - Per fondazione: Napoli 1224; Tolosa 1229; Salamanca 1218; Perugia;
Roma; Pisa; Firenze; Pavia 1361; Ferrara
NON È UNA REALTÀ COSÌ ‘PLATONICA’. Importante Le Università del Medioevo 1973,del francese Vergés; qui i modelli sono: bolognese (associazione distudenti, collegati da un giuramento cioè da una parola fondativa), coicapi riconosciuti dalle autorità a garantir ai propri membri privilegi ea reclutare docenti); parigino (Nord Europa), in cui vi è un’associazionedi maestri e federazione di scuole dove ogni prof. Resta responsabile deipropri alunni e dove l’associazionismo di maestri garantisce protezionereciproca e privilegi.(Slide) Filippo di Gréve (1218-1236), “ Il parere del cancelliere di Notre-Dame ”, cit. in Vergér, “Le Università” del Medioevo, 1982, p. 64 [ vd. Lezz. precedenti ] . È un rimpianto per il passato: non ci sono più gli scolarieducati e zelanti di una volta…Parigi era davvero internazionale, quindi c’erano questioni di gestione.Di qui, Universitas doctorum dove c’è facoltà di Teologia. Non è chiara lagenesi, ma sembra che dopo l’epoca in questione i documenti confermavanoquanto già fatto (nulla di nuovo….).Tale Università che vien formandosi ha appoggio papale: specie,opposizione sia ai vescovi di Parigi, sia la cancelliere della Cattedraledi Notre-Dame. Quest’ultimo ricevette licentia docendi in occasionedell’allora III Concilio lateranense (vd. Cronologia data in classe), quindi dipoter giudicare studenti e in ciò scontrandosi col Papa e col vescovo
locale, che a loro volta si arrogano il diritto di giudicare “delitti”,concetto diverso da oggi perché allora indicava in generale “mancanza”. Acomplicare il tutto sono da un lato le eresie, dall’altro le radici dellalaicità: il nascente monarca francese ha capitale Parigi, quindi si alleacol Papa per maggior prestigio. Maestri e prof., appoggiandosi al Papa,dal loro canto (ricatti: scioperi, migrazioni…) hanno strumenti contro leingerenze dei poteri locali (quali i vescovi).(Fotocopia, stessa della lezione prima) “Bolla” fondativa, 1237Conflitto, almeno fino a Napoleone, dopo cui esso è ‘solo’ tra studenti einsegnanti come lo è di recente col Sessantotto. La situazione è legataal Carnevale: nel Medioevo, questa Festa equivale a grandi trasgressioni.Allora problemi: chi giudica i delitti? Papa Gregorio IX, riprendendoInnocenzo III, che diede all’Università (contro vescovo e cancelliere)più possibilità di auto-organizzarsi in virtù di questa bolla:
- Come accennato, importante la propaganda: intanto, c’è la Crociatacontro gli Albigesi…
- Si tira in ballo il diavolo come guastafeste- Accento su preminenza di faccende teologiche- Divieto di girar armati- Divieto agli studenti di parlar Volgare in Università: il Latino è
in voga sino a metà secolo XVIII in occasioni ufficiali quali lelezioni
- Una delle poche Università dove si insegnava Ebraico (non corrotto)è Parigi
BOLOGNA: ATTORI IN GIOCO- Studenti e docenti: spesso in contrasto- Imperatore, che assume funzione di sostenitore e protettore (Barbarossa) o
(Federico II) di oppositore/detrattore degli studenti- La Chiesa: vuole avere voce nella formazione degli studenti- Organi comunali: in bilico, perché contrastati fra ingerenza e incentivazione
L’ultimo degli elementi citati è nuovo del Basso Medioevo, peculiaredell’Italia Centro-Nord.L’Università di Parigi, sul finire del Medioevo, diviene regia, quindi sidice “Università di Parigi come figlia maggiore del re di Francia. A Bologna, più ancorache in Europa, si ha interesse per il diritto romano: le radici (delrecupero) sono in Giustiniano. Una copia del suo Corpus arriva a Ravenna,da lì a Bologna. Di qui, varie scuole si formano. Graziano, monacocamaldolese, nel Bolognese pubblica il Decretum, che (diritto canonico)
insieme al Corpus forma il “Diritto comune europeo”; non a caso, l’uno el’altro sono studiati in primis a Bologna.Nel 1158 ( Roncaglia ) il Barbarossa trova legittimazione della propria autorità mediante richiamo allo ius . In quest’occasione ( leggenda ) alcuni studenti vanno a trovare il Barbarossa che chiede loro come va a Bologna;costoro rispondono: tutto bene, ma il problema è che noi paghiamo debitinon saldati. Lui decide di difenderli, ed emana “Privilegium scholasticum” che, dalla prima parola (vd. MGH), fa autenticare entrando a far parte dell’ultima sezione (“Novelle”)del “Corpus” giustinianeo.Idea di fondo: potere non assoluto (ci si consulta), in virtù dell’ideadi consultum ; di qui la futura peregrinatio , dovuta agli studi. Importante anche il concetto di sicurezza e tutela . Privilegio : lo studente può decidere da chi farsi giudicare, privilegio abolito nel 1700 da Giuseppe II d’Asburgo . Nel 1182 (Pace di Costanza) anzitutto si discute quanto deciso dal Barbarossa, contro la suapretesa di sottoporre al Tribunale imperiale…Di qui, come reazione, anche Corporazioni di studenti per l’“emancipazione” dai maestri: sono le nationes, che derivano dalla terrad’origine (citromontani e ultramontani, rispettivamente al di qua e al dilà delle Alpi).Gli studenti ci tengono a non essere subordinati ai maestri, come visto,e allora fanno Corporazioni. Essi, in particolare, vanno a immatricolarsinella propria nazione. Gli studenti sono membri di Corporazioni delComune, mentre ciò non vale per studenti stranieri che allora siorganizzano nel modo sopra detto. Di fatto solo allora (1252, circa) siebbe una “super-Università” in tal senso. Nel 1252 si ha uno Statuto:ogni Università è governata da un rettore, la cui elezione varia in basealla natio (ciò non vuol dire che il rettore cambi a seconda dell’area);egli è in carica un anno, e ha segni che ne stabiliscono grandipriorità . Il prof. È pagato dagli studenti mediante collecta, sullo sfondodella (seconda) lotta fra Comuni e Impero (1248). Il Comune ottiene dalprof.: fine di prerogative precedentemente godute, e il Comune in cambiotrasforma la collecta in “condotta” (stipendio) oltre a scegliere ilprof. . Fino alle soglie del 1300, grandi trasformazioni: scuolecomunali, ove i Comuni decidono stipendi dei prof. . In Papa inizia asalire sul palco scenico: Bologna si ribella a lui e poi si piega, e luial tempo stesso vuole stabilire potere sulla città. La Bolla di PapaOnorio III (1219) decreta che al vescovo di Bologna si attribuisca facoltà di assegnare lauree. IL TUTTO SI COMPLICA NEL 1300-1400: CATTIVITÀAVIGNONESE; SCISMA D’OCCIDENTE…BOLOGNA E PARIGI SONO MODELLI? Il paradigma del modello (empirico) ècriticato. Tuttavia sono distinguibili: intellettuali (insegnamenti);
sociali (età, ceto); politici (rapporti, coi locali e non), che nel caso di Bologna concernono rapporti studenti/Comune.
UNIVERSITÀ NEL MEDIOEVO: ASPETTI UNITARI- Livello istituzionale: componenti dei governi sono ‘gli stessi’, ma
può esserci diversità di organizzazione interna.- Volontà associativa, spirito comunitario, autocoscienza. - Obiettivo comune: insegnamento, conferimento di gradi. - Bologna e Parigi hanno in più l’ auctoritas.
TORNANDO A INIZIO LEZIONE: TIPOLOGIE ISTITUZIONALILe Università nate in Età moderna saranno per lo più “per fondazione”:cambia concezione del potere, rispetto al Medioevo. L’Italia èparticolare: Federico II (1224) fonda l’Università di Napoli, come sortadi contraltare rispetto a Bologna. Così lui si fa giuristi e notai. Sianticipa il Moderno: “protezionismo scolastico” (“statalizzazione”dell’Università). Perché si cita tanto il Papa? Perché il 1300 è unsecolo in cui lui ci mette tanto il becco, finchè col Concilio di Basilea(1436) si stabilisce: per avere il cardinalato, ci vuole la laurea inDiritto o in Teologia.Le istituzioni di fine 1300, e radiciPapa; Impero; Studium parigino (rispettivamente: Italia, Germania,Francia). Bonifacio VIII è attivo in epoca di crisi dei Poteriuniversali. Il Papa tenta allora provvedimenti nei confrontidell’Università. Si ha quindi attenzione per la fondazione di nuoveUniversità: più facilmente gestibili, per distanze in primis, e tra leUniversità ‘riformate’ in tal senso c’è appunto quella di Pavia nata nel1361. Il Papa a fine Trecento permette a Francescani e Domenicani dipredicare in Studia, non solo in chiese e monasteri, fino ad allora diconnotazione relativamente laica. Di qui, i frati occupano cattedre‘miste’, non più prevalentemente teologiche. Lo studio romano vieneesteso; d qui, aumento di forza. Ricorda, con radici centennali, iChierici (di Ordini minori che non assumono subito consacrazione daisacerdoti), nel periodo in cui tornano allo stato laicale, possonomettere a punto un beneficio ecclesiastico (non controllo pastorale) purnon essendo in quella diocesi.Parallelamente al rinnovamento di Roma, Bonifacio fonda uno Studium adAvignone: una sorta di avanguardia anti-pretese règie (parigine). Bolognaviene scomunicata da Bonifacio, per essersi a lui ribellata. Papa
Clemente V, supplicato, con una Bolla trasforma il Bolognese in Studiageneralia. Ulteriore esodo da Bologna fu il 1321, quando uno studenteforestiero ha forse stuprato una ragazza incorrendo nella condanna amorte, la cui sentenza è emanata dal podestà (non dal più ‘popolare’capitano del popolo) e quindi ci sono appunto esodi…Appena dopo il 1321, il Papa Giovanni XXII esorta a richiamare gente aBologna: essa è troppo importante. Allora si moltiplicano le Università:i sistemi politici sono più articolati, quindi è impensabile latrascuratezza universitaria. Inoltre la Cattività avignonese complica:eppure il Papa si occupa ancora di Università italiane, come in generalene nascono in Europa.Nascono nuove dottrine: Occamismo; “Studi generali”, con radici relative.Ricorda che Lutero, prima di darsi alla religione all’età di 24 anni, fuprof. Universitario; lui è ricordato specie per lo scandalo delleIndulgenze, oltre che per varie contingenze ‘esplosive’ come miscela: laStampa (1452), l’Umanesimo…
III LEZIONEPRIMA ETÀ MODERNA E SOGLIEÈ un termine tuttora diffuso per distinguerlo da “Storia contemporanea”,e che risale alla storiografia anglotedesca (“Early modern age”). Nel 1436(Concilio di Basilea”) si impone un titolo in Teologia, per l’accessoall’Episcopato o al Cardinalato. Tutte le Facoltà hanno tendenzialmenteuna Facoltà di Teologia. Del resto, si pensi alla coeva Cattivitàavignonese, pvvero quando Parigi è capitale di Teologia. Nel 1300 il Papatenta di opporsi a questa centralità parigina ritenuta troppo eclettica(Tomismo, Occamismo, Ordini mendicanti…). Di qui, “federazioni di studi”.La laurea era data da un collegio di Teologi. Urbano V (1360-1372) dàvita alla diffusione: Cracovia nel 1363 (cfr. Praga nel 1348), Vienna nel1360… Insomma c’è diffusione delle Università verso Est. Sono Universitàdi fondazione papale, ma la richiesta parte da autorità laiche locali (ilre di Polonia a Cracovia, per es.). Quest’ultimo infatti ha emancipazione
dai Poteri universali (“Rex est imperator in regno suo”…), eppure questoappoggio serviva come primo imprinting : si pensi all’Università di Pavia…Lo Scisma d’Occidente (1378-1414) crea problemi, che si riversano anchenell’unità ecclesiastica. Papa Clemente VII, in concorrenza con Roma,riporta la sede papale ad Avignone nel 1378. Le Università seguono unastrada simile: Scisma, le une con l’uno e le altre con l’altro. Alloral’Università è un tertium accanto ai Poteri universali, dove-a secondadello schieramento-il Papato è a Roma o ad Avignone. Nel secondo Trecentosi diffondono idee conciliariste: collegamento col pensiero filosoficouniversitario (Occamismo); l’idea è che il potere papale non derivi daDio direttamente, ma da una delega del Concilio, che allora in quantoresponsabile del Gregge ha facoltà di deporre Papa indegni. Non a caso iPadri conciliari deliberano per nationes, sulla falsa riga dellaCorporazione universitaria. Di fatto questa idea conciliarista ‘muore’nel 1415. Lutero (utopia…) viene liquidato dalla Chiesa mediterranea(1545-1463: Concilio di Trento…), su questo tema.Non è un caso che molti Conciliaristi (come Cusano, irenico perfino neiconfronti delle eresie…) siano divenuti Cardinali, abbandonando semprepiù il Conciliarismo e, di fatto, anticipando così il Conciliotridentino. Lo Scisma di fine Trecento decreta il tramonto dellaposizione di Parigi come ‘unica’ capitale della Teologia: vi sonospostamenti, specie da parte di chi parteggia per Roma e quindi va astudiare da Parigi a Roma. Colonia (1388) è un altro esempio di ciò:migrazioni sull’onda di quanto detto, e prima ancora cronologicamenteall’insegna delle esperienze universitarie pregresse: nel secolo XIII adesempio nasceva l’Università di Padova, ‘figlia’ di quella bolognese.TIPI DI UNIVERSITÀ-Spontanee: Parigi, Bologna, Oxford…-Nate da secessione/migrazione: Cambridge, Padova…-Nate per fondazione: Napoli (1224), Tolosa (1229), Salamanca (1218),Perugia, Roma (1303), Pisa, Firenze, Pavia (1361), Ferrara…Nel 1200 il monopolio ecclesiastico dell’Istruzione rimane tale (sia pure non come nell’AltoMedieovo…). In particolare l’Università di Napoli è voluta come contraltare imperiale dellaguelfa bolognese. Nel 1300 si hanno apogeo e crollo dei Poteri universali, e si sviluppa unaBurocrazia statale (regni, signorie…). A fine secolo l’espansione viscontearaggiunge il culmine: abbraccia quasi tutto il Nord Italia, sino a unaparte di Toscana e Umbria per arrivare alla porte di Perugia; allora c’èbisogno di una più efficiente burocrazia. Il sovrano non è solo “re guerriero”, nésolo taumaturgo: diviene anche “re saggio”. Coerentemente a ciò, aumenta la laicitàanche ai Vertici, non solo nella società in generale, accrescendosi fra
Umanesimo e Rinascimento. Del resto, una volta ottenuto il titoloimperiale, si torna ‘come niente’…alla vita usuale.
FASI-1300: riempimento dei ‘buchi’ attraverso fondazioni di Università:Portogallo (Coimbra, Lisbona, ecc., dipendenti dal re); Catalogna; (sottoi re d’Aragona); Praga (vi si incrociano interessi del re e interessi delPapa: legame risalente al “Privilegio papale”, ma voluta da un’autoritàsecolare (il re di Boemia).-1378-1415: Scisma. Di qui, come ricordato, grandi spostamenti. È il casodi realtà come Colonia, ad esempio.-Umanesimo: aumentano laicizzazione e legami con la Corona. Alloraaumentano le Università: si pensi al Parigino, come a Champàgna e ingenerale nel Nord del Paese, la cui capitale universitaria è Parigi.Altri casi sono: Edimburgo, seguita da altre quali Űppsala e Copenaghen(1400-1415 cca)…-Riforma: nascono nuove Università, come si vede specie dal caso deiPaesi Bassi, i quali danno vita alle “Province Unite” e alle Universitàcalviniste…CARLO IV, IMPERATORE DI LUSSEMBURGO-BOEMIA (1316-1378) [ vd. slide ] Egli si forma specie a Parigi, legato a Papa Clemente VI che nel 1354 aRoma lo incorona imperatore. Interessi di ambo i Poteri convergono: essifondano Università, e l’uno conferma quella dell’altro, quindi si pensiall’analogo caso dell’Università di Praga. Quest’ultima è un esempioimportante: come tentativo di spostamento del baricentro culturaleeuropeo dal Mare nostrum all’Europa centrale, ad esempio dal Lionese aPraga. Carlo fonda Università specie lungo quest’asse: Ginevra (metà delsecolo) ecc. . Egli sa che, per l’elezione imperiale, deve recarsi inItalia a farsi incoronare dal Papa (1354). Lui allora scende nellapenisola, dove si assiste a nuove fondazioni: Arezzo, che nasce dasecessione da Bologna, è confermata; Perugia; successivamente fu la voltadi Cividale, allora mai realizzata, e di Pavia nel 1361. Qui l’esigenza èanche di tipo locale: sono specie i Visconti, più che i Poteriuniversali, a ‘volere’ l’Università ticinese. Inoltre si intravede chePavia è ghibellina [cfr. a fine lezione: risultato della Dieta imperiale, che comprendeprìncipi tedeschi laici ed ecclesiastici ]. Una novità di allora è appunto larichiesta ‘dal basso’ fatta all’imperatore. [vd. Libro: “Almum studiumpapiense. Storia dell’Università di Pavia”, Volume 1, “Dalle origini all’età spagnola”, Tomo I,
a c. di Dario Mantovani, p. 22]. Quanto a elementi più contingenti sullecircostanze dell’Università ticinese, dobbiamo ricordare che i Viscontiprendono Pavia proprio nel 1359, quindi se ne tenta un decollo sotto piùpunti di vista e all’insegna della sua posizione vitale: la Certosa diPavia (1396); “Strada nuova” (1370); il Castello visconteo (1360). Amonte di tutto è il 1350, allorchè i Visconti sono nominati Vicariimperiali. Si rivitalizza il mito della Scuola come legata al potere (inquesto caso Lotario, che-stando ai racconti-nel 925 gettò le basidell’Università di Pavia). È una plurisecolare tradizione regia, bensfruttata dai Visconti sotto Galeazzo II nel tentativo di avere la Coronad’Italia.27 Ottobre 1361: prima forma di “protezionismo scolastico” [slide]Il Visconti esorta…a studiare a Pavia. Anzi obbliga, pena la morteseguita da confisca dei beni, come ribadito dagli Sforza. È segno di unasvolta: ancora, peregrinatio academica (“Università itinerante”), che però alui…non piace.Bonifacio IX, 1389 [slide]Decreta la Facoltà di Teologia a Pavia. Modello di riferimento è Bologna:il “portico”, a livello di strutture e partizioni, che però nonabbracciano la Teologia. Quest’ultima, di contro, è ‘sparsa’nell’organizzazione in “Federazioni”…L’UNIVERSITÀ DI PAVIA; CRONOLOGIE SULLE UNIVERSITÀ FAMOSE E I FATTISembra l’archetipo dell’Università di Stato.-1402: morto Gian Galeazzo, si disgregano i domìni viscontei.-1404: è fondata l’Università di Torino.-1405: Padova, dopo una tentata secessione, passa al dominio veneto, chein cambio ne fa l’unica Università dei territori della Serenissimastessa.-Toscana: Pisa, Siena, Firenze, Arezzo… Ma la prima, fino al 1472, difatto non ha insegnamento, limitandosi a conferimenti di Lauree permotivi di costo. Non a caso andranno a laurearsi importanti personagginella Regione; Copernico, ad esempio, studia a Padova e si laurea aFerrara.-Sud Italia: situazione precaria, se confrontata con il resto dellapenisola. Napoli non decolla ancora. Di fatto la prima è Catania, doveforte è l’influenza aragonese come quella angioina su Napoli. Quando nel1442 Alfonso il Magnanimo d’Aragona prende la Campania, come in Siciliaaccresce l’importanza della Corte più che dell’Università-Roma: sotto Papa Eugenio IV nel 1443, la sede papale torna nel Lazio.Come per l’Europa, anche qui prendono piede circoli umanistici. Si ha
decentramento di studenti, nelle Università periferiche rispetto alcapoluogo latino, a scopo di stabilità e controllabilità.-Pisa: sotto Lorenzo il Magnifico, nel 1473 l’Università è rifondata.Come lui dice in un documento, tale città ha l’Università che più sipresta rispetto a Firenze per più motivi: approvigionamenti (vicinanza almare), alloggi… Comunque è soprattutto Firenze capitale dell’Umanesimocome Pisa per le Scienze [cfr. con la bibliografia del corso di Medioevo: come è statorecentemente enfatizzato, Firenze e la Toscana nell’Autunno del Medioevo corrispondevanorispettivamente a Londra e all’Inghilterra nel 1800, perché si tratta sempre di capitalicosmopolitiche…].
Bartolomeo Sozzini, 1483 (slide)Opinione sua è rappresentata dalle Università come vero business. Lui ègiurista. Era ricercato da tante Università: egli si trova a Pisa, eSiena lo reclama. Quest’ultima Repubblica indipendente scrive allora aiSenesi questo documento, dove si esorta a far tornare Sozzini (soldi…).MODELLI DI “STUDIO GENERALE” IN ITALIA ALLA FINE DEL SECOLO XV
1. Città sedi di Università e capitali politiche: di Regno (Napoli);di Chiesa (Roma); di Repubbliche patrizie (Siena); ducali (Ferrara,Torino).
2. Città sùddite: di Stato, istituzioni trasferite in città sùddite(Pisa); di Stato periferiche (Padova, Pavia); di Provincia(Bologna, Perugia, Catania).
ORGANIZZAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI-Pubblico-PrivatoIn “Antico regime” la Facoltà si dividono in Arti, propedeutiche a:Diritto; Teologia; Medicina (/Astrologia: l’Oroscopo…). Il modello, inlinea di massima, è quello bolognese. Allora, in quest’àmbito, la ScuolaSecondaria e l’Università erano un tutt’uno.Le “Arti liberali” sono composte da: Trivio umanistico (Grammatica,Retorica, Dialettica), Quadrivio scientifico (Aritmetica, Geometria,Musica, Astronomia). Come da nome, esse sono degne dell’uomo libero, inopposizione alle “Arti meccaniche” [cfr. l’Umanesimo, ma anche Adalberonedi Laon e, prima ancora, l’Antichità: per secoli, il lavoro manuale èritenuto degno di essere associato alla schiavitù…]. Si fa risalirequesta suddivisione al Tardo impero romano, nonchè a Severino Boezio, etali discipline sono l’ hardcore. Infatti per i giuristi è necessariosaper maneggiare la Lingua, come il corpo per il medico. Un retaggiopitagorico è la Musica: la “Matematica dei suoni”, quindi fa parte delleMatematiche ‘miste’ (applicate, in ciò diverse dalle pure).
Dipinto da un enciclopedia: “Hortus deliciarum”, 1180: “Le Sette Arti liberali al servizio dellaFilosofia (slide)Simile è: “Margarita philosophica”, Reish, 1496 (slide).Si capisce come si tenti un ritorno ad Aristotele, tipico delleUniversità di “Antico regime”. Infatti è didatticamente più ‘facile’rispetto ad altri quali Platone, perché più agevolmente spiegabile.Aristotele è riscoperto negli anni Trenta del 1100. Di lui si conoscevapoco, ma allora ‘torna’ in Europa il filosofo (ritradotto dal Greco, incui i Siriaci lo avevano tradotto): Averroè, Avicenna. Il problema ècostituito dai rischi di Paganesimo, e in ciò lo Stagirita è diverso daPlatone. Allora nel 1215 a Parigi il legato pontificio (novità) dà un’etàper l’accesso a Facoltà teologiche. Aristotele infatti crea un mondo‘nuovo’ rispetto a Dio, senza contare l’insito Empirismo. Ecco perché nelMedioevo si tenta di imporre un Aristotele ‘non integro’, spogliato diqueste parti ritenute pericolose. Invece Alberto Magno getta basi per lariammisisione del filosofo a Parigi, affermando che si devono distinguerela Filosofia e la Fisica.Corrado di Megenberg (vd.; m. nel 1374) scrive “Oeconomica”: se tutti gli studiosi di qualsiasidisciplina sono filosofi, il vero artista è chiamato “filosofo” per eccellenza…Nel 1600 il medico francese Màgnen scrive una presentazione di Democrito,spiegando il Tomismo e sottolineando come sia necessaria la conoscenza diDemocrito…IL METODO SCOLASTICO-Lectio: lettura e approfondimento delle auctoritates-Quaestio: il docente lancia problemi-Disputatio: discussione teorica, al termine di cui il docente fa unasintesi-Quaestio disputata: procedimento dialettico cui prendono parte più persone,secondo precise regoleCon l’Età moderna, questo sistema vacilla: nuove materie, nuovo metodo empirico…
LEZIONE IVL’UNIVERSITÀ NEL RINASCIMENTOI Corsi si dividono in Ordinari e Straordinari: i primi si basano sulleauctoritates, i secondo invece sono facoltativi e ‘al di fuori’.Bibliografia sul tema include “Encyclopedia of tha Renaissance”. L’epoca è di“municipalizzazione”/”aristocratizzazione” dell’Università. La lectio e lalectura si basano sulla dictatura, durante le lezioni. La puncta è unaporzione di testo, di anno in anno, da leggersi (spiegarsi) in duesettimane, punctualiter (senza né abbreviazioni né modifiche: ‘Bigini’ antelitteram). La repetitio è serale, ascoltata da un maestro più giovane.Auctoritates:-Filosofia: Aristotele-Medicina: Galeno (“Ars medica”); “Canone” (Avicenna: “Fisica” di Aristotele,più Ippocrate e Galeno)-Legge: Giustiniano-Teologia: “Bibbia”; Graziano; Pier Lombardo (“Libri delle quattrosentenze”, 1155-1158)L’ “Ordo librorum legendorum” non è ‘tutto uguale’. Esso, in particolare,è più o meno articolato a seconda della genesi dell’Università inquestione: ad esempio il Diritto a Bologna, o la Teologia a Parigi.DOCUMENTO (slide)
Sull’Università del secondo Quattrocento, come Università principesca.Come si vede dai documenti di oggi, il modello in via di affermazione èquello asburgico. Il Bacelliere è quello che deve imparare le Arti in unafase ‘di passaggio’ (come oggi il passaggio dal Biennio al Triennio, peresempio). Alcuni documenti qui visti sono su paghe, che variano a secondadelle funzioni universitarie. Vi sono casi di lezioni ‘in concorrenza’,quando c’è possibilità di lezioni ‘opzionali’ (l’una o l’altra). In unaprima fase i costi sono piuttosto alti: costa pagar l’affitto delle aule.Figura importante sono gli “stazionari” [da “stactio”, cioè “deposito (dilibri)”], che conservano i libri e a volte li producono. Il sistema diproduzione è mediante le “peciae”: l’ “exemplar” (il libro in originale,la matrice) è diviso in questi fascicoli numerati,-da cui l’espressione“sistema peciario”-ciascuno copiato da una sola persona o gruppo. Il“corrector” controlla la correzione; i “peciari”, funzionari universitari,fanno l’ultima revisione.PRIVILEGI-Generali: giurisdizione (un tribunale proprio); poter fruire di beneficiecclesiastici nel corso del periodo di studio-Locali: esenzione da leva, da tasse cittadine (compensando i bassistipendi), da dazi su certe merci; calmiere di prezzi“DISPUTATIONES”-Alcune durante le lezioni, altre invece pubbliche e solenni-Funzioni: scientificità (risoluzione rigorosa di problemi chiaramenteenunciati; insegnamento/approfondimento (discussione e confronto);verifica pubblica della preparazione di studenti e docentiIL RETTORE-Carica annuale-A Bologna gli studenti, raccolti nelle principali nationes, eleggono iloro delegati, tenendosi in contatto con le autorità comunali. I nonBolognesi, immatricolati, eleggono il rettore-A Pavia, similmente, il rettore è eletto dagli studenti delle dueUniversità di giuristi e di artisti, con rotazione a seconda dellenationes presenti-Modello parigino: il rettore rappresenta i maestri delle Arti (Facoltànumericamente più consistente). È eletto dai capi delle 4 nationes, concompiti: giurisdizionali, amministrativi, finanziariCOLLEGIO DEI DOTTORI-Riunisce i Graduati in una Facoltà e nelle Università; ne fanno parte i“doctores legentes” e quelli “non legentes”: gli uni insegnano nello “Studio”,gli altri fanno attività professionali
-Possono essere incorporati tutti i cittadini di Pavia, inclusi ilDistretto e la Diocesi, purchè laureati. Quelli che vengono da fuori,anche stranieri, possono entrarvi previo giuramento di rimanere a Pavia odi insegnare nello “Studio” per almeno un anno -A numero chiuso; sono divisi in “numerarii e non: di questi, i primiesaminano i laureatiNel 1400, fra le Professioni liberali emerge una nuova figura: l’Umanista.
“DOCUMENTO PER LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA NELLA SECONDA METÀ DELQUATTROCENTO [slide]Si può intravedere il Nepotismo. Emerge pure l’Università come retta daun elemento ‘esterno’, quindo non c’è autogoverno. Un problema sono glistipendi; come si vede, essi sono diseguali e relativamente bassi. Allorail duca si pone un problema: se si alza lo stipendio di qualcuno, bisognaalzare anche quello di altri. Infatti il duca suscita dispute in questamaniera. La situazione è relativamente immutata fino a Napoleone: glistipendi si differenziano secondo i “meriti” e l’importanza di quanto siinsegna. In pratica a regolare lo stipendio è la fama, come pure laprovenienza o meno da fuori: per via dei coti di spostamento, glistipendi sono più alti per chi si muove. Vi sono intellettuali al difuori delle ganasce corporative: sono gli Umanisti, che gradualmenterompono appunto le maglie del sistema. Primaria importanze è rivestita damedici e giuristi, di cui i primi entrano in una fase di crisi nel 1300perché la Peste ne rivela il ventre molle. I medici, allora, colleganoMedicina e Società: di qui la “Medicina naturale”, la “Fisica”aristotelica. Loro si occupano altresì di materie “interfacoltà”:l’Astrologia, in quanto il medico cura attraverso il “pronòstico”. LaMetafisica è a metà fra corpo (Medicina) e anima (Teologia); di qui laversatilità della filosofia dello Stagirita. Umanisti e Preumanistiriflettono sul senso delle Arti, mettendone anche a nudo punti deboli. Siriconosce che non si debba pensare all’uomo come di una ‘professione’particolare, ma all’uomo in quanto tale e come base per le Arti (minimocomun denominatore).Petrarca, “Familiares”, 1325-1361 [slide]“Perché mi domandi, o amico [“Giovanni dell’orologio”, medico che insegnò aPavia], s’io osi per amore tuo contraddire Aristotele? Può a molti sembrare un sacrilegio, ma èforse maggior sacrilegio volerlo seguire con ostinazione in tutto”: è un esempio di comel’Umanesimo recuperi una nuova lettura del Sapere, il metodo criticoetimologicamente inteso…L’UMANESIMO-Studi filologici
-Culto per l’Antico-Critica del Sapere convenzionalmente accettatoSi formano allora Università umanistiche, sull’onda di una nuovamentalità: ormai le Università sono “tecniche” (quindi non invece“liberali” o fini a sé).Parigi, “De ingenuis moribus”, Vergerio; uscito per la prima volta a stampa nel 1494 [slide]Già più simile al libro, in particolare a differenza che [slide] l’ed.veneziana della “Naturalis Historia” (1469). Simile caso di monopolio (lobby) èofferto da Oxford e Cambridge: l’imprimatur, la possibilità nel mondoinglese di fare testi scolastici solo in queste due realtà.LE GOFF, “TEMPO DELLA CHIESA…” [slide]Addomesticamento delle Università: perdita di libertà giuridiche;assoggettamenti economici a prezzi maggiori dei finanziamenti pubblici;vien meno l’internazionalità, perché le Università rappresentano Staticonfessionali; nuove fondazioni, con obiettivi utilitari; disciplinamentosociale; cambia la composizione sociale, in quanto aumentano gli studentiborghesi e nobili.
LEZIONE VQuando Maria Teresa riafferma la figura del rettore, questo è sì affidatoancora agli studenti ma è scelto tra i docenti e non più fra glistudenti, a garanzia di affidabilità. Inoltre [vd. slide], a differenza dioggi, le paghe sono ad personam o ad disciplinam , e seconda di: materia ecclesiastica (ritenuta di più pregio) o no; qualità relativa; … . “Fasciculus medicinae”, 1493, in “Anathomia” di Mondino de Liuzzi, immagine [slide]Lezione pratica anatomica. Per motivi di immagine il Rettore non seziona,ma spiega. La Chiesa, intanto, si apre gradualmente a cose ‘disgustose’ o‘basse’: si pensi a coeve realtà ‘onnipresenti’ come il Barocco.“De humani corporis fabrica librorum epitome”, Oporino, 1543, Basilea, immagine [slide]A differenza di sopra, è il capo a toccare la salma. Qui si commentaironicamente la presunzione dei professori. Come descritto, si dice chela “Bibbia” dei medici era (ormai in originale) Galeno, che studiavaAnatomia non sull’uomo ma sulla scimmia e facendola passare per uomo. Delresto, c’erano casi in cui si tentava di far spacciare testi per scrittidi Galeno.“Teatro anatomico di Leyda”, immagine [slide]Siamo nell’AULA SCARPA dell’Università di Pavia. Si vede che scheletrireggono bandiere recanti detti morali: intreccio psicofisico, stessomotivo per cui attività del genere sono tipiche del Carnevale, aproposito dei legami già visti (corpo, anima, meteorologia, astronomia:
tutte all’insegna dell’ astrologia). Del resto tali elementi nasconosoprattutto ‘per i forestieri’, stessa ragione del parallelo formarsi dicollegi universitari di cui il primo nasce a Parigi e precisamente sullabase dell’Hotel Dieu [cfr. corso del Prof. Frank].
SUNTO SOMMARIO…L’Università è sempre più legata al potere. Si accavallano tante novità:mondi; scoperte astronomiche; Stampa; Riforma e Controriforma; … . Tra le novità, degno di nota il Collegio, perché prima invece glispostamenti continui potevano alla lunga condurre all’impoverimento dellostudente. Come soprattutto nel caso dei Gesuiti, spesso il modello per iCollegi sono i Conventi [si pensi anche solo all’etimo della parola…].Sempre per volontà specie gesuita, si avviano pure Corsi integrativi nelCollegio. Allora, sull’onda delle pressanti richieste di frequentareanche Corsi laici, l’intervento di papa Farnese nel secondo Cinquecento:la trasformazione di questo tipo di Collegio in Studium generale, perl’insegnamento di Filosofia e Religione.Ignazio di Loyola (1551): “Con lezioni pubbliche di Lettere si tira la gioventù non solamentealla dottrina secolare ma etiam a sapere le cose che devono essere sapute dai Cristiani[slide]Centrale è la formazione di Classi dirigenti. L’apice dei Collegi si ha, in Età moderna, coi “Seminaria nobilium”…
LEZIONE VI
LE UNIVERSITÀ DOPO L’UMANESIMO: COSMOPOLITISMO
In Età moderna declina il mito dell’Università come centro ‘assoluto’ della cultura. Del resto, in parallelo, declina la centralità assoluta dei Classici. Si pensi ad Aristotele: più che esso, si legge invece l’apparato dei suoi commentatori.
La lezione ex cathedra è quella sui testi canonici, pubblica, di cui uno spazio era dedicato al parlar d’altro. Ma c’era pure (ufficializzabile o meno) la lectio domestica (privata) [cfr. Galileo], spesso durante i pasti, emolto discussa sulla sua legittimità o meno.
A fine 1500 il Senato ordina che i prof non cambino il canone: quindi, sideducono i tentativi di introdurre cose nuova [insegnamenti ‘alla moderna’]. Ecco perché allora si poteva venir licenziati come niente…
[Slide] 1493 (“Anathomia”, “Fasciculus medicinae”, di Mondino de Liuzzi): anatomia come conferma del testo (non viceversa). I primi secoli di Anatomia, questi. Poi però vi è un cambiamento [slide]: il Prof. … tocca il corpo (fatto epocale).
Come genesi, l’Università ‘produce per sé’: “Laurea” = Licentia docendi ubique, cioè il fine è imparare per poi insegnare.
Dalla fine del 1300 tutto cambia: aumenta il cosmopolitismo. Infatti, da allora, servono certi titoli per certi lavori (Burocrazia; Diplomazia; Arti liberali).
[Infatti oggi Stone (‘successore’ del pluripremiato ‘re’ degli storici inglesi defunto, Hobsbawm) parla di “Educational revolution” in «Past and Present»].
Vien meno lo spazio medievale tipico dei Nobili: educazione, ma specie militare. In Età moderna, allora, Nobiltà di sangue e di spada perdono ilpredominio precedente, quindi aumenta l’accesso di Aristocratici all’istruzione ‘per tutti’. Con l’impoverimento della popolazione in seguito alle crisi di Età moderna, aumenta la fascia nobiliare nell’istruzione [cfr. , come più ampio panorama storico-ideologico, la “Rifeudalizzazione” coeva …].
Paolo Prodi: Il sacramento del potere, 1992. Si parla del giuramento come basefondamentalmente politica (Feudalesimo, Università…), anche se in Età moderna non è più così in toto. Si passa da ratione officii (giuramento di fronte a: Dio, Vertici, collettività) a ex officio (tutti i sudditi, naturalmente, hanno ‘funzione pubblica’ di fronte alle Autorità).
Nel caso dell’Università, ciò di cui sopra è un cambiamento : dal giuramento (di fronte ad Autorità universitarie) al ‘cosmopolitismo’ (vien meno la componente corporativa e ‘autoreferenziale’ degli Studia).
Paolo Prodi: questo processo inizia da metà ‘400, e si lega a fatti epocali (Concili, scismi…) per cui il giuramento arriva a divenire anche
di fronte a una dottrina [culmine del processo è l’Età confessionale]. Con l’Età moderna, insomma, lo Studium si avvicina sempre più al potere politico: si pensi all’Università di Parigi, che dalla metà del XV secolonon giura più di fronte al Papa, bensì di fronte al re di Francia. Non a caso [slide]: Pico della Mirandola, « Io mi son proposto di non giurare sulla parola di nessuno, di frequentare tutti i maestri di Filosofia, di esaminare tutte le posizioni, conoscere tutte le Scuole » [vd. De hominis dignitate, 1486].
Insomma in giuramento è anche ideologico: intanto, col consolidarsi delloStato nazionale, vi sono disciplinamento ed Età confessionale [cfr. LuigiXIV: «One roi, one loi, one foi»].
Con la Pace di Augusta (1555), c’è più stabilità (assestamento). Sono esempi di come, nella Prima età moderna, lo Studium sia determinante nel formare schieramenti di lotte e scismi. Si pensi a Lutero: era un Prof. Universitario; a sua volta Calvino, scampato alle persecuzioni rifugiandosi a Ginevra, lì fonda una “Accademia” (come lui la chiama…). Èlo stesso motivo per cui l’Università spesso è centro di reclutamento: Inquisitori; ‘controllori’ (Consultori del Sant’Uffizio) per i Libri Proibiti…
Il Concilio di Trento [vd. Scheda, «Magnum bullarium romanum», specie p. 2]è importante svolta per serrare quanto sopra detto. Infatti è imposto un giuramento al Cattolicesimo (“Profissio Fidei”) a tutte le Università cattoliche, come intanto accade in seno al Protestantesimo. La Scozia però è più culla di libertà, dato che non c’è tale imposizione di giuramento: non a caso, il Paese nordico fu importante culla dell’Illuminismo.
[Slide] Ayo-Buch, opera del tedesco Veit Guggenberger (1738). Si vede come ilgiuramento non sia solo pubblico, ma pure corporale: si pensi, nella didascalia, alla postura simboleggiante la Croce e la Trinità in analogia col Cristo Pantocratore. Un effetto importante del Concilio tridentino, infatti, è la separazione tra Fisico e Metafisico. Ignazio di Loyola (1551) capisce l’importanza delle Lezioni pubbliche di Lettere: per educare la gioventù non solo alla dottrina secolare, ma anche al sapere ciò che i Cristiani devono.
COLLEGI GESUITI
È un’importante svolta connessa coi Collegia nobilium, più o meno a pagamento(non per chi è stato grande benefattore per il Collegio gesuita).
A Pavia i Gesuiti arrivano a inizio ‘600: perché ‘ c’è già ‘ l’Università pavese; infatti è a Milano che nasce, intorno al 1570, a Brera il primo Collegium nobilium della Regione (Chiesa di San Fedele). I Gesuiti includono gli insegnamenti universitari a pagamento.
[Slide] Lettera del Rettore del Collegio gesuita di San Fedele (Milano) , 1569 : si vede comeil Collegio gesuitico sia molto gettonato, a tal punto da ‘succhiare’ persone dallo Studium pavese per tutta una serie di garanzie (controllo, disciplina…). Intanto (Controriforma) a Pavia nascono il Ghislieri e il Borromeo, dove ci sono studenti poveri (per come allora li si intendeva di solito: “depauperati” o ‘poveri provvisori ’, specie perché di solito èNobiltà decaduta…).
La “Condotta” è un contratto fra persona e potere.
Per una classificazione dei Collegi gesuiti :
- Pieno esercizio: possibilità (per volere papale) anche di dare dottorati (in Teologia e Filosofia, in città dove non ci sono Università)
- Medio esercizio- Piccolo
LEZIONE VII
[Vd. Scheda: Documento del 1668…]È una carrellata di Studia e laureati, tra cui l’Università di Montpellier che era faro per la Medicina.Molti (di norma, Patrizi) facevano Filosofia generale presso i Gesuiti, poi si formavano presso Collegi professionali (‘tirocini’), dove c’erano Collegia instituta (presso qualche avvocato celebre), e infine Esame e Laurea. Questa la forza dei Gesuiti: fornir le basi per le Arti.Cesena è città municipale, dove ci si può laureare (non, per contro, fare Corsi) dopo aver dimostrato una buona cultura. Un esempio di città nata da impulso gesuita. Ma attenzione: come per altre realtà quali Piacenza, lì si acquistavano lauree.
ALBERTO RADICATI DI PASSERANO (MORTO NEL 1738, DOPO LA FUGA DA TORINO)Sotto Vittorio Amedeo. Inizia riforme e modernizzazioni, ma…senza Illuminismo. Quindi, in barba alle speranze di gente come Radicati .Radicati tenta di dar voce all’Illuminismo radicale , ma invano: stanco di lui, Amedeo lo manda in esilio. Poi, a causa di idee religiose, lui a maggior ragione è isolato: anche i Protestanti lo biasimano [vd. schede]. Amedeo ispirerà Muratori : Illuminismo moderato, 1748 [cfr. l’Illuminismo francese].NOMENCLATURANel 1569 il Podestà di Pavia diviene “Senatore”, quindi atto a occuparsi dello Studium, rosicchiando prerogative al Vescovo locale.Ecco perché [vd. Documento del 1611] si fa continuo riferimento al “Podestà” pavese. Sembra da questo Documento, ricorda che i “Consiglieri” erano “Consiglieri del Rettore”, rappresentanti dellenationes. In quell’epoca: decadenza, perché il Rettore e la componente ‘studentesca’ come relativamente autonoma (a fine ‘500 non ci sono più verbale su tali figure: il Rettore perde sempre piùpeso…). Infatti in questo Documento tali figure sono considerate perniciose; riferimenti , qui, al Borromeo e all’ “Alessandrino” (ilGhislieri, così detto perché Ghislieri era di Marengo), che invece stavano avendo sempre più successo . Si penso al contesto: sull’ondadi Riforma e Controriforma, aumenta l’importanza di disciplinamentoe controllo.A livello di metodo di insegnamento: nel 1500 il metodo di dettatura è criticato, mentre è molto in voga presso i Gesuiti. Di fatto, volenti o nolenti, ‘tutti’ finiscono con l’usare questo metodo ex scripto (“da scritto”: appunti, letti e poi dettati).UNIVERSITÀ DI PAVIA: ORGANIZZAZIONE
- Università dei Giuristi (Statuto): Rettore- Università degli Artisti (Statuto perso): Rettore- Collegio dei Dottori giuristi (Statuto)- Collegio dei Dottori in Arti e Medicina (Statuto)- Collegio dei Teologi- Cancelliere : Vescovo
Lo Studium ticinese odierno è figlio del modello teresiano, più simile al modello parigino che non a quello bolognese: la centralità è caratteristica del Prof., non dello studente (si pensi infatti: chi dàla Laurea?).
Secondo il modello di Bologna, i Collegi dei Dottori non coincidono coi Docenti della Facoltà, ma coi Laureati, dotati di certi requisiti (tra cui, la Cittadinanza).
Nel 1447 i Membri del Collegio dei Dottori giuristi devono essere anche membri del Collegio professionale cittadino. Questa disposizioneè estesa al Collegio medico-artistico.
I Collegi cittadini vanno assicurandosi il monopolio dell’esercizio professionale.
Tutte queste sovrapposizioni (da un lato, Collegi universitari e cittadini; dall’altro, monopolio nell’esercizio) condurranno, conseguentemente, a una crescente provincializzazione del corpus docente.
LEZIONE VIII
BACONE [CFR. CON SCHEDE DELLA LEZIONE VI]
Parola chiave è “progresso”: novità! Svolta, anticipando la ‘fine’ della querélle tra Antichi e Moderni (fine ‘600): così, non più «nani sulle spalle dei giganti», ma un gigante formato da più nani (come dice Fontenelle).
Il monarca, quindi, non è più solo “guerriero”, “benefattore”, “pater familias” e “giustiziere”, ma fecondo per il progresso e per la cultura.Allora i compiti sono trasmissione e ricerca di progresso e conoscenzadel sapere: insegnamento e ricerca sono interrelati…
Declina l’idea originaria dell’Università come “Corporazione”: da una dialettica col potere, si passa…alla ‘statalizzazione’.
La ricerca ha due fasi: ricerca ‘vera’ (pura), poi condivisione e spiegazione (ecco perché ci sono sia il “ricercatore” sia l’ “autore”,considerando etimi e concetti).
Bacone, non a caso, scrisse Atlantide, a proposito di utopia: dove gli abitanti realizzino un progetto di ricerca scientifica (“Casa di Salomone”: non a caso, lo scrittore inizia con una citazione salomonica). Di qui la “Royal Society”, sotto Carlo II Stuart; essa infatti è ‘internazionale’, e l’Inghilterra è particolarmente avvantaggiata in virtù dell’ “insularità”, come si vede fra ‘700 e ‘800. Importante anche la componente economica: le paghe.
Insomma Bacone è un Manifesto della Scienza sperimentale istituzionalizzata.
Non basta più solo l’osservazione, ma anche la sperimentazione. Di quiil bisogno di denaro…
Allo stesso modo, non ha più senso la disputa meramente verbale. Dunque il libresco e l’orale sembrano out of the world quando si va al lavoro.
A fronte del tutto, importante la libertà di circolazione (a 360 gradi), nonché (va ribadito) la compresenza di teoria e pratica. Ecco perché “fratellanza” è tipica parola attribuita alla Scienza. Le Fonti: Classici, Testi Sacri, usate da un ex politico come Bacone (a dimostrazione della costanza di determinati modelli). Infatti, nella Guerra civile inglese del 1600, diffusissima è l’idea del Millenarismo.
Altra idea innovativa: cooperazione fra Università ai fini scientifici, al di là di problemi religiosi e di divergenze confessionali… Elementi non sempre realizzatisi!
UNIVERSITÀ DI TORINO
Include succursali, come Nizza ad esempio. Fu fondata dai Savoia. Il secolo XVI fu critico, per le invasioni francesi. Nel 1556 lo Studium fu trasferito definitivamente a Torino: Università ducale, anche se leautorità cittadine hanno un certo peso (sostentamento economico). Di qui, ‘statalizzazione’ dell’Istituto e (in ciò, invece, a differenza che a Pavia) sede in capoluogo. Quindi la carica di Rettore (intesa come affidata a uno studente) è soppressa.
Anche la fine del secolo XVII è crisi: lotta fra Impero e Francia, unavolta scongiurati i Turchi a Vienna nel 1683. A ciò si aggiunge la minorità di Vittorio Amedeo, che poi prenderà parte alla Guerra di Successione spagnola dove si mostra che “i Savoia non finiscono mai una guerra dove [schieramenti, posizioni, contendenti] l’hanno iniziata [alleanza]”. Intanto il rafforza la ‘statalizzazione’ dello Studium torinese inizia a calare. Lo Stato sabaudo, dopo il 17\5, diviene Regno (non più Ducato), insieme al loro dominio che passa da Sicilia a Sardegna.
Per le nuove esigenze, aumenta il bisogno di nuova Aristocrazia: Nobiltà “di Servizio” (o “di Toga”), non più “di Sangue” (e neppure “di Spada” o “di Terra”).
Amedeo fa riforme nel 1720 e nel 1729 sull’Università: Magistrature e Titoli sono ormai di nomina regia.
A Torino, i Titoli sono incorporati in Università: ai Dottori, si aggiungono i Prof. . Nascono i “Collegi delle Facoltà”, con relativi miglioramenti nel secolo XIX. Prima, di contro, questi Collegi erano solo per i Prof. .
LEZIONE IX
La parola “costituzione” è una costante. È un segno degno di nota: vuol dire che Vittorio Amedeo ha lasciato una vera traccia archetipicadi fatto, a proposito di riforme. Del resto, elementi importanti sono:abolizione dei Gesuiti (1773); Scuole elementari pubbliche (Lombardia austriaca), ecc. .
Dalla posizione di Pavia (‘dove metto’ l’Università riformata?) si innesca rivalità con Milano: in tempo di crisi, ci si aspettava che loStudium ticinese fosse ‘trasportato’ a Milano (come infatti era successo a Torino, come capoluogo del Piemonte) in quanto capoluogo lombardo, e invece così non avverrà (Pavia non era ‘a sé’ o autonoma, ma di cerniera fra Lombardia asburgica e Impero, per cui senza l’Università la città ticinese…morirebbe).
Ricapitolazione generale sulle svolte del secolo XVIII- Fine delle autonomie studentesche.- Statalizzazione, burocratizzazione, professionalizzazione.- Nel Collegio religioso si fanno “Arti”.- L’Università perde il monopolio di dare dottorati.- Secolarizzazione, laicizzazione, riformismo, miglioramenti catastalie fiscali; ‘liberalizzazione’ (vien meno la ‘segretezza’, contestata insieme all’oscurantismo da personaggi come Pompeo Nero o Paolo Sarpi).Fatti chiaveLa guerra di successione austriaca. Da lì, infatti, l’Impero rischia un vero sfacelo, quindi Maria Teresa avvia una campagna di riforme in cui Vienna diviene modello di riferimento (che negli ultimi 30 anni del secolo XVIII è esportato in Lombardia).
A monte è la riforma del Catasto (Pompeo Neri), nonché la “riforma Pallavicini”.Novità poi, come già sotto Vittorio Amedeo (e da lì a Maria Teresa) è questa: l’idea di un (embrionale) forma di “Ministero della pubblica Istruzione”-il “Magistero dell’Università”-in seno all’amministrazione.PrincìpiUniformità politico-amministrativa; scelta dei Prof. Attraverso concorsi, che però non equivalgono a ‘libertà assoluta’: l’epoca è l’Assolutismo, fatta salva la riforma sulla libertà di stampa e quindisulla censura (il cui monopolio è sottratto alla Chiesa ad opera dei monarchi). Il tutto, all’insegna di metodicità e sistematicità, quindianche controllo. Si ha poi ristabilimento (riconferma) del “Foro privilegiato”: tribunale speciale (di fatto, corporativo) per l’Università, almeno fino al 1786, quando invece Giuseppe II ‘appiana’e cancella i privilegi (abolizione delle Corporazioni).Il tema è anche la “libera professione”, comunque regolamentata.Si badi: allora, non c’era l’esame di fine Corso (solo di Laurea), introdotto invece sotto Napoleone. Con la Restaurazione, per circa unaventina d’anni tale modello napoleonico tramonterà provvisoriamente a vantaggio, invece, del modello prussiano. In quest’ultimo caso, in compenso, gli esami ‘finalissimi’ sono … super difficili !!!!!!!!!!
BIBLIOGRAFIA E … POSTILLE- Elena Brambilla [cfr. Bibliografia della Ferraresi]: la ‘vera’
riforma è in epoca Giuseppina ben più che teresiana: in virtù della«rivoluzione legale» e della meritocrazia.
- [Su Pavia, ricorda specie la “Deputazione degli Studi” (1769), che in pratica apre la porta al riformismo austriaco nell’amministrazione lombarda, imponendo la ‘foresteria’ locale come amministrazione…].