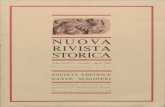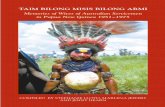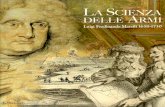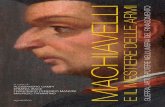La armi della Guardia Civica del Granducato a Montepulciano
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La armi della Guardia Civica del Granducato a Montepulciano
112-115 - Interno della chiesa di S. Bernardo, le statue delle sante: Sant’Agnese poliziana, Santa Caterina da Siena, la Maddalena, Santa Rosa da Lima, realizzate da Bartolomeo Mazzuoli.
188
LE ARMI DELLA GUARDIA CIVICA DEL GRANDUCATO A MONTEPULCIANO
di Marco Merlo e Luca Tosin
Non toccar quei fiori porporinich’apron le foglie sul finir di maggio,son tinti ancor del sangue dei meschiniche preferir la morte a reo servaggio.Eran venuti qui da’ lor confiniper liberarci da straniero oltraggio.Eran giovani e prodi, io li ho veduti:eran giovani e prodi, ei son caduti.Non toccar quei fior, sorella cara,fiori di Curtatone e Montanara;dànno la febbre a chi sul cuor li pone,fiori di Montanara e Curtatone.Francesco Dall’Ongaro
Eventi politici e militari dal 1844 al 1852: la formazione della GuardiaCivicaDopo la scomparsa nel 1844 del Conte Vittorio Fossombroni, che dal 1815teneva le redini del governo del Granducato di Toscana e, nel 1845, del suosuccessore, il Principe Neri Corsini, il nuovo governo fu particolarmentemal visto dai liberali toscani. L’espulsione di Massimo D’Azeglio (reo diaver scritto pagine sgradite al governo papale) e la consegna alle autoritàpontificie di Pietro Renzi, uno dei capi dell’insurrezione di Rimini contro ilgoverno del Papa, che proprio in Toscana aveva trovato asilo, furono iprovvedimenti maggiormente criticati e causa di malcontento. In Toscana dopo la Restaurazione avevano trovato asilo politico innumere-voli esuli dai diversi Stati italiani. La sua classe dirigente, liberale, anticleri-cale e colta (ricordiamo iniziative culturali di risalto europeo qualil’Antologia, la rivista voluta da Gian Pietro Vieusseux, e gli intellettuali libe-rali fiorentini del celebre Gabinetto scientifico e letterario1), orgogliosa divantare tra i granduchi l’illuminato Pietro Leopoldo, mal sopportava l’alli-neamento del proprio governo alle politiche interne pontificie. Le prime significative proteste si ebbero durante il carnevale del 1846. Neglistessi giorni professori universitari ed eminenti cittadini pisani firmavanouna protesta inviata al Granduca nella quale veniva richiesto di non conce-dere il permesso alle Suore del Sacro Cuore di Gesù di fondare un educan-dato a Pisa. Contemporaneamente molti giovani inscenavano proteste dipiazza proprio contro le Suore. Le proteste furono ascoltate: il Granducaritirò l’autorizzazione. La situazione fortemente anticlericale si attenuò nei giorni successivi all’ele-zione al soglio pontificio di Pio IX. Risultò decisivo l’atto di amnistia pro-mulgato dal nuovo pontefice il 16 luglio 1846. Infatti tale provvedimento fuaccolto con entusiasmo anche dai liberali toscani, che da quel momento inavanti urlavano sempre più spesso quello che divenne un vero motto: “VivaPio IX”2. A concorrere a una solidarietà reciproca tra i sudditi del Papa edel Granduca furono due calamità naturali: un terremoto che danneggiòPisa e dintorni e l’esondazione del Tevere a Roma. Questi due eventi favo-rirono la creazione di comitati di soccorso in entrambi gli Stati, le cui popo-lazioni si affratellavano, seppur nella sventura, nonostante che le due poli-tiche nazionali rimanessero distanti. In questo modo nascevano contattianche politici, come l’iniziativa di Giuseppe Montanelli3, professore univer-sitario, il quale aprì una sottoscrizione per aiutare economicamente gliamnistiati bisognosi. Ma le politiche liberali di Pio IX non si limitarono alla sola amnistia.Promulgò una legge che limitava il diritto di censura delle autorità politichesulla stampa. Inoltre fu promotore della formazione di una Guardia Civica,
con compiti principalmente di pubblica sicurezza, il cui regolamento risaleal novembre del 18474. Questa era la prima Guardia Civica istituita in unoStato italiano dalla fine della stagione napoleonica. Il malcontento toscano continuava a dilagare, contro un governo succubedell’Austria. Le proteste si diffondevano in tutte le città e in tutti i maggioricentri del Granducato. L’anima più attiva era incarnata dagli studenti pisanie senesi. Al fianco degli inni a Pio IX si aggiungeva sempre più spesso l’odioverso gli austriaci: “Viva Pio IX” e “Abbasso i tedeschi” erano i motti piùdiffusi. Iniziò a essere stampato un giornale clandestino, ma tollerato dalleautorità ufficiali, intitolato Notizie italiane, nel quale venivano riportate noti-zie dei giornali romani e, più in generale, notizie provenienti da tutti gli Statidella penisola. Era corredato da pungenti vignette satiriche, indirizzate a tuttigli strati sociali. Questo favorì il proliferare di foglietti politici anti-governa-tivi che le notti venivano appesi nei luoghi pubblici. Ma a questo punto lareazione del governo fu dura: alle perquisizioni fecero seguito arresti dimassa che riempirono le carceri di studenti, tipografi e liberali, a volte solosulla base di sospetti. Vi fu anche la reazione, pacatamente antigovernativa,di personaggi moderati quali Bettino Ricasoli, Vincenzo Salvagnoli, l’abateRaffaello Lambruschini, Gino Capponi e Cosimo Ridolfi, i quali firmaronodue petizioni che si facevano portavoce delle volontà popolari. Ma ilMetternich, nell’aprile del 1847, intimava al Granduca Leopoldo II di nonascoltare le voci liberali, in quanto dettate esclusivamente dall’odio naziona-listico italiano nei confronti dei regimi filoaustriaci. Non nascondeva lavolontà di un’invasione militare, nel caso in cui il governo non fosse riusci-to ad arginare le proteste, come effettivamente avrebbe ordinato nei con-fronti di Ferrara5. Ma appariva chiaro come il Granduca non fosse persuasodall’idea di una svolta esclusivamente autoritaria, senza prima rilasciare qual-che concessione. Oltretutto prendeva piede nel Granducato l’ammirazioneper Garibaldi, a un punto tale che a Firenze si aprì una colletta per inviare indono una spada d’onore all’Eroe, che si trovava ancora a Montevideo. Per prima, il 6 maggio 1847, arrivò la legge sulla stampa che, sull’improntadi quella pontificia voluta da Pio IX, manteneva la censura preventiva, mala regolamentava attraverso un Consiglio di Censura. Questo però nonaccontentava i liberali. Un foglietto clandestino, comparso nel 1847, benillustrava quali fossero le richieste: “Unione dell’Italia contro il Tedesco,ordinamenti interni quali si convengono alle condizioni dei tempi e dellaToscana; pieno diritto di petizione e reclamo, riordinamento del comune,istituzione di consigli provinciali; censura di stampa repressiva non preven-tiva; guardia nazionale”. In ultima istanza si chiedeva quindi la formazionedi una Guardia Civica, sull’impronta di quella voluta da Pio IX, come erastata recentemente costituita nel limitrofo ducato di Lucca (che il 4 ottobresarebbe stato annesso al Granducato di Toscana). Il 4 settembre 1847 veniva costituita, in esecuzione del motuproprio, laGuardia Civica del Granducato (con notifica il 15 settembre), allo scopo digarantire “la sicurezza privata e pubblica” e di “conservare e ristabilire l’or-dine, coadiuvando, ove necessario, le milizie attive dello Stato”. Le intenzioni dei liberali erano evidenti: con la formazione di una GuardiaCivica veniva anche richiesta (e ottenuta) una riforma delle comunità localie un avvicinamento di tutti i sudditi alla politica granducale, che gli eventidi quegli anni avvicineranno sempre più ai fermenti politici della penisola. Il 17 febbraio 1848 Leopoldo II firmava uno Statuto che si distingueva daglialtri per numerosi provvedimenti liberali, come la concessione dei pienidiritti ai cittadini di tutte le religioni, e nel quale veniva regolamentata laGuardia Civica. Il 18 marzo nasceva il primo governo costituzionale tosca-no, presieduto da Francesco Cempini. Venivano annessi al Granducato
189
anche i comuni della Lunigiana e l’alta Garfagnana e il ducato di Massa eCarrara, le cui popolazioni avevano chiesto di essere toscane, secondo ilprincipio che ogni popolo era libero di decidere la propria sorte. Con l’an-nessione di Lucca al Granducato di Toscana, avvenuta quasi quattro mesiprima, queste zone erano state cedute nel 1847 ai Borbone di Parma e agliEste di Modena in virtù del trattato di Firenze del 1844, che regolamenta-va l’annessione dei territori lucchesi allo Stato toscano. Intanto il Regno diSardegna il 23 marzo del 1848, il giorno seguente il ritiro delle truppeaustriache da Milano, dichiarava guerra all’Austria, segnando l’inizio dellaprima guerra d’indipendenza. Leopoldo II, insieme al pontefice Pio IX e a Ferdinando II, Re delle DueSicilie, decise di inviare truppe ad affiancare quelle sarde. Questa decisionesuscitò l’entusiasmo popolare toscano, dove già la notizia della ribellione diMilano aveva riscaldato gli animi. Il Montanelli racconta che, quando il 21marzo uscì di casa a Firenze, le notizie della ribellione milanese avevanoinfuocato i Fiorentini. A questa andava unendosi la voce che il Metternichfosse fuggito da Vienna, anch’essa in rivolta. Montanelli, apprendendo que-sti fatti, chiese alla gente per strada: “E che si ha a che fare?”; la risposta fusemplice e lapidaria: “Pigliar lo schioppo e partire!”6. La decisione diLeopoldo II fu seguita dalla creazione di corpi di volontari pronti, con armiin pugno, ad affiancare le truppe regolari toscane (7000 uomini). Ma ilGranducato, influenzato a corte fin dal XVIII secolo da una politica anti-militarista, aveva sempre avuto un esercito esiguo7. Quindi per la campagnaal fianco del Piemonte fu deciso di inviare anche reparti della GuardiaCivica appena costituita, e ad affiancarla vi furono i professori e gli studen-ti della Guardia Civica Universitaria (circa 4000 uomini)8.
L’esercito si mosse verso il fronte in due colonne: una da Pisa verso Massa,composta da Pisani, Senesi, Lucchesi, Maremmani, Livornesi e dai batta-glioni di universitari. L’altra colonna, partita da Firenze in direzione diModena, era composta da Fiorentini, Aretini, Pistoiesi e Pratesi. I volonta-ri, della Guardia Civica, della Guardia Civica Universitaria e quelli prove-nienti da un po’ tutti i paesi della Toscana, apparivano come “legioniimprovvisate nelle quali il medico, l’avvocato, l’artigiano, il nobile, il ricco,l’indigente, il prete, il padrone e il servitore, marciavano mescolati in cultod’Italia! Oh letizia di sentirci finalmente guerrieri d’Italia”9. I volontari pro-venivano dalle città e paesi più diversi: ad esempio, dalla piccola comunitàmaremmana di Massa Marittima partirono per il fronte 16 giovani, tre deiquali caddero in combattimento10. Il 9 aprile il Granduca, in un proclama, consegnava il vessillo granducaleall’esercito regolare e alla Guardia Civica, in cui veniva sottolineato che lamaggior parte dei mobilitati sono volontari. Il proclama si concludeva conl’incitamento “Onore alle armi cittadine! Viva l’indipendenza d’Italia!”11.Seguendo l’esempio del Re di Sardegna e del Re delle Due Sicilie, alleatinella guerra contro l’Austria, per decreto granducale del 17 aprile, compo-sto da tre articoli, alla bandiera lorenese veniva sostituito il Tricolore12 siaper l’esercito sia per la marina militare. L’articolo 2 stabiliva che le bandie-re della Guardia Civica avrebbero portato “sul fondo Tricolore da una partelo scudo granducale, dall’altra l’arme della comunità a cui appartengono”13.Celebri sono gli eventi durante i quali si distinse il contingente toscanodurante la battaglia di Curatone e Montanara14. Le truppe toscane eranoattestate sulla strada che da Porta Pradella risale per gli Angeli, Curtatone,Grazie e Rivalta verso Goito. Questa linea fu l’obiettivo dei comandiaustriaci, che il 28 maggio facevano partire da Mantova un forte esercito (37battaglioni, 27 squadroni, 88 pezzi), fresco e ben equipaggiato15. L’esercitosardo, male informato, poté solo tentare di ripiegare. Quindi venne ordina-to ai Toscani e ai Napoletani di resistere a ogni costo. In grave inferioritànumerica e con un’artiglieria anche qualitativamente inferiore venne tenta-ta la resistenza, prima di ripiegare su Goito e su Volta (come da ordini delcomando sabaudo)16. In linea erano schierati 5400 uomini con un piccolo squadrone di cavalleriae 9 cannoni. Gli Austriaci attaccarono con circa 20000 uomini. Al coman-do del corpo di spedizione, aggregato al corpo del generale piemonteseEugenio Bava, vi era il generale toscano Cesare De Laugier, uno dei milita-ri che più appoggiarono la scelta del Granduca di istituire la GuardiaCivica17, il quale qualche mese prima aveva guidato un piccolo contingente
toscano in difesa della Repubblica di Venezia, dove si era distinto in alcuneazioni. A Montanara erano schierati 2300 uomini agli ordini del tenentecolonnello lucchese Giovanetti18; alle Grazie, su ordine del De Laugier (cheproprio in questa località aveva stabilito il quartier generale), erano in riser-va due compagnie di granatieri e lo squadrone di cavalleria (di appena 100cavalli). Qui era anche schierato un battaglione composto dai volontari dellaGuardia Civica Universitaria: 270 uomini, proveniente dagli atenei di Pisa(comandati dal professore Ottaviano Fabrizio Mossoti), Siena (guidati dalprofessore Alessandro Corticelli) e Firenze, con l’ordine di proteggere idepositi e l’ospedale da campo lì allestito19; su tutta la linea furono dissemi-nate le unità della Guardia Civica granducale, soprattutto quella fiorentina,4 compagnie livornesi, 2 compagnie lucchesi e un numero imprecisato divolontari provenienti da tutto il Granducato. La battaglia fu violentissima dalle rive del Lago Superiore in località QuattroVenti, sul corso dell’Osone, sin oltre Montanara, protraendosi per l’interagiornata sino a tarda sera. Il grosso dell’attacco fu concentrato a Curtatone,dove la resistenza contava solo su tre bocche da fuoco: un grosso obicerimasto subito intasato e due cannoni di piccolo calibro che esplosero colpisenza sosta. Ai pezzi si distinse il livornese Elbano Gasperi20 che, rimastonudo a causa di un razzo che gli aveva incendiato i vestiti, continuava a stareal pezzo. Come lui molti altri artiglieri colpiti dai razzi continuavano a ser-vire ai pezzi con le vesti bruciate. Riportò ustioni anche il professorePiccolini, investito dalle fiamme di una cassa di munizioni centrata dai razziaustriaci. Con questa determinazione riuscirono non solo a resistere all’ar-tiglieria austriaca (24 pezzi e diversi lanciarazzi), ma respinsero più volte ilnemico. Qui tre compagnie della Guardia Civica, con alcuni volontari, alcomando del maggiore Beraudi furono impegnate negli scontri al fiancodelle truppe regolari toscane e napoletane, riuscendo a esercitare una forteresistenza. Mentre il capitano Conti, muovendo da Curtatone con pochiuomini, tentò un diversivo stuzzicando il lato sinistro del nemico. Dopo le due del pomeriggio gli Austriaci attaccarono nuovamente: sull’alasinistra furono impegnati gli studenti, sulla destra la Guardia Civica lucche-se. Dopo le quattro era chiaro che le posizioni di Curtatone e Montanaraerano perdute. Il De Laugier ordinò di ripiegare partendo proprio daCurtatone: Guardia Civica, studenti e volontari toscani con gli uomininapoletani, continuavano a resistere in modo che gli Austriaci non taglias-sero la ritirata. A Montanara si continuava a combattere. Alle Grazie i volontari universita-ri, contravvenendo all’ordine del De Laugier, non attesero gli ordini e pas-sarono al contrattacco spontaneamente. All’arrivo dell’ordine di ripiega-mento l’ala sinistra continuava a reggere, ma la destra incontrava gravi dif-ficoltà. Solo dopo una serie di manovre (sempre ostacolate dal nemico)Giovanetti riuscì ad aprirsi la strada su Marcaría, sull’altra sponda dell’Oglio,ma aveva perso circa la metà dei suoi uomini. A fine giornata il contingente toscano e napoletano, che aveva impegnato5400 uomini, contava 166 morti (tra cui il professore Leopoldo Pilla, esi-mio geologo che aveva guidato i suoi studenti in battaglia), 518 feriti (ripor-tò una ferita anche il De Laugier nel tentativo di impedire alla cavalleriatoscana di ritirarsi)21, 1178 prigionieri (tra cui Giuseppe Montanelli, che fuferito e catturato insieme all’amico massetano Giovanni Morandini, chenon volle abbandonarlo)22 e 4 cannoni distrutti. Gli Austriaci invece conta-vano 95 morti, 516 feriti e 178 dispersi23. Il contingente toscano affrontò ancora gli Austriaci a Sommacampagna e,nonostante l’idea di De Laugier di inglobare nei ranghi piemontesi le trup-pe toscane (per la precisione nella divisione Boyl che si trovava con le trup-pe toscane presso Villafranca), iniziò la ritirata verso la Lunigiana e i confi-ni del Granducato. Militarmente il ripiegamento di Curtatone e Montanara era stato un succes-so e la resistenza fu tenace e significativa anche dal punto di vista politico.Il generale austriaco Schoenhals scrisse: “contro ogni operazione i Toscanifecero testa … , si difesero con gran valore”. Ma indicativi furono anchealtri due dati di fatto. La storiografia recente ha giustamente ridimensionato il ruolo delle truppevolontarie, comprese quelle universitarie e civiche toscane (ovviamente malequipaggiate e mal comandate), e rivalutato il ruolo delle truppe napoleta-ne24 e abruzzesi, che in effetti diedero una grande prova25.
190
Truppe di volontari, bande irregolari e guardie civiche furono spesso pro-tagoniste degli eventi risorgimentali26, ma raramente furono schierate in col-laborazione con truppe regolari. A Curtatone e Montanara, al fianco deidue reggimenti (piuttosto minuti) di fanteria, di uno squadrone di cavaliericomposto da soli 100 cavalli e di una batteria d’artiglieria, furono schieratele unità della Guardia Civica provenienti da differenti comunità toscane. Lacombinazione fu ben sfruttata, contribuendo non poco alla resistenza ita-liana (e in effetti anche il Regno di Sardegna aveva fondato poco tempoprima una Guardia Civica27). Una combinazione che il generale D’ArcoFerrari avrebbe voluto sfruttare anche con l’esercito pontificio, chiedendol’invio di contingenti della Guardia Civica romana, che però gli furononegati. Il secondo dato di fatto fu che le autorità militari e politiche tosca-ne ebbero dall’intera vicenda la convinzione dell’incapacità piemontese direggere il comando di un contingente militare eterogeneo composto datruppe alleate e, soprattutto, registravano il pregiudizio piemontese verso letruppe civiche e volontarie. Infatti Leopoldo II, non appena si rese contodella volontà espansionistica sabauda a scapito degli altri governi, decise dirichiamare le truppe. Il 17 agosto il Granduca fu costretto a sciogliere il governo moderato delRidolfi in favore del Capponi. Quest’ultimo, in seguito ai tumulti diLivorno scoppiati il 25 agosto, dovette rassegnare le dimissioni il 9 ottobrein favore di un governo guidato dal Montanelli, che volle il Guerrazzi, guidapolitica dei moti livornesi, come ministro degli interni. Ma la svolta “ultrademocratica”, come si disse all’epoca, non si fermò. Il 30gennaio 1849 Leopoldo II si trovò obbligato ad abbandonare Firenze, nonprima di aver firmato il decreto per la costituente, rifugiandosi prima aSiena e poi tentando di mettersi in salvo fuori dai confini granducali. Ilgoverno di Montanelli instaurava la repubblica il 15 febbraio, ma LeopoldoII, ospitato su una nave da guerra inglese a Porto Santo Stefano, prima diabbandonare lo Stato, in accordo con Carlo Alberto, tentò di ripristinare lapropria autorità: ordinava al De Laugier di raggiungere Sarzana e mettersiagli ordini di La Marmora per marciare su Firenze28. A Firenze si temeva l’attacco, e alla difesa della città accorsero volontari daogni comunità toscana, anche le più piccole, compresi gli uomini delle varieGuardie Civiche29; proprio in questa occasione fu ordinato ai “civici” di rac-cogliere ogni arma funzionante e in esubero, anche di proprietà privata,all’interno dei depositi comunali per poterle distribuire alla popolazione incaso di grave necessità (che evidentemente si prevedeva). Molto cautamente Carlo Alberto decideva che solo il generale toscanoavrebbe dovuto compiere la marcia e quindi ordinò a La Marmora di nonseguire il De Laugier. Ma dopo un ripensamento Leopoldo II ordinò algenerale di attestarsi a Lucca e tentare di mantenere nei ranghi le truppeancora fedeli. Da Firenze il Guerrazzi si recava personalmente a Lucca, conuna colonna di soldati comandati dal generale D’Apice. Nel frattempo ledefezioni e le diserzioni avevano notevolmente ridimensionato le truppe alcomando del De Laugier. Quando le truppe granducali si trovarono di fronte alle milizie repubblica-ne (in gran parte formate dalla Guardia Civica) i pochi soldati ancora fede-li al Granduca si rifiutarono di combattere e De Laugier, che rischiò l’arre-sto, dovette tornare presso La Marmora. Fallito il tentativo, Leopoldo trovòrifugio a Gaeta, sotto la protezione del re delle Due Sicilie. Dopo la definitiva sconfitta di Carlo Alberto a Novara i moderati toscanisperavano che sarebbe bastato rovesciare il governo Guerrazzi per nonavere ripercussioni da parte dell’Austria. Quindi richiamarono in patria ilGranduca, anche con la speranza che attuasse le riforme. Ma la realtà andòdiversamente. L’Austria intervenne con un contingente di 18000 uominiche occuparono la Toscana (i fatti più drammatici si ebbero a Livorno, chefu completamente e ferocemente saccheggiata su ordine del feldmarescial-lo Costantino d’Aspre30). Lo stesso Leopoldo II sbarcò a Viareggio in divi-sa da generale asburgico e scortato da truppe austriache e cavalleria unghe-rese, segno evidente della rottura del Granduca con le politiche liberali. Inun primo momento tentò di riconciliarsi con i liberali, emanando un’amni-stia e ponendo una targa in memoria dei caduti toscani nella prima guerrad’indipendenza, e ripristinò l’autorità Granducale attraverso un plebiscito.Ma i provvedimenti presi in seguito, forse su pressione di Vienna, dimostra-rono nei fatti la svolta autoritaria: tra il 1851 e il 1852 fu ripristinata per
alcuni reati la pena di morte (fatto inaccettabile per i Toscani, poiché l’abo-lizione, voluta da Pietro Leopoldo, era stata il primo provvedimento aboli-zionista al mondo e solo dopo ciò i Toscani si erano sentiti politicamenteuniti tra loro, superando campanilismi secolari31), fu abolito lo Statuto e conesso la Guardia Civica e fu nominato ministro della guerra il controversoDe Laugier. Si chiudeva così l’avventura della Guardia Civica, che in alcune città, comeSiena, si trasformava in Guardia Municipale. Ma in generale era andatadisgregandosi già prima della sua abolizione ufficiale: dal ritorno delGranduca l’autorità della Guardia Civica andava via via diminuendo e i suoimembri rassegnavano, uno a uno, le proprie dimissioni. I volontari toscani,però, continuarono a partecipare ad azioni politiche e militari delRisorgimento. Il contributo toscano alla causa unitaria fu notevole anche negli anni a veni-re. Solo a titolo d’esempio tra i numerosi eventi che si potrebbero citare,ricordiamo il corpo di spedizione toscano nella Seconda Guerrad’Indipendenza32; l’affetto dei Toscani verso Garibaldi33; la massiccia pre-senza di volontari toscani tra i Cacciatori delle Alpi e tra i Mille34; nella cam-pagna del 1866, a seguire il Generale come volontari, vi furono tra gli altritoscani Frederick Stibbert e Stefano Bardini, due tra i più significativi colle-zionisti d’armi antiche del XIX secolo. Un piccolo episodio significativo delsentimento unitario e anticlericale toscano si registra con i fatti dell’ottobre1867: un contingente di circa 250 uomini della colonna garibaldinaGuerrazzi, proveniente dalle comunità nei dintorni di Massa Marittima,sulle Colline Metallifere, tentò l’invasione dello Stato Pontificio nella zonadi Montalto di Castro, ovviamente fallendo35. Il secondo presidente del con-siglio dell’Italia unita fu proprio uno dei Toscani che più si erano profusiper l’unità nazionale, Bettino Ricasoli36, promotore del plebiscito nel qualei Toscani all’unanimità espressero la volontà di divenire sudditi del regno diVittorio Emanuele II37. Firenze stessa, dal 1865 al 1871, fu la seconda capi-tale del neo Regno d’Italia.
Organizzazione della Guardia Civica Per l’organizzazione della Guardia Civica fu emanato, il 15 settembre 1847,un primo regolamento composto da cinque capitoli38 a cui seguirono altridue regolamenti provvisori39 in attesa di quello definitivo, che però non fumai redatto poiché l’istituzione fu abolita prima della stesura. In tutti i rego-lamenti l’articolo 1 recitava “lo scopo della Guardia Civica è difendere ilLegittimo Sovrano, l’indipendenza e l’integrità dello Stato, di garantire l’ob-bedienza alle leggi, di conservare o ristabilire l’ordine e la pubblica tranquil-lità, coadiuvando, quando necessario, l’esercito regolare”. Nello Statuto del1847, l’articolo 10 recitava: “La Guardia civica è mantenuta istituzione delloStato a norma della legge organica”, mentre nell’articolo 78 veniva decreta-to che “Il presente Statuto fondamentale, e tutti i diritti e poteri da esso san-citi, sono affidati alla lealtà, al patriottismo, al coraggio della guardia civica,e di tutti i cittadini toscani”. Gli statuti regolamentavano ogni aspetto della Guardia Civica. In essa pote-vano entrare tutti i cittadini compresi fra i 18 e i 60 anni, residenti nelGranducato e aventi lo status di contribuenti in quanto proprietari terrieri oesercenti di attività commerciali e professionali, costituendo la Guardia atti-va. Ne erano esclusi gli ecclesiastici, i militari di carriera, i funzionari pub-blici e i magistrati. Braccianti, operai giornalieri, domestici, coloni e quantialtri non potevano essere distolti dal proprio lavoro, furono invece inclusinei quadri della Riserva40, da richiamare in servizio in caso di particolarinecessità. Ma nel novembre 1847 il governo di Firenze sentì la necessità diaumentare la propria forza armata con quattro nuove Compagnie. Il 25novembre fu emanato il bando di arruolamento41, ma pochi giovani si pre-sentarono agli uffici di leva, tanto che il 29 dicembre la Segreteria di Guerraemanò una circolare nella quale, in via eccezionale, venne comunicato che,per i giovani che si sarebbero offerti volontari entro fine del gennaio 1849,il servizio sarebbe stato limitato a soli tre anni anziché sei e sarebbero stateconcesse immediatamente, a titolo d’indennità, 60 lire a ogni volontario42.Probabilmente a causa della scarsità di nuove reclute vennero integrate, trail novembre e il dicembre 1847, le disposizioni che precludevano l’ingressonella Guardia Civica attiva alcune categorie sociali. Il 6 novembre vennechiarito l’articolo 8 dello statuto emanato il giorno precedente, che proibi-
191
va l’ingresso nella Guardia Civica ai cittadini condannati per decreto pena-le o decreto economico43. Il 18 novembre fu concesso di poter entrare a farparte della Guardia Civica a numerose categorie di ufficiali e funzionaripubblici, che nei regolamenti precedenti erano esonerate dal farne parte,purché i giorni di servizio siano conciliabili con la loro funzione pubblica44.L’1 dicembre venne introdotto per la Guardia Civica il diritto di “obiezio-ne di coscienza” per i cittadini di fede non cattolica (in particolare a bene-ficio dei protestanti), qualora ne volessero usufruire; inoltre venne stabilitoche i comandanti dovessero concedere giorni di licenza ai membri dellaGuardia Civica non di fede cattolica, in occasione delle loro festività religio-se45. Il giorno successivo venne concesso anche ai contadini di entrare neiranghi della GC, ma per evitare che abbandonino i lavori nei campi duran-te i mesi di raccolto, non sarebbero entrati nella Guardia Civica attiva manella Riserva46. Mentre il 10 dicembre venne stabilito che gli stranieri resi-denti nel Granducato da alcuni anni, che volessero entrare nella GuardiaCivica, sarebbero stati esonerati dal prestare il giuramento di fedeltà, ondeevitare che la loro posizione non andasse contro la fedeltà e i doveri dovu-ti alla propria Nazione di origine47. Il 17 dicembre venne decretato che nellaGuardia Civica dovessero entrare anche chirurghi, medici e infermieri, cheavrebbero avuto direttamente i gradi di ufficiali e sarebbero entrati imme-diatamente in servizio come ufficiali medici48: a seguito dell’ingresso nellaGuardia Civica attiva dei medici, il 29 gennaio del 1848, fu emanato unnuovo regolamento sanitario militare, che sostituì il precedente, emanato il12 marzo 1836. Il 27 febbraio venne stabilito che avrebbero potuto ricopri-re gratuitamente i gradi di Sergente Maggiore e Furiere i membri dellaGuardia Civica che ne avrebbero fatto richiesta e che costoro avrebberodovuto portare un segno distintivo a indicazione del grado “onorifico”49;mentre il 5 marzo fu notificato che gli uomini della Riserva avrebbero potu-to, tramite richiesta, entrare nei ruoli della Guardia Civica attiva50. Il 2marzo, in attesa di un regolamento definitivo, fu stabilito che gli impiegatipubblici non potessero far parte della Guardia Civica, a meno che non siaconciliabile con il proprio lavoro, poiché il servizio volontario li avrebbeprivati di stipendio, mentre quello remunerato ne avrebbe conferito lorouno doppio51. L’8 marzo 1848 fu istituita la Guardia Civica volontaria, conapposito regolamento provvisorio composto da sei capitoli, che fu in vigo-re durante la guerra contro l’Austria. In questo corpo entrarono tutti i cit-tadini che, pur non facendo parte della Guardia Civica attiva né dellaRiserva, vollero battersi per l’indipendenza d’Italia52. Poiché la Guardia Civica si era dimostrata l’istituzione migliore per garanti-re l’ordine pubblico e la pacifica attuazione delle riforme intraprese tra il1847 e il 1848, il governo ne volle urgentemente aumentare il numero deglieffettivi in ogni comunità53, ma ancora a febbraio l’istituzione non era dota-ta di un regolamento definitivo. La crisi politica, sia interna sia estera, face-va presagire una mobilitazione militare, tanto che il 10 febbraio, per ovvia-re ad alcune lacune statutarie, furono emanate una serie di regolamentazio-ni per la mobilitazione dei civici fuori dai confini granducali, le quali sostan-zialmente prevedevano che gli uomini delle comunità dipendessero in tuttodall’esercito54, come stabilito anche all’articolo 49 del regolamento del 9marzo 1848, anche se sarebbero stati comandati direttamente dai propriufficiali, come decretato dalla notificazione del 2 marzo precedente. La Guardia, organizzata in battaglioni, compagnie e sezioni di compagnia55,era amministrata dai diversi Comuni, su cui gravarono anche le spese diacquartieramento e di gestione, e sotto l’aspetto organizzativo e militaredipendeva dal Ministero dell’Interno e dalle autorità locali. Gli ufficialisuperiori e i comandanti di battaglione erano nominati dal sovrano, chedesignava anche i comandanti di compagnia e gli ufficiali subalterni, sce-gliendoli da terne di nomi espresse dalle stesse compagnie. I comandanti dibattaglione sceglievano, sempre da terne di nomi, i sottufficiali. OgniBattaglione sarebbe stato composto al massimo da 1600 uomini, mentre leCompagnie non avrebbero dovuto superare il numero di 200 soldati. Neicasi in cui si fossero presentati degli esuberi, questi sarebbero dovuti esse-re suddivisi tra i Battaglioni e le Compagnie già formate e, qualora se nepresentasse la necessità, sarebbero stati eletti nuovi ufficiali56.Per la formazione dei ruoli della Guardia Civica, sia della Guardia attiva siadella Riserva, in ogni comunità esisteva una Deputazione di arruolamentopresieduta dal gonfaloniere. Presso tutti gli Uffici comunali vennero aperti
192
112-115 - Interno della chiesa di S. Bernardo, le statue delle sante: Sant’Agnese poliziana,
dei registri dove i cittadini tenuti a far parte della Guardia avrebbero prov-veduto a far iscrivere i loro nomi e le loro generalità, mentre le Deputazioni,dopo aver verificato l’idoneità e i requisiti degli iscritti, provvedevano a for-mare i ruoli generali e quelli delle compagnie. I registri sarebbero statiaggiornati entro il mese di gennaio di ciascun anno, iscrivendovi i giovaniche avessero Compiuto i diciotto anni e cancellandone coloro che avesserosuperato i sessanta. Con apposito regolamento del 4 ottobre fu prevista l’istituzione, pressoogni battaglione, di un Consiglio di Revisione, competente a giudicare suireclami avanzati in materia di arruolamento. Il consiglio era composto permetà da ufficiali e sottufficiali e per metà da caporali e guardie. Una voltadefiniti l’arruolamento annuale e la distribuzione dei contingenti inCompagnie, si procedeva alla distribuzione delle armi, che le guardie con-servavano personalmente presso la propria abitazione. Per lo svolgimento dei servizi di guardia i sergenti compilavano appositiRuoli di Compagnia, indicandovi i giorni in cui le singole guardie eranostate impiegate. A livello di battaglione l’Aiutante Maggiore teneva un ruologenerale contenente i dati complessivi del servizio giornaliero prestato.Sempre a norma del regolamento generale fu istituito presso i battaglioniun Consiglio di Amministrazione, presieduto dal comandante e compostoper metà da sottufficiali, con il compito di controllare le spese e di appron-tare il conto consuntivo dell’anno decorso e il bilancio di previsione di quel-lo successivo. Alcune cariche percepivano una remunerazione mensile adiscrezione di ogni singola comunità, ma stabilita all’interno di soglie mini-me e massime fissate da un decreto granducale del 24 ottobre 184757. Eraprevisto per i Battaglioni che l’Aiutante Maggiore con il grado di Capitanopotesse percepire da lire 100 a 150; il Quartier Mastro con il grado diTenente da 60 a 80 lire; il Caporale Tamburo da 15 a 30 lire; l’Armaiolo da15 a 25 lire. Invece nelle Compagnie il Sergente Maggiore poteva percepireda 2 a 40 lire; il Furiere da 15 a 30 lire; ciascun Tamburo da 10 a 20 lire.Gli statuti regolamentavano attentamente anche gli aspetti disciplinari. Adesempio per l’erogazione delle sanzioni superiori a quelle ordinarie commi-nate dai vari capiposto alle guardie (per assenze dal servizio) e dai coman-danti delle Compagnie agli ufficiali fu istituito presso ogni battaglione unConsiglio di Disciplina. I Consigli, composti dal comandante di battaglio-ne, da un capitano, da un tenente, da un sergente, da un caporale e da dueguardie, erano competenti ad applicare l’ammonizione semplice o pubblicaagli ufficiali, gli arresti e il carcere per più di 2 giorni agli stessi ufficiali, laprigione per i sottufficiali, i caporali e le guardie e, in casi estremi di recidi-va, la privazione del grado. Per la guerra contro l’Austria fu stabilito che dovesse essere mobilitata solouna parte della Guardia Civica, mentre l’altra sarebbe rimasta a difendere laPatria, come previsto dallo statuto58. Il 3 aprile furono emanate disposizio-ni militari dal Granduca (7 articoli in totale), il cui articolo 1 prevedeva chetutti i volontari sarebbero stati sottoposti all’autorità militare e, all’articolo4, venne ribadito che le pene corporali erano bandite dall’esercito e che que-ste dovessero essere commutate in giorni di reclusione59. Ma per la campagna in Lombardia evidentemente gli effettivi non eranoritenuti sufficienti e il governo tentò di aumentare il numero dei soldatiemanando un provvedimento di 14 articoli60 in cui si stabiliva, tra le altrecose, che fosse necessario aumentare di 2000 uomini l’esercito richiamandoalla leva coloro che avrebbero dovuto prestare servizio militare nel 1849;tutti i nati nel 1829, anche se esentati dal servizio militare, avrebbero dovu-to presentarsi alle rispettive Cancellerie delle Comunità (agli articoli 4 e 5sono elencate le pene per i renitenti)61; i “cresciuti” degli Spedali deiGettatelli avrebbero dovuto comunicare alla Direzione dell’Arruolamentomilitare i nomi degli orfani che avrebbero dovuto essere richiamati nel1849. Inoltre venne stabilito, su suggerimento del Ministro dell’Interno, chea ogni Battaglione della Guardia Civica, privo di ufficiale medico, ne saràdestinato uno dalla Guardia della comunità limitrofa che ne avesse in forzapiù d’uno62. A questo provvedimento seguirono nuove disposizioni in mate-ria di sanità militare, a integrazione delle precedenti.In generale, l’attività della Guardia Civica si dimostrò molto carente, soprat-tutto nell’intervenire nelle baruffe campaniliste tra comunità confinanti63, ela sua importanza diminuì anche in conseguenza dell’istituzione nel 1849della Guardia Municipale Toscana, un organismo completamente dipen-
dente dal Ministero dell’Interno, a cui vennero affidati compiti di poliziaamministrativa, di polizia municipale e di polizia giudiziaria. Le funzioni della Guardia Civica furono rivalutate dal governo provvisoriotoscano che, con il provvedimento del 13 febbraio 1849, la trasformò inGuardia Nazionale, privilegiando gli aspetti della mobilitazione dei compo-nenti ai fini della partecipazione alla guerra contro l’Austria. La Guardia fudichiarata mobile (cioè mobilizzata obbligatoriamente) e vi furono compre-si tutti i soggetti non esclusi dal regolamento del 1847, costituendo unaGuardia Stanziale con gli ammogliati, i figli unici, i contadini che nonlasciassero sulla terra almeno due braccia da lavoro e altri soggetti per i qualiera stato deciso che non potessero essere allontanati dal proprio lavoro. A Siena, per esempio, la Guardia Civica fu istituita nel 1847 per volontà delgonfaloniere della città, il signor Clemintini, a seguito di un regolare bando.Qui fu creato un Battaglione comandato dal tenente colonnello AlessandroSaracini e interamente formato da volontari. Questi, che fuori dalle ore diservizio potevano svolgere qualunque attività (fuorché quelle previste dalregolamento), venivano richiamati a turno quando ve n’era bisogno. Il bat-taglione era formato da tre Compagnie, una delle quali prestava serviziofisso presso il Palazzo Pubblico. Qui, nonostante fossero tutti volontari, lepaghe mensili prevedevano che l’Aiutante Maggiore dovesse ricevere 140lire; il Quartier Mastro 70; l’Aiutante Sottoufficiale 60; il Capitan Tamburo22,10; l’Armaiolo 20; il Sergente Maggiore 30; il Furiere 22,10 e ogni tam-burino 15. Inoltre il comune forniva armi e divise ai membri della Guardiameno abbienti, in pratica a coloro che non erano in grado di pagarsi la divi-sa e procurarsi un’arma adeguata. Nel 1847 il magistrato del comune diSiena stanziò per la Guardia 7000 lire, di cui 2500 destinate all’acquisto difucili e 4500 per le divise. L’anno successivo il comune spese per la GuardiaCivica un totale di 13035,75 lire. La Guardia Civica Universitaria, invece, era formata da classi intere di stu-denti, comandate dai professori. C’erano dei battaglioni mobilitati con loscopo esclusivo di affiancare l’esercito regolare. Ma questo tipo di organiz-zazione non rendeva certo questa milizia efficiente e disciplinata. Nei giorni della guerra contro l’Austria fu istituito un servizio di posta permilitari regolari, Guardia Civica e volontari, il cui bollo era un cuore coninscritto “Firenze 6”64. Le truppe godevano di totale franchigia: per laCuardia Civica il bollo di franchigia era triangolare con spade incrociate alcentro con la scritta “Guardia Civica di Cast. N° di S°” in verde brunastro.Addirittura, in prossimità delle elezioni politiche in Toscana, il governo diFirenze stabilì che i militi, impegnati nelle operazioni in Lombardia, potes-sero usufruire del diritto di voto presentando scheda elettorale presso i pro-pri acquartieramenti65. Il 15 marzo del 1849 si procedette alla riorganizza-zione della Guardia Civica a Pisa, Lucca, Viareggio, Camaiore, Pescia,Pistoia, Siena, Arezzo, Cortona e Volterra, anche se in alcune comunità giànel luglio del 1848 venivano affissi cartelli infamanti nei confronti deiCivici. Per le vie di Pistoia, all’alba del 16 luglio 1848, furono trovati appe-si ai muri cittadini cartelli con disegnati dei pugnali insanguinati e la scritta“Stilettate e morte alla Guardia Civica e ai signori”66. Il 17 aprile il Comando Generale della Guardia, nel tentativo di difendere ilgoverno provvisorio dopo la disfatta piemontese, emanò addirittura un pro-clama perché gli elementi stanziali della guardia consegnassero le armi ineccedenza per utilità dei reparti mobilitati a difesa del territorio toscano.Con la restaurazione del Granduca e la fine del governo provvisorio laGuardia cadde dovunque in abbandono poiché la sua autorità si era defini-tivamente sfaldata. Di lì a breve, con un provvedimento del 23 ottobre 1851,ne fu sancita ufficialmente la soppressione su tutto il territorio dello Stato.
Uniformi, armi ed equipaggiamentoPer la Guardia Civica era prevista un’uniformità nelle divise, nell’equipag-giamento e nelle armi. Il 28 ottobre 1847 venne stabilito che ogni repartodella Guardia Civica sia dotato di bandiera. In ognuna doveva campeggiarelo stemma della comunità stessa67. Al Capitolo 3 del regolamento del 15 settembre 1847 è decretato che siaprevista un uniforme uguale per tutti i membri della Guardia Civica, masaranno obbligati a indossarla solo i civici residenti a Firenze, Pisa, Pistoia,Siena, Arezzo e Livorno. I gradi saranno identici a quelli della truppa dilinea, ma dal 27 febbraio 1848, secondo la disposizione N. 484, i Sergenti
193
Maggiori e i Furieri, che ricoprono gratuitamente tale grado, dovrannoindossare un segno distintivo. Lo Statuto Organico del 4 ottobre 1847 sta-biliva che l’uniforme dovesse essere a acquistata da ogni singolo milite men-tre l’armamento sarà a carico dello stato. Nelle comunità in cui non vi èobbligo di uniforme sarà indossato il simbolo con i colori della GuardiaCivica, come indicato nel motuproprio del 24 settembre 1847. Quindi, secon-do le disposizione del 1847, una buona percentuale di civici non era dotatadi uniforme, ma i regolamenti dell’anno successivo conterranno disposizio-ni più precise. Il regolamento del 9 marzo 1848, che suddivide i militi dellaGuardia Civica in fucilieri e in bersaglieri o volteggiatori, al Capitolo V sta-bilisce in modo dettagliato la divisa e i capi di ricambio che ogni milite deveavere con sé durante la mobilitazione. Mentre il Capitolo IV è dedicatoall’uniforme e all’equipaggiamento: all’articolo 46 è stabilito che per ognicampagna militare i Civici potranno aggiungere alla manica una lista in gal-lone di lana amaranto, detta “scevrone”. In ogni manica potranno essereaggiunti fino a tre galloni, partendo dal braccio sinistro. I bersaglieri alposto dell’elmetto porteranno un cappello di feltro nero simile a quello deibersaglieri piemontesi.L’ultimo regolamento, del 1 maggio 1848, redatto seguendo la necessità didotare tutti gli uomini di una divisa poco costosa per la guerra inLombardia, all’articolo 3 stabiliva che l’uniforme dovesse essere obbligato-ria per tutti i mobilitati. Se le uniformi dell’esercito regolare erano ispirate alla moda militareaustriaca68, le divise della Guardia Civica erano simili a quelle della GuardiaCivica pontificia, modello in quasi tutto per quella toscana. La somiglianza maggiore tra l’uniforme della Guardia Civica toscana e quel-la pontifica (comune del resto a un po’ tutte le guardie civiche degli Statipreunitari, che proprio a quella pontificia si rifacevano) è l’elmetto chioda-to. Quello toscano in cuoio nero, con il sottogola a scaglie dorate, placcametallica in fronte con scritto “Leopoldo II” e chiodo sfaccettato alla cuisommità vi era un crine di cavallo (in alcuni esemplari attualmente conser-vati il crine è sostituito da una sfera metallica). Nel regolamento del 1 mag-gio viene introdotto anche un altro cappello in feltro bigio con striscia dipelle nera e fibbia in ottone, con tesa sul lato sinistro “formata in modo dapoter in servizio essere alzata fino a contatto con del cocuzzolo per mezzod’un bottone, con coccarda formata al punto d’attacco con piccolo laccet-to d’ottone, con pennacchi composto d’un mazzo di penne di cappone dicolor naturale”. La divisa era costituita da una casacca lunga fino al ginoc-chio, pantaloni blu scuro e ghette di vitello nero patinato. Bavero, polsini ebande laterali dei pantaloni erano amaranto. Le spalline erano dorate concordelline in filato amaranto per la truppa e dorato per gli ufficiali. Questiultimi intorno alla vita portavano una fusciacca dorata, che durante la PrimaGuerra d’Indipendenza fu sostituita da una tricolore (figura 1). Il 28 otto-bre dell’anno precedente era stato deciso che nei bottoni delle divise (allacui fabbricazione avrebbe soprinteso il General Comando della GuardiaCivica di Firenze) dovesse esserci la scritta GUARDIA CIVICA TOSCA-NA69. Gli uomini chiamati alla mobilitazione possedevano un sacco di pelleda portare a spalla. Tuttavia i capi di vestiario dovevano essere in larga partecivili: basandosi sui documenti conservati nell’archivio storico diMontepulciano, oggi facente parte della Biblioteca Civica, possiamo dedur-re che almeno parte del vestiario fosse commissionato dalla comunità diret-tamente agli artigiani locali70.La Guardia Civica Universitaria portava sul copricapo (un chepì rigido o unbonnet) e sulla casacca azzurrina le iniziali GU (Guardia Universitaria). Altristudenti indossavano come copricapo la feluca universitaria71. Molti porta-vano un camicione millerighe. Un’idea generale su come si presentavano materialmente i militi dellaGuardia Civica la forniscono i disegni realizzati tra gli anni settanta e ottan-ta da Quinto Cenni72, che si basava su una corrispondenza con i reduci diCurtatone e Montanara, e le tavole dell’opera del colonnello NiccolòGiorgetti73. Fonte molto utile è anche un manuale edito nel 1847 e destina-to a far conoscere ai giovani la Guardia Civica, corredato da figurini di uni-formi74.L’equipaggiamento era mutuato dall’esercito regolare: nel 1816 ilGranducato commissionò alla ditta fondata dalla coppia di soci Paris eFranzini, armaioli di Gardone Val Trompia, 3000 fucili, 5000 paia di pisto-le e 1080 sciabole, che in seguito furono impiegate dalla Guardia Civica75.
Per gli armamenti non vi era un’omologazione vera e propria, ma indicazio-ni di massima.Il regolamento del 15 settembre 1847, al Capitolo 3, stabiliva che le armidestinate alla Guardia Civica, a prescindere dalla provenienza, saranno sem-pre di proprietà del governo, inventariate e custodite da un Rappresentantela Comunità. Nelle comunità rurali le armi saranno custodite sotto laresponsabilità del Comandante della Compagnia locale, mentre nelle città ildeposito sarà stabilito e approvato da un’apposita commissione. Mentre loStatuto Organico stabiliva che, una volta distribuite le armi per ordined’iscrizione sui Registri di Arruolamento, queste sarebbero state custodite emantenute da ogni singolo milite nella propria abitazione. Lo Statuto con-sentiva a ogni uomo, qualora l’avesse desiderato, di provvedere personal-mente al proprio armamento, purché si attenesse alle disposizioni generaliin materia. Inoltre consentiva alla Guardia Civica, laddove se ne presentas-se l’occasione, di essere dotata di cannoni con i quali creare Compagnie diArtiglieria, a patto che queste fossero comandate da ingegneri, matematicie tecnici delle arti meccaniche. Il regolamento sintetico del novembre 1847 chiariva, all’articolo 7, che unavolta stabiliti i luoghi per istruire i volontari all’uso delle armi, che fino aquel momento erano conservate nelle scuole private, queste dovranno esse-re consegnate ai comandanti e agli ufficiali della Riserva. L’articolo 11 sta-biliva provvisoriamente che il Gonfaloniere di ogni comunità dovesse ren-dere conto: delle armi in dotazione ai militi civici entro novembre; di tuttele armi giunte alla Guardia Civica, a qualunque titolo (acquistate dallacomunità, inviate dal governo, donate o acquistate dai singoli uomini); dellearmi comprate per uso specifico della Guardia Civica; del numero di armiche la comunità fosse disposta ad acquistare a proprie spese. Mentre l’arti-colo 15 disponeva che, per facilitare l’acquisto di armi da destinare alle mili-zie civiche, le varie comunità sarebbero state esentate dal pagamento di ognigabella.Il regolamento del 9 marzo 1848 è un po’ meno ambiguo sui modelli diarmi da fuoco da adottare: i fucili sarebbero dovuti essere del modelloapprovato; inoltre dovranno portare sempre con esso uno spillo da foconeda appendere alla bottoniera, il cinturone con il fodero per la baionetta e lagiberna. Mentre i bersaglieri avrebbero avuto una carabina a canna rigata esciabola-baionetta. Per costoro era provvisoriamente consentito l’uso delfucile da volteggiatori; differentemente dai fucilieri, i bersaglieri porterannoanche una fiasca da polvere. I Tamburi porteranno un tamburo in ottonecon i colori dello Stato, mentre i volteggiatori avranno i Trombettieri dota-ti di una cornetta.I fucili potevano essere di differente provenienza76, così come le baionette.Una circolare del 17 febbraio 1848 afferma che il Governo aveva acquista-to appositamente per la Guardia Civica un grande numero, non precisato,di fucili commissionati in Francia77. Per la truppa l’arma bianca principale era una sciabola del tipo del briquetmodello 1814 (alle quali saranno aggiunti negli anni Quaranta i modelli1834, decisamente più leggeri e adatti alla fanteria), in dotazione ancheall’esercito regolare, soprattutto ai granatieri. Al fornimento era fissata unadragona rossa. Questa è una peculiarità della Guardia Civica granducale inquanto tutte le altre guardie civiche, compresa quella pontificia, adottaronole daghe78. Anche nel Granducato i briquet, come chiarito al Capitolo IV delregolamento del 9 marzo 1848, sarebbero dovuti essere sostituiti dalledaghe, ma l’istituzione fu abolita prima che queste fossero prodotte. In generale i modelli di briquet toscani, rispetto a quelli in dotazione all’eser-cito sardo, erano più piccoli e presentavano quasi sempre “una scanalaturaparallela al dorso della lama per circa due terzi della lunghezza, sui due lati.La cappa del fodero è in genere munita di gancio di sospensione, ma siincontrano anche versioni col bottone ovale”79, e molti esemplari recano leiniziali GC (Guardia Civica), ma più spesso riportano una varietà di marchiche indicano il produttore (spesso lombardo)80. Gli ufficiali invece, come stabilito nel regolamento del 9 marzo, furonodotati di sciabola all’ussara con fodero in metallo, mentre durante le cam-pagne militari sarebbero stati dotati di cinturone con due pistole a percus-sione; i sottufficiali possedevano una spada o una sciabola. Le armi bianchedei graduati a volte sono riconoscibili perché recano incisi motti come“Viva Pio IX”81.
194
La Guardia Civica di Montepulciano: organizzazione e armamentoNegli archivi comunali delle città e dei paesi toscani, che istituirono laGuardia Civica, è conservata la documentazione prodotta dai consiglicomunali. Di norma negli archivi si trova una serie di atti riuniti in ordinecronologico, più raramente organizzati in serie. Questi comprendono: Attidella deputazione; Registri degli appartenenti alla Guardia Civica; Ruoli atti-vi e della riserva; Atti del consiglio di revisione; Atti del consiglio di ammi-nistrazione; Atti del consiglio di disciplina. A Montepulciano i documenti relativi alla fondazione e gestione dellaGuardia Civica si possono reperire in alcuni registri di DeliberazioniPreunitarie82, nonché in uno specifico repertorio delle deliberazioni che lecomunità locali sede di compagnia erano obbligate a tenere83. Qui sonoconservate tutte le delibere e le spese sostenute dal Comune per la localeGuardia Civica. Ulteriori indicazioni, valide per tutto il territorioGranducale, si possono infine desumere dalle raccolte di leggi e proclami,conservate sempre nell’Archivio Storico presso la Biblioteca Comunale diMontepulciano84. Il 9 luglio 1847 la comunità di Montepulciano faceva formale richiesta algoverno di Firenze per la creazione della propria Guardia Civica85. Il 30 set-tembre vi furono i festeggiamenti per l’avvenuta istituzione: il Palazzocomunale, il Tribunale Collegiale, il Commissariato, la casa dell’Ispettore dipolizia e la caserma dei Carabinieri furono illuminate tutta la notte86 e furo-no ospitati i rappresentanti di Firenze, Siena, Arezzo e Cortona, con cui cifu lo scambio delle bandiere comunali87.Il denaro per le spese ordinarie, come l’olio per le lampade, era anticipatoda facoltosi cittadini, in seguito rimborsati dal comune88; per la stampa degliavvisi della Guardia Civica veniva pagato il tipografo locale Angelo Fumi89.Mentre gli stipendi mensili per i graduati furono fissati il 17 dicembre184790. È registrato il pagamento al falegname Ferdinando Bernabei per lerastrelliere per le armi da collocare nella sede della Guardia Civica91, cosìcome previsto all’articolo 54 del regolamento del 4 ottobre 1847. Onerosifurono gli esborsi per le uniformi92, l’equipaggiamento dei tamburini93; quel-li per le per le armi94 e per il trasporto di esse: il 24 maggio del 1849, i gior-ni in cui gli Austriaci del D’Aspre invadevano militarmente Livorno, Pisa eLucca, furono trasportate a Montepulciano, sotto la responsabilità delCapitano della 2ª Compagnia della Guardia Civica, 77 sciabole e relativebuffetterie95. Nel settembre del 1849 (i giorni in cui l’autorità di LeopoldoII veniva restaurata con effimere sfumature liberali) è registrato, invece, iltrasporto di alcune casse di fucili militari della Guardia da Montepulciano aSiena da conservarsi “per l’interesse della comunità stessa” presso il coman-do militare di Siena, come da ordini impartiti dalla Prefettura alGonfaloniere96. Dalla documentazione d’archivio emerge però che le difficoltà maggiorifurono incontrate durante la ricerca degli edifici adatti a ospitare la GuardiaCivica. Il 23 novembre del 1847 il consiglio comunale discusse quali localidestinare alla pattuglia notturna e altri servizi di guardia97; il 24 gennaio del-l’anno successivo furono approvate le spese per il pagamento degli affittidei locali occupati dai civici98 e l’11 febbraio seguente furono destinatiall’istituzione altri edifici99, ma ancora il 25 aprile si discuteva sui problemiderivati dalle spese d’affitto dei locali100. I documenti raramente chiarisconodove si trovassero tali edifici, ma da una delibera del comune, datata 22maggio 1848, sappiamo che la sede del corpo di guardia della GuardiaCivica si trovava al piano terra di una casa, di proprietà del Conte FrancesoVenturi, in Via di S. Bartolomeo nel Corso101. Quando la Guardia Civicaverrà disciolta anche a Montepulciano, il locale di proprietà del Venturidiverrà la sede del corpo di Guardia del Comando di Piazza, precedente-mente situato in un immobile di proprietà della duchessa Carradori102.La Guardia Civica di Montepulciano, il 4 dicembre 1847, era composta dadue Compagnie, per un totale di 391 uomini103, e sembra che i numeri deglieffettivi non siano mutati in modo percepibile nel corso degli anni, poichél’11 febbraio 1848 vengono comunicate dai capitani delle due compagnie inomi dei tamburini104, mentre il giorno 23 dello stesso mese prendono ser-vizio attivo i sergenti neo eletti105. Un’ultima elezione di un SergenteMaggiore nella 1ª Compagnia è registrato il 10 marzo 1849106. Da questadata nei documenti d’archivio non compaiono altre disposizioni riguardan-ti il numero degli uomini e elezioni per i graduati, fatto che suggerisce come
la forza dei civici poliziani non sia sostanzialmente mai mutata, supposizio-ne confermata anche dal registro degli iscritti alla guardia civica107.Militarmente l’area compresa tra Montepulciano, Chiusi e Sarteano era trale più delicate dell’intero Granducato a causa della vicinanza del confinecon lo stato pontificio, soprattutto a partire dal 1848108. In tutte le comuni-tà di questa zona era stata istituita una Guardia Civica, che andava ad affian-care la già notevole presenza di reparti dell’esercito regolare. A Sarteano inparticolare erano stati dislocati anche un reparto di Veliti e uno diArtiglieria109 ed era stato istituito un reparto locale di Cacciatori Volontari110.La località era strategicamente molto importante, al punto che una riunio-ne della Deputazione per la Difesa della Frontiera fu tenuta proprio aSarteano il 10 maggio 1849111, la quale alla fine del mese approvò ilRegolamento della Direzione per la Difesa della Frontiera del CompartoSenese112. A Montepulciano l’aumento di truppe regolari, a difesa del con-fine, iniziò a essere incrementato a partire dal dicembre del 1849: a tale datail Gonfaloniere rilevava l’aumento di truppe in città e la conseguente neces-sità di valutare dove alloggiarle113. Infatti l’acquartieramento era a caricodella comunità locale e anche a Montepulciano sono registrati, oltre che lespese per gli alloggiamenti militari114 e materiale di diversa natura occorren-te a tali alloggi115, pagamenti al fabbro Cesare Benedetti per lavori fatti pres-so la compagnia di linea di stanza in città116, all’incaricato della fattoriadell’Abbadia per la fornitura di paglia per la compagnia di linea117 e altrespese militari, probabilmente conseguenti all’ampliamento della guarnigio-ne118. Dal 14 settembre è documentata la presenza di Cacciatori a Cavallo,data in cui le autorità cittadine stanziano la cifra necessaria per coprire lespese di “accasermamento” dell’unità di cavalleria, come richiesto dal lorocomandante119. Probabilmente furono sempre a beneficio di questo repartole cifre stanziate per le funi delle scuderie con altre spese legate al corpo diguardia e caserme120 e i rimborsi alla fattoria Acquaviva per aver fornitopaglia per la guarnigione121.I carabinieri erano prevalentemente impegnati in operazioni di pubblicasicurezza, soprattutto il pattugliamento delle fiere e dei mercati. Per questicompiti gli effettivi di stanza nei paesi limitrofi venivano accorpati tra loroe durante i giorni di servizio venivano ospitati presso le locande locali122.La Guardia Civica di Montepulciano svolgeva regolarmente le esercitazionia fuoco e quelle ordinarie, come previsto all’articolo 35 dello StatutoOrganico e minuziosamente descritto al Capitolo V delle disposizioni ema-nate il 9 marzo 1848. L’addestramento militare delle reclute fu affidato altenente dei carabinieri Augusto Gori, in seguito promosso al grado di capi-tano, a cui la comunità, riconoscente per il servizio svolto, decise di donareun orologio d’oro con dedica123. Mentre l’addestramento all’uso delle armifu organizzato dal Sergente Francioni, che ottenne una gratifica il 20 set-tembre 1848124. Il comune pagava inoltre una Scuola di Musica ai tamburi-ni125. Le esercitazioni a fuoco dovevano svolgersi con regolarità, poiché il 24ottobre 1849 fu pagato il falegname Luigi Tofanini per aver riparato il ber-saglio da esercitazioni della Guardia Civica126. L’addestramento comportavacomunque un ulteriore incremento delle spese per la comunità; abituare imiliti al tiro comportava un costante consumo di munizioni, come risultada una comunicazione (relativa alla Guardia Civica di Sarteano, che si eser-citava con le armi da fuoco presso la locale Scuola di Tiro e di Bersaglio)datata 11 luglio 1848, in cui si comunica l’invio al comando di compagniadi 312 cartucce a palla, 312 capsule fulminanti e 90 cartucce per fucili a pie-tra focaia, il tutto destinato “per l’istruzione non tanto per la Guardia Civicama anche per la istruzione e Scuola del tiro e del Bersaglio”127. In data 24ottobre 1849 veniva poi approvato il pagamento per la sistemazione deibersagli usati dalle truppe per addestrarsi128.I principali compiti svolti dalla Guardia Civica furono quelli di pubblicasicurezza: il 22 maggio 1848 dodici civici di Montepulciano affiancarono icarabinieri nel pattugliamento della Fiera locale129; il 21 marzo 1849 ilcomando di Piazza di Arezzo scrive al Pretore del Tribunale di Chiusicomunicando che è stato consegnato da due Guardie Civiche di Foranodella Chiana un renitente alla leva di quella comunità130. La Guardia Civicadi Sarteano invece, il 25 luglio 1847, aveva segnalato alle autorità la presen-za nel territorio di quattordici disertori svizzeri, ex soldati pontifici; fu quin-di ordinato al Sergente Maggiore della Guardia Civica locale di procedereall’arresto131.
195
Forse l’evento più significato nel quale fu coinvolta la Guardia Civica diMontepulciano si svolse nel luglio del 1849. Il 18 luglio fu convocata unaseduta straordinaria del Consiglio Comunale a cui presero parte la CivicaMagistratura, il Vescovo, il Sottoprefetto e tre capitani, due tenenti, unSergente Maggiore della Guardia civica132. La riunione iniziò con un rappor-to sugli spostamenti della colonna di armati guidata da Giuseppe Garibaldi,in fuga da Roma. Il Generale e i suoi uomini avevano attraversato il confi-ne pontificio, erano entrati nel Granducato e avevano attraversato Chiusi,Cetona, Sarteano, Chianciano “ove hanno ritirato una forzata contribuzio-ne”, e si dirigevano verso Montepulciano. Quindi la seduta straordinaria erachiamata a stabilire il da farsi quando i garibaldini sarebbero arrivati in città.Molto realisticamente i membri del consiglio considerarono “che la Cittànon ha attualmente mezzi di difesa, né può far resistenza ad una forzasuperiore, e desiderando perciò di dare le più energiche disposizioni perconservare la tranquillità del Paese, prevenire quei disordini che potesseroderivare dalla licenza militare insubordinata, e assicurare la Prosperità, e lePersone dei Cittadini”, fu stabilito che “nel caso si presentassero dei distac-camenti della divisione Garibaldi, anziché opporsi saranno tenute coiComandanti per mezzo di una Deputazione delle amichevoli trattative …per indurli, e persuaderli a non inoltrarsi in città facendo loro pervenire leoccorrenti razioni”. La Deputazione sarà composta dal Gonfaloniere, ilprimo Priore Giovanni Contucci, il Dott. Giovambattista Chini e un uffi-ciale della Guardia Civica. Venne stabilito che “qualora da una forza impo-nente venisse richiesta una multa di denaro contante la Deputazione sud-detta sarà autorizzata a limitarla nella minor forma possibile prelevando perurgenza la somma che sarà convenuta o dai depositi del monte Pio, o dallacassa del Sale, o dalla Cassa del Registro, attesa la mancanza di fondi nellaCassa Communitativa, per restituirli quindi col mezzo di una Imposta suiPossidenti della Comunità e sui Collettati della Tassa di Famiglia escluse laClassi inferiori”. I capitani della Guardia Civica furono incaricati di adope-rarsi “con attività, zelo e premura, tenendo in ordine nelle rispettive Case imiliti di detta Guardia per essere pronti al suono del Tamburo di riunirsi nelluogo che sarà da Loro indicato, a fine di prestare man forte nel caso che simanifestassero dei disordini all’interno della Città, sotto la dipendenza deirispettivi uffiziali”.Alle ore 10,00 del giorno seguente arrivarono le richieste di Garibaldi: due-mila razioni di pane di libbre una e mezza; duemila razioni di carne di bue;duemila razioni di vino di una Foglietta; trecento razioni di foraggi comple-ti cioè biada e fieno e duemila scudi in contanti133. Il comune però era nel-l’assoluta impossibilità di pagare la somma richiesta di duemila scudi e furiferito che già il giorno precedente erano state fornite razioni e cento lirein contanti. Venne deliberato di mandare le razioni e seimila lire, la cifra cheriuscì a raccogliere in un giorno il Primo Priore Giovanni Contucci, e ven-nero nominati gli addetti che avrebbero dovuto recuperare le razioni richie-ste. È evidente da tutta la situazione come i poliziani fossero ben informa-ti sui movimenti di Garibaldi. Il sospetto che nasce leggendo la documen-tazione è che in città avesse molti simpatizzanti e sostenitori, come l’avvo-cato e Segretario Comunale Silvio Colombi, il cui figlio era caduto durantela Prima Guerra d’Indipendenza, e che fu proprio tra gli addetti alla conse-gna delle masserizie agli uomini del Generale, o Giuseppe Garbini, checombatté per la difesa della Repubblica Romana. Probabilmente il Vescovofu convocato con l’intento di tenere sotto controllo i preti delle campagne,che avrebbero potuto fomentare contro i repubblicani fuggiaschi la popo-lazione rurale. D’altra parte nei giorni successivi pervennero numeroselamentele e richieste di risarcimento dai poderi nei dintorni della città per ibeni prelevati dai garibaldini134: lo stesso Garibaldi, nelle sue memorie, affer-ma che nei giorni della ritirata fu molto difficile mantenere la disciplina trai suoi uomini, ma narra di diserzioni nottetempo e mai di saccheggi135.Infatti è molto probabile che parte delle richieste di risarcimento fosserofasulle o gonfiate, tanto che fu istituita una commissione per verificare lareale consistenza dei danni136. Le stesse autorità cittadine fecero formalerichiesta di risarcimento presso il Governo per aver dovuto rifornire perquattro giorni consecutivi i garibaldini in ritirata da Roma137. Costoro perònon furono gli unici a rifornirsi a spese delle popolazioni locali: anche letruppe austriache che inseguivano Garibaldi si approvvigionarono presso lacittà e i poderi138. Già dal maggio precedente austriaci e truppe papali si
muovevano tra il confine pontificio e granducale alla caccia di fuggiaschirepubblicani139. In questa situazione la Guardia Civica fu messa in allerta,ma probabilmente, considerato che i suoi membri dovevano essere in largaparte liberali se non democratici o addirittura repubblicani, il suo compitodoveva essere quello di forza d’interposizione tra i fuggitivi e gli inseguito-ri.Nella Biblioteca Comunale di Montepulciano, all’interno dell’ArchivioStorico, oltre ai documenti si trova un piccolo arsenale della prima metà delXIX secolo. Lo stato di conservazione non è eccellente, ma nemmenodrammatico: sebbene non presentino tracce di interventi di recupero recen-ti, i pezzi sono stati ben conservati, limitando al minimo i danneggiamenti. Non sappiamo con precisione il motivo della loro presenza in quell’edifi-cio140, ma che si tratti delle armi della locale Guardia Civica è fatto assoda-to grazie alla presenza di un tipico elmo della Guardia. Al pezzo manca ilcrine di cavallo sulla sommità del chiodo e uno dei sottogola è parzialmen-te scucito, ma sostanzialmente si trova in buone condizioni, soprattutto laplacca frontale con il nome di Leopoldo II sotto corona granducale e al disopra, in rosso, il numero del battaglione di appartenenza. Il fondo più consistente è composto da 125 briquet (più alcune decine gra-vemente danneggiati), l’arma bianca tipica della Guardia Civica toscana. Ilfornimento è monoelsa in un unico pezzo di ottone lavorato per simulareuna falsa cappetta; alcuni possiedono ancora integra la dragona rossa. Possiamo essere certi che si tratti di armi in dotazione alla Guardia Civica,anche se non sono presenti punzoni con le iniziali GC, poiché uno degliesemplari reca impresso nel fodero un medaglione di Pio IX, anziché il soli-to “Viva Pio IX” inciso sulla lama. Tra queste potrebbero esserci le giàricordate 77 sciabole da fanteria trasportate il 24 maggio del 1849 sotto laresponsabilità del Capitano della 2ª Compagnia.I modelli di briquet presenti a Montepulciano possono essere ricondotti acinque tipologie.Il primo modello ha impugnatura quasi dritta a ventotto spire smussate,bottone a mezza oliva, guardia a spigoli vivi. Il secondo modello, invece, possiede ventisette spire smussate; bottone amezza oliva, guardia smussata, ricciolo diverso da altri modelli.L’impugnatura di questi modelli ha una brusca curva verso il pomo. A que-ste vanno aggiunte quelle con il bottone leggermente diverso, ma pratica-mente identiche in tutti gli altri particolari. La terza tipologia presenta ventotto spire smussate, guardia smussata a pro-filo un po’ squadrato; ricciolo rilevato vagamente cilindrico; impugnaturacon curva leggermente accentuata verso il pomo.Il quarto tipo ha sempre ventotto spire smussate; bottone molto basso,guardia smussata; impugnatura come quella della prima tipologia.Infine il quinto modello ha ventisette spire smussate, ma l’inferiore è piùlarga; bottone a mezza oliva; guardia smussata, impugnatura con curvaaccentuata verso il pomo. Questa varietà indica differenti produttori, e in effetti vi è una quantità dimarchi notevole (anche se non siamo in grado d’identificare le aziendearmiere a cui appartengono tali marchi), che ritornano sempre simili all’in-terno di una stessa tipologia. È presente, però, anche una grande quantitàdi marchi e sigle punzonate anche sui fornimenti. Per gli esemplari sabaudisappiamo che questi erano i marchi dei controllori ufficiali, mentre le sigleindicavano i reggimenti e la fila a cui erano destinati i briquet141, ma per gliesemplari toscani, compresi quelli di Montepulciano, non sappiamo ancoradecifrare queste punzonature.Anche i foderi si dividono in due tipologie: con la cappa munita di ganciodi sospensione oppure con occhiello per fissare i passanti del cinturone. Sono conservate anche diciotto spade, probabilmente appartenute agli uffi-ciali e ai sottoufficiali. Le lame sono quasi tutte rifilate, soprattutto al debo-le e in punta, probabilmente per garantire un migliore affondo. Le misuresi aggirano tra i 640 mm e i 740 mm (per quelle non rifilate). Tutte possie-dono sul ricasso lo stesso marchio punzonato uno scudetto presente anchesu due lame conservate presso il Museo Stibbert di Firenze142. Il Lensi (chele schedò entrambe) non conosce l’origine del marchio, così come il Boccia,che ne schedò una sola143. Un dettaglio interessante è che negli esemplari diMontepulciano, nella faccia opposta al marchio, sono visibili le dentaturedel supporto sul quale è stato battuto il punzone: sei o otto (a seconda della
196
forza con la quale sono stati battuti) negativi di denti circolari, uno affian-co dell’altro. Questi sono visibili anche all’interno dei fornimenti: evidente-mente il supporto sul quale è stato battuto il fornimento per conficcare ilcodolo della lama all’interno dell’impugnatura era lo stesso. I fornimenti sono tutti di 140 mm. Le forme sono molto simili a quelle dialcuni spadini civili del Granducato144, ma le lame sono da guerra. Del restole forme dei fornimenti di alcuni modelli di spade, sia civili sia militari,destinate agli ufficiali, prodotte in Italia tra il 1849 e il 1850 circa sonomolto simili a quelle conservate a Montepulciano: pelta asimmetrica con alcentro una panoplia a rilievo145, guardia ondulata e decorata a fogliami. Ilpomo è piegato leggermente in punta verso la lama ed è terminato da unatesta di cane, così come il braccio di guardia curvato verso la lama, mentreil braccio di parata, curvato anch’esso verso la lama, è decorato a fogliami. Teste di leoni o antropomorfe sono molto diffuse nelle spade delGranducato (i cui armamenti sono ancora per molti versi enigmatici)146 dellametà del XIX secolo, in particolare per quelle civili. Questo fatto lascia sup-porre che si tratti di armi destinate agli ufficiali o ai sottufficiali. Questespade sono state depositate nell’archivio legate tutte insieme tra loro conuna cordicella, alla quale era fissato un cartellino con scritto, in una grafianovecentesca, che si trattava delle spade della banda musicale diMontepulciano. È possibile che, una volta disciolta la Guardia Civica, que-ste spade siano state destinate alla banda musicale proprio in virtù della fog-gia elegantemente civile del fornimento. Una solamente possiede una lama azzurrata. Questa ha il fodero di cuoio(non della sua misura e privo di puntale) oramai incollato alla lama e, nonessendosi ancora presentata l’occasione di intervenire per separare i due ele-menti, si osservano solo le decorazioni messe a oro solo fino al forte dellalama e la punta (non decorata), che ha sfondato il fodero. Le caratteristichesembrano essere comuni a una lama da ufficiale descritta da Calamandrei:lama dritta a filo e punta, azzurrata al primo terzo, con leggeri disegni inci-si e messi a oro147. I foderi sono tutti di cuoio nero con puntale e cappa in ottone. I puntalisono di due tipologie: una con cresta tonda “a ferro di cavallo”, l’altra ondu-lata ai lati. Tutti i foderi possiedono una tasca in corame bianco per allac-ciare le spade al cinturone, come gli esemplari in dotazione all’esercito rego-lare fino al 1859148; da esse fuoriesce una croce in ottone come in esempla-ri di armi bianche appartenute ad altre guardie civiche149. Completa le armi bianche dell’archivio una sciabola da cavalleria della primametà dell’Ottocento. Il pezzo non sembra aver avuto manutenzione néinterventi di recupero, ma nonostante ciò è ancora sostanzialmente in otti-me condizioni, fatto che indica l’eccellente fattura della sciabola. La lamaricurva misura 842 mm, è decorata finemente all’acquaforte con fogliami etrionfi d’armi e reca ancora tracce di doratura. Il fornimento, lungo 152mm, ha un ramo di guardia da cui hanno origine due rami traversi. L’alettafermafodero è stondata (e non squadrata come in molti esemplari italianicoevi)150 a forma di noce. Braccio di parata curvo verso la lama terminantein una sfera. La cappetta è ricurva e culmina in un bottone ovale. Sembra essere molto simile alle sciabole dei Cacciatori a cavallo francesimodello 1802-1803151, ma differisce per il bottone, più arrotondato nelmodello di Montepulciano. La sciabola francese modello 1802-1803 si svi-luppò in altri due modelli, Anno IX e Anno XI; questi furono adottati daeserciti italiani come quello piemontese, che per esempio lo dette in dota-zione ai Carabinieri a cavallo152. Ma queste di norma non presentavanodecorazioni sulla lama e hanno l’impugnatura in legno fissata da due chio-di a mezza oliva153. Il fodero, curvo (lungo 860 mm), di tipologia piuttosto comune, è in lamie-ra di ferro, con bocchetta e due fascette con campanelle (a una delle qualisono ancora fissati i resti della catenella per appenderla al cinturone), cul-minante con una cresta. Potrebbe trattarsi di una delle sciabole all’ussarache il regolamento del 9 marzo 1848 destinava agli ufficiali della GuardiaCivica.Accanto a questo consistente quantitativo di armi bianche, nell’Archivio èstato anche rinvenuto un esiguo numero di armi da fuoco: trattasi di cinquefucili, in stato di conservazione variabile, di cui quattro sicuramente ascrivi-bili alla metà del XIX secolo e quindi coerenti da un punto di vista tempo-rale con il materiale sopra descritto, mentre il quinto dovrebbe avere una
origine differente; di ogni arma è stata ritrovata anche la relativa baionetta,mentre tutte sono prive della bacchetta. Per praticità di trattazione le armiin questione sono state numerate da I a V, e a tale numerazione si farà rife-rimento d’ora in poi. Il fucile I è un’arma a luminello, con meccanismo a molla indietro tuttorafunzionante, lunga circa 1480 mm e con una canna di 1050 mm, in calibro17,5 mm. Lo stato di conservazione è molto buono: la cassa e il calcio innoce sono integri e presentano solo evidenti segni di utilizzo oltre alla nor-male patina del tempo; le parti metalliche (in ferro, compresi i fornimenti)sono intatte e coperte da un leggero strato di ossidazione uniforme che nonpare averne compromesso la solidità. L’arma presenta alcuni marchi, quat-tro sul calcio e due sulla canna: l’usura purtroppo ha reso difficilmente leg-gibili due dei segni impressi sul legno, ma dal confronto con le altre armisappiamo che uno è una W, mentre l’altro resta del tutto oscuro154: inveceben chiari sono un numero 14 cerchiato, e un numero 2. Sulla canna sonoriportati nuovamente il 2155 e il marchio riconducibile al banco di prova del-l’arsenale di Liegi156. Sul calcio del fucile è inoltre incollato un foglio di carta,apposto dai Reali Carabinieri: i timbri e il testo non sono pienamente leggi-bili, ma si tratta di una dichiarazione datata 20 gennaio 1919 in cui si atte-sta che l’arma in questione era stata in precedenza rubata157 a tale Martini G.Battista, furto del quale si era data comunicazione con denuncia n° 198; siala denuncia che il fucile evidentemente erano destinati ad essere trasmessial magazzino del tribunale, tanto che sullo stesso foglio una mano diversaha annotato: “172/1919 – Registro corpi reato del tribunale”158. L’identificazione del modello di questo fucile, così come degli altri tre aseguire, ha presentato parecchi problemi. Ad una prima occhiata è eviden-te la somiglianza, per forma e dimensioni, con il modello francese 1840 dafanteria e successivi: tuttavia un più attento esame evidenzia chiaramentealcune differenze ben individuabili. Anzitutto la forma del cane, che nellearmi francesi dell’epoca risulta meno tozzo e con curve leggermente piùmarcate, e quella del grilletto (meno incurvato); la cartella è sostanzialmen-te identica nella sagoma, ma tutti i modelli d’oltralpe che si sono potutivisionare presentano alcune differenze, fra cui il costante uso nella parteposteriore di una vite con impronta a due fori159 che qui invece è sostituitada una normale vite con testa a taglio. Analoghe considerazioni si possono esprimere riguardo alle armi numerateda II a IV, che sono del tutto simili fra loro e quindi verranno trattate assie-me, sottolineandone le specificità. Si tratta di versioni leggermente più corte della precedente, lunghe circa 126cm, con canna di 90 cm sempre in calibro17,5 mm: più propriamente, quin-di, stiamo parlando di tre fucili. Il meccanismo a luminello a molla indietro,la cartella, la contro cartella e il grilletto sono identici a quelli del fucile I, evalgono le stesse considerazioni già fatte in merito alla morfologia. Delle trearmi, la II e la III sono perfettamente conservate, con la sola ossidazionedelle parti metalliche e lieve usura di quelle lignee (più marcata nella III): laIV invece ha riportato nel corso della sua esistenza un serio danno, tale dapregiudicare il funzionamento del meccanismo di scatto. Il calcio si presen-ta infatti fessurato per il verso della lunghezza, e la spaccatura si spinge sullato sinistro fino alla controcartella: manca la vite posteriore della cartella,la quale sembra essere leggermente sollevata dalla propria sede. Marchi e punzoni sono presenti secondo uno schema abbastanza costante.Il calcio della II porta impressi un 2 cerchiato, un 6, la lettera W; la canna èpunzonata all’altezza della culatta col marchio di Liegi, nuovamente col 6, econ un altro segno poco chiaro, che compare più nitidamente anche sullaIII. Su quest’ultima poi ritornano la W sul calcio e una cifra (il 5), che com-pare sia impressa sul legno che sul ferro, assieme al punzone belga; infinela IV ha in comune con le altre la solita W, nuovamente il marchio di Liegie lo stesso segno punzonato nel fucile II accompagnato pare da una X. Questo gruppo di armi, come si è detto, ha creato un po’ di problemi lega-ti all’identificazione del modello preciso: ma di certo a giudicare dai marchipresenti si tratta di copie realizzate in Belgio dei diffusissimi fucili a lumi-nello prodotti in Francia a partire da metà secolo160. Potrebbe trattarsi deifucili commissionati proprio in Francia dal governo di Firenze per armarela Guardia Civica, che sarebbero stati venduti alle comunità che ne avesse-ro fatto richiesta al solo prezzo d’acquisto, senza le spese di trasporto edogana161.
197
La sicurezza raggiunta sulla loro provenienza ci permette oltretutto diacquisire maggiori certezze nell’identificarle come appartenenti alla dota-zione della Guardia Civica o comunque delle forze armate Granducali, poi-ché si sa, infatti, che a più riprese in Toscana furono utilizzati armamenti diimportazione belga. Sul campo di Curtatone e Montanara erano già presen-ti, oltre a fucili ex ordinanza napoleonici, armi a pietra esemplate sul mod.1821 francese; quando poi attorno alla metà del secolo le forze granducalicominciarono a passare all’uso dei più recenti e funzionali modelli con inne-sco a percussione, si dotarono di copie delle armi francesi mod. 1840-42 esuccessive di produzione estera162, al contempo riutilizzando parte dei pre-cedenti fucili a pietra ancora presenti nei loro depositi, modificandone lebatterie. Questo è quanto accaduto al fucile designato come V, che si discosta netta-mente dagli altri. Siamo di fronte ad un’arma di peso e dimensioni maggio-ri, circa 1350 mm di lunghezza totale, con una canna da 1000 mm, di formanettamente esagonale per i primi 300 mm a partire dalla culatta. Si trattacon certezza di un’arma più antica, a pietra focaia, riadattata a luminello inun secondo momento163. La cartella mal si adatta alla sagomatura del legno,e nello spazio che resta è stato inserito un tassello per tenerla in posizione;essa mostra, inoltre, evidenti segni di rimaneggiamenti, con parecchi fori diviti ora vuoti ma in precedenza utilizzati per fissare in posizione la martel-lina con relativa molla e lo scodellino. Il cane sicuramente fu realizzato arti-gianalmente da un fabbro164, così come luminello e porta luminello, palese-mente applicati sulla canna preesistente; la decorazione, a linee spezzate epuntinatura, è piuttosto rozza e si ritrova peraltro nella produzione ruralesenese durante tutto il XIX secolo. Il grilletto, di forma peculiare (dritto eal fondo incurvato verso il calcio in un ricciolo), nonché il ponticello e rela-tive bandelle devono invece risalire all’arma originaria; il meccanismo discatto è comunque completamente bloccato. Posteriormente al cane è fis-sata una tacca di mira d’ottone, forse parte dell’ammodernamento dell’ar-ma. Il fusto ligneo è spaccato nettamente poco oltre la maglietta porta cin-ghia, ed è fissato alla canna tramite una larga fascetta sempre di ottone, inci-sa lievemente nella parte superiore con motivi molto semplici. Non vi sonomarchi o punzoni visibili su alcuna parte dell’arma, il che non aiuta l’operadi riconoscimento, ma dall’aspetto della stessa possiamo dire che probabil-mente si trattava di un fucile civile, databile forse attorno alla metà delXVIII secolo. I rimaneggiamenti subiti da questa arma testimoniano in ogni caso i tenta-tivi di ammodernare e rifornire come meglio possibile le neonate GuardieCiviche con equipaggiamenti che fossero all’altezza dei tempi. Il governocentrale da parte sua cercò da subito di affrontare tali problematiche,dovendo forzatamente sopperire alla carenza di industrie armiere locali conl’importazione dall’estero ma avendo la necessità al tempo stesso di mante-nere un giusto equilibrio fra i contributi del governo centrale e la spesa gra-vante sulle singole comunità. Era sicuramente evidente che queste ultime avrebbero dovuto far fronte abuona parte delle spese ordinarie con le proprie forze165, e tuttavia le auto-rità granducali si impegnarono nel ridurre perlomeno in parte tale carico, adesempio rivendendo le armi acquistate all’estero alle autorità locali senzal’aggravio delle spese di spedizione166. Vi era poi evidente la preoccupazio-ne di regolamentare le spese stesse, prevenendo eventuali sprechi o raggiri:un’altra comunicazione a stampa emanata dal governo centrale stabiliva chele casse regie avrebbero rimborsato le spese relative all’acquisto di sciaboleda fanteria (i briquet), baionette e altro materiale bellico, ma solo dopoapprovazione e forniva una indicazione di spesa a cui attenersi per ciascunarticolo, fra cui le baionette167.A questo riguardo, va fatto notare come fra le armi rinvenute nellaBiblioteca Civica vi siano pure cinque baionette, tutte identiche nella forma:presentano una lama di 350 mm con costola centrale e sguscio, con innestoa manicotto e ghiera stretto da una fascetta a vite, di forma assimilabile aquelle di coevi modelli d’oltralpe, e sono lunghe in totale circa 410 mm. Lalieve ossidazione non impedisce di scorgere alcuni marchi impressi sulmetallo: ciascuna di esse è infatti numerata (nell’ordine 3, 4, 5, 6, 8) sul latosinistro del braccio, che quasi certamente fanno riferimento agli stessinumeri apposti sui fucili168. Sul piatto della lama della baionetta identificatacol numero 3 è impresso un segno non molto chiaro, forse un 98 sormon-
tato da altro, mentre la 4 nella stessa posizione reca una C maiuscola. Le cautele del Governo relativamente alle spese militari per i Civici sicura-mente trovavano qualche fondamento nel timore che l’entusiasmo dellapopolazione locale portasse a qualche investimento incauto169; è interessan-te a tal riguardo notare l’evoluzione della vicenda dei cannoni, di cui per ini-ziativa di un cittadino, Bernardo Basetti, si era cominciato a parlare già dallaseduta del 23 novembre 1847170, pensando alla possibilità di fondare pressola Guardia Civica una Compagnia d’Artiglieria, come consentito dal regola-mento del 15 settembre 1847.La proposta iniziale era stata di far fondere i “mortaletti” in bronzo di pro-prietà della comunità per ricavarne due cannoni da montagna per laCivica171; a tal proposito si era consultato un fonditore di Pistoia, che avevafornito un preventivo di spesa. In seguito, tuttavia, nel corso della riunionedel 23 febbraio 1848, si pensava bene di rinunciare ai due cannoni da mon-tagna più piccoli, in favore di un sicuramente più imponente e rappresenta-tivo pezzo da campagna calibro 4, di seicento libbre di peso, a cui si propo-neva inoltre di assegnare il nome di “Leopoldo”172. Le autorità centrali,interpellate per l’approvazione della spesa, prudentemente replicavano tra-mite l’arsenale di Livorno sulla maggiore utilità del precedente progetto,suggerendo quindi di limitarsi alla fabbricazione di due pezzi da montagnadi 270 libbre l’uno173.Indubbiamente le spese ordinarie per il mantenimento e l’alloggiamentodella Guardia pesavano parecchio sul bilancio: numerose delibere infatti nedanno testimonianza, e dimostrano come sulla comunità ricadessero lespese legate all’affitto ed adeguamento degli alloggi174, nonché la fornituradi almeno parte delle uniformi per i militi175, che a Montepulciano doveva-no raggiungere un numero piuttosto elevato dal momento che nel dicem-bre 1847, come già detto, risultano attive due Compagnie con un organicodi 391 armati176.Resterebbe da chiedersi se le armi da fuoco conservate a Montepulcianosiano state utilizzate: si ritiene di sì, così come è stato supposto anche perle armi bianche sopra descritte. Lo deduciamo poiché insieme ad esse èconservata una cassetta di legno colma di micce, le quali potrebbero esserestate utilizzate per fucili più vecchi, ma molto più probabilmente servironocome stoppacci per caricare le armi ancora conservate, forse anche solo perle esercitazioni. E’ certo che questi fucili furono perlomeno usati con unacerta frequenza per l’addestramento delle truppe, avvalendosi quando pos-sibile, della collaborazione di militari di professione provenienti dall’eserci-to o dai carabinieri, come già visto per il caso del Tenente dei CarabinieriAugusto Gori e del Sergente Francioni,.La Guardia Civica di Montepulciano fu soppressa sicuramente dopo il 29gennaio 1850: a questa data era ancora operativa essendo registrato lo stan-ziamento di l.119 lire per i militi volontari della Guardia Civica inviati aPisa177.Come abbiamo già accennato la presenza di liberali e democratici aMontepulciano era di notevole entità. Il 1 agosto 1848 venne emanato unbando dalla Prefettura di Montepulciano, firmato dal firmato dal Sotto-Prefetto Gregorio Fineschi, nel quale tutti i cittadini sono esortati a pren-dere le armi contro gli austriaci, poiché ogni giorno ricevono l’invio dinuovi rinforzi178. Negli eventi militari del 1848 e del 1849 furono coinvolti nei vari corpi(esercito regolare, volontari, Guardia Civica e battaglione universitario)trentuno cittadini di Montepulciano179, molti di essi presenti alla battaglia diCurtatone e Montanara. Dagli elenchi ufficiali dei caduti risulta che duevolontari poliziani persero la vita in quei combattimenti: lo studente CesareColombi che, nonostante i gravi problemi di salute da cui era afflitto findalla nascita, decise di unirsi al battaglione universitario, cadendo sul campodi Curtatone, e il volontario Luigi Ilari180. Il 30 settembre 1848 il Sotto-Prefetto di Montepulciano emanava una circolare nella quale chiedeva didenunciare chiunque avesse prestato cure “abusive” ai “militi volontarireduci dal Campo di Lombardia”: il Pretore di Sarteano comunicava il 2ottobre che localmente non si riscontravano casi del genere181, probabil-mente nascondendo al Sotto-Prefetto alcuni feriti della sua comunità. Nel1849 ebbe luogo il processo a Giuseppe Garbini, reo di “ingaggio arbitra-rio contro potenza estera”. Il Garbini aveva combattuto per la difesa dellaRepubblica Romana, e fu ferito a un fianco durante un scontro con i fran-
198
cesi182. La vicenda giudiziaria si concluse con un’amnistia che permise all’im-putato di tornare in libertà183.Nei giorni della restaurazione granducale Amedeo Bennati di Sarteano sirifiutò di prestare giuramento al governo provvisorio. Il 6 novembre 1849il governo di Firenze comunicava al Pretore di Sarteano che la domanda discarcerazione, fatta dal padre di Amedeo, Barbera Bennati, era stata respin-ta184. Ancora negli anni a venire cittadini poliziani si distingueranno neicombattimenti per l’unità d’Italia185: almeno un cittadino di Montepulciano,Gioacchino Perchi o Perelli186, fu tra i volontari dei Cacciatori delle Alpi gui-dati da Garibaldi. Tra le Camicie Rosse sbarcate a Marsala vi furono trepoliziani: Bartolomeo Armellini, Zelindo Ascani e Giuseppe Migliacci187.Trentuno poliziani presero parte all’infelice campagna di Roma del 1867,per la quale Zelindo Ascani, che aveva in precedenza fatto tutta la campa-gna del 1860-1861 da Quarto al Volturno e, nel 1866, aveva preso parte allacampagna in Trentino con Garibaldi, ottenne una decorazione188. I documenti e le armi di Montepulciano, ciò nonostante, testimonianocome tutte le comunità toscane si siano prodigate per la causa nazionale e,in secondo luogo, offrono nuovo e interessante materiale per lo studio dellastoria militare e degli armamenti dell’Italia Preunitaria e Risorgimentale.
NOTE Un grosso debito di riconoscenza va alla Biblioteca Comunale diMontepulciano, in particolare a Duccio Pasqui e Antonio Sigillo, che hannogenerosamente messo a disposizione il materiale conservato in biblioteca e inarchivio, seguendo con grande attenzione gli sviluppi di questa ricerca. Inoltredobbiamo ringraziare Sivlia Di Pasquale, Duccio Rossi, che ci hanno segnalatodocumenti e bibliografia di grande interesse, e Girogio Dondi per i preziosi sug-gerimenti in materia oplologica. 1. La rivista si occupava di numerosi argomenti non solo letterari o filosofici. Alfianco della storia e del diritto, comparvero articoli di economia, ingegneria,architettura (che in quegli anni in Toscana si concentrava sulla realizzazione diedifici di pubblica utilità). Spazio rilevante trovarono gli articoli di statistica ematematica. In maggior parte i saggi scientifici erano finalizzati al progresso,come ad esempio la bonifica delle zone paludose o gli studi sulla lavorazioneindustriale dell’acciaio. Ma la rivista era indirizzata anche all’educazione popola-re, con l’idea di creare una classe d’insegnanti in grado di sconfiggere analfabe-tismo e ignoranza. Fu soppressa nel 1833 per le pressioni del governo di Viennasul Granduca, proprio per il carattere spiccatamente liberale, quando nondemocratico. 2. COPPI 1859, p. 33. 3. Giuseppe Montanelli fu nonno del giornalista Indro. Partecipò alla battagliadi Curtatone e Montanara con i suoi studenti, ma “benché capitano del batta-glione degli scolari, mi feci soldato comune parendomi che toccasse a noi libe-rali più sporgenti dare un po’ di buon esempio di abnegazione in fatto di spal-line e paghe, cosa tanto necessaria alle imprese popolari” MONTANELLI 1963, p.9. 4. La prima Guardia Civica fu istituita nei territori Pontifici per volontà deiFrancesi durante l’occupazione napoleonica. In Francia la Guardia Nazionalesorse spontaneamente nel 1789 su proposta del Conte de Mirabeauall’Assemblea Legislativa, con l’idea di creare una guardia armata borghese. Lasua creazione fu ufficializzata dall’Assemblea Costituente il 14 ottobre 1791 (ilprimo comandante fu il de La Favette). Il regolamento fu modificato nel 1793e nel 1805. Nel 1831 fu profondamente modificata sotto il regno di LuigiFilippo e ancora modificata nel 1851 e nel 1852. Mobilitata durante la guerrafranco-prussiana, fu abolita definitivamente il 30 agosto 1871. 5. La città fu presa d’assalto dalle truppe austriache il 13 agosto 1847. Ciò con-tribuì ad attirare le ire patriottiche contro l’Austria e un sentimento diffuso disolidarietà nei confronti del Pontefice: ALBÈRI 1847. 6. MONTANELLI p. 8. 7. Una panoramica della situazione degli eserciti preunitari la fornisce Pedonenel suo intervento al congresso tenutosi al Museo Canonico di Roma il 13 feb-braio 2002, dal titolo Dagli eserciti pre unitati all’esercito italiano. 8. Fino al plebiscito che unirà il Granducato al regno di Sardegna, la Fanteriaera composta solo da un battaglione di veliti (l’élite della Fanteria, con compitianche di Guardia di Palazzo); dieci battaglioni di Fanteria di linea; un battaglio-ne di Bersaglieri: La guerra del 1859 per l’Indipendenza d’Italia, vol. II, Roma 1912,pp. 10-11. 9. MONTANELLI, p. 9.
10. LOMBARDI 1983, p. 167. 11. ASCM Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 9 aprile 1848. 12. Al tricolore già si inneggiava nel settembre del 1847, durante i festeggiamen-ti per la concessione delle riforme. 13. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 17 aprile 1848. 14. Ad affiancare i toscani vi era anche un battaglione del 10° Fanteria napole-tano e un numero imprecisato di volontari (soprattutto universitari) provenien-ti dal Regno di Napoli. In più era presente un battaglione del 10° Fanteria degliAbruzzi al comando del tenente colonnello Rodriguez. 15. Le informazioni sulla battaglia sono ricavate da: MONTANELLI, Memoriesull’Italia e specialmente la Toscana, pp. 8-12; M. CELLAI, Elenco delle tavole componen-ti l’atlante geografico/militare annesso all’opera I fasti militari della guerra dell’indipenden-za d’Italia dal 1848 al 1863, Milano 1863, tav. 6; P. PIERI, Storia militare delRisorgimento italiano, 2 voll., Torino 1962, vol. I, pp. 219-222; M. SCARDIGLI, Legrandi battaglie del Risorgimento, Milano 2011, pp. 119-122. 16. Ordini per la verità poco lucidi, poiché a Volta, già in quelle ore, si eranoammassate le truppe piemontesi, e quindi sarebbe stato più opportuno creareuna linea difensiva proprio in questa località. 17. Cesare Niccolò Giovacchino De Laugier, Conte di Bellecour, fu un perso-naggio molto importante per il Risorgimento toscano. Nato a Portoferraio il 5ottobre 1789, in piena rivoluzione francese, fu personalità complessa e contro-versa. Di famiglia politicamente moderata, se non ambigua (lo zio fu ghigliotti-nato dai rivoluzionari, mentre il padre fu accusato di essere giacobino e prestoscagionato), ebbe un’infanzia turbolenta. Dopo diversi collegi entrò comecadetto nel reggimento Carlo Ludovico. Qui divenne un valente duellante, tantoche pubblicò L’arte di non farsi uccidere né ferire in duello, edito probabilmente nel1828 (MARCOTTI 1898, p. 332). Ma questa abilità lo costrinse ad arruolarsi nelletruppe napoleoniche poiché ferì mortalmente in duello un cadetto suo compa-gno. Militò come velite, quella che lui stesso, come tutti gli altri veliti, conside-rava l’élite delle truppe italiche nonostante la fatica del ruolo (PIGNI 2001, p.153). Qui fece una rapida carriera dai ranghi più bassi dell’esercito, all’insegnadi decorazioni e promozioni sul campo per atti di eroismo e coraggio. Nel 1814fu fatto prigioniero degli austriaci mentre tentava di far giungere un messaggiosegreto a Napoleone in persona. Dopo la restaurazione le sue simpatie bona-partiste non lo rendevano ben visto dal governo dei Lorena; il primo ministrogli consigliò di arruolarsi nell’esercito murattiano. Ma, grazie all’intercessionedel cugino Charles De Laugier, figlio dello zio ghigliottinato e colonnello del-l’esercito austriaco, il 29 giugno 1814 fu inglobato nei ranghi dell’esercito gran-ducale, fino a diventare generale. Militare tutto d’un pezzo, sarebbe stato pron-to a sedare con ogni mezzo la rivolta di Livorno, anche contro il parere di quasitutti i suoi ufficiali. Il comando del contingente fu visto con diffidenza dal mini-stro della guerra Neri Corsini. Ma De Laugier stringeva contatti anche con iliberali, tanto che nel 1859 ebbe un piccolo incarico nel governo del Ricasoli.Fu tra i più vivi sostenitori della Guardia Civica, tanto che nella sua abbondateproduzione letteraria (tra cui numerosi diari e memorie) troviamo un’opera,Teoria che potrebbe esser idonea per la Guardia civica italiana, pubblicata a Livornoall’indomani dell’istituzione della Guardia, e il Regolamento generale per il “serviziodi piazza” della Guardia toscana, edita l’anno successivo sempre a Livorno. Scrisseanche alcune memorie sui fatti di Curtatone e Montanara, ricche di informazio-ni e dettagli, tre delle quali edite, le altre rimaste manoscritte (conservate pres-so l’Archivio di Stato di Firenze con altri suoi testi inediti). Per un approfondi-mento sul De Laugier: N. DANELON VASOLI, Cesare De Laugier e la figura dell’eroemilitare italiano tra l’età napoleonica e la prima Guerra d’Indipendenza, in Mythes et figu-res de l’héroisme militaire dans l’Italie du Risorgimento, Caen 1984, pp. 37-49; ID, DeLaugier, Cesare Niccolò, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XXXVI, Roma1988, pp. 281-289. 18. Veterano dei dragoni di Napoleone I. 19. Per i fatti d’armi che ebbero protagonista il battaglione universitario si veda:G. NERUCCI, Ricordi storici del battaglione universitario toscano alla guerra d’Indipendenzaitaliana del 1848, Prato 1891. 20. Il valore italiano. Storia dei fatti d’armi e atti compiuti dal 1848 al 1870 per l’indipen-denza d’Italia, vol. I, Roma 1883, pp. 134-139. Da Livorno partirono per primi il2° Reggimento di Linea Real Ferdinando, un battaglione della Guardia Civica a cuisi erano aggregati i civici universitari di Pisa. In seguito furono raggiunti da altricorpi regolari e di volontari sempre provenienti da Livorno. 21. Fu sul punto di essere ucciso dagli Austriaci se non fosse intervenuto il suoaiutante di campo Giuseppe Cipriani, l’unico soldato dell’armata toscana a esse-re insignito dal Regno di Sardegna di medaglia d’oro e nominato commendato-re dell’Ordine di Santo Stefano.
199
22. LOMBARDI, Massa Marittima e il suo territorio nella storia e nell’arte, p. 167. 23. SCARDIGLI, Le grandi battaglie del Risorgimento, pp. 119-122. 24. Il fatto fu segnalato con forza anche da Giuseppe Bandi, il Maremmano chefu ufficiale d’ordinanza di Garibaldi durante l’impresa dei Mille, quando raccon-tò nelle sue memorie che a Calatafimi i Garibaldini dovettero affrontare il 10ºreggimento di linea napoletano: “soldati del decimo reggimento di linea, diquello stesso che combatté così gloriosamente in Lombardia, a fianco dei tosca-ni, nella battaglia di Montanara e Curtatone, nell’anno 1848”. G. BANDI, I Mille:da Genova a Capua, Milano 1977, p. 183. 25. All’indomani della battaglia fu imba-razzante per le autorità sarde ammettere che un ruolo determinante fu ricoper-to da truppe regolari borboniche, ben comandate ed equipaggiate. Quindi siesagerò il ruolo dei volontari toscani, sopratutto degli studenti, che nella realtàdei fatti, pur combattendo con coraggio e valore, non erano addestrati e pron-ti per affrontare un esercito efficiente come quello austriaco. 26. A.M. ISASTIA, Il volontariato militare nella seconda guerra d’indipendenza,in Studi sto-rico militari 1984, Roma 1985, pp. 11-48; ID., Il volontariato militare nelRisorgimento, Roma 1990. 27. La sua nascita è decretata nello Statuto concesso da Carlo Alberto l’8 feb-braio 1848, all’articolo 14. 28. In questa circostanza il De Laugier lesse un proclama nel quale annunciaval’ingresso delle truppe piemontesi. Questa notizia scatenò la reazione di Vienna,che a Torino si ripercosse nella caduta del governo Gioberti. 29. G. BADII, Massa Marittima nella storia del Risorgimento italiano, Milano 1927, pp.27-29. 30. A Livorno, dopo il fallimento della Repubblica Toscana e l’arresto delGuerrazzi, fu creato un governo popolare sostanzialmente contrario al nuovogoverno moderato di Firenze. La città quindi era destinata a essere duramentecolpita dalla restaurazione austriaca come esempio, e il casus belli fu offertoall’Aspre dalla resistenza armata di alcuni livornesi contro le truppe imperiali. 31. L’abolizione della pena di morte in Toscana fu decretata il 30 novembre1786. Il fatto sintomatico di quanto tale provvedimento riuscì nell’unificazionepolitica e culturale della Toscana, da sempre divisa in campanilismi e municipa-lismi, è che il 30 novembre divenne, ed è tutt’oggi, festa regionale. 32. La guerra del 1859 per l’Indipendenza d’Italia, pp. 9-26. 33. Ad esempio si veda: Qui sostò l’eroe. Garibaldi in terra di Siena, a cura di L.OLIVETO, Siena 2008. 34. Durante la spedizione dei Mille l’ufficiale d’ordinanza del Generale fuGiuseppe Bandi, maremmano di Gavorrano, uno dei suoi uomini più fidati, giàsuo attendente nella campagna del 1859. Alla colonna guidata da CallimacoZambianchi, che sbarcò, su ordine di Garibaldi, a Talamone dal Lombardo e dalPiemonte, per operare un diversivo nei territori pontifici, si unirono numerosimaremmani al comando di Andrea Sgarallino: Garibaldi e Garibaldini in Maremmaa Talamone, Orbetello e Porto Santo Stefano, a cura di I. Terramoccia, Arcidosso2011. 35. S. GALLI, Memorie storiche di Massa Marittima, vol. II, Massa Marittima 1874,p. 503. 36. D. MACK SMITH, Il Risorgimento italiano. Storia e testi, Bari 1982, pp. 555-561;M. TADDEI, Siamo onesti! Bettino Ricasoli il barone che volle l’unità d’Italia, Firenze2010. 37. Per alcuni il regno d’Italia era anche più gradito del Granducato, visto che aLucca si continuava a dire: “Italiani sì, Toscani mai!”: D. BALESTRACCI, Dallaparte di quelli che persero, in La battaglia di Scannagallo. 2 agosto 1554, Firenze 2004,p. 69. 38. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 15 settembre 1847. Era cosìsuddiviso: Capitolo 1: Disposizioni Generali; Capitolo 2: Della formazione dellaGuardia Civica, e della Nomina ai Gradi; Capitolo 3: Delle Uniformi, delleArmi, delle precedenze; Capitolo 4: Delle spese occorrenti per la GuardiaCivica; Capitolo 5: Della Formazione dei Ruoli della Guardia. 39. Rispettivamente: ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, StatutoOrganico, 4 ottobre 1847; ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 5novembre 1847. Si tratta di uno statuto sintetico composto da 112 articoli, l’ul-timo dei quali sanciva che questo regolamento è da considerarsi l’unica normaper l’organizzazione e servizio della Guardia Civica. 40. L’articolo 3 del regolamento sintetico, del 5 novembre 1847, stabiliva che laGuardia Civica, ancora provvisoria, sia agli ordini della Riserva. 41. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 25 novembre 1847. 42. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 29 dicembre 1847. 43. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 6 novembre 1847. 44. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 2513.
45. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 2590. 46. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 2610. 47. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 2700. 48. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 2744. 49. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 530. 50. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 5 marzo 1848. 51. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 2 marzo 1848. 52. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 8 marzo 1848: Capitolo 1:Disposizioni Generali; Capitolo 2: Formazione delle Compagnie di Fucilieri;Capitolo 3: Nomina dei Graduati; Capitolo 4: Uniforme, corredo, armamento;Capitolo 5: Istruzione; Capitolo 6: Servizio, accessori e conseguenze), che fu invigore durante la compagna contro l’Austria. 53. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 5 febbraio 1848. 54. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 456. 55. A proposito si vedano le pp. 4 e 7 del regolamento del 4 ottobre 1847. 56. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 2670. 57. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 2384. 58. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 31 marzo 1848. 59. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 3 aprile 1848. 60. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 5 aprile 1848. 61. A Montepulciano sono individuati dalle autorità due giovani renitenti allaleva: il contadino latitante Luigi Paoloni di Valiano (di cui viene diramata ladescrizione fisica) e Giuseppe Biscottini, accusato del tentativo di farsi esonera-re dall’arruolamento. Per entrambi saranno applicati provvedimenti giudiziari.Rispettivamente ASCM, Processi Criminali 1847-1849, cc. 514r, 535r-535v. 62. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 24 aprile 1848. 63. Fu emanata appositamente una circolare granducale, nella quale LeopoldoII ricordava che la Guardia Civica è animata dal sentimento di fratellanza.Esortava quindi i membri dell’istituzione a sedare eventuali baruffe e a nonprenderne parte. Inoltre ricordava che, qualora una comunità avesse voluto isti-tuire un proprio reparto civico, ma non avesse raggiunto gli effettivi per caren-za demografica della comunità stessa, i paesi vicini avrebbero dovuto fornire gliuomini mancanti, con la speranza che tutte le comunità toscane si affratellasse-ro: ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 2793. 64. Dalla corrispondenza di miliziani e militari toscani con le loro famiglieapprendiamo la maggior parte delle informazioni sulle battaglie di Curtatone eMontanara. 65. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 30 maggio 1848. 66. F. MARTINI, Il Quarantotto in Toscana. Diario inedito del Conte Luigi Passerini de’Rilli, 2 voll., Firenze 1919, vol. I, p. 77. 67. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 2384. 68. La somiglianza con le uniformi austriache era tale che i comandi sabaudi, sianella prima sia nella seconda guerra d’indipendenza, fecero pressioni sulle auto-rità militari toscane affinché modificassero le divise, onde evitare di scambiaregli alleati con il nemico: La guerra del 1859 per l’Indipendenza d’Italia, p. 11. 69. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 2384. 70. In data 10 maggio 1849 le autorità locali riportano la spesa relativa alla fab-bricazione di 34 paia di scarpe presso 5 diversi calzolai, per un totale di £218.3.4, e all’acquisto di stoffa per cappotti. ASCM, Deliberazioni Preunitarie, 153,c. 111r. Particolare interesse pare avessero proprio le spese per i cappotti (fon-damentali d’inverno) che ritornano più volte nella documentazione in esame (adesempio ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti laGuardia Civica , c. 16v.), nonché quelle relative alle uniformi dei tamburini(ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica , c. 16r.; ASCM, Deliberazioni Preunitarie, 153, c. 160v.). 71. All’epoca della campagna del 1848 la feluca degli studenti universitari avevala tesa tonda, e non a punta. La tradizione goliardica che vuole la feluca deglistudenti pisani tagliata in punta per poter prendere meglio la mira con il fucile,è da ritenersi una leggenda. 72. I disegni sono conservati presso numerosi istituti. 288 acquarelli sono con-servati presso il Museo Nazionale di Castel S. Angelo a Roma; altri 133 si tro-vano al Museo del Risorgimento di Milano; mentre l’Ufficio Storico dello StatoMaggiore dell’Esercito possiede, assieme all’archivio privato dell’artista (oltre a300 tavole del suo manoscritto), una raccolta di 2.500 fogli divisi in vari volumi,nei quali Quinto (e in seguito il figlio) aveva raccolto appunti e disegni sulle uni-formi, sulle armi e sugli eserciti di tutto il mondo e tutte le epoche.Recentemente sono comparsi, in occasione di una mostra a New York, 50acquarelli di Quinto Cenni sul Ducato di Parma al tempo di Maria Luigia, deiquali non si conosceva l’esistenza.
200
73. N. GIORGETTI, Le armi toscane e le occupazioni straniere in Toscana (1537-1860),3 voll., Città di Castello 1916. 74. Tesoro di cognizioni utilissime destinato alla istruzione ed al divertimento della gioventùitaliana e dedicato alla guardia civica, Firenze 1847. La copertina dell’opuscolo èincorniciata dagli inni: viva Pio IX, viva Leopoldo II, viva l’Italia. 75. C. QUARENGHI, Tecnografia delle armi da fuoco italiane, vol. II, Napoli 1881, p.130. 76. I reparti di linea dell’esercito regolare toscano adottarono il fucile ingleseEnfield 1853 (calibro 17,8 mm; peso 3,870 kg; lunghezza 1421 mm). 77. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 484. 78. C. CALAMANDREI, Storia dell’arma bianca italiana, Firenze 2008, pp. 333-360. 79. C. CALAMANDREI, Armi bianche militari italiane (1814-1950), Firenze 1987, p.230. 80. CALAMANDREI, Storia dell’arma bianca italiana, p. 351. 81. È conservata una spada, per esempio, che reca su un piatto della lama lascritta “Guardia Civica Toscana” e sull’altro “Viva Pio IX”: CALAMANDREI,Storia dell’arma bianca italiana, p. 351. 82. I registri d’interesse per la Guardia Civica di Montepulciano si trovano in:ASCM, Deliberazioni Preunitarie, 152; 153. Tuttavia altre indicazioni sparse relati-ve alla sua attività si sono potute reperire in altri faldoni, come ad esempioASCM Processi criminali 1848 –1849; ASCM, Anni 1846 e 1847 - ordini e circolari,o nei carteggi con le autorità militari centrali conservati in mezzo al resto dellacorrispondenza ufficiale, come in ASCM, FILZA IX - carteggio dal gennaio 1848a tutto dicembre 1849, al cui interno è rilegato il Carteggio con la superiore autorità mili-tare, n. 4. Relativamente alla situazione dell’archivio comunale diMontepulciano, va fatto inoltre rilevare come in esso siano confluiti anche quel-li di comunità vicine, come quella di Sarteano, esse stesse sede all’epoca di unitàmilitari; pertanto è stato a volte possibile sfruttare tali documenti per arricchireil quadro relativo al funzionamento e alle attività istituzionali delle GuardieCiviche locali. 83. Il registro in questione, dal titolo “Repertorio del protocollo delle deliberazioni magi-strali della Guardia Civica” si trova in ASCM, Comunità di Montepulciano - delibera-zioni magistrali riguardanti la Guardia Civica [n° 3829]. In apertura del fascicolo sifa richiamo alla deliberazione n° 2547 emanata dalla Soprintendenza Generaledelle Comunità in data 27 novembre 1847, che stabiliva l’obbligo di tenere unregistro di protocollo per i verbali delle riunioni del Gonfaloniere e dei Prioricomponenti il Civico Magistrato relative alla Civica. 84. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848.85. ASCM, Deliberazioni Preunitarie, 152, c. 92r. 86. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 152, c. 107r. 87. Che fu deciso di collocare o nel Palazzo Comunale o nella Cattedrale:ASCM, Deliberazioni magistrali riguardanti la Guardia Civica, 3828, c. 2r. 88. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, cc. 141r, 141v, 162v. 89. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 112r. 90. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, c. 4r. Il documento però non segnala l’entità delle paghe. 91. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, cc. 7v-8r. 92. Il 5 aprile del 1849 veniva registrata una spesa di oltre 34 lire per scarpe ecappotti da destinare alla Guardia Civica: ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, cc.111-112v. 93. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 160v; ASCM, Comunità di Montepulciano- deliberazioni magistrali riguardanti la Guardia Civica, c. 16r. 94. Comprese le spese per pulirle: ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazio-ni magistrali riguardanti la Guardia Civica, c. 13r. 95. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 155v. 96. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 181r. 97. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 152, cc. 130r-130v. 98. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, cc. 4 r-6r. 99. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, 3828, c.7v. 100. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, c. 10v. 101. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 1r: il comune destina 986.14 lire peril bando dei lavori di sistemazione dell’immobile. 102. Deliberazioni 153, 163r. 103. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, cc. 3r-4r.
104. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, 3828, c.7v. 105. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, c. 8v. Secondo lo schema della tabella di pagina 10 del regolamento del 4di ottobre del 1847 per una Compagnia formata da 200 uomini i Sergenti dove-vano essere 8, mentre i tamburini 2. 106. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, c. 16r. 107. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, c. non numerata. 108. Non vi era un timore d’invasione, ma era necessario evitare qualsiasi inci-dente diplomatico con il Papa. Una qualunque aggressione contro i territoripontifici avrebbe scatenato la dura reazione dell’Austria e della Francia. 109. ASCM, FILZA IX - carteggio dal gennaio 1848 a tutto dicembre 1849, c. 26r;ASCM, Processi Criminali 1847-1849, cc. 487r, 530v-531r, 154r. 110. ASCM, Maggio 1849 – Sarteano. Cartolare, c. 1v. 111. ASCM, Maggio 1849 – Sarteano. Cartolare, cc. 7r-8r. 112. ASCM, Maggio 1849 – Sarteano. Cartolare, cc. 2r-5r. 113. ASCM, Deliberazioni Preunitarie i 153, c.158v. 114. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 146r. 115. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 162r. 116. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 181r. 117. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c.182r. 118. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, cc. 180r-189r. 119. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 147v. 120. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 155r. 121. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 161r. 122. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 152, cc. 89v, 105v, 180v, 181v, 182r. 123. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, cc. 10v, 15r. 124. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, c. 16r. 125. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, c. 8v. 126. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 154r. 127. ASCM, Maggio 1849 – Sarteano. Cartolare, c. 27. 128. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 154r. 129. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, c. 12v. 130. ASCM, Processi Criminali 1847-1849, c. 531r. 131. ASCM, Maggio 1849 – Sarteano. Cartolare, 2 ottobre 1848. 132. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 131v. 133. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 132v. 134. ASCM, Deliberazioni 153, cc. 148r-149r. 135. G. GARIBALDI, Memorie autobiografiche, Firenze 1888, p. 241. 136. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 136v. 137. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 133v. 138. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c. 136v. 139. ASCM, Maggio 1849 – Sarteano. Cartolare, 9 maggio 1849. 140. Forse in passato l’edificio fu utilizzato anche come luogo di conservazio-ne per oggetti e cimeli di particolare interesse per la storia della comunità.Infatti, tra le altre cose, sono conservati nella biblioteca tutti gli atti ufficiali delcomune e una spada da ambasciatore donata da Cesare Nerazzini, che era natoa Montepulciano. Il Nerazzini, con un brillante passato di ufficiale medico dellaMarina Militare, ricoprì incarichi diplomatici dal 1883 al 1911. Nel 1877 fu luiad essere scelto come responsabile della missione per il recupero delle ceneri diNino Bixio in Asia. Negli archivi toscani è facile imbattersi in materiale preuni-tario di differente natura, grazie alle caratteristiche del sistema istituzionale mili-tare del Granducato, in specie per la leva sia delle truppe regolari sia delle mili-zie volontarie: C. LAMIONI, La documentazione dell’ufficio di leva di Firenze. Classi dinascita 1842-1939, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n.s., anno III (maggio-agosto 2007), pp. 255-256. 141. M. LUPO, Le lame del Re. Sabri e spade dell’Armata Sabauda dal 1560 al 1831,Torino 2007, pp. 442-446. 142. Rispettivamente: Firenze, Museo Stibbert, inv. 2117 e 2148. Queste duehanno anche inciso sulla lama “en Toledo”, ma è probabile che questa incisio-ne sia stata eseguita in un secondo momento per immettere i due pezzi sul mer-cato antiquario a prezzo maggiore, come sovente accadeva. 143. A. LENSI, Il museo Stibbert. Catalogo delle armi europee, 2 voll., Firenze, 1917-
201
202
1918, vol. I, pag. 349 e 354; L.G. BOCCIA, Il Museo Stibbert a Firenze, voll. III,L’armeria europea, 2 voll., Milano, 1975, vol. I, pag. 126, cat. 343. 144. Due sono conservati presso il Museo d’Arte Medievale e Moderna diArezzo. 145. Molto simile all’esemplare pubblicato in C. CALAMANDREI, Armi bianche alloStibbert 1700-1800, Sesto Fiorentino 2005, p. 25. 146. CALAMANDREI p. 419. 147. CALAMANDREI p. 135. 148. La guerra del 1859 per l’Indipendenza d’Italia, p. 11. 149. CALAMANDREI p. 337. 150. PIANCASTELLI 2007. 151. GRIMALDI1965, p. 321. 152. Per una panoramica vedere: PIANCASTELLI, Lame del Risorgimento. 153. CALAMANDREI p. 39. 154. Potrebbe essere la parte superiore di una corona, oppure trattarsi di unprimo tentativo fallito di imprimere la W. È anche vero che nel fucile III sem-bra di scorgere lo stesso segno, praticamente sovrastante la W: si potrebbe quin-di escludere che si tratti di un segno impresso sul legno accidentalmente, per unurto o per pressione di qualche oggetto solido. 155. Impresso due volte, una sul lato destro e l’altra sul sinistro. 156. FRAIKIN 1940. 157. Il testo riporta un “sequestrata”, subito cancellato con un tratto di pennae sostituito da “rubata”: sicuramente si trattò di un errore dello scrivente. 158. Questa notazione potrebbe darci qualche ulteriore spunto per formulareun’ipotesi verosimile su quando le armi siano state raccolte: evidentemente nel1919 almeno una di esse era ancora di proprietà di un privato. Potremmo allo-ra ipotizzare che ci si trovi proprio di fronte a un fondo raccolto ad un certomomento dai Carabinieri o dal tribunale nel corso della loro attività istituziona-le, e poi rimasto confinato negli archivi dove è stato da noi rinvenuto. 159. Oggigiorno definite commercialmente viti Spanner. 160. In seguito le forze granducali si dotarono di modelli più recenti a percus-sione, copia dei modelli francesi 1840-42 e successivi; di questi ultimi si cono-scono sicuramente esemplari prodotti dalla Fabbrica Sociale d’Armi di Lecco.CALAMANDREI p. 291 e p. 368. 161. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, N. 484. 162. Oltre alle armi di produzione belga, ne furono sicuramente utilizzate altreprodotte altrove, come quelle provenienti dalla Fabbrica Sociale d’Armi diLecco. CALAMANDREI, p. 291, 352, 368 e 432. Tuttavia alcune restrizioni impo-ste al commercio delle armi, come quelle adottate dal governo austriaco nel1835 volte a limitare l’esportazione di merci delle fabbriche del Bresciano, favo-rirono l’affermarsi delle manifatture estere: dovendo procurarsi 40000 fucili, ilRegno di Napoli dovette rivolgersi proprio al Belgio. GAIBI 1968, p. 47. 163. Caso tutt’altro che raro per l’epoca, come si è detto sopra: si vedano infat-ti i numerosi esempi, reperibili sul mercato antiquario, di esemplari ammoder-nati in modo similare. 164. Nei documenti di Montepulciano sono riportate spese militari sostenuteper le prestazioni offerte dai fabbri: ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, cc.133v; 158v; 180r-189v. 165. Una circolare del governo, la n° 2583 del 27 novembre 1847, doveva evi-dentemente disciplinare tale materia, stabilendo la tenuta di altri registri in cuiannotare le somme stanziate, che in ogni caso dovevano essere revisionate eapprovate dalle autorità centrali. L’entusiasmo per la costituzione della GuardiaCivica in ogni caso doveva essere forte, al punto che in data 4 dicembre 1847,prendendo atto delle norme di cui sopra, si deliberava di stanziare 2000 lire perl’acquisto di fucili, da recuperare in seguito mediante un aggravio delle tasselocali. La spesa veniva approvata tempestivamente, tanto che in data 24 genna-io 1848 si prendeva atto della possibilità di procedere. ASCM, Comunità diMontepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la Guardia Civica, c. 3r. e c. 4r. Il23 febbraio 1848 sono ancora registrate spese per il trasporto di tre fucili daFirenze a Montepulciano: ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magi-strali riguardanti la Guardia Civica, c. 9r. 166. Come da comunicazione della Sopraintendenza Generale delle Comunitàdel 17 febbraio 1848. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, n° 484. E’probabile che ci si riferisse comunque alle spese legate al trasporto dalle fabbri-che fino al Granducato, perché da altra documentazione risultano stanziamentidi fondi destinati a pagare i carrettieri che avevano trasportato fucili da Firenzea Montepulciano, come in ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magi-strali riguardanti la Guardia Civica, c. 7r, o in ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153,c. 181v. per un trasporto di fucili questa volta da Montepulciano a Siena.
167. Il 14 febbraio 1848 il governo diramava una circolare nella quale venivadetto che la distribuzione dei fucili per la Guardia Civica sta procedendo rego-larmente. Tuttavia il Granducato non era in grado di produrre il restante arma-mento ed equipaggiamento necessario a tutti i militi. Pertanto disponeva un pre-ziario affinché le comunità potessero acquistare l’equipaggiamento necessario,che sarà successivamente rimborsato dalla Cassa Regia, non prima però che nevenga testata l’efficacia. L’elenco comprendeva: Cinturone con gibernino, com-prese le cifre: £ 8,16,8; Sciabole da fanteria (briquet): £ 8,12,8; Foderi da baio-netta da 16 pollici: £ -19-; Foderi da baionetta da 14 pollici: £ -18-; Cavastrcci:£ -12,8; Cacciavite: £ -10-; Sacco di pelle per i Corpi che dovessero mobilitarsi:£13-. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 14 febbraio 1848. 168. Alla prova pratica, si è potuto verificare che le baionette marcate 5 e 6 siinnestano perfettamente sui fucili con gli stessi numeri (rispettivamente il II e ilIII); è da considerarsi altamente probabile che esse fossero state spedite giàaccoppiate alle rispettive armi. Il fatto poi che la numerazione delle baionettearrivi al numero 8 rende chiaro come in origine vi fossero molte più armi dafuoco di quelle giunte fino a noi (perlomeno, evidentemente almeno otto). 169. E’ anche probabile che si temesse qualche malversazione. Una lettera invia-ta dal Comando della Guardia civica di Sarteano al Pretore della città stessasembra rispondere ad accuse relative a vendita irregolari di forniture militari(non possediamo la missiva corrispondente, per cui non siamo in grado di averemaggiori dettagli). ASCM, Maggio 1849 – Sarteano. Cartolare, c. 29r. 170. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, c. 2v. 171. Veniva segnalato che l’esercito toscano non possedeva artiglieria da mon-tagna, mentre a Montepulciano, per le sue caratteristiche geografiche, questatipologia di cannoni sarebbe stata molto utile. 172. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, c. 9r. 173. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, c. 9v. La questione dei cannoni comunque veniva ribadita ancora in data30 dicembre 1848, e si stabiliva persino in seguito di aggiungere al bronzo deimortaletti pure quello della campana del Palazzo Pretorio. ASCM, Comunità diMontepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la Guardia Civica, cc. 17 v.e 18 r. 174. Numerosissime le deliberazioni su tale argomento, che tornano puntual-mente in quasi tutti i verbali delle deliberazioni magistrali: dovendo sopperirealla necessità di disporre di arsenali e corpi di guardia, la comunità affittò ocomprò nel tempo diversi locali, fra cui possiamo ricordare alcune di originereligiosa, come quelli di S. Agostino o dell’ex convento di S. Maria. 175. Anche questo capitolo di spesa, come visto in precedenza, torna costante-mente nei verbali esaminati. 176. ASCM, Comunità di Montepulciano - deliberazioni magistrali riguardanti la GuardiaCivica, c. 3r. 177. ASCM, Deliberazioni Preunitarie 153, c.198r. 178. ASCM, Leggi dal gennaio 1847 al 30 luglio 1848, 1 agosto 1848. 179. L’elenco ufficiale dei poliziani che combatterono nelle guerre risorgimen-tali, dal 1848 al 1867, fu edito per volontà del comune nel 1878 dalla tipografiaFumi di Montepulciano ed esposto nella mostra della Biblioteca Comunale diMontepulciano inaugurata il 10 marzo 2011. 180. Il valore italiano, pp. 134-139. Nell’elenco dei caduti di Montepulciano nelleguerre del Risorgimento, edito nel 1878 l’Ilari non compare. 181. ASCM, Maggio 1849 - Sarteano. Cartolare, 2 ottobre 1848. 182. ASCM, Processi Criminali 1847-1849, cc. 758 r-761r. 183. Si trattava della modesta amnistia concessa da Leopoldo II al suo rientroin Toscana dopo l’esilio a Gaeta. 184. ASCM, FILZA IX - carteggio dal gennaio 1848 a tutto dicembre 1849, c. 152r. 185. Si veda l’elenco edito nel 1878 dal tipografo Fumi. 186. Non è chiaro il suo vero nome. Nell’elenco del 1878 fatto stampare dalColombi compare Gioacchino Perelli, mentre in un elenco ufficiale deiCacciatori a Cavallo è contato un Gioacchino Perchi di Montepulciano: Il valoreitaliano. Storia dei fatti d’armi e atti compiuti dal 1848 al 1870 per l’indipendenza d’Italia,vol. I, pp. 134-139. 187. DI PASQUALE 2011, in corso di stampa. 188. Il documento è conservato nella Biblioteca Comunale di Montepulcianoinsieme alle sue medaglie, tra cui una celebrativa dello sbarco dei Mille, confe-rita solo ai volontari che una rigidissima commissione riconobbe come coloroche s’imbarcarono a Quarto e sbarcarono a Marsala.