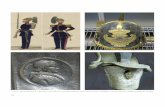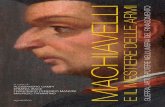Lame benedette. Qualche riflessione per studiare le armi e i loro committenti, in Medioevo: i...
Transcript of Lame benedette. Qualche riflessione per studiare le armi e i loro committenti, in Medioevo: i...
Medioevo: i committenti
Atti del Convegno internazionale di studiParma, 21-26 settembre 2010
a cura di Arturo Carlo Quintavalle
AISAMEAssociazione Italiana Storici dell’Arte Medievale
Electa
In copertinaMoissac, abbazia di Saint-Pierre,chiostro, galleria est, pilastrocentrale, Durand de Bredons;e galleria ovest, pilastro centrale,Iscrizione di fondazione del chiostrodell’abate Ansquitil, 1100(foto A.C.Q.)
Enti promotori
Comune di ParmaFondazione CariparmaUnione Parmense degli IndustrialiCamera di Commercio di Parma
Comitato scientifico
Francesco AcetoMaria AndaloroMichele BacciXavier Barral i AltetMiklós BoskovitsJean-Pierre CailletAntonino CalecaEnrico Castelnuovo Manuel Castiñeiras GonzàlesLaura CavazziniFulvio CerviniMarco CiattiEnnio ConcinaRoberto CoroneoFabrizio CrivelloAnna Maria D’AchilleAndrea De MarchiClario Di FabioMaria Monica DonatoMario D'OnofrioGrazia Marina FallaEric FernieFrancesca Flores d’ArcaisMaria Luigia FobelliFrancesco GandolfoJulian GardnerRoberto GreciAntonio IacobiniWerner JacobsenHerbert KesslerGiovanni LorenzoniSilvia MaddaloGiordana Mariani CanovaAnna Rosa MasettiMaria Raffaella MennaJohn MitchellAlessio MonciattiXenia MuratovaEnrica NeriGiulia Orofino Valentino PaceArturo Carlo QuintavalleNicolas ReveyronMarina RighettiSerena RomanoMarco RossiLucinia SpecialeAlessandro TomeiGiovanna ValenzanoJean Wirth
Comitato organizzatore
Arturo Carlo QuintavalleMaria AndaloroXavier Barral i AltetManuel Castiñeiras GonzàlesFrancesco Gandolfo
Segreteria scientifica
Francesca Stroppa
Comitato esecutivo
Stefania BabboniMaria Pia BranchiCarlotta Taddei
www.electaweb.com
©2011 Mondadori Electa S.p.A.,MilanoTutti i diritti riservati
Secondo uno dei film in costume più squinternati degli ultimitempi1, Federico Barbarossa se ne andava in giro con una speciedi “pittoresca daga stile Tolkien-Conan” con inciso sull’elsa nomee titolo – Federicus Imperator – a lettere goticheggianti belle gran-di, in modo che il suo pubblico (compreso quello del film) potes-se leggerle comodamente (un po’ come i giocatori di calcio o dibasket che portano il nome sul dorso della maglia). “A chi avessescritto il suo nome così anziché nella forma Fridericus, l’impera-tore avrebbe fatto tagliare la mano destra”. Peccato infatti chenon solo quest’uso non fosse così invalso, a quanto ne sappiamo,ma che nemmeno un oggetto di quella fisionomia fosse ben do-cumentato nel XII secolo. Non conosciamo infatti spade atrofiz-zate con elsa larga dai bracci ricurvi come quelli, né peraltro con-notati in chiave così insistentemente epigrafica (fig. 1). Nel farfabbricare – ovvero aggiornare – la spada dell’impero, Ottone IVdi Braunschweig sceglierà di inserire il proprio blasone sul pomoe un’iscrizione beneaugurale di tutt’altro tenore sul verso. Ma noncerto il suo nome. Eppure il rapporto tra personaggio di rango– dunque committente – e la propria spada, dunque la personaliz-zazione dell’arma, è una costante della cultura medievale, anzi: unadi quelle costanti che ha finito per influenzare e corroborare, conla mediazione di letteratura, arti figurative e cinema, la nostra im-magine del Medioevo. Senza scomodare Excalibur, basterà ram-mentare l’enfasi con cui Nicolò scrive Durlindana sulla lama diRolando a Verona (fig. 2), vero attributo che rende riconoscibile ilcavaliere2. Mai come in questo caso, il committente è definito dal-la sua spada. D’altronde, la personalità del proprietario dell’armaera molto spesso la ragione per cui l’arma veniva tesaurizzata e col-lezionata. Gli inventari gonzagheschi citano le armi di Oggeri ilDanese3, Jean Baptiste Carré pubblica alla fine del Settecento ri-dondanti armature manieriste da pompa spacciate per quelle diRolando e Goffredo di Buglione, e tra i cimeli allestiti da VivantDenon nella Salle des Victoires al Louvre per ordine di Napoleonenel 1807 spiccano pezzi non meno personalizzati, come l’elmo e loscudo di Attila4.
Ma non tutti i possessori di armi medievali valevano Rolandoo Barbarossa (quello vero o quello del film). A Giotto gran dipinto-re è dato uno palvese a dipingere da un uomo di picciolo affare.Questo l’argomento di una novella di Franco Sacchetti – la nume-ro sessantatré su trecento – nota soprattutto perché divulga l’im-magine di un artista-intellettuale cosciente del proprio rango e del-la propria dignità, riluttante a sporcarsi le mani con lavori disdice-voli, e altrettanto fermo nel selezionare i committenti con cui in-teragire. In verità Sacchetti finisce per illuminare non solo la figu-ra dell’artista-umanista, ma pure quella di un cliente che può as-surgere a paradigma di una committenza ambiziosa ma poco at-trezzata, smaniosa di autorappresentarsi senza bene conoscere imezzi della rappresentazione. E che gran conto faceva sia dell’ar-ma in quanto blasone che dell’arma in quanto scudo. Un parvenudi recenti fortune ma di oscuri natali chiede all’artista di dipinger-gli “l’arme mia” su un palvese, cioè su un grande scudo come quel-li imbracciati dalle fanterie comunali, per l’occasione portato daun servitore. Giotto si indispettisce sia perché gli viene chiesto unlavoro da pittori di seconda fascia, sia perché il suo committentenon i ha i natali, cioè i titoli, per comportarsi in questo modo.
“‘Mai non mi fu recato palvese a dipingere; e costui che ‘l recaè uno omicciatto semplice, e dice che io gli facci l’arme sua, comese fosse de’ reali di Francia; per certo io gli debbo fare una nuovaarme’. E così pensando fra sé medesimo, si recò innanzi il dettopalvese, e disegnato quello gli parea, disse a un suo discepolo des-se fine alla dipintura. E così fece. La qual dipintura fu una cervel-liera, una gorgiera, un paio di bracciali, un paio di guanti di ferro,un paio di corazze, un paio di cosciali e gamberuoli, una spada, uncoltello e una lancia”5.
Naturalmente l’omicciatto si offende e trascina Giotto davanti aun giudice, il quale dà ragione all’artista, sentenziando che il com-mittente deve tenersi lo scudo (dipinto) e dare al pittore sei scudi(in moneta sonante). Il committente di cui parla Franco Sacchettinon esaurisce certo la casistica dei committenti medievali delle ar-mi, ma certo è un punto di partenza interessante. Egli chiede di di-pingere l’insegna del casato – l’arme, appunto –, ma il supportodel dipinto richiesto è un’arma, cioè uno di quegli scudi che dava-no fior di lavoro a legioni di pittori in genere meno accreditati diGiotto, ma con le dovute eccezioni. Se il Medioevo tardo ci ha ser-bato qualche scudo dipinto tutt’altro che disprezzabile, non di-mentichiamo che ancora la Medusa di Caravaggio sarà una rotellada parata6. Secondo Sacchetti, la committenza di armi del suotempo non era necessariamente altolocata né acculturata. Potevaanzi essere una committenza ambiziosa e desiderosa di legittima-zione, quasi sempre in grado di spendere ma non sempre in gradodi capire.
Davanti alle armi, non solo medievali, lo storico dell’arte mo-derno si trova spesso nella condizione sia di Giotto che dell’omic-ciatto. Salvo alcuni oggetti di eccellenza, guardati piuttosto comemanufatti d’arte suntuaria, le armi entrano molto a stento nel ca-none delle arti, tanto che si preferisce lasciarne lo studio a specia-listi puri, che non di rado privilegiano un approccio prevalente-mente tecnico (documento eloquente ne sono ancora gli studi, purfondamentali e impeccabili, di Lionello Boccia), considerando lealtre arti soltanto come serbatoio iconografico. Al tempo stesso sicomporta da omicciatto perché delle armi vede soltanto uno o piùaspetti prevalenti, e in genere quello estetico non è tra questi. Il ri-sultato è la prevalenza schiacciante di una bibliografia iperspeciali-stica generalmente disertata sia dagli storici dell’arte che dalla mag-gioranza degli storici tout court, ove prevalgono attitudini descrit-tivistiche e tassonomiche fondamentalmente disinteressate a stabi-lire connessioni storiche se non con la storia militare e alla menopeggio con quella delle attività metallurgiche. Una prova indirettaviene dalle immagini fotografiche che per decenni hanno accom-pagnato la letteratura specializzata: bianchi e neri a volte di rag-guardevole qualità tecnica e non privi di efficacia espressiva, manon sempre adeguati a dar conto della complessità formale di og-getti difficili da restituire nella loro tridimensionalità come nellafunzionalità; per tacere della componente cromatica, quando essariesce determinante. La nostra conoscenza si è così modellata su unapproccio prevalentemente bidimensionale a un universo di ogget-ti concepiti per venire indossati e maneggiati, dunque per muover-si nello spazio in necessaria interazione con i loro manovratori eindossatori, che molto spesso coincidevano con i loro committen-ti. E se anche il contributo che state leggendo è illustrato da alcu-
Lame benedette. Qualche riflessione per studiare le armi e i loro committenti
Fulvio Cervini
376
ne fotografie d’annata, tratte dalle grandi sintesi di Boccia, è so-prattutto per sottolineare con quali difficoltà ricognitive deve mi-surarsi tuttora lo studioso, e a maggior ragione se intende fare unosforzo per leggere le armi come documenti storici proprio in quan-to manufatti di un altissimo artigianato che sconfinava non di ra-do nella creazione artistica. Non si vuole distinguere sterilmentetra poesia e non poesia, ma semmai trovare delle chiavi per rian-nettere armi e armature a una storia delle forme che non può farea meno di esse7.
Per riconsiderare le armi medievali anche in un’ottica di civiltàfigurativa non sembra tempo perso ripartire dai committenti.Qualche ragionamento in merito aiuterà a comprendere intantochi sia da intendere per committente (più che in altri campi fab-brili, emerge per esempio il ruolo di una committenza collettiva eistituzionale, dei comuni e degli stati); in che misura il committen-te possa influenzare il prodotto finito, cioè in che termini l’armasia il frutto di un negoziato; e come non sempre il rapporto tra ar-tefice e committente osservi un modello bilaterale, laddove è fre-quente l’intervento di mediatori più o meno qualificati. Ecco dun-que che queste poche considerazioni potrebbero aiutarci anche adiscutere di paternità delle opere e di geografia culturale adottan-do punti di vista non troppo frequentati.
Chiedersi a chi siano destinate le armi illumina anche sulla for-nitura dei modelli, e sull’uso che se ne fa. Tra gli oggetti più sin-golari dello “stile manuelino” portoghese, ormai al principio delXVI secolo, sono olifanti d’avorio intagliati da artisti di culturaSapi, nella Sierra Leone, per una committenza europea che ha
1. Manifesto del film Barbarossadi Renzo Martinelli, 2009
2. Verona, duomo, Nicolò, Rolando,particolare del portale maggiore,1139-40 circa (da Boccia-Coelho1975)
377
chiesto esplicitamente una decorazione all’europea, piuttosto cheall’africana: tanto che vi sono illustrate scene di caccia che i Sapinon potevano avere mai visto, e che sono desunte da modelli gra-fici, come le illustrazioni xilografiche dei libri d’ore parigini (figg.3-4)8. Però gli intagliatori hanno interpretato quei modelli con lasensibilità propria, non limitandosi a copiarli ma aggiungendovitemi e motivi derivati invece dalla loro tradizione. Li hanno, cioè,africanizzati; ma con lo scopo finale di farli circolare tra non afri-cani. Questo singolare incrocio, che vanta pochi termini di para-gone, avviene guarda caso su oggetti che non sono armi in sensotecnico, ma sono molto vicini alle armi. Qualche volta, dunque, laproduzione di armi ed equipaggiamenti destinati alla guerra e/o al-la caccia può funzionare anche da laboratorio di sperimentazionicreative e di intersezioni culturali.
In genere, nel Medioevo come prima e dopo, le armi si fabbrica-no per essere adoperate in combattimento (ovvero per cacciare), edunque devono prima di tutto rispondere a requisiti funzionali. Manon dovevano servire soltanto a spaccare teste e braccia. Esse pote-vano e dovevano essere esibite alla stregua di un qualsiasi altro og-getto suntuario, se non proprio opera d’arte figurativa. Non perniente, nel De laude novae militiae, Bernardo di Chiaravalle apprez-za, intorno al 1136, l’arredo interno del “Tempio” di Geusalemme,dove i cavalieri Templari hanno sostituito lumiere, oro e gemme conscudi, selle e lance: “Ornatur tamen hujus quoque facies templi, sedarmis, non gemmis; et pro antiquis coronis aureis, circum penden-tibus clypeis paries operitur, pro candelabris, thuribulis atque urceo-lis domus undique frenis, sellis ac lanceis communitur”9.
La pratica non era limitata alle sole chiese degli ordini milita-ri, tanto che gli stessi confratelli di Bernardo, nel capitolo genera-le del 1203, decretano che vengano rimossi gli scudi appesi nellechiese cistercensi, evidentemente per contrastare quel che dovevaessere diventato un abuso, ovvero una pratica non pertinente al ri-gore dell’ordine10. D’altra parte le testimonianze tardomedievalidi armi, scudi e bandiere esposte all’interno delle chiese, specie inrelazione a monumenti funerari, è tanto largamente documenta-ta da renderci un’immagine molto alternativa di spazi sacri larga-mente profanizzati, in cui armi e insegne valevano come ex voto ecantavano le glorie del defunto. Basti ricordare la descrizione del-l’interno di Santa Croce a Firenze nel XV secolo, tramandata nelSettecento da Giuseppe Richa, o le celebri armature di SantaMaria delle Grazie a Curtatone presso Mantova.
Certo che i Templari cari a Bernardo non avevano molto da esi-bire, in termini propriamente artistici e figurativi. L’equipaggia-mento di un cavaliere dei secoli XII e XIII concedeva poco all’or-nato11, e l’esposizione di armi in quel contesto valeva sostanzial-mente come un’offerta a Dio, cui non si dedicavano ori e tesori,ma si consacrava l’uso assennato e ispirato della forza. Prima delladiffusione dell’araldica individuale, che prende piede assai largonel corso del XIII secolo, e prima dell’affermazione dell’armaturadi piastre di acciaio, che si codifica intorno al 1370-80, gli ogget-ti deputati per la personalizzazione delle armi restano essenzial-mente lo scudo e la spada. Anzi, soprattutto la spada, perché loscudo era generalmente dipinto con l’insegna araldica, e quindidocumentava non tanto la persona quanto la stirpe. Era in sostan-
3. Torino, Armeria Reale,intagliatore Sapi, Olifante da caccia,1495-1521 circa
4. Torino, Armeria Reale,intagliatore Sapi, Olifante da caccia,particolare, 1495-1521 circa
5. Toledo, cattedrale, spadaio e orafocastigliani, Spada di Sancho IV di Castiglia, ante 1298 (da Oakeshott 2004)
378
za la spada a parlare realmente di chi la portava, tanto che essa po-teva e doveva letteralmente accompagnare il cavaliere nel viaggioultraterreno. Perché se la spada era deposta sulla tomba, o scolpitanell’effigie funeraria del cavaliere, spesso e volentieri poteva segui-re il defunto nel sarcofago. Così fu, per esempio, dello stocco nelduomo di Monza appartenuto a Estorre Visconti, morto nel 1413e per breve tempo signore di Milano, che fu ritrovato nella sua se-poltura12. Ovvero – facendo un passo indietro per cronologia mauno avanti per qualità – la spada che nel 1298 accompagnòSancho IV di Castiglia nella tomba nella cattedrale di Toledo13. Ilfornimento, che alterna stemmi di Castiglia in vetro dipinto conincisioni cufiche e intrecci arabeggianti nel pomo e nell’elso (fig. 5),è a tutti gli effetti un’opera di oreficeria che riflette una certa per-meabilità culturale della penisola iberica, e pone comunque an-che un problema di percezione. Esso richiede infatti una contem-plazione molto ravvicinata, che può essere compiuta o dal deten-tore stesso della spada, o da coloro che erano tanto intimi del so-vrano da potersi avvicinare a lui per ammirare una decorazionecosì miniaturistica.
Rispetto a un dipinto o una scultura, un’arma è un’opera se-movente, che funziona al meglio quando viene indossata (e ado-perata, non necessariamente in modo cruento). Ma ammirarla èquestione di prossemica, perché sono in pochi ad avervi reale ac-cesso. A meno che non si ritenesse importante che vi fossero sim-boli e ornati indipendentemente dal fatto che fossero visibili.Quasi si confidasse in un valore magico che doveva essere attri-buito anche a molte delle incisioni ancora leggibili sulle lame, eper noi altrimenti incomprensibili (combinazioni di lettere e cro-ci, per esempio).
Così bisogna essere molto vicini al cavallo per apprezzare l’or-nato di un raro morso mediotrecentesco, entrato nell’Ottocentonelle raccolte sabaude ma decorato probabilmente a Napoli da ar-tisti di educazione limosina, che commemora le nozze tra AngeloAcciaiuoli e una Grimaldi, figlia di Antonio, signore di SanGiorgio in Calabria (figg. 6-7)14. Forse proprio alla donna potevaappartenere il cavallo, visto che lo scudo quadrato è in genere ap-pannaggio delle dame. E allora converrebbe chiedersi chi abbiascelto la formula iconografica e decorativa del morso (e verosimil-mente di sella e gualdrappa): se cioè sia stata la donna in primapersona, o qualcun altro non abbia piuttosto scelto per lei. Sia co-me sia, anche le armi e i loro accessori valgono come luoghi diostentazione e di esibizione di simboli e insegne, ma la loro pub-blicità è in genere piuttosto riservata. Ancora una volta, per legge-re quel che è dipinto sul morso non ci si può allontanare dal caval-lo che di pochi metri.
Certo altrimenti intelligibile è il drago che connota un bel mar-tello d’arme al Museo Correr, databile al tardo secolo XIV e appar-tenuto presumibilmente a Francesco il Vecchio da Carrara, signo-re di Padova, il cui stemma è inciso quasi fosse un marchio di ap-partenenza, più che un’insegna del potere da esibire (fig. 8)15.Evidentemente doveva bastare e avanzare la stessa morfologia zoo-morfa del martello, col drago che ne inghiotte la punta. In questaluce, l’ostentazione della forza ferina ha nettamente la meglio sul-la comunicazione araldica, ma vale in un certo senso come un’in-segna. Il drago sul martello non era da tutti, e doveva convenire a
6. Torino, Armeria Reale, orafolimosino-angioino, Morso da cavallocon stemmi Acciaiuoli e Grimaldi,metà del XIV secolo
7. Torino, Armeria Reale, orafolimosino-angioino, Morso da cavallocon stemmi Acciaiuoli e Grimaldi,particolare, metà del XIV secolo
379
condottieri di rango. E forse il rango era ribadito sia dalla scelta delmostro che dalla fattura dell’oggetto: mostrare un martello comequesto significa infatti esporre al tempo stesso un’arma e una mi-croscultura, per giunta realizzata in un materiale non propriamen-te facile da lavorare in termini plastici, come l’acciaio. Un altrodrago, non per caso, rende speciale l’elsa della spada dell’impera-tore Sigismondo I (incoronato come tale nel 1433), che peraltro sisegnala anche per ulteriori peculiarità materiche del fornimento,come l’impugnatura eburnea (fig. 9)16. Avendo Sigismondo fonda-to l’ordine cavalleresco del dragone, il movimentato animaletto ri-sulta qui non solo pertinente, ma addirittura necessario, specie seconsideriamo la presumibile funzione cerimoniale dell’oggetto.
A confrontare questi pezzi con un martello e una spada di quel-li correntemente usati in battaglia, viene da pensare che deroghe alcanone, ovvero una più marcata connotazione plastico-figurativa,dovessero convenire soprattutto ad armi che fossero espressione di-retta di un sovrano o di un signore di alto lignaggio. Quando unaspada è essenzialmente un’insegna di comando, ovvero entra a pie-no titolo nei regalia utilizzati nelle cerimonie di incoronazione,tende addirittura a dissimulare la propria natura di strumento bel-lico per assumere la fisionomia di oggetto di oreficeria17. Sarà il ca-so della spada di Essen, donata da Ottone III alla badessa Matilde;ovvero del fodero della già ricordata spada dell’impero, una galle-ria di microsculture a sbalzo, eseguita al tempo di Enrico IV, chemostra i quattordici imperatori da Carlo Magno a Enrico III, edunque fornisce una legittimazione iconografica e ideologica aogni nuovo portatore della spada. Questi due capolavori dell’XI se-colo ci rammentano come il fodero non fosse ritenuto meno im-portante dell’arma vera e propria, quale supporto sia di ornamen-ti che di simboli e immagini dalla forte valenza politica e istituzio-nale. La regola è confermata da un’eccezione come la spada dell’in-coronazione di Federico II, fabbricata verso il 1220 da un labora-torio siciliano: eccezione per il rivestimento di tessuto con abbon-dante ricorso alle perle e inserimento di placchette smaltate, cheimmediatamente dichiara il suo contenuto come qualcosa di mol-to diverso da un’arma da guerra (fig. 10). Visto che la decorazioneè coordinata con i guanti, pure conservati, e con la celebre cuffiadi Costanza d’Aragona, il minimo che si possa pensare, ben den-tro i confini dell’ovvietà, è che lo stesso Federico abbia interferitonon poco nella realizzazione di questi oggetti. I quali, però, eranodestinati a cambiare detentore, per rappresentare la trasmissione delpotere: e nel segno di una volontà di legittimazione storica, potevaben trattarsi di una legittimazione à rebours. Per questo il CarloMagno di Dürer (Norimberga, Germanisches Nationalmuseum)ostenta una spada imperiale che a giudicare da quanto si vede sem-bra proprio quella di Federico II. Forse discutendo di armi medie-vali non dobbiamo fermarci ai committenti, ma considerare anchetutti i loro successori che le hanno adoperate ed esibite, magari ag-giornandole e integrandole, diventando in un certo senso dei nuovicommittenti. Come i massari di una cattedrale che curano il re-stauro di una chiesa esistente, ovvero vescovo, capitolo e/o comuneche se ne gloriano, facendo proprio il messaggio culturale, ideolo-gico ed estetico di quell’edificio ben oltre i tempi della sua proget-tazione e dell’avvio del cantiere.
Una spada medievale è in un certo senso garanzia di una tradi-
8. Venezia, Museo Correr,manifattura dell’Italia settentrionale,Martello d’arme, forse di Francescoda Carrara, particolare, 1380-90circa (da Boccia-Coelho 1975)
9. Vienna, Schatzkammer, spadaio e orafo dell’Europa centrale, Spada di Sigismondo I, particolare del fornimento, primo terzo del XV secolo (da Boccia-Coelho 1975)
380
zione e di un diritto. Ciò spiega perché Luigi XIV, nel celeberrimoritratto con l’abito dell’incoronazione dipinto da Rigaud (Parigi,Musée du Louvre), indossi una spada ben più antica dei giorni suoie per giunta molto famosa, perché è la cosiddetta Spada diCarlomagno, fino al 1793 a Saint-Denis e oggi al Louvre (fig. 11)18.Carlo Magno non è, in questo caso, il committente, se non a livel-lo mitico. Le parti più antiche dell’oggetto, da riconoscere nel po-mo e forse nelle parti a fogliami dell’elsa, sembrano infatti databi-li all’XI secolo, mentre al tardo XII dovrebbero convenire i dra-ghetti stilizzati che formano i bracci dell’elso; l’impugnatura è as-sai verosimile rilavorazione ottocentesca di un pezzo due-trecente-sco, mentre la lama è affatto moderna. Il notevole fodero si propo-ne come oggetto di oreficeria gotica della seconda metà del XIII se-colo, con pietre ben distanziate contro un fondo liscio e privo difiligrane. Forse non è un caso che la spada venga ricordata per laprima volta col suo nome famoso – Joyeuse – in occasione dell’in-coronazione di Filippo III l’Ardito, nel 1271: fatto sta che spada efodero non sembrano pertinenti, perché il profilo del fodero im-
pedisce alla lama di entrarvi completamente. Siamo allora in pre-senza di un manufatto composito che non solo non può attribuir-si per evidenza filologica e stilistica al suo primo e tradizionale de-tentore, ma che ha avuto in realtà molti padri.
La questione della paternità è un problema centrale nello stu-dio delle armi medievali. Una spada o un’armatura sono il fruttodi un processo progettuale e creativo che vede il coinvolgimento dipiù figure di quanto siamo portati ad ammettere. Ciò vale soprat-tutto nel caso di committenze statali: la maggior parte delle armiprodotte nel Medioevo sono manufatti da guerra che servono, peresempio, ad armare le fanterie di un grande comune italiano, cheordina pertanto ingenti quantitativi di pezzi affatto seriali, macontraddistinti da un apprezzabile standard qualitativo; e al tempostesso, magari, si premura che su scudi e bandiere (ma persino sul-le balestre, come è attestato a Genova) ci siano colori e insegne del-la città19. Come si muova in questo campo un comune (e in gene-rale uno stato) medievale è difficile dire oltre le valutazioni dei ca-si specifici, in assenza di studi davvero comparativi. Ma quei casi
10. Vienna, Schatzkammer, orafosiciliano, Spada cerimoniale diFederico II di Svevia, particolare del fornimento e del fodero, 1220circa (da Boccia-Coelho 1975)
11. Parigi, Musée du Louvre, orafi e spadai francesi dei secoli XI-XIII, e restauratore del secolo XIX, Spadadetta di Carlo Magno, particolaredel fornimento e del fodero
381
possono valere per un orientamento utile anche allo storico dell’ar-te. Molto famoso è il passo del De Magnalibus Mediolani diBonvesin de la Riva, da cui apprendiamo che nel 1288 c’erano incittà più di un centinaio di armorari, e per giunta una moltitudi-ne di scudai, tanto che l’autore manco ne fornisce, come per le al-tre categorie professionali, il numero preciso20. A Milano, che pro-prio nel corso del Duecento diventa uno dei maggiori centri euro-pei per la fabbricazione delle armi, conquistando rinomanza asso-luta fra Tre e Quattrocento, si può dire che vi fosse l’imbarazzo del-la scelta. La pubblica amministrazione aveva gli armaioli in casa, epoteva semmai giocare sul rapporto tra qualità e prezzo, innescan-do una concorrenza virtuosa. Dove non c’era una tradizione inquesto campo, la committenza doveva però industriarsi diversa-mente, magari non limitandosi alle importazioni ma provando adalimentare una produzione propria. Nel 1461 – i documenti sonotardi ma rendono l’idea – lo stato estense stipula un accordo conmastro Ottolino da Milano perché si trasferisca a Ferrara con la fa-miglia e vi apra una bottega di armoraro con due maestri e duegarzoni. Non conosciamo bene le fortune di questa impresa. Sta difatto che nel 1469 Nicolò d’Este compra ingenti quantitativi di ar-mi a Brescia da Giovanni da Vimercate, pure milanese21.
Il caso di Vercelli è piuttosto interessante. Produttori locali non
dovevano mancare già per tempo. Due spadai, Bonifacio e Arduino,possiedono una casa in città nel 1167, e uno spadaio, Omodeo, èdocumentato da atti del 1209 e del 1211. Nella Società di SantoStefano sono attestati lo spatarius Michele nel 1224 e il coltellariusPietro nel 124622. Più tardi la fabbricazione di armi non sarà cosaesclusivamente cittadina, se il Comune pagherà nel 1392 unSimone da Siena per impennare (di carta) i verrettoni delle bale-stre. Al principio del XV secolo, però, il mercato di riferimento èormai quello milanese, dove partite molto cospicue di armi sonoacquistate dal comune, per esempio, nel 1426 e nel 1427. Nel1448 succede peraltro un fatto minimo ma singolare, che credopossa gettare luce nuova sulla committenza “istituzionale”: il co-mune concede la cittadinanza a certi Giovanni della Mola, diCasale, e Antonia de Coxola, a patto che in cambio consegnino trecerbottane (cioè colubrine) di bronzo (due l’uomo e una la don-na)23. Già che l’ente pubblico richieda piccole bocche da fuoco èsegno dei tempi che suscita interesse; ma forse lo è ancor più cheesso eserciti una committenza indiretta: perché poi sono i nuovicittadini, Giovanni e Antonia, a doversi attivare per cercarsi (e ve-rosimilmente farsi fabbricare) le colubrine richieste.
Su questo orizzonte poteva diventare determinante il ruolo diun mediatore che in genere non esiste in relazione alle altre cate-
12. Torino, Armeria Reale, spadaiofranco-piemontese (?), Spada detta di san Maurizio, con fodero, secolo XIII
13. Torino, Armeria Reale, spadaiofranco-piemontese (?), Spada detta di san Maurizio, particolare del fornimento, secolo XIII
382
14. Torino, Armeria Reale, maestrodi corami franco-piemontese,Custodia della spada di sanMaurizio, 1434-38
15. Torino, Armeria Reale, maestrodi corami franco-piemontese,Custodia della spada di sanMaurizio, particolare, 1434-38
16. Milano, Civiche Raccolte d’ArteApplicata, coltellaio inglese (?) e intagliatore dell’Italia settentrionale (?),Coltello eucaristico, da Sant’Andrea a Vercelli, secoli XII-XIII
383
gorie di manufatti artistici medievali (se non per le stoffe e le gem-me): il mercante. Perché se è vero che il mercante d’arte in sensomoderno è figura estranea al Medioevo, esistono purtuttavia i mer-canti di armi. Fra Due e Trecento, questo mercato si era del restofatto sempre più complesso e articolato. Prima che si affermasserole armature complete come unitario prodotto “sartoriale” di unasola bottega, e dunque tagliato su misura per un singolo commit-tente, i cavalieri erano soliti costruirsi degli assemblaggi persona-lizzati di pezzi, acquistando separatamente, e da vari rivenditori, ilbacinetto, il petto, i cosciali, la cotta di maglia, le armi offensivestesse. Di qui la specializzazione degli artigiani: per cui, oltre la tra-dizionale distinzione tra armorari e tarconieri, c’era chi fabbricavadi preferenza bacinetti e chi spade; ma anche la necessità di mer-canti a loro volta specializzati, che sapessero trovare per il clientequel che meglio serviva, e al prezzo migliore.
Assai eloquente è in merito l’archivio del più famoso (e per noimeglio documentato) mercante del Trecento, il pratese FrancescoDatini. Nel 1396 un suo amico, Ridolfo di Lanfranco da Prato, glirichiede una cotta di maglia d’acciaio, e per procurarglielaFrancesco scrive subito al suo agente a Milano, Tommaso di SerGiovanni. La richiesta non è di facile soluzione, perché Ridolfovuole una maglia molto leggera, e non sono molti gli armorari mi-lanesi che al momento hanno disponibili maglie di quel tipo.
Neanche uno dei più accreditati su piazza, Simone Correnti (oCorrente), possiede un pezzo che faccia al caso suo (in ogni caso,scrive Tommaso, una cotta fatta da lui costerebbe più della media:cioè, sui 19 fiorini). Alla fine, dopo due mesi di ricerche e tratta-tive, la cotta è pronta: è costata 13 fiorini e 9 soldi, e nel mezzoTommaso ha pure spedito a Firenze un campione di maglia24.Dunque il committente non ha mai trattato con l’armoraro, macon un’agenzia mercantile. I clienti di Datini, insomma, vanno daldettagliante e non dal fabbricante. Sono cioè committenti debolie forti al tempo stesso: perché hanno disponibilità e richieste par-ticolari, ma non al punto da trattare direttamente con l’autore.Anche perché, magari, l’autore non è disponibile sul posto.
Alla fine degli anni settanta, ad Avignone, Datini aveva intrat-tenuto proficui rapporti con Martino da Milano, armoraro specia-lizzato nella produzione di bacinetti. Nell’arco di un cinquanten-nio, dal 1366 al 1410, Datini importa bacinetti un po’ dappertut-to: da Firenze e Milano, come par ovvio, ma anche da Genova,Lione, Parigi, e dalla Germania. La relazione con Martino è tutta-via interessante, perché costui è un milanese che tiene bottega adAvignone, lavora per mercanti vari – in questo caso un toscano –e a sua volta si procura i fogli di acciaio e i coppi grezzi da rifinirenon in Provenza né in Lombardia, ma a Pinerolo e Avigliana, dun-que in Piemonte, sulle Alpi Occidentali25. Esisteva insomma una
17. Vienna, Schatzkammer,manifattura europea, Santa lancia,qui mostrata dentro la Crocedell’Impero, secoli VIII, XI e XIV
18. Vienna, Schatzkammer,manifattura europea, Santa lancia,priva di fascette auree, secoli VIII, XI e XIV
384
prelavorazione che avveniva presso i luoghi di estrazione del mine-rale, là dove c’erano industrie metallifere; e una lavorazione di qua-lità che poteva avvenire anche molto lontano dai luoghi dove gliartefici si erano formati. Come si potrà allora definire, in terminidi geografia artistico-artigianale, un bacinetto di Martino daMilano? Milanese? Provenzale? O non piuttosto, “internazionale”?E i committenti di Martino, alla fine, chi sono? Soprattutto tipicome Francesco, che le armi non le portano ma le vendono. E fil-trano le richieste di chi invece le vuole e le deve portare. In un cer-to senso, proprio per la loro funzione intermediaria, i mercantid’armi sono quasi come i fabbriceri di una cattedrale. Non costrui-scono, non progettano e non finanziano direttamente nulla, maanche a loro si deve il buon esito dell’impresa.
Pur vero, per tornare a oggetti fuori dalla media, che vi sono ar-mi dal destino singolare, perché conservate come reliquie. Bastipensare alla cosiddetta alabarda di san Giusto (in realtà uno spie-do del XIII secolo), o alla “spada nella roccia” di Galgano Guidottia Montesiepi. Sarà anche il caso della già ricordata spada dell’im-pero, perché la si attribuiva a san Maurizio. Ma nell’abbazia diSaint-Maurice d’Agaune si conservava fino al 1591, quando ven-ne portata a Torino da Carlo Emanuele I, l’altra e più verace spa-da che si riteneva posseduta dall’ufficiale romano Maurizio: chenon è, malgrado la tradizione, una spada tardoantica, ma un ma-gnifico esemplare del primo Duecento (figg. 12-13). Di essa si co-mincia a parlare però dopo il 1434, quando Pierre Fornéry diven-ta abate d’Agaune, restando poi in carica fino al 1438. Egli com-missiona per questa spada, che già aveva il suo semplice fodero ori-ginale in legno rivestito di pergamena, una spettacolare custodia dicuoio cotto, impresso e dipinto, dove spicca la figura dello stessoMaurizio, vestito come un cavaliere di quegli anni (figg. 14-15)26.Non è da escludere che proprio al Fornéry si debba l’inventio del-la spada, forse vista come abbastanza démodée da passare per roma-na. Oppure può darsi che nel Duecento la spada antica fosse stataconsapevolmente sostituita da una moderna che figurava l’antica.Sia come sia, non è forse un caso che proprio nel 1434 AmedeoVIII di Savoia, di cui Pierre era stato luogotenente generale, si ri-tiri nel castello di Ripaille sul lago di Bourget insieme ai primi ca-valieri dell’ordine di San Maurizio, da lui appena fondato. In talsenso il santo sulla custodia è l’ideale cavaliere mauriziano moder-no, come la spada è suggello e legittimazione del suo agire. L’abated’Agaune è dunque un committente politicamente impegnato, edesteticamente allineato a un gusto cortese che forse può stupirenella custodia di una reliquia, ma trova molti riscontri in quel chesappiamo di armi e bardature in auge presso la corte sabauda deltempo. L’inventario del castello di Torino del 1431 è così prodigodi citazioni di cotte guarnite d’argento e di perle, di bacinetti condecorazioni pure d’argento, di gualdrappe di cuoio, e ancora dispade definite “turche”, probabile ricordo delle spedizioni orienta-li dei Savoia, magari del secolo precedente: citazione che dovrebbeanche farci ragionare sul ruolo svolto dalle raccolte principeschenella circolazione di manufatti “esotici” che spesso e volentieri era-no armi27.
Non è invece, propriamente, né una reliquia né un’arma il col-tello liturgico, destinato cioè a tagliare il pane eucaristico (fig. 16),donato dal cardinale Guala Bicchieri all’abbazia di Sant’Andrea a
Vercelli intorno al 1220, acquistato dopo le soppressioni napoleo-niche per l’Accademia di Brera e finito al Castello Sforzesco, ove èdocumentato dal 186428. Meglio: non lo è integralmente. Secondouna tradizione attestata ancora nel XVIII secolo dal Frova – chetrascrisse gli inventari duecenteschi oggi irreperibili – l’oggetto sa-rebbe stato addirittura il gladius che aveva ucciso TommasoBecket, e come tale acquisito da Guala e poi consegnato, con tut-te le attenzioni che si riservano a una reliquia, all’abbazia che eglistesso aveva fatto costruire nella sua città. Non è inverosimile cheGuala potesse entrare in possesso di un oggetto legato a Tommaso,per via del suo rango e delle sue missioni diplomatiche inglesi. Madi fatto il coltello non sembra prevedere un uso cruento. Il mani-co è intagliato in legno di bosso con le raffigurazioni dei mesi29, maè pur vero che esso potrebbe essere stato fabbricato in Italia, e dun-que sancire una “riconversione” dell’oggetto. Non solo, peraltro, lalama risulta troppo sottile per un’arma da offesa, ma quel che stu-pisce è la sua lavorazione a traforo, collegata al suo verosimile usoliturgico. Se davvero in origine si trattava del coltello di un omici-da, bisogna ammetterne una necessaria e profonda rilavorazione.La bibliografia sull’oggetto non ha mai troppo indugiato su questalama; in assenza di un vero dibattito, varrà la pena provare a rilan-ciarne uno partendo da una certa somiglianza tra il coltello vercel-lese e una famosa reliquia conservata a Vienna, che oggi si tende adatare all’VIII secolo ma che già nell’XI secolo doveva avere rag-giunto il suo aspetto attuale (figg. 17-18): mi riferisco alla Santalancia, la cui lama venne aperta a giorno per ospitare un chiododella crocifissione di Gesù, e successivamente protetta da una dop-pia fascetta, una col nome di Enrico IV e una trecentesca30.L’apertura centrale del coltello e le due protuberanze potrebberoleggersi in tal senso come una citazione – analogica e non lettera-le, com’era nello spirito del tempo – della cuspide di lancia credu-ta di Longino. In ogni caso, a quanto ne sappiamo, l’oggetto me-dievale più vicino alla lama del coltello di Guala è proprio l’HeiligeLanze. Se davvero il coltello serviva a tagliare il pane eucaristico –cioè il corpo di Cristo – non era del resto inverosimile che la suaforma evocasse quella dell’oggetto che aveva trafitto il corpo car-nale del Redentore, ma che per questo era diventato, da strumen-to di morte, testimone della Salvezza. Se l’analogia funziona, è al-lora possibile che l’associazione con Becket fosse già duecentesca,e maturata magari nello stesso ambiente di Guala. Sempre che lalama sia stata effettivamente rilavorata sulla matrice di un coltelloinglese. In questo caso l’associazione iconologica non sarebbe me-no significativa, perché rafforzerebbe il valore del martirio conl’assimilazione ancora più esplicita a Cristo. Se la fonte del coltel-lo, comunque, è la Santa lancia, non può che essere stato il com-mittente – e per giunta un committente della cultura e degli in-teressi di Guala – a individuarla e a richiederne esplicitamenteuna sorta di traduzione in un’altra lingua. Il caso vercellese restaindubbiamente isolato nella sua singolarità, e pertanto dobbiamousare molte cautele nel ritenere che operazioni del genere fosserofrequenti. Ma dovrebbe ottenere almeno l’effetto di indurci a ra-gionare sul fatto che molto spesso, nel mondo medievale (e in cer-ta misura anche in quello moderno e contemporaneo) le arminon sono soltanto armi e i loro committenti non sono soltantoguerrieri.
385
1 Si parla naturalmente del Barbarossa di Renzo Martinelli (2009), con RutgerHauer nel ruolo di Federico I e Raz Degan in quello di Alberto da Giussano.Traggo le citazioni da F. Cardini, Omaggio a Federico I di Hohenstaufen il“Barbarossa”, 5/10/2009, in www.francocardini.net, recensione calzante sul tas-so di attendibilità storica di questo immondo polpettone. Se ringrazio qui alcu-ne persone che mi sono state di aiuto, stimolo e giovamento durante le ricerchenon è certo per mescolarle al polpettone, ma semplicemente perché ci troviamoall’interno della prima nota. Sono dunque riconoscente a Gianluca Ameri,Michele Bacci, Xavier Barral I Altet, Enrica Boldrini, Alessandra Guerrini, SantoMaccarrone, Marco Merlo, Maria Giuseppina Romagnoli, Ornella Savarino,Francesca Tasso.2 L.G. Boccia-E.T. Coelho, Armi bianche italiane, Milano 1975, fig. 5.3 M. Scalini, Le armi di “Oggieri” il danese e altre meraviglie delle armerie gonza-ghesche attraverso gli inventari, in Gonzaga. La Celeste Galleria. Le raccolte,Catalogo della mostra, a cura di R. Morselli, Milano 2002, pp. 369-386.4 S.W. Pyhrr, De la Révolution au romantisme: les origines des collections modernesd’armes et d’armures, in Les vies de Dominique-Vivant Denon, Atti del convegno,Parigi 1999, Paris 2001, pp. 621-650. In generale, su questi temi, mi permettodi rimandare a F. Cervini, Medioevo manierista nella Reale Armeria. Spunti di ri-cerca sul collezionismo del XIX secolo, in Dal disegno alla fotografia. L’Armeria Realeillustrata 1837-1898, Catalogo della mostra, a cura di P. Venturoli, Torino 2003,pp. 17-54.5 L’edizione consultata è F. Sacchetti, Il Trecentonovelle, a cura di D. Puccini,Torino 2008 (I ed. 2004), pp. 196-198.6 Cfr. Caravaggio. La Medusa. Lo splendore degli scudi da parata del Cinquecento,Catalogo della mostra, Cinisello Balsamo 2004.7 Particolarmente indicativi sono ad esempio i lavori di Ewart Oakeshott, peral-tro uno degli studiosi che con maggiore continuità si sono occupati di spade me-dievali: per esempio The Sword in the Age of Chivalry, Woodbridge 1997 (I ed.1964), o il comunque indispensabile Records of the Medieval Sword, Woodbridge2004 (I ed. 1991); essi sembrano avere come obiettivo principale quello di defi-nire e delimitare tipologie, non di rado ricorrendo a oggetti di controllo nonsempre agevole (e talvolta di autenticità dubbia) perché appartenenti all’univer-so del collezionismo privato. Altro spessore hanno i contributi di LionelloGiorgio Boccia (anche in collaborazione con Eduardo Coelho), che per l’area ita-liana costituiscono punti di riferimento imprescindibili benché ormai bisognosidi un aggiornamento più sensibile verso il contesto e i rapporti con le altre arti.Si vedano così Boccia-Coelho, Armi bianche cit; Id., L’arte dell’armatura in Italia,Milano 1967; L.G. Boccia-F. Rossi-M. Morin, Armi ed armature lombarde,Milano 1980; L.G. Boccia, Armi difensive dal medioevo all’età moderna.Dizionario terminologico, Firenze 1982; Guerre e assoldati in Toscana 1260-1364,Catalogo della mostra, a cura di L.G. Boccia, Firenze 1982. Sulla guerra – e ingenerale l’uso, anche ludico, delle armi – nel Medioevo può essere utile partiredalla bibliografia raccolta in A. Barbero, La cavalleria medievale, Roma 1999, eF. Bargigia-A.A. Settia, La guerra nel medioevo, Roma 2006. Ottime bussole perorientarsi saranno oeuvres de reference come Ph. Contamine, La guerra nelMedioevo, Bologna 2002 (I ed. 1986; ed. or. La guerre au Moyen Age, Paris1980); D. Balestracci, La festa in armi. Giostre, tornei e giochi del Medioevo, Bari2001; A.A. Settia, Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel Medioevo, Bari 2002.Fanno del resto gioco esplorazioni mirate in cui il riscontro archeologico vienericondotto al sistema produttivo, in base a dati di scavo come d’archivio. Vediper esempio D. De Luca-R. Farinelli, Archi e balestre. Un approccio storico-archeo-logico alle armi da tiro nella Toscana meridionale, “Archeologia Medievale”, XXIX2002, pp. 455-487. Giustamente c’è un volume dedicato agli armamenti nellacollana delle Typologie des sources du Moyen Age occidental (al numero 34), ossiaC. Gaier, Les Armes, Turnhout 1979; ma la stessa Enciclopedia dell’Arte Medievaleriflette una tradizionale titubanza nei confronti di questi oggetti, laddove la par-te più corposa della voce dedicata alle armi bianche, redatta da Boccia, parla inrealtà soltanto di armi in asta, mai soffermandosi sulle spade, che dunque nonbeneficiano di uno spazio appropriato. Cfr. L.G. Boccia, a.v. Armamento difen-sivo, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, II, Roma 1991, pp. 460-470; B.M.Alfieri, Armamento difensivo. Islam, in Enciclopedia cit., pp. 471-474; L.G.Boccia, Armi bianche, in Enciclopedia cit., pp. 492-496; A. Tomei, Armi bianche.Altre tipologie, in Enciclopedia cit., pp. 496-498 (armi da botta e lanciatoie);D.C. Nicolle, Armi bianche. Islam, in Enciclopedia cit., pp. 498-500; L.G.Boccia, Armi da fuoco, in Enciclopedia cit., pp. 500-503. Un doveroso risarci-mento alla bellezza e alla polisemia delle spade medievali dovrebbe venire dallagrande mostra del Musée de Cluny a Parigi, annunciata mentre stiamo scriven-do. Da noi un’occasione sfruttata solo in parte è il catalogo di una mostra alle-stita ad Aosta, che spaziava fino all’inoltrato Cinquecento (A bon droyt. Spade diuomini liberi, cavalieri e santi, a cura di M. Scalini, Cinisello Balsamo 2007).
8 L’esemplare dell’Armeria Reale di Torino (Q 10) viene esaminato anche com-parativamente, tra gli altri, da E. Bassani, Due Olifanti afro-portoghesi nelle colle-zioni pubbliche italiane, “Rassegna di studi musicali”, II 1975, pp. 97-103; G.Dondi-M. Sobrito Cartesegna, Schede critiche di catalogo, in L’Armeria Reale diTorino, a cura di F. Mazzini, Busto Arsizio 1982, p. 399; E. Bassani-W.B. Fagg,Africa and the Renaissance: Art in Ivory, Catalogo della mostra, New York 1988;Africa. Capolavori da un continente, Catalogo della mostra, a cura di E. Bassani,Firenze 2003; Arts of Africa. 7000 ans d’art africain, Catalogo della mostra, a cu-ra di E. Bassani, Monaco 2005 (cfr. in particolare la scheda dello stesso Bassani,pp. 271-272). Peraltro esso non è alieno da questa trattazione anche perché rap-presenta un episodio di committenza piuttosto interessante. Viene infatti da cre-dere, vista l’insistenza sulle insegne araldiche della casa d’Aviz, che sia stato inta-gliato appositamente per Manuele I, re di Portogallo dal 1495 al 1521. Esso ap-proda nell’Armeria Reale già nel 1833, con provenienza dall’Università, ma de-ve identificarsi con quello ricordato nell’inventario di Palazzo Ducale del 1682.Dunque è probabile che fosse giunto a Torino per mano di Beatrice d’Aviz, fi-glia di Manuele I e madre di Emanuele Filiberto, andata in sposa a Carlo II diSavoia nel 1521.9 S. Bernardi De laude novae militiae ad milites Templi, V, in V. Mortet-P.Deschamps, Recueil de textes relatifs à l’histoire de l’architecture et à la conditionsdes architectes en France, au Moyen-Âge, XIe-XIIIe siècles, Paris 1995, p. 678 (I ed.1911-1929).10 Abbates nostri ordinis, in quorum oratoriis scuta dependent, provideant ut quamcitius amoveatur, et ab octava Omnium Sanctorum sint in pane et aqua, si ex tuncdigne non fuerit emendatum, in Mortet-Deschamps, Recueil de textes cit., p. 672.11 Lo si veda, per esempio, in H. Nicholson, Knight Templar 1120-1312, London2004.12 A bon droyt cit., pp. 172-175 (scheda di M. Scalini).13 Oakeshott, Records cit., pp. 72-73.14 La scheda di Simonetta Castronovo e Luisa Clotilde Gentile in Blu rosso & oro:segni e colori dell’araldica in carte, codici e oggetti d’arte, Catalogo della mostra, acura di I. Massabò Ricci, M. Carassi, Milano 1998, pp. 80-81, riassume lo sta-to delle conoscenze e propone l’identificazione delle insegne.15 Boccia-Coelho, Armi bianche cit., figg. 33-34.16 Ivi, figg. 95-96.17 Cfr. N. Drechsler, a.v. Regalia, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, IX, 1998,pp. 863-868.18 Vedi la scheda di Danielle Gaborit-Chopin in Le Trésor de Saint-Denis,Catalogo della mostra, a cura di D. Gaborit-Chopin, Paris 1991, pp. 202-209.Merita ricordare che l’inventario del 1534 ricorda a Saint-Denis almeno quattrospade medievali o riferite a personaggi medievali: oltre alla Joyeuse, ve n’era infat-ti una attribuita all’arcivescovo carolingio Turpino, una a Luigi IX, portata vero-similmente dalla Terrasanta perché citata come épée d’un sarrazin, e una aGiovanna d’Arco. Entro il 1793 se ne aggiunse almeno un’altra, appartenuta alcondottiero inglese Talbot, che di Giovanna fu avversario a Orléans. Sempre in-dispensabile B. De Montesquiou-Fezensac, Le trésor de Saint-Denis, con la colla-borazione di D. Gaborit-Chopin, Paris 1973-77.19 M. Vignola, Guerra e castelli a Genova nel Duecento, Genova 2003, pp. 118-119. Meriterebbe peraltro rileggere in una prospettiva davvero incrociata (sia distoria delle armi, cioè, che di storia dell’arte) i tanti documenti censiti nelleNotizie dei professori del disegno di Federigo Alizeri (Genova 1870-80), che neldelineare una storia della pittura a Genova e in Liguria non manca di soffermar-si sull’arte di dipingere scudi e bandiere: anche perché di questi oggetti, in luo-go di affreschi e tavole, parlano più spesso i documenti. Un riscontro interessan-te di committenza statale viene poi dalla documentazione angioina della guerradel Vespro, quando lo stato ordina armi specificando talvolta anche dimensionie caratteristiche (per esempio delle frecce). Ma si tratta certo di oggetti seriali dacombattimento (C. Minieri-Riccio, Memorie della guerra di Sicilia negli anni1282, 1283, 1284 tratte da’ registri angioini dell’Archivio di Stato di Napoli,“Archivio storico per le Province Napoletane”, I 1876, pp. 85-105, 275-315,499-530).20 De magnalibus Mediolani, V, XX-XXI. Cfr. Bonvesin da la Riva, Le meravigliedi Milano, a cura di P. Chiesa, Milano 2009, pp. 125-127.21 A. Angelucci, Documenti inediti per la storia delle armi da fuoco italiane, I, par-te I, Torino 1869, p. 259.22 A. Degrandi, Artigiani nel Vercellese dei secoli XII e XIII, Pisa 1996, pp. 73-74,151-152. 23 Angelucci, Documenti cit., pp. 23-25.24 L. Frangioni, Una cotta di maglia milanese a Firenze sulla fine del Trecento, inStudi in memoria di Federigo Melis, II, Milano 1978, pp. 479-495. 25 L. Frangioni, Bacinetti e altre difese della testa nella documentazione di un’azien-
386
da mercantile, 1366-1410, “Archeologia Medievale”, XI 1984, pp. 507-522;Ead., Martino da Milano “fa i bacinetti in Avignone” (1379), “Ricerche storiche”,XIV 1984, 1, pp. 69-115; e in generale Ead., Milano fine Trecento. Il carteggiomilanese dell’Archivio Datini di Prato, I, Firenze 1994. Sui centri metallurgici su-balpini: Miniere fucine e metallurgia nel Piemonte medievale e moderno, Atti delconvegno, Rocca de’ Baldi, 12 dicembre 1999, a cura di R. Comba, Rocca de’Baldi 1999, con particolare riguardo al contributo di R. Comba, “Coltelaria deConi”, “coltelaria de Pineyrol” e altri manufatti d’acciaio: le produzioni metallurgi-che di due grossi centri del Piemonte sud-occidentale alla fine del Medioevo, pp. 63-78; e ancora A. Longhi-M. Frati, Forges et chateaux au bas Moyen Age, en Piémontet en Toscane, “Fasciculi Archaeologiae Historicae”, XIII-XIV 2002, pp. 69-83.Per un quadro di riferimento generale: F. Zagari, Il metallo nel Medioevo. Tecnichestrutture manufatti, Roma 2005.26 Blu Rosso Oro cit., pp. 82-83 (scheda di C. Bertolotto).27 Benché noti e pubblicati da tempo, gli inventari sabaudi di primoQuattrocento non hanno ancora goduto di grandi attenzioni storiografiche, spe-cie per quanto riguarda la storia delle armi nei loro rapporti con le altre arti. Miriprometto di tornare sull’argomento in una prossima e specifica occasione. Mavedi senz’altro M.R. Conta, Armi e armature in Piemonte nella prima metà del se-colo XV (dagli inventari dei castelli dei principi d’Acaia), “Studi Piemontesi”, VI1977, 2, pp. 410-437.28 Mi limito qui a una bibliografia essenziale: O. Zastrow, Una prima analisi si-
stematica sulla tecnologia e sullo stile del coltello liturgico medioevale, “Rassegna distudi e di notizie”, III 1975, pp. 285-325; S. Castronovo, Il tesoro di GualaBicchieri cardinale di Vercelli, in Gotico in Piemonte, a cura di G. Romano, Torino1992, pp. 221-224; Ead., Il tesoro e la biblioteca di Guala Bicchieri: il gotico set-tentrionale a Vercelli, in Arti figurative a Biella e a Vercelli. Il Duecento e il Trecento,a cura di V. Natale, A. Quazza, Biella 2007, pp. 25-42, in partic. pp. 28-31.29 Ancora in attesa di un approfondimento sul piano storico-formale, dopo l’ana-litica ricognizione di Zastrow (di taglio però soprattutto iconografico) e la mes-sa a punto di Castronovo. Peraltro non sono ancora chiare le modalità di ingres-so dell’oggetto nelle collezioni civiche milanesi: infondata appare la tesi, a lungosostenuta, secondo cui sarebbe stato il pittore Giuseppe Bossi ad acquistarlo perl’Accademia (cfr. F. Tasso, Il Medioevo nella Milano ottocentesca. Qualche nota sul-la costituzione delle raccolte civiche di arte suntuaria, “Rassegna di studi e di noti-zie”, XXXI 2007-2008, pp. 163-183, in partic. pp. 171-174). 30 Un solo rimando bibliografico, ma fondamentale: Die Heilige Lanze in Wien.Insignie – Reliquie – “Schicksalspeer”, a cura di F. Kirchweger, Wien 2005(Schriften des Kunsthistorischen Museums, 9).
Referenze fotografiche: Civiche Raccolte d’Arte Applicata, Milano: 16; Die HeiligeLanze in Wien, Wien 2005: 17, 18; Soprintendenza per i Beni Storici Artisticied Etnoantropologici del Piemonte, Torino: 3, 4, 6, 7, 12-15; Le Trésor de Saint-Denis, Paris 1991: 11.
387