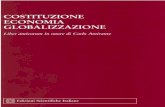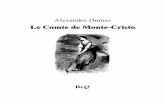LA MEDIAZIONE DI CRISTO NEL LIBRO IV DI "DE TRINITATE" DI SANT'AGOSTINO
-
Upload
facoltateologica -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of LA MEDIAZIONE DI CRISTO NEL LIBRO IV DI "DE TRINITATE" DI SANT'AGOSTINO
LA MEDIAZIONE DI CRISTO NEL LIBRO IV DI DE TRINITATE DI
SANT’AGOSTINO DI IPPONA
Introduzione
Il ruolo di mediazione di Cristo non è iniziato dal momento
della sua incarnazione e manifestazione nella storia, ma ha
origine nell’eternità della Trinità, e viene esercitato fin dalla
creazione. «Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di
tutta la creazione … Tutte le cose sono state create per mezzo di
lui e in vista di lui» (Col. 1, 15 -16). Gesù Cristo è il
Mediatore tra Dio e l’uomo. Egli è il «Verbo di Dio e nello stesso
tempo Mediatore di Dio e degli uomini come Figlio dell’uomo, uguale al Padre per
l’unità della divinità e nostro simile per l’umanità che assunse,
pregando il Padre per noi con la sua umanità, senza tacere
tuttavia di essere con il Padre una sola cosa nella
divinità»1. L’unico soggetto capace di mediare tra Dio e
l’umanità, pensa Agostino, colui che può stare per gli uomini
davanti a Dio, deve essere perfettamente Dio e perfettamente
uomo. E Gesù è Mediatore proprio perché ha ambi due le nature.
Agostino non intende per mediazione una semplice intercessione,
preghiera; mediazione qui vuole dire soprattutto «stare per».
Nessun uomo è degno di stare davanti a Dio in nostro favore;
nondimeno fino a che ci non sia un uomo come noi a stare per noi
non saremmo pienamente rappresentati. Agostino riconosce la
profondità misterica dell’evento dell’incarnazione. Mentre è
difficile spiegare che cosa sia avvenuta nella congiunzione di1 Sant’ Agostino, La Trinità, 4, 8, 12, Città Nuova, Roma, 1987. (Da ora in poi DeTrinitate)
1
Dio e l’uomo in un solo soggetto, remane però una verità
evangelica, attestata anche dalle parole di Cristo stesso. Dio ha
voluta nascondere la gloria della sua divinità nell’umiltà della
nostra umanità, ma non ha nascosto che è stato lui che in Cristo
parlava a noi, stando con noi secondo la nostra natura.
Il concetto di mediazione nella religione è sempre correlata
a quello del sacrificio. Per Agostino, nessun altro sacrificio
può essere efficace per la remissione della nostra colpa come
quello di Cristo. Il vero sacrificio è dovuto solo all’unico vero
Dio, e questo sacrificio deve essere offerto da un sacerdote
santo e giusto. Se ciò che viene offerto è difettoso, non sarà
capace di mondare le colpe di coloro per i quali viene
offerto. Il sacrificio di Cristo è il sacrificio più
irreprensibile, perché offerto da colui che non ha la necessità
di essere purificato dalle proprie colpe, perché egli non ha
nessuna colpa in lui. Infatti, Agostino fa un elenco di quattro
elementi necessari per offrire un sacrificio; il sacrificio di
Cristo è più efficace perché è stato capace di unire in se stesso
questi quattro elementi. «Che se in ogni sacrificio sono quattro
gli aspetti da considerare (a chi si offre, da chi si offre, che
cosa si offre, per chi si offre), tutti e quattro convengono nel
medesimo unico e vero Mediatore che ci riconcilia con Dio per
mezzo del suo sacrificio di pace, rimanendo egli tutt’uno con Dio
a cui si offriva, facendo tutt’uno in sé coloro per i quali
2
l’offriva, tutt’uno essendo lui che offriva con ciò che
offriva»2.
Stiamo considerando qui la dottrina della redenzione nella
teologia, o particolarmente, nella cristologia di S.
Agostino. Questa redenzione dell'umanità per il nostro autore si
svolge in forma di mediazione. Più spesso c'è la tentazione di
interpretare la dottrina agostiniana della redenzione solo dal
punto di vista della teoria della espiazione: gli uomini hanno
peccato e per questo sono giustamente tenuti sotto la schiavitù
di Satana, poi per redimerlo, Cristo, uno senza
peccato, ingannevolmente si consegna al diavolo che lo uccide, un
omicidio ingiusto di un uomo senza peccato. In questo modo Cristo
avrebbe pagato per il resto dell'umanità e l'umanità viene
liberata dalla carcerazione della morte. Ma non è che questa,
come la penserebbe Lewis Ayres, sia un modo metaforico di
esprimere un mistero secondo il linguaggio tradizionale
dell’epoca del nostro autore? Non c'è bisogno di pensare in
questa direzione, perché vediamo che in Agostino la teologia
della redenzione mediatrice è, in un modo molto significativo,
legata alla dottrina trinitaria. Ciò significa che la mediazione
cristologica in Agostino potrebbe proprio essere considerate come
l'illuminazione, la santificazione, la giustificazione che il Dio
Padre opera nell’umanità, ammettendola all'eternità del suo amore
trinitario attraverso la partecipazione alla vita, morte e
2 De Trinitate, 4, 14, 19
3
risurrezione del suo Figlio Gesù Cristo per opera dello Spirito
Santo3.
La cristologia di De Trinitate di S. Agostino
Cristologia è il cuore della teologia cristiana, poiché
studia il mistero di Gesù Cristo come Dio e l’uomo. Tuttavia il
mistero di Cristo come Dio fatto uomo non può essere considerato
al di fuori del principale mistero della Santissima Trinità.
Questi due misteri costituiscono i temi principali dell’opera di
Agostino, De Trinitate. La nostra considerazione della cristologia
di Agostino si baserà soprattutto sul Libro IV di questa opera,
dove egli sviluppa una cristologia dalle sue riflessioni sulle
questioni di felicità, la condizione protologica dell’uomo persa
attraverso il peccato, che in Gesù Cristo è stata restituita a
lui come salvezza.
Perché Dio doveva diventare l’uomo in Gesù Cristo? Questa
risposta è data dall’evento della Croce: attraverso la sua morte,
noi siamo stati giustificati.
Cristologia in Agostino non è tanto esplicita. Egli si
preoccupava delle controversie che nel suo tempo ponevano delle
tensioni nel modo di vivere il cristianesimo e di capire la fede
della Chiesa. È più facile identificare tali temi che riguardano
il peccato e il male, il senso della storia, le caratteristiche
normative della Chiesa, la relazione tra la grazia divina e la
libertà umana, la relazione tra vita cristiana e la vita secolare
3 Cf. Lewis Ayres, “Augustine on Redemption” in M. Vessey and S. Reid (eds.) ACompanion to Augustine, Willey –Blackwell, London, 2012. pp. 416 -417
4
ecc4. La sua cristologia invece va presa dall’insieme di tutti i
suoi discorsi che comunque hanno tutti qualche portata
cristologica. Anche l’opera in cui stiamo per esaminare non parla
di Cristo in modo specifico, ma vedremmo come il suo stile ha il
vantaggio di mettere Cristo a centro di tutto, e mai escluso da
nulla. De Trinitate è forse uno dei trattati teologici più profondi
di S. Agostino. In questo lavoro Agostino sviluppa i suoi temi
cristologici centrali nei libri IV e XIII. Nel libro IV parla del
mistero dell’incarnazione del Figlio unigenito di Dio, generato
come una missione di cui il principio è il Padre. La missione del
Figlio nel mondo non è lo stesso con la missione dello Spirito
Santo. Il Figlio è inviato in missione di mediazione rispetto
agli uomini. Cristo, il mediatore della vita è mandato al fine di
abolire la pena di morte pronunciata sull’uomo, portandolo fuori
dalle tenebre alla luce. Questo tema del motivo dell’incarnazione
è ulteriormente sviluppato nel libro XIII.
Una delle maggiori difficoltà incontrate dalla teologia a
partire dalla prima origine della fede cristiana è il mistero
dell’incarnazione. Ciò che è accaduto nella incarnazione come
deve essere espresso e spiegato nella teologia? Non c’erano dei
dubbi, almeno, da teologi cristiani, sull’origine divina di Gesù
di Nazareth, sul fatto che abbia vissuto la storia e l’esperienza
umana, sul fatto che egli è il Redentore dell’umanità. Egli è
Dio. La difficoltà girava intorno all’espressione del fatto che
questo uomo Gesù di Nazareth è Dio e allo stesso tempo
4 Cf. B.E. Daley, “A Humble Mediator: The Distinctive Elements in Saint Augustine’s Cristology” in Word and Spirit; 9 (1987), p. 100
5
uomo. L’incarnazione secondo S. Agostino, è l’assunzione della
carne dalla Parola di Dio, cioè, il farsi uomo di Dio nella
storia. Contro ogni forma di monofisismo e contro la divisione
inutile di Nestorianismo, egli sostiene che questo divenire uomo
della Parola, questa congiunzione della divinità all’umanità non
significa una trasformazione da parte della divinità che rimane
intatto, né significa il cambiamento dell’umanità in divinità. Il
Verbo si è fatto carne, ma «senza essere tuttavia convertito e
trasformato in ciò che si è fatto, e si è fatto esattamente in
tal modo che in lui si trova non solo il Verbo di Dio e la carne
dell’uomo, ma anche l’anima razionale e che questo tutto si dica
Dio a causa della natura divina, e uomo a causa della natura
umana»5. Il nostro autore è consapevole della difficoltà di
accettare questa spiegazione. Si tratta di un mistero che può
essere appreso solo dalla fede, preghiere, opera buone, la
coltivazione di santi desideri e rinuncia al peccato.
La missione del Figlio come una manifestazione della vita del Dio
trinitario
«Il mistero di Cristo c’introduce in quello di Dio-Trinità:
la dottrina cristologica è inseparabilmente legata a quella
trinitaria che, della prima, è il presupposto e il fine. Cristo,
“un’unica persona nella Trinità” è il rivelatore del Padre e il
datore dello Spirito Santo che riconduce al Padre l’umanità
redenta».6 Il mistero dell’incarnazione è così legato al mistero
del Dio trinitario che non possiamo avvicinarci o comprendere uno
5 De Trinitate,4, 21, 316 A. Trapè, Introduzione Generale a sant’agostino, Citta Nuova, Roma, 2006, p. 161
6
senza l’altro. La missione salvifica di Cristo consiste
principalmente nel rivelare Dio a noi7. In realtà lo stesso
Agostino sostiene che Cristo è la via per la patria trinitaria.8
Dio nel suo amore non abbandona l’uomo nel suo stato miserabile,
nella sua condizione di mancanza della felicità, quindi manda il
suo Figlio. La profondità dell’amore di Dio è incommensurabile. È
un amore trinitario, amore in relazione, amore che va verso
l’altro. Egli viene a cercare l’uomo per portarlo a partecipare
alla sua vita. L’uomo non è in grado di partecipare alla vita
divina a causa dei suoi peccati, ma rimane in lui una brama per
la vita divina. Tali desideri nell’uomo per la beatitudine, per
la verità e per l’eternità sono una forma di esilio di cui soffre
l’uomo. L’uomo non è capace di realizzare questi desideri ma
restano fortemente in lui. Sarà Dio a realizzare nell’uomo questi
desideri attraverso la missione del Figlio.
Agostino insiste sull’unità e uguaglianza della Trinità e
solo da lì ci sarebbe da considerare la distinzione. La sua
insistenza sull’uguaglianza in tutti gli aspetti è strategica per
la sua dottrina dell’incarnazione, perché alcuni già pensano che,
poiché colui che manda è sempre superiore di chi è mandato,
Cristo allora dovrebbe essere subordinato o inferiore al
Padre. Ma Agostino riconosce inoltre la necessità di
distinguere contro le opinioni di coloro che dicono che le tre7 Joseph Ratzinger afferma che la cristologia è il mister del Figlio come il rivelatore di Dio Padre. In tutte le sue azioni e discorsi Gesù di Nazareth è visto adempiere questa particolare missione(cf., J. Ratzinger, Gesù di Nazaret,Rizzoli, Milano, 2007, pp. 27 – 28)8 Cf. G. Madec, La patria e la via. Cristo nella vita e nel pensiero di Sant’Agostino, Borla, Roma, 1993, pp. 40 -42
7
persone si sono incarnate. Non è così. Certamente la Trinità
è uno e indivisibile nell’operazione e nell'essere, ma questo non
significa che qualsiasi altro che non sia il Figlio sia stato
incarnato, che la voce dell’altro sia stata sentita se non la
voce del Padre sulla Tabor o che qualsiasi altro che non sia lo
Spirito Santo sia stato inviato ai discepoli nella Pentecoste9.
Se Gesù Cristo è stato inviato in missione10 per liberare
l’uomo dalla condizione penosa che il suo peccato l’ha
giustamente meritato, essere inviati significa un rapporto con
colui che invia. La missione del Figlio rivela quindi non solo
l’origine (processione) di colui che viene inviato, ma rivela
anche l’identità di colui che manda (il Primo Principio). Il
Figlio procede dal Padre e lo Spirito Santo è un dono che procede
sia dal Padre che dal Figlio. La Trinità è un solo Dio, Padre,
Figlio e Spirito Santo. Eppure Padre non può essere chiamato
Trinità se non in un senso implicito, così anche il
Figlio. L’unico Dio può essere chiamato Spirito Santo, perché il
Padre è lo Spirito e il Figlio è santo. Eppure lo Spirito Santo
non è la Trinità. Egli è lo Spirito sia del Padre che del Figlio,
pur mantenendo la sua corretta personalità e nome11. La
generazione del Figlio e la processione dello Spirito come dono
non significa una disuguaglianza o la precedenza del Figlio
rispetto allo Spirito; non significa disuguaglianza dei due in
relazione al Padre. Cristo, il Figlio, è inviato in missione
9 Cf, A. Tapè, op.cit., pp. 161-16310 De Trinitate, 4, 20, 27 - 3011 De Trinitate, 5, 11, 12
8
salvifica del Padre. Tutta la Trinità è uguale nella sostanza,
nell’eternità. « Ora è stato sufficientemente stabilito, a mio parere, come il Figlionon è inferiore perché è stato mandato dal Padre, come non lo è loSpirito Santo perché è stato mandato dal Padre e dal Figlio. Queste cosevengono dette dalle Scritture per riferimento alla creatura visibile opiuttosto per sottolineare il ruolo di principio in Dio, non perdisuguaglianza, disparità o differenza di sostanza. Perché anche se DioPadre avesse voluto manifestarsi visibilmente per mezzo della creaturadocile sarebbe completamente assurdo affermare che è stato mandato dalFiglio che egli ha generato o dallo Spirito Santo che da lui procede»12.
Questo passaggio di De Trinitate è molto utile per comprendere
ciò che Agostino sta spiegando qui: Incarnazione può quindi
essere intesa come il punto più alto della manifestazione storica
di Dio, uno e tre. Essa è l’espressione, nel tempo e nello
spazio, tra gli uomini, la vita intra- trinitaria (pericoresi).
Il mistero della mediazione di Cristo
Secondo Sant’Agostino la realtà della mediazione del Figlio
di Dio è legata a tutta la creazione. Anche prima di prendere la
carne umana nella Vergine, questa Parola di Dio, per mezzo della
quale sono state fatte tutte le cose, è sempre stata al centro
dell’intero ordine creato e di ogni evento della storia. Le
diverse esperienze religiose dei nostri antinati prima di questo
avvenimento di incarnazione erano dei riflessi o ombre di questo
accadimento13. Sì, perché fin dall’origine, tutte le cose sono
state destinate a partecipare alla vita di Dio attraverso questa
mediazione. Cristo, il Verbo di Dio fatto carne, è in grado di
mediare tra noi e Dio, perché egli è prima di tutto uguale al
12 De Trinitate, 4, 21, 3213 De Trinitate, 4, 7, 11
9
Padre nell’unità della Divinità e uguale a noi nell’umanità. Per
questo egli è il nostro vero intercessore presso Dio, il
mediatore degno e capace. Cristo ha pregato per coloro che
credono in lui, affinché siano uno con lui come lui è uno con
Dio. Questo secondo Agostino, mostra come l’intercessione di
Cristo sia una mediazione: mira a farci uno con lui, e attraverso
di lui, uno con Dio14.
Gli uomini non possono essere uno da soli, se non in
Cristo. Essi non possono essere uno a causa dei loro voleri e
piaceri peccaminosi; tuttavia, purificati dalla loro impurità da
Cristo, sono resi capaci di diventare in lui uno con lui così
come egli è con il Padre. L’unicità della mediazione di Cristo,
sta nel fatto che egli è Dio e uomo. Tra la divinità e l’umanità,
c’è una sola mediazione della divinità umana e umanità divina di
Cristo (cfr Sermo 47, 12, 21 ). Il mediatore deve essere in grado
di stare tra i due estremi della peccaminosità e mortalità della
natura umana e la giustizia e immortalità della natura
divina. Questo è il motivo dell’incarnazione: l’uomo non può
essere salvato senza Cristo. Il mediatore riconcilia
oggettivamente tutti gli uomini a Dio morendo per tutti gli
uomini15.
Nella teologia della mediazione cristologica di Agostino,
c’è un legame tra la mediazione della verità e la mediazione
della vita. Lasciato da solo l’uomo vive su ciò che è in basso,
14 De Trinitate, 4, 8, 1215 Cf. E. Cutaneo et al, Patres ecclesiae. Una introduzione alla teologia dei padri della chiesa, Il Pozzo di Giacobbe, Roma, 2008. P. I86
10
incapace di guardare verso ciò che è eterno e immutabile. Ma
attraverso la purificazione operata da Cristo mediante il suo
sangue, l’uomo è in grado di contemplare la verità eterna. Questo
è possibile non attraverso l’orgoglio della filosofia, ma per
mezzo della fede in Cristo. La distanza tra fede e verità è
paragonata a quella tra la mortalità e l’eternità. La fede
conduce alla verità, ed è temporale, e la verità è la vita eterna
promessa a coloro che hanno creduto in Cristo. Il mediatore della
verità è anche il liberatore, egli stesso si definisce la Verità
(cfr Gv 14, 6), e dice che quando gli uomini conoscono la verità,
la verità li farà liberi (cfr Gv 8, 32) 16.
Cristo, il Mediatore della vita
Secondo Agostino, Cristo è il Mediatore della vita, mentre
il diavolo è il mediatore della morte. Dio ha voluto che, proprio
come l’uomo è stato corrotto e distaccato da lui, fonte di vita,
attraverso la mediazione del diavolo così ritornerà l’uomo a lui
attraverso la mediazione di Cristo. Gli strumenti della
mediazione in entrambi gli attori sono dialetticamente opposti
gli uni agli altri e hanno i risultati che sono corrispondenti
alle loro cause efficienti. Lo strumento di mediazione del
diavolo è l’orgoglio e il risultato è la morte; lo strumento di
mediazione di Cristo è l’umiltà attraverso l’obbedienza, ed il
risultato è la vita17. Orgoglio, la preferenza per il potere al
posto della giustizia, falsa filosofia e riti religiosi
sacrileghi sono le strategie con cui il diavolo inganna l’uomo e16 De Trinitate, 4, 18, 2417 Cf. De Trinitate 4, 10, 13
11
lo tiene prigioniero nel regno della morte. Egli può anche
operare alcune “meraviglie” che attraggono i sensi, ma che a
lungo andare hanno lo scopo di ingannare. Il diavolo dà pretende
di essere luce, mentre lui è oscurità; fa capire che in lui c’è
la vita, mentre in lui c’è soltanto la morte. I miracoli non sono
sempre segni di Dio. Il diavolo anche li può fare18.
Agostino afferma che, proprio come la separazione dell’anima
dal corpo provoca la morte corporale, così anche l’allontanamento
di Dio dall’anima porta alla morte spirituale. L’anima lascia il
corpo a motivo della sua corruttibilità, così anche Dio si
allontana dall’anima a causa del peccato19. Ciò implica che se
Dio in Cristo ha assunto la nostra natura, ha un corpo e un’anima
umana, la vita ci è stata veramente ridonata. Siamo vivi, non
solo nell’immortalità della nostra anima, ma mediante la
risurrezione del nostro corpo in Cristo nell’ultimo
giorno. Quando Agostino parla della nostra doppia morte e la
nostra salvezza attraverso la sola morte di Gesù Cristo, vuole
dire che eravamo morti nel corpo e nell’anima; Cristo non ha mai
peccato e quindi non ha sperimentato la morte dell’anima, ma il
suo evento singolare della morte e risurrezione abolisce la
nostra doppia morte, ci ridona la vita nel corpo e nell’anima20.
Agostino insiste sulla risurrezione dei nostri corpi
mortali. Gesù Cristo aveva un corpo mortale simile al nostro , e
«avendo concorso il suo corpo come opportuna medicina, in ambedue
18 Cf. De Trinitate 4, 11, 1419 Cf. De Trinitate 4, 3, 520 Cf. De Trinitate 4, 3, 6
12
le direzioni della morte e della risurrezione, come sacramento
per il nostro uomo interiore e come esempio per il nostro uomo
esteriore »21. Quello che è stato appeso sulla croce, ciò che ha
sperimentato la morte, non è solo la carne di Cristo, ma anche la
nostra carne peccaminosa. Di conseguenza, il ritorno alla vita
della sua carne è anche il riportare alla vita della nostra
carne.
Peccando volontariamente (allontanamento da Dio), la anima
aveva incorso la morte – la partenza sgradita dell’anima dal
corpo. Ora il Mediatore della vita è colui che muore non
controvoglia, ma volentieri perché è lui che si dona liberamente,
che volontariamente ha dato se stesso, quando l’ha voluto e il
modo in cui l’ha voluto22. Il diavolo è morto nello spirito;
Cristo è sempre vivo nello Spirito. Cristo, il Mediatore della
vita suscitò il suo corpo attraverso il suo Spirito sempre vivo,
e con questo ha cacciato e allontanato lo spirito di morte del
mediatore di morte da quelli che hanno fede in lui. Poiché il
diavolo è stato cacciato via attraverso la morte libera del
mediatore, ora non è più in grado di regnare dal di dentro, ma
dal di fuori. Agostino certamente riferisce al mondo, i suoi
poteri e ricchezze come il regno del diavolo, mentre l’anima del
cristiano è stata purificata da tutte le azioni di morte. Infatti è accaduto che le catene tra innumerevoli peccati einnumerevoli morti sono state rotte con la morte di uno solo,assolutamente libero dal peccato. Il Signore soffrì per noi talemorte indebita, affinché non nuocesse a noi la morte a noidovuta. Non esisteva potere che avesse il diritto di spogliarlo
21 De Trinitate 4, 3, 622 Cf. De Trinitate 4, 13, 6
13
del suo corpo; se n’è spogliato lui stesso. Infatti Colui cheavrebbe potuto non morire, se lo avesse voluto, senza alcundubbio morì perché lo volle, dando così una bella lezione aiprincipati e alle potestà che egli aveva schiacciato totalmente nella sua persona. Conla sua morte, l’unico sacrificio assolutamente vero offerto pernoi, tutto ciò che c’era in noi di colpevole e che dava ildiritto ai principati e alle potestà di costringerci a espiarecon i supplizi, egli ha pulito, abolito, estinto, e con la suarisurrezione a una vita nuova ha chiamato noi, i predestinati, chiamati ci hagiustificati, giustificati ci ha glorificati23.
Cristo, il Mediatore della Verità
Nella prefazione del libro IV del De Trinitate Agostino dice
che la vera conoscenza può venire solo da Dio come un dono.
L’uomo si preoccupa così tanto nel cercare di capire le cose
esterne, ma la più grande verità, la più grande conoscenza è la
conoscenza del più grande Essere. L’uomo rimane bloccato
nell’ignoranza rispetto alla verità di Dio, fino a quando egli
non venga in suo aiuto per farlo uscire da questa
ignoranza. Agostino prega quindi che Dio gli aiutasse a non dire
qualcosa che fosse diverso dalla solida verità infusa in lui dal
soffio della sua Verità24 L’unica via verso tale Verità eterna e
immutabile è la via tracciata da Dio in Cristo. Più lontano
l’uomo è da questa «via che Egli ha tracciato con l’umanità della
divinità del suo Figlio unico»25 più lontano egli è dalla verità.
Agostino sostiene inoltre che tutte le cose sono state fatte
per mezzo della Parola di Dio, essendo essa la Verità
immutabile. Tutte le cose dunque, quelle che sono e quelle che
23 De Trinitate 4, 13, 1724 Cf. De Trinitate 4, 1, 125 De Trinitate 4, 1, 1
14
saranno, trovano il loro significato e sussistenza in lui. La
vita e la luce sono collocate insieme qui e hanno una sola
origine nel Verbo eterno. Attraverso di lui tutte le cose
ricevono non solo la vita ma anche la luce. La vita che viene
dalla Parola è luce anche negli uomini, è questa luce negli
uomini che li rende diversi dagli animali, come esseri che
possiedono anima razionale26. Ma il peccato ha offuscato questa
luce negli uomini, e rimangono al buio fino a quando il mediatore
della verità e della vita (luce) non intervenga. Il motivo per
cui la stessa Parola attraverso la quale sono state fatte tutte
le cose ha dovuto prendersi la carne è quello renderci capaci di
partecipare in lui secondo la nostra natura; e partecipando alla
sua vita, lui anche partecipa alla nostra. Questa vita che
condividiamo è la luce degli uomini. Partecipare alla sua vita,
dunque, diventiamo illuminati di nuovo, otteniamo di nuovo la
luce perduta al peccato.
Commentando la dottrina teologica di S. Agostino, A. Trapè
osserva che il nostro autore fa una distinzione fra due forme
della conoscenza: scienza e sapienza27. Il primo ha che fare con
le verità storiche temporali: «la cognizione razionale delle cose
temporali», mentre il secondo è la contemplazione delle verità
eterne: «la cognizione intellettuale delle cose eterne»28. La
conoscenza di Dio è in Cristo scienza e sapienza. È scienza
perché avendo la fede come punto di partenza, l’intelletto
26Cf. De Trinitate 4, 1, 327 Cf A. Trapè, Introduzione generale a Sant’Agostino, Città Nuova, Roma, 2006, p. 14828 De Trinitate 12, 15, 25
15
riconosce Dio nella meravigliosa opera di Dio nella storia. Le
azioni di Dio nel suo Verbo Gesù Cristo, la sua vita, il suo
operare, la sua sofferenza e morte hanno avuto luogo in questo
nostro spazio-temporale mondo, e quindi appartengono alla
scienza. Ma queste dovrebbero essere viste come sapienza perché
la Parola di Dio supera il tempo e lo spazio. Egli è co-eterno al
Padre. Perciò, conoscere Gesù, credere in lui, è anche
contemplare la sapienza eterna, la Verità eterna. Gesù Cristo
appartiene allo spazio e al tempo ma allo stesso tempo li supera.
Egli è umano ma anche divino. Egli è la nostra scienza e la
nostra sapienza. Questa realtà della sua doppia appartenenza gli
rende per noi veramente il Mediatore della Verità di Dio. Senza
di lui rimaniamo chiusi entro i confini dello spazio e tempo, in
lui lo spazio-temporale apre all’eterno, come anche in lui
l’eterno si irrompe nello spazio-temporale. In Gesù Cristo
scienza e sapienza si combaciano come una cosa sola29.
Il peccato e la Beatitudine : la necessità di un Liberatore
mediatore
Dio non ha creato la morte, né ha creato l’uomo per finire
nella morte. La morte è la conseguenza del peccato, la giusta
retribuzione che Dio ha inflitto sull’uomo per la sua caduta. Ma
proprio come la morte è venuta attraverso il peccato di un uomo,
così anche la vita è venuta attraverso la giustizia di uomo. Dal
momento che il peccato di Adamo e la sua conseguenza raggiungono
tutte le generazioni umane, solo colui che essendo l’uomo è senza
29 De Trinitate 13, 19, 24
16
peccato può liberare l’uomo dal peccato e la sua conseguenza. La
morte di questa Mediatore dunque è il sacrificio che paga il
debito per il peccato. La morte di questo mediatore giusto è una
conferma di quello che lui ci ha insegnato, che la morte non è da
temere, ma da temere è la causa della morte – empietà,
peccato. Per Agostino la fede è l’arma che ci tiene lontano dal
peccato30.
È per amore che Dio viene a salvare l’uomo in Cristo. Questo
è ancora più evidenziato dal fatto che eravamo in uno stato di
peccato quando Dio è venuto in nostro soccorso. Più pensiamo di
essere stati salvati dai nostri meriti, più ci ritiriamo alla
nostra vecchia condizione. Siamo salvati per i meriti di Gesù
Cristo. È solo quell’atteggiamento dell’umiltà che accetta la
verità della nostra debolezza e incapacità di salvare noi stessi
che può rafforzare e perfezionare in noi la virtù della carità.
Infatti ci possiamo chiedere: In che cosa consiste questo peccato
di Adamo secondo Agostino? Per Agostino il peccato di Adamo, il
peccato originale, è semplicemente l’orgoglio che vuole dire
«volgere le proprie spalle a Dio»31. Se attraverso l’orgoglio di
un uomo tutti gli uomini da generazione in generazione ereditano
per propagazione la morte dell’anima, in questa nuovo accadimento
in cui attraverso l’umiltà radicale di Gesù la vita viene
ridonata a tutti, si debba sottolineare la virtù dell’umiltà come
partecipazione alla vita di beatitudine. L’orgoglio, infatti, è
30 Cf. De Trinitate 4, 12, 1531 E. Clark, «Peccato originale» in A.D. Fitzgerald (ed.), Agostino. Dizonario enciclopedico, Città Nuova, Roma, 2007, p. 1068.
17
la presunzione che potremmo essere salvati senza di lui che viene
a liberarci per grazia. È questo che si esprime nel Salmo in cui si dice: Una pioggia dibenefici facesti cadere, o Dio, sulla tua eredità; era esausta, tu le rendesti la forza.Questa pioggia benefica non può significare che la grazia, laquale non è data in ricompensa ai nostri meriti ma concessagratuitamente e per questo si chiama grazia: ce l’ha accordatainfatti non perché ne fossimo degni, ma perché così gli èpiaciuto. Sapendo questo noi non confideremo in noi stessi equesto significa "essere esausti". Ma Dio ci dà forza, lui cheanche all’apostolo Paolo ha detto: Ti basta la mia grazia, perché la forzatrionfa nella debolezza32
La consapevolezza che Dio ci ama, nonostante i nostri
peccati ci salva dal vizio della disperazione, dandoci la virtù
della speranza; ma la consapevolezza siamo salvati per la sua
grazia, e non per i nostri meriti, ci salva dal vizio
dell’orgoglio, dandoci la virtù dell’umiltà.
A causa del suo peccato l’uomo è completamente inadatto per
partecipare alla vita della beatitudine, la vita di Dio. Ma egli
è stato purificato dal peccato per mezzo di Cristo. Questa
purificazione avviene attraverso il sangue del Mediatore, l’unico
Giusto. Attraverso la condiscendenza di Dio nel suo prendersi
della carne umana, siamo elevati allo stato di beatitudine
divina. Questa nostra elevazione è secondo, Sant’Agostino, un
restauro di ciò che era perduto, che originariamente era
nostro. Agostino dice una cosa importante, che in futuro
preoccuperà Sant’Anselmo nella sua opera teologica, Cur Deus
Homo?: attraverso l’accadimento dell’incarnazione Cristo opera
la soddisfazione, paga il debito per nostro peccato e restituisce
32 De Trinitate 4, 1, 2
18
a noi quello che abbiamo perso a motivo di peccato33. L’uomo è
stato creato, non per essere tormentato dalla sofferenza e dalla
morte, ma per vivere in armonia orientato verso la
beatitudine. La morte è la conseguenza del peccato dell’uomo, che
consiste nel l’ingiustizia della sua scelta contro la volontà di
Dio.
Il Exsultet della Veglia Pasquale sottolinea come l’intervento
di Cristo va oltre un semplice ripristino dello stato originario
dell’uomo, ma anche lo eleva alla vita di Dio. E Agostino sembra
aver sufficientemente considerato questa riflessione. Egli
osserva che Gesù Cristo assume la nostra natura in modo che
possiamo contemplare Dio. Non abbiamo potuto contemplare Dio
perché per natura non siamo Dio, e non siamo più fedeli alla
nostra natura a causa del nostro peccato. Se Dio non interviene,
noi siamo in una condizione miserabile, perché non siamo né la
nostra natura autentica, né siamo in grado di raggiungere la
partecipazione alla vita di Dio, che è la ragione del nostro
essere. Ora, Dio si fa uomo nella persona di Gesù Cristo, prende
la nostra natura, ed è in grado di intercedere per noi
peccatori. Questo è molto in linea con la teoria di soddisfazione
e di restituzione che Anselmo svilupperà in seguito. Anche se
Anselmo sembra fermarsi solo con la soddisfazione e restituzione,
Agostino ci aiuta ad andare oltre: la mediazione liberatrice di
Cristo non solo ripristina ma eleva.
33 Cf., Anselm d’Aosta, Perché un Dio uomo?, I, III, pp. 85 - 86
19
Ora la sola purificazione dei peccatori e dei superbi è il sangue delGiusto, e l’umiltà di Dio; affinché, per poter giungere allacontemplazione di Dio che per natura noi non siamo, venissimopurificati da Dio stesso fattosi quello che per natura siamo equello che per il peccato non siamo. Infatti non siamo Dio pernatura, siamo per natura uomini, non siamo giusti per il peccato.Dunque Dio, fattosi uomo giusto, ha propiziato Dio per l’uomopeccatore. Non c’è infatti rapporto tra peccatore e giusto, matra uomo e uomo. Dunque sommando a noi la sua umanità uguale allanostra, ha sottratto a noi la disuguaglianza della nostrapeccaminosità e, fattosi partecipe della nostra mortalità, ci hareso partecipi della sua divinità. Giustamente la morte delpeccatore, proveniente da una condanna necessaria, è stata toltain virtù della morte del Giusto, proveniente da una liberamisericordia, con il rapporto tra lui e noi di uno a due34
Gesù Cristo non è solo il nostro Liberatore, ma anche
Mediatore tra noi e Dio. È mediatore anche perché, stabilisce un
legame tra umanità e divinità, grazie a lui l’uomo è divinizzato.
Cristo ha rinnovato in meglio ciò che era stato mutato in
peggio35.
Conclusione
Gesù Cristo è il mediatore della verità e della vita di Dio
per noi uomini. L’incarnazione è un accadimento che non solo
rivela Dio come Amore Trinitario, ma è realizzata quando l’uomo
entra in questo amore. Agostino non ha delle opere specificamente
cristologiche, comunque in tutti i suoi pensieri e scritti Cristo
ha sempre un posto fondamentali e incancellabile. Infatti secondo
le ricerche fatte il nome Christus appare circa 19.000 volte mentre
il nome Iesus appare circe 4.500 volte nei suoi scritti36. La sua
34 De Trinitate 4, 2, 435 Cf. De Trinitate 4, 3, 536 Cf. R. Rombs, «Augustine on Christ» in C.C. Pecknold e T. Toom (edd.), Bloomsbury, New York, 2013, p. 36
20
Cristologia allora viene estratta dai diversi suoi insegnamenti e
scritti che pur focalizzando sui altri temi sempre aiutano i
lettori a intendere la cristologia che sta in essi. Il vantaggio
di questo opera De Trinitate è che Agostino, pensando la Trinità e
Gesù Cristo contemporaneamente egli fornisce alla teologia delle
importanti chiavi di lettura del mistero di Dio. Grazia ad
Agostino «la riflessione intorno alla realtà di Dio non potrà più
avere per oggetto la sostanza divina, astratta e chiusa nella
solitudine dell’Uno. Essa, invece, dovrà tener necessariamente
conto del fatto che il Dio cristiano è comunione di un Noi
trinitario»37. Certamente questo non è possibile dedurre fuori
dell’evento Cristo. Se Gesù è stato mandato da Dio a noi come un
Mediatore che ci libera dalla morte donandoci la vita, questa
missione è una missione della rivelazione di Dio, manifestazione
del volto di Dio come Agape38. Se interpretiamo l’immutabilità di
Dio, la sua assolutezza, libertà ed eternità da punto di visto
dell’evento di mediazione di Cristo, noi riusciremo ad accogliere
la portata teologica del mistero trinitaria come una dottrina
dell’amore divina. Dio, in Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito
Santo si comunica all’uomo e alla storia.39
Infatti il tema della mediazione non può che essere il tema
centrale della cristologia; e questo tema va oltre la mediazione
della verità, della vita e della luce. Cristo è anche il
Mediatore del tempo e dell’eternità, del finito e l’infinito,37 P. Sguazardo, Sant’Agostino e la teologia trinitaria del xx secolo, Citta Nuova, Roma, 2006, p.57538 Cf. ibid., p. 57739 Cf. W. Kasper, Gesù il Cristo, Queriniana, Brescia, 2013, p. 256.
21
della libertà e necessità, della storia di Dio e la storia degli
uomini, della sofferenza e perfezione, della kenosi e epifania.
Attraverso lui queste cose che sembrano contraddittorie non si
escludono, ma sono invece superate e sintetizzate nell’amore
supreme e infinitamente libero di Dio40. Attraverso la sua unica
mediazione la tensione messa dal peccato tra uomo e Dio è stata
tolta, o meglio, superata, e noi siamo in lui riconciliati a Dio.
BIBLIOGRAFIA
ANSELM D’AOSTA, Perché un Dio uomo? Lettera sull’incarnazione del Verbo,(trad. A. Orazzo),
Città Nuova, Roma, 2007.
BONANNI S.P. Bonanni, «Quo nihil maius fueri potest, ovvero: il temposuperato. Percorsi
schellinghiani e riflessione cristologica in Water Kasper»
in Lateranum 2 (1999).
CUTANEO E., et al, Patres ecclesiae. Una introduzione alla teologia dei padridella chiesa, Il
Pozzo di Giacobbe, Roma, 2008.
DALEY B.E., “A Humble Mediator: The Distinctive Elements in SaintAugustine’s Christology” in
Word and Spirit 9 (1987).
FITZGERALD A.D. (ed.), Agostino. Dizonario enciclopedico, Città Nuova,
Roma, 2007.
KASPER W., Gesù il Cristo, Queriniana, Brescia, 2013.
MADEC G., La patria e la via. Cristo nella vita e nel pensiero di Sant’Agostino,Borla, Roma,
1993.
PECKNOLD C.C. and TOOM T. (eds.), Bloomsbury, New York, 2013.40 Cf. S.P. Bonanni, «Quo nihil maius fueri potest, ovvero: il tempo superato. Percorsi schellinghiani e riflessione cristologica in Water Kasper» in Lateranum 2 (1999), pp. 236 - 247
22
RATZINGER J., Gesù di Nazaret,Rizzoli, Milano, 2007.
SANT’ AGOSTINO, La Trinità, Città Nuova, Roma, 1987.
SGUAZARDO P., Sant’Agostino e la teologia trinitaria del XX secolo, Città Nuova,
Roma, 2006.
TRAPÈ A., Introduzione Generale a sant’agostino, Citta Nuova, Roma, 2006.
VASSEY M. and REID S. (eds.) A Companion to Augustine, Willey –
Blackwell, London, 2012.
23