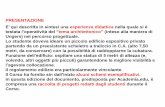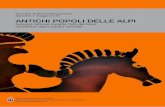Il progetto di ricerca di via Mauceri
Transcript of Il progetto di ricerca di via Mauceri
RICERCHE DI ARCHEOLOGIA CLASSICA E POST CLASSICA IN SICILIA
Questa innovativa serie monografica nasce dalla volontà di promuovere sul territorio siciliano nuovi studi e ricerche che, superando la frammentazione che spesso ha contraddistinto lo spirito della ricerca archeologica in Sicilia, guidino verso un approccio globale e multidisciplinare al fenomeno storico ed archeologico di età classica e post-classica. Essa riflette anche il recente revival che sul tema del documento, del paesaggio e della cultura materiale si è avviato in questi ultimi anni. L’aggettivo “post-classico” non è inteso esclusivamente nel suo significato storiografico restrittivo ma serve, invece, per creare una congiunzione tra culture recenti spesso immeritatamente trascurate.L’obiettivo è chiaro: dar vita ad una piattaforma operativa che possa vedere finalmente dialogare, con un linguaggio comune improntato su metodologie di approccio nuove e stimolanti, specialisti di discipline diverse il cui contributo, specie in ricerche di ampio respiro come queste qui presentate, è sicuramente innegabile. L’elemento aggregante è quello delle metodologie di approccio all’argomento in virtù delle quali oggi si può cercare di analizzare e studiare uno specifico tema da angolazioni e punti di vista differenti, da competenze professionali diverse all’interno di un ampio contenitore cronologico che sia in grado di far valutare un territorio o un manufatto non nella specificità di uno o due secoli solamente ma, al contrario, all’interno di una sequenza cronologica di sei, sette o più secoli, l’unica in grado di far emergere dati coerenti con lo sviluppo storico complessivo cui i medesimi dati appartengono.
Daniele Malfitana - Giuseppe CaCCiaGuerra
arCheoloGia ClassiCa in siCilia e nel MediterraneodidattiCa e riCerCa nell’esperienza Mista Cnr e università
Il contributo delle giovani generazioni. Un triennio di ricerche e di tesi universitarie
con la collaborazione di annarita di Mauro e Maria luisa sCrofani
testi di G. aMara, p. aMato, s. Barone, B. Basile, a. BranCa, G. CaCCiaGuerra,
a. Cannata, p. Cannia, C. Capelli, l. Carilli, l. Claessens, l. de GiorGi, a. di Mauro, G. fraGalà, C. franCo, i. Giordano, v. Guarnera, v. Gullotta,
l. idà, M. indeliCato, r. lanteri, G. leuCCi, d. Malfitana, a.M. Manenti, n. Masini, G. Monterosso, M. MusCo, M.e. MusuMeCi, C. pantellaro, v. reina,
C. rizza, C. santaGati, G. sCardozzi, a. sCienza, M.l. sCrofani, e. shehi, v. sMiriGlio
Catania
2014
© Tutti i diritti riservati. è vietata la riproduzione di testi ed illustrazioni senza il permesso scritto dell’Editore, dei Curatori, del Responsabile scientifico dei progetti e degli Autori.
Ricerche di archeologia classica e post-classica, vol. II
arCheoloGia ClassiCa in siCilia e nel Mediterraneo. didattiCa e riCerCa nell’esperienza Mista Cnr e università.Il contributo delle giovani generazioni. Un triennio di ricerche e di tesi universitarie
446 pp., ill. 17 x 24 cm.ISBN(13): 978-88-89375-12-9
I. Malfitana, Daniele <1967>II. Cacciaguerra, Giuseppe <1977>
Progettazione grafica ed impaginazione: Maria Luisa ScrofaniCoordinamento grafico e rielaborazione immagini dei contributi: Giovanni Fragalà, Maria Luisa ScrofaniCopertina: Giovanni Fragalà, Samuele BaroneCoordinamento editoriale: Daniele Malfitana, Giuseppe CacciaguerraCuratela redazionale: Annarita Di Mauro, Maria Luisa Scrofani
INDICE
Introduzionedaniele Malfitana, Archeologia classica oggi: il “modello catanese” nell’interazione CNR e Università. Opportunità di crescita ed innovazio-ne per le giovani generazioni
daniele Malfitana, Giuseppe CaCCiaGuerra, Il quadro delle ricerche e delle attività in laboratorio e sul campo. Strategie per la crescita delle nuo-ve generazioni
BeatriCe Basile, anGela Maria Manenti, Giuseppina Monterosso, Le collaborazioni tra l’IBAM e il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa
rosa lanteri, Le collaborazioni tra l’IBAM e l’Unità Operativa Beni Ar-cheologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
Cultura materiale e società: processi di conoscenza, analisi ed intepretazioneRicerche di archeologia della produzione e del consumo: il quartiere artigianale di Siracusadaniele Malfitana, Giuseppe CaCCiaGuerra, Il progetto di ricerca sul quartiere artigianale di Santa Lucia
paolo aMato, alBerto BranCa, Gli scarti di fornace e gli strumenti per la produzione ceramica
valeria reina, Cristina rizza, La ceramica tipo “San Giuliano”
Claudia pantellaro, Le ceramiche fini da mensa a vernice nera e rossa. Introduzione
valerio Gullotta, Le ceramiche a vernice nera con impasto grigio tipo “Campana C”
lorenza Carilli, La ceramica fine a vernice nera: le “pinecone moldmade bowls”
Claudia pantellaro, Le produzioni a vernice nera e rossa: anfore e broc-chette
antonino Cannata, La ceramica a pareti sottili e altre produzioni fini
valeria Guarnera, La coroplastica
viviana sMiriGlio, Gli unguentari
pag.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
11
25
35
37
43
53
63
69
71
73
79
85
91
97
Ricerche di archeologia urbana a Siracusarosa lanteri, daniele Malfitana, Giuseppe CaCCiaGuerra, Il progetto di ricerca di via Mauceri
Cristina rizza, La ceramica comune tipo “San Giuliano”
Claudia pantellaro, Le produzioni italiche e le importazioni orientali
antonino Cannata, La ceramica a pareti sottili
viviana sMiriGlio, Le lucerne
paola Cannia, La sigillata italica: nuovi bolli da Siracusa e dalla Sicilia
Insediamenti, territorio, paesaggi: strumenti, metodologie e tecnichedaniele Malfitana, Giuseppe CaCCiaGuerra, Ricerche multidisciplinari nel territorio di Priolo Gargallo. Un progetto di ricerca per lo sviluppo sostenibile
daniele Malfitana, Giovanni leuCCi, Giuseppe CaCCiaGuerra, lara de GiorGi, Giovanni fraGalà, La Guglia d’Agosta: indagini archeo-geo-fisiche per una nuova conoscenza e percezione culturale del monumento
rosa lanteri, italo Giordano, Indagini archeologiche preventive: nuovi dati sulla viabilità antica nel territorio megarese
daniele Malfitana, rosa lanteri, Giuseppe CaCCiaGuerra, Archeolo-gia a Ponte Diddino (Priolo Gargallo, SR). Un progetto multidisciplinare su un sito rurale ellenistico, romano e bizantino. Note per un campo scuola di archeologia classica e post-classica per gli studenti
daniele Malfitana, Giuseppe CaCCiaGuerra, Archeologia della pesca nella Sicilia sud-orientale: tra metodologie di ricerca e nuove linee inter-pretative
livio idà, MarCo MusCo, Archeologia della pesca nella Sicilia sud-orien-tale: ricerche e nuovi dati
Archeologia sperimentaleattilio sCienza, Quando il DNA incontra la storia: nuovi riscontri sui rapporti genetici di alcuni vitigni dell’Italia meridionale e della Sicilia
Mario indeliCato, Una vigna “romana” archeo-sperimentale alle pendici dell’Etna
pag.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
101
111
113
119
125
131
141
161
181
195
205
211
237
239
Le ricerche in Turchia
daniele Malfitana, Maria luisa sCrofani, La ceramica di Sagalassos decorata a matrice. Tipologia, cronologia, iconografia. Gli oinophoroi
liesBeth Claessens, From iconography to cultural identity, based on the mould-made wares from late Roman Sagalassos
Le ricerche in Albaniadaniele Malfitana, eduard shehi, Giovanni leuCCi, Giuseppe CaC-CiaGuerra, niCola Masini, Giuseppe sCardozzi, Giovanni fraGalà, Cettina santaGati, Maria elena MusuMeCi, A Late Roman villa in Dürres (Albania). Digital restitution from an integrated archaeological, remote sensing and geophysical research
Saggidaniele Malfitana, CarMela franCo, Giuseppe CaCCiaGuerra, Giovanni fraGalà, Archeologia della Sicilia romana, tardoantica e medievale: focus e prospettive di ricerca su documenti, cultura materiale e paesaggi
daniele Malfitana, Giuseppe CaCCiaGuerra, CarMela franCo, annarita di Mauro, Giovanni fraGalà, Merci e scambi tra il Nord e il Sud dell’Italia: dati ed osservazioni da alcuni contesti della Sicilia romana, tardoantica e bizantina. Il contributo del «Roman Sicily Project: Ceramics and Trade»
daniele Malfitana, La “Campana C” in Sicilia: un problema archeolo-gico-archeometrico aperto
CarMela franCo, Claudio Capelli, Sicilian flat-bottomed amphorae (1st-5th century AD). New data on typo-chronology and distribution and from an integrated petrographic and archaeological study
Giulio aMara, Archeologia e statalismo in Rostovtzeff. L’Egitto tolemaico del III sec. a.C.
Maria luisa sCrofani, Abbreviazioni bibliografiche
Organigramma, autori coinvolti nell’edizione del volume e collaboratori
pag.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
253
263
269
287
303
333
341
363
377
437
Il progetto dI rIcerca dI vIa MaucerI
rosa lanterI, danIele MalfItana, gIuseppe caccIaguerra
lo scavo dI vIa MaucerI a sIracusa
Fra il 2010 e il 2012 la U.O. Beni archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa è stata impegnata nell’attività di sorveglianza archeologica durante i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria della “Borgata” di Siracusa, nella zona cioè che gravita in particolare intorno al quartiere di Santa Lucia, area coincidente in parte con l’antico quartiere di Akradina1. La natura dell’intervento (sostituzione della vecchia rete fognaria attraverso lo scavo di trincee la cui lar-ghezza non superava m 1,40/1,502) non ha purtroppo permesso scavi estensivi. A ciò va aggiunto che i precedenti sottoservizi avevano il più delle volte comportato lo sconvolgimento della stratigrafia e la distruzione delle preesistenze archeologi-che, motivo per cui l’analisi e lo studio dei dati deve necessariamente tener conto della loro frammentarietà.
Quest’area, che ancora alla fine dell’800, quando Siracusa era limitata ad Orti-gia, si presentava come un vasto spazio rurale coltivato a vigneti e mandorleti3, a partire dal 1885 fu interessata da un’intensa opera di urbanizzazione che dall’area ad Ovest della Piazza S. Lucia, si estese per successive lottizzazioni sia ad Ovest che ad Est, operazione che si protrasse sino al 19204.
All’urbanizzazione del quartiere della Borgata assistette Paolo Orsi, al quale si devono le prime osservazioni sulla dislocazione delle necropoli arcaiche scoperte in occasione degli scavi per le fondazioni dei nuovi edifici e le conseguenti consi-derazioni sui limiti dell’espansione di Siracusa sulla terraferma in età arcaica5. Più tardi, altri dati relativi alla presenza di tombe arcaiche sotto le attuali via Carso, via Ragusa, via Pasubio vennero registrati da L. Bernabò Brea in occasione degli scavi realizzati per la costruzione dei ricoveri anti-aerei durante la seconda Guerra Mondiale6.
Le nuove conoscenze a seguito dei recenti scavi7 hanno arricchito il quadro del-la distribuzione delle tombe arcaiche, rinvenute sotto le attuali via Pasubio, via Carso, via Ragusa, via Testaferrata, via Di Natale, via Mauceri, Piazza della Vit-toria, via del Santuario, via Carabelli, via Eumelo, via Enna, via Monfalcone, via
1 I lavori per la realizzazione del nuovo sistema fognario del quartiere della Borgata hanno avuto inizio nel 2008 sotto la direzione di Lorenzo Guzzardi, dirigente pro tempore del Servizio Beni Arche-ologici della Soprintendenza. Dal settembre 2010 la direzione scientifica è stata assunta da chi scrive, subentrata quale dirigente responsabile della U.O. VIII Beni Archeologici. 2 La larghezza delle trincee per la realizzazione della rete primaria oscilla tra m 1,10/1,40, quelle per la terziaria tra m 0,80/1,20. Le quote di scavo variano, per la rete primaria, da m 1,60 a 4,00.3 Cfr. cavallarI - HolM 1883, tav. II.4 Cfr. adorno 2004, pp. 169 -189.5 orsI 1891b; orsI 1925.6 BernaBò Brea 1947, pp. 172-214.7 Si fa qui riferimento alle scoperte nel periodo settembre 2010-aprile 2012; i dati di scavo precedenti, condotti sotto la direzione di Lorenzo Guzzardi, sono per il momento inediti.
102 Rosa LanteRi - DanieLe MaLfitana - Giuseppe CaCCiaGueRRa
dello Stadio, via Bainsizza (Fig. 1). Purtroppo, la maggior parte delle tombe, a fossa scavata nella roccia e ormai prive di copertura, è stata violata in antico e raramente si sono recuperati resti del corredo.
I dati più interessanti, tuttavia, riguardano le dinamiche dell’organizzazione degli spazi urbani fra l’età ellenistica e quella romana. Si è visto, soprattutto nella zona più settentrionale dell’area oggetto di indagine8, che alle tombe arcaiche si so-
8 Area compresa fra Viale Teocrito a Nord e l’asse via Agrigento -Via Eumelo a Sud.
Fig. 1. Localizzazione delle aree di rinvenimento delle tombe arcaiche (scavi 2010-2012).
Fig. 2. Domus di Via dello Stadio (rilievo A. Russo).
Il progetto dI rIcerca dI vIa MaucerI 103
vrappongono direttamente le abitazioni di età tardo ellenistica e romana. Le strut-ture murarie che per tecnica costruttiva e quota di giacitura possono ritenersi più antiche, mostrano un orientamento Nord/Ovest-Sud/Est coerentemente a quanto già si conosceva dell’impianto urbano di Siracusa9, orientamento evidentemente influenzato in origine dall’assetto geomorfologico dell’area.
I dati confermano quanto finora emerso dagli scavi condotti a partire dagli anni ’50 del secolo scorso da Gentili10, che in genere definisce ellenistico-romane le strut-ture messe in luce, datate nell’arco cronologico di tre secoli. In realtà, occorrerebbe una più puntuale definizione cronologica, fondamentale per la comprensione della evoluzione urbanistica di Siracusa dopo la deduzione della colonia augustea nel 21 a.C.11 Alla luce delle nuove acquisizioni, infatti, sembrerebbe di assistere, a seguito dell’arrivo dei nuovi coloni nello scorcio del I sec. a.C. e quindi delle aumentate necessità abitative, all’edificazione di nuovi lotti che si presentano perfettamente orientati Nord-Sud lungo i cardi e i decumani del nuovo sistema viario che viene progressivamente a sostituirsi al precedente orientamento secondo assi stradali orientati Nord/Ovest-Sud/Est. La modifica dell’assetto urbano parte dalle aree fino a quel momento meno densamente abitate, se non a tratti libere, per le quali era meno problematico procedere alla ridefinizione degli isolati.
Il processo, chiaramente leggibile grazie ad alcuni saggi nell’area a Nord dell’ar-teria Est-Ovest che attraversa l’attuale Piazza della Vittoria, da dove ebbe probabil-mente inizio, si estese progressivamente anche a Sud della strada, man mano che si operarono quelle demolizioni e ricostruzioni che portarono alla ‘romanizzazione’ dell’impianto urbano della città che fino ad età ieroniana aveva seguito il più antico orientamento Nord/Ovest-Sud/Est.
La nuova organizzazione augustea secondo isolati Nord-Sud si legge in tutta una serie di strutture murarie pertinenti ad abitazioni disposte secondo gli assi viari del nuovo impianto urbano. Sulla base di lacerti di piani pavimentali in coc-ciopesto e/o opus signinum, si è proposta per la maggior parte di questi resti di abitazioni una datazione fra il I sec. a.C. e il I d.C. Non è stato possibile, per i motivi accennati in premessa, datare in maniera più puntuale i successivi rifacimenti.
Fra gli edifici costruiti secondo il nuovo orientamento Nord-Sud degli isolati va ricordata la domus messa in luce in via dello Stadio (Fig. 2) di cui sono stati indi-viduati almeno 8 ambienti, i cui muri perimetrali, di spessore che varia da m 0,30 a m 0,50, sono disposti secondo l’orientamento Nord-Sud e gli altri ortogonali ad essi. L’ambiente maggiore, ampio almeno m 8,00, era interamente ricoperto da un mosaico di età augustea a tessere bianche e nere con un motivo geometrico di sei triangoli disposti ai lati di un esagono centrale a formare un motivo a stella, a sua volta entro cornice esagonale, più volte ripetuto su due file lungo un’ampia fascia che inquadra un emblema quadrato, mutilo, al centro del pavimento (Fig. 3). Gli al-tri ambienti sono pavimentati in opus signinum, uno con semplici motivi geometrici a crocette realizzate con tessere di marmo bianco e nero inserite nel cocciopesto.
Un altro edificio costruito secondo il nuovo orientamento Nord-Sud degli iso-
9 voza 1999b, pp. 89-105, fig. 67.10 gentIlI 1952; gentIlI 1956b.11 Strabo, VI, 2, 4.
104 Rosa LanteRi - DanieLe MaLfitana - Giuseppe CaCCiaGueRRa
lati è, ad Ovest di Piazza della Vittoria, il criptoportico, la cui ala est era stata individuata dal Gen-tili nei pressi dell’incrocio con via Mauceri negli anni ’50 del secolo scorso nel corso di indagini pre-cedenti la costruzione delle palaz-zine INA12 (Fig. 4). I nuovi scavi13 hanno intercettato, a m -1,10 sotto
il piano stradale di via Di Natale nei pressi dell’incrocio con via Archia, l’ala ovest (Fig. 5). Va rilevato che la distanza fra le due ali è di m 76,00, pari a due isolati di m 38,00 (Fig. 6). Purtroppo, l’edificio si presentava ricol-mo di materiale di riporto, ma per la sua tecnica costruttiva può datarsi ad età au-gustea14. La costruzione del criptoportico ha comportato la distruzione degli edifici preesistenti, come dimostrano gli scavi di Gentili che aveva avuto modo di rilevare resti di muri che seguono il più antico orientamento Nord/Ovest-Sud/Est15.
La Via Mauceri è una delle strade moderne sotto cui, malgrado i rimaneggia-menti dell’ultimo sessantennio, è stato ancora possibile mettere in luce resti di strutture e raccogliere dati utili alla ricostruzione della topografia della città antica.
Oltre alla necropoli arcaica cui si è prima accennato, di cui si sono messe in luce
12 gentIlI 1956b, p. 108.13 Lo scavo è stato eseguito da Lucia Midolo.14 Gentili individuò la base di un muro intonacato, coperto di graffiti, che ritenne il muro di chiusura del criptoportico, su cui oggi si imposta la recinzione di un condominio. Cfr. gentIlI 1956b, pp. 135-138.15 gentIlI 1956b.
Fig. 3. Particolare del mosaico della domus di Via dello Stadio (rilievo A. Russo).
Fig. 4. Pianta da gentIlI 1956 con il posizionamento dell’ala est del criptoportico.
Fig. 5. Ala ovest del criptoportico in corso di scavo.
Il progetto dI rIcerca dI vIa MaucerI 105
Fig. 6. Posizionamento delle ali est (scavo Gentili) ed ovest (scavi 2010-2012) del criptoportico.
Fig. 7. Via Mauceri, tomba a fossa. Fig. 8. Via Mauceri, sepoltura entro sarcofago litico (disegno G. Pelligra).
106 Rosa LanteRi - DanieLe MaLfitana - Giuseppe CaCCiaGueRRa
quattro tombe a fossa scavate nella roccia (Fig. 7) ed una in sarcofago litico con i resti dell’inumato ancora in situ (Fig. 8)16, notevoli sono i dati relativi alle abitazioni di età ellenistico-romana che alla necropoli si sono sovrapposte.
Già negli anni ’50 del secolo scorso, durante gli scavi per le fondazioni di nuovi edifici popolari costruiti negli isolati compresi fra le attuali via Archia, Via Di Na-tale e Piazza della Vittoria, G.V. Gentili aveva messo in luce alcuni pozzi e cister-
16 Lo scavo in quest’area è stato eseguito da Pietro Piazza.
Fig. 9. Via Mauceri, posizionamento della cisterna.
Fig. 10. Via Mauceri, la cisterna al momento della scoperta.
Fig. 11. Via Mauceri, cisterna (disegno G. Pelligra).
Il progetto dI rIcerca dI vIa MaucerI 107
ne pertinenti alle abitazioni di cui si rintracciarono alcuni tratti dei resti murari17.
Si tratta delle case di età ellenistico-romana, demolite e poi ricostruite secondo il nuo-vo impianto urbano ad assi ortogonali orientato Nord-Sud.
Ad una di queste abitazio-ni è pertinente la cisterna in-tercettata all’incrocio fra via Mauceri e via Di Natale18 (Fig. 9). La bocca è risultata in par-te demolita dalla precedente posa in opera di un pozzetto (Fig. 10), ma il suo riempimento si presentava ancora intatto (Figg. 11-12).
I materiali, che comprendono lucerne, ceramiche comuni, ceramiche fini da mensa a vernice nera e rossa, due dadi in osso, una gran quantità di frammenti di vetro (Fig.13), si collocano per la maggior parte nell’ambito del I sec. a.C. e I d.C., mentre il materiale più antico è rappresentato da due lucerne acrome di età iero-niana. è chiaro che la cisterna una volta non più in uso, è servita come discarica, come dimostra pure la notevole quantità di frammenti di intonaci parietali dipinti probabilmente derivati dalla demolizione di una casa (Fig. 14). Il terminus post quem per la definitiva chiusura del deposito è rappresentato dai materiali più recenti datati non oltre il primo decennio del II sec. d.C.
17 gentIlI 1956b, pp. 107-138.18 Lo scavo è stato condotto dalla dott.ssa Mariella Lentini, che ha in corso di studio i materiali.
Fig. 12. Via Mauceri, sezione della ci-sterna (disegno G. Pelligra).
Fig. 13. Frammenti vitrei dal riempimento della cisterna di Via Mauceri.
Fig. 14. Frammenti di intonaco parietale dipinto, dal riempimento della cisterna di via Mauceri.
108 Rosa LanteRi - DanieLe MaLfitana - Giuseppe CaCCiaGueRRa
I materiali, grazie alla collaborazione scientifica istituita fra l’U.O. Beni archeo-logici e l’IBAM, sono oggetto del progetto di ricerca avviato congiuntamente, i cui primi risultati sono presentati in questo volume19.
r. lanterI
Il progetto dI rIcerca e lo studIo deI MaterIalI: datI prelIMInarI
Nell’ambito del progetto di ricerca sulle ceramiche ellenistiche e romane di Siracusa, la problematica archeologica fondamentale da risolvere per affrontare l’analisi e l’interpretazione della cultura materiale è stata individuata nella sua contestualizzazione. Le ricerche sulle ceramiche ellenistiche e romane di Siracusa, infatti, sono ormai da circa quarant’anni affette da un enorme vuoto documentario che non permette un pieno inquadramento nell’ambito delle produzioni artigianali del Mediterraneo.
L’assenza di associazioni a precisi contesti stratigrafici e la conseguente difficol-tà di realizzare sequenze attendibili e una seriazione delle produzioni ha prodotto una generale e condivisibile diffidenza nell’utilizzare le ceramiche come elemento per la datazione. La questione, pertanto, va posta non solo sul piano strettamente legato al mondo delle produzioni ceramiche ma attraversa trasversalmente l’ap-proccio alla ricerca archeologica. La mancata seriazione, infatti, ha causato una vasta problematica sulla datazione stratigrafica delle fasi ellenistiche ed in parti-colare di età repubblicana con una evidente bassa precisione nella definizione dei fenomeni.
A questi aspetti deve aggiungersi l’assenza di specifici studi che permettano di differenziare e comprendere l’uso e il consumo delle ceramiche in relazione al con-testo di rinvenimento. In riferimento all’età repubblicana di Siracusa, possediamo, infatti, una bassa conoscenza dell’uso delle ceramiche nei contesti funerari, quasi nulla per le aree di culto e pressoché nulla per gli ambiti residenziali e domestici.
La collaborazione stabilita con l’U.O. Beni Archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa ha offerto l’occasione per studiare i materiali ceramici pro-venienti da una cisterna individuata presso l’incrocio tra Via Mauceri e Via Di Na-tale che permettono di gettare una prima luce sulle problematiche sopra descritte. Si tratta di un’area di fondamentale importanza per la comprensione della città in età classica che ha restituito una straordinaria sequenza di strutture e stratigrafie relative a diverse fasi urbanistiche. Il contesto risulta particolarmente interessante poiché, grazie ai dati di scavo, ha fornito una prima importante base per ricostruire le dinamiche di trasformazione delle produzioni siracusane e conoscere i modelli di consumo e distribuzione. La cronologia, infatti, compresa almeno tra il I secolo a.C. e gli inizi del II secolo d.C., permette di affrontare un periodo molto delicato per l’interpretazione della cultura materiale siracusana e siciliana.
Le ricerche sui materiali sono state concentrate sullo studio di alcune classi ceramiche che rappresentavano la maggioranza delle produzioni rinvenute e, so-prattutto, su quelle che possedevano potenzialmente il maggior volume di infor-
19 I materiali della cisterna sono stati oggetto di studio delle tesi discusse nell’anno accademico 2011/2012 da A. Cannata, C. Pantellaro, C. Rizza, V. Smiriglio. Vedi infra, i contributi degli stessi autori.
Il progetto dI rIcerca dI vIa MaucerI 109
mazioni. Il primo gruppo, studiato da Cristina Rizza, è costituito dalla ceramica comune tipo San Giuliano. Si tratta di una produzione locale ampiamente trascu-rata in passato ma che in realtà risulta fondamentale per ricostruire le dinamiche della cultura materiale di Siracusa tra l’età ellenistica e la prima età imperiale. Le indagini preliminari condotte sul contesto, hanno permesso di evidenziare alcune forme poco o per nulla conosciute che vanno ad aggiungersi al vasto repertorio di questa produzione.
La seconda produzione su cui sono state concentrate le ricerche è la ceramica a pareti sottili studiata da Antonino Cannata. Il gruppo ha restituito un quadro molto interessante non solo sul piano morfologico delle produzioni locali ma soprattutto per l’attestazione di materiali che sottolinea l’impatto evidente delle importazioni provenienti da Italia, Gallia e Penisola Iberica. Parallelamente, lo studio delle sigil-late italiche e orientali, condotto da Claudia Pantellaro, ha permesso di confermare il progressivo aumento delle importazioni ceramiche almeno a partire dal I secolo d.C. Infine, le lucerne, documentate da Viviana Smiriglio, permettono di seguire la diffusione dei principali tipi diffusi tra l’età ellenistica e la prima età imperiale.
Il gruppo di ricerca costituito per lo studio dei materiali è in parte coincidente con quello dell’area produttiva di Santa Lucia. Non è un caso. è stato così possi-bile, infatti, confrontare e incrociare dati e documentazioni provenienti dalle due aree archeologiche, diversi per funzione e formazione, ma che rappresentano due ambiti che necessariamente vanno paragonati per comprendere la trasformazione della cultura materiale in relazione al contesto.
Le cronologie, in parte coincidenti, inoltre, hanno permesso di realizzare l’in-quadramento contestuale e di individuare esattamente l’impatto delle produzioni siracusane su quelle importate. Si tratta di un primo importante tassello che in-sieme ad altri che si stanno aggiungendo potrà finalmente permettere una lettura complessiva della cultura materiale ellenistica e romana di Siracusa.
d. MalfItana - g. caccIaguerra