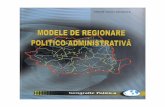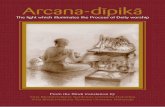Arcana imperii. La ricerca sul ‘politico’ di Gianfranco Miglio
Transcript of Arcana imperii. La ricerca sul ‘politico’ di Gianfranco Miglio
Dalla Humana, Respublicaalla crisi dell'ordinamentobipolare: Miglio e la politicainternazionale
II sogno impossibile di unanuova Costituzione per gliitaliani
La struttura fondamentaledel Politico nella visionescientifica di Miglio
II federalismi
II decisionisirMiglio
Miglio e Sehndel Politico
Confessione dradicale
L'avventura intellettualer\\
Dalla Humana Respublica,alla crisi dell'ordinamentobipolare: Miglio e la politicainternazionale
Il sogno impossibile di unanuova Costituzione per gliitaliani
La struttura fondamentaledel Politico nella visionescientifica di Miglio
L'avventura intellettualedi un pensatore scomodoe geniale: un ricordo
II federalismo come scienza
II decisionismo funzionale diMiglio
Miglio e Schmitt: il rischiodel Politico
Confessione di un realistaradicale
Rubbettino
IlSSsHStgSs
Rivista di Politica"Bimestrale di studi, analisie commenti
DirettoreAlessandro Campì
Comitato di DirezioneLeonardo Allodi, Danilo Breschi,Valter Corafiuzzo, Luigi Cimmino,Stefano De Luca, Giovanni Dessi,Stefano B. Galli, Alessandro Crossato,Spartaco Pupo, Maurizio Serio, .Pasquale Serra, Roberto Valle,Angelo Ventarne, Sofia Ventura
Comitato di RedazioneGiulio De Ligio, Chiara Moroni,Leonardo Varasano
Direzione e SegreteriaRivista di PoliticaCorso Cavour, 9906121 PerugiaTEL. 075-5733727www.rivistadipolitica.it
PRESENTAZIONE
5 Gianfranco Miglio, dieci anni dopoAlessandro Campi, Stefano Bruno Galli
DOSSIER MIGLIO
9 Miglio, una nota biografica (e qualche consiglio di lettura)Alessandro Campi
15 Arcana, imperii. La ricerca sul 'politico' di Gianfranco MiglioDamiano Palano . (-
57 La concezione politologica di Gianfranco Miglio nelle Lezionidi Scienza della Politica Alessandro Vitale
75 Miglio costituzionalista Fulco Lanchester97 La politica e le relazioni internazionali nella concezione
scientifica di Gianfranco Miglio Alessandro Vitale109 Con Schmitt, oltre Schmitt. Miglio e il rischio del 'politico'
Riccardo Cavallo129 Dare un volto al potere. Il "decisionismo funzionale''
di Gianfranco Miglio Davide Gianluca Bianchi143 Miglio, scienziato del federalismo Stefano Bruno Galli161 Gianfranco Miglio e la Padania Roberto Marraccini169 II federalismo tra radici naturaìistiche e nuove tecnologie
dell'informazione Chiara Maria Battistoni179 Un ricordo di Gianfranco Miglio Marcelle Stagliene
ARCHIVIO MIGLIO
197 L'equilibrio bipolare come forma di ordine internazionaleGianfranco Miglio
211 Uno scienziato politico davanti a se stesso. Colloquiocon Gianfranco Miglio Alessandro Campi, Alessandro Vitale
229 NOTIZIE SUGLI AUTORI
DOSSIER MIGLIO
Damiano Palano
1. Su questa fase della storiadella Facoltà di Scienze politi-che dell'Università Cattolica,cfr. A. COLOMBO, L. OKNAGHI, Le
Facoltà di Scienze politiche dìPavia e della Cattolica. Duecasi di «autonomia» durante ilfascismo, in «II Politico», LI(1986), n. 1, pp. 23-42, e D. PA-LANO, La scienza politica al-l'Università Cattolica del SacroCuore: profili storici e modelliteorici, in v, i. COMPARATO, R.LUPI, G. E. MONTANARI (a cura
dì), Le scienze politiche. Modellicontemporanei, Franco Ange-
"li, Milano 2011, pp. 124-138,2. G. MIGLIO, Considerazioniretrospettive, in n>., Le regola-rità della politica. Scritti scel-ti raccolti e pubblicati dagliallievi, Giufirè, Milano 1988,1,pp, XVII-LXXV, specie p.XXII.3./w',p.XXIII.4. Per un estratto di questocarteggio; cfr. A. VITALE, Dialo-go sulla scienza politica, in«La Provincia di Como», 15 ot-tobre 2006, pp. 46-47, dovesono anche riportate alcunedelle lettere.
Nelle Considerazioni re-trospettive poste adapertura delle ormaiclassiche Regolarità del-la politica, GianfrancoMiglio rievocò l'occa-sione del suo primo for-tuito incontro teoricocon Cari Schmitt. Miglioera allora al terzo annodi corso della Facoltàdi Giurisprudenzadell'Università Cattolica,e si apprestava ormaiad avviare la tesi di lau-rea, in Diritto interna-zionale, sotto la guida diGiorgio Balladore Pal-lieri. Neppure in quel
La teoria dell'obbigazione politica,elaborata da Erigilo nel corso dei decenni,è senza dubbio i3 cuore della suariflessione scientifica. Ma qua9 è Pesatestruttura logico-argomentativa di questacostruzione concettuale, a partire da99aquale egii ha sviluppato alcune delie suepiù celebri categorie d'analisi, dalrapporto di contratto-scambio allaconcezione della rendita politica? QyaSisolo le fonti intellettuali e ! materialiempìrici ai quali tìglio ha attinto per lamessa a punto di tale teoria? Quai è il suoreale valore esplicativo per lo studio delle"regolarità" che caratterizzano l'agirepolitico degli uomini? E eguali sono lecontraddizioni e le aporie - quantoinsanabili, quanto risolvibili - che essapresenta?
periodo, il giovane stu-dente abbandonò però la frequentazione con Alessandro Passerin d'Entrèves,che divenne forse addirittura più assidua. Benché fosse iscritto a Giurispru-denza, Miglio aveva infatti scoperto una straordinaria fonte di sollecitazioninelle lezioni dello studioso valdostano, allora incaricato dell'insegnamento diStoria delle dottrine politiche nella Facoltà di Scienze politiche dell'Ateneo fon-dato da Agostino Gemelli1. «Perla disciplina che insegnava, perla vastissimacultura di livello europeo, per il fascino ineguagliabile delle sue eleganti le-zioni, e per l'aristocratico stile di vita» - secondo le parole di Miglio - «que-sto docente e grande intellettuale esercitò ben presto su di me una influenzadecisiva: in particolare mi consentì di individuare il campo della ricerca piùcongeniale (allora) ai miei interessi»2. Fu d'altronde proprio Passerin d'En-trèves a far scoprire al giovane allievo autori come Otto von Gierke, Ernst Tro-eltsch e Friedrich Meinecke, oltre che la riflessione anglosassone suu'«obbli-go politico». E fu lo stesso Passerin d'Entrèves a far incontrare Miglio per laprima volta - seppur solo incidentalmente - con la personalità intellettualedi Schmitt. «Alcuni anni più tardi», scrisse infatti Miglio, «mi ricordai di aver-lo trovato nel suo studio, ai primi del 1939, sprofondato nella lettura di un li-bro 'bellissimo' (disse lui): era il Thomas Hobbes di Cari Schmitt»3. Dopo quelfortuito incontro, Miglio sarebbe tornato a confrontarsi più volte, e quasi inin-terrottamente, con il pensiero di Schmitt. Oltre a coltivare qualche rapporto,epistolare con il giurista di Plettenberg*, Miglio attinse infatti ai suoi scritti
DOSSIER MIGLIO
Damiano Paiano
1. Su questa fase della storiadella Facoltà di Scienze politi-che dell'Università Cattolica,cfr. A. COLOMBO, L. OBNAGHI, Le
Facoltà di Scienze politiche dìFa-ma e della Cattolica. Duecasi di «autonomia» durante ilfascismo, in «II Politico», LI(1986), a. 1, pp. 23-42, e D. PA-LANO, La scienza politica al-IVniversità Cattolica del SacroCuore: profili storici e modelliteorici, in v. i. COMPARATO, R.LUPI, G. E. MOHEANAJU (a curadi), Le scienze politiche. Modellicontemporanei, Franco Ange-
'li, Milano 2011, pp. 124-138.2. G. MIGLIO, Considerazioniretrospettive, in ED., Le regola-rità della politica. Scritti scel-ti raccolti e pubblicati dagliallieoi, Giuffiè, Milano 1988,1,pp. XVII-LXXV, specie p.XXII.3. Ivi, p. XXIII.4. Per un estratto di questocarteggio; cfr. A. VITALE, Dialo-go sulla scienza politica, in«La Provincia di Como», 15 ot-tobre 2006, pp. 46-47, dovesono anche riportate alcunedelle lettere.
Nelle Considerazioni re-trospettive poste adapertura delle ormaiclassiche Regolarità del-la politica, GianfrancoMiglio rievocò l'occa-sione del suo primo for-tuito incontro teoricocon Cari Schmitt Miglioera allora al terzo annodi corso della Facoltàdi GiurisprudenzadeflUniversità Cattolica,e si apprestava ormaiad avviare la tesi di lau-rea, in Diritto interna-zionale, sotto la guida diGiorgio Balladore Pal-lieri. Neppure in quel
La teoria dell'obbigazione politica,elaborata da Sbàglio nel corso dei decenni,è senza dubbio il cuore della suariflessione scientifica. Ma quaS è l'esattastruttura logico-argomentativa di questacostruzione concettuale, a partire daliaquale egli ha sviluppato alcun® dell© suepiù celebri categorìe d'analisi, dalrapporto di contratto-scambio allaconcezione della rendita politica? Q&iaSisolo le fonti intellettuali e i materialiempìrici ai quali Stiglio ha attinto per lamessa a punto di tale teoria? Quai è i@ suoreale valore esplicativo per lo studio delle"regolarità" che caratterizzano l'agirepolitico degli uomini? E eguali sosia lecontraddizioni e le apode - quantoinsanabili, quanto risolvibili - che essapresenta?
15
periodo, il giovane stu-dente abbandonò però la frequentazione con Alessandro Passerài d'Entrèves,che divenne forse addirittura più assidua. Benché fosse iscritto a Giurispru-denza, Miglio aveva infatti scoperto una straordinaria fonte di sollecitazioninelle lezioni dello studioso valdostano, allora incaricato dell'insegnamento diStoria delle dottrine politiche nella Facoltà di Scienze politiche dell'Ateneo fon-dato da Agostino Gemelli1. «Perla disciplina che insegnava, per la vastissimacultura di livello europeo, per il fascino ineguagliabile delle sue eleganti le-zioni, e per l'aristocratico stile di vita» - secondo le parole di Miglio - «que-
. sto docente e grande intellettuale esercitò ben presto su di me una influenzadecisiva: in particolare mi consentì di individuare il campo della ricerca piùcongeniale (allora) ai miei interessi»2. Fu d'altronde proprio Passerài d'En-trèves a far scoprire al giovane allievo autori come Otto von Gierke, Ernst Tro-eltsch e Friedrich Meinecke, oltre che la riflessione anglosassone sull'«obbli-go politico». E fu lo stesso Passerin d'Entrèves a far incontrare Miglio per laprima volta - seppur solo incidentalmente - con la personalità intellettualedi Schmitt. «Alcuni anni più tardi», scrisse infatti Miglio, «mi ricordai di aver-lo trovato nel suo studio, ai primi del 1939, sprofondato nella lettura di un li-bro 'bellissimo' (disse lui): era il ThomosHobbes di Cari Schmitt»3. Dopo quelfortuito incontro, Miglio sarebbe tornato a confrontarsi più volte, e quasi inin-terrottamente, con il pensiero di Schmitt. Oltre a coltivare qualche rapporto^epistolare con il giurista di Plettenberg*, Miglio attinse infatti ai suoi scritti
RIVISTA DI POLITICA 3
16 5. Cfr. e. SCHMITT, Scritti suThamas Hobbes, Giuffrè, Mi-lano 1986.6. e. SCHMITT, Le categorìe del'politico'. Saggi di teoria politi-ca, a cura di G. Miglio e P.Schiera, il Mulino, Bologna1972.7. In altre parole, dunque, comeha osservato Lorenzo Orna-ghi, «il giurista tedesco - allastregua di altri autori, anche seforse in misura maggiore e piùvistosa - viene 'incorporato'nel modello di Miglio». Cfr. L.OBNAGHI, II disordine della po-litica. Uh positivista atta cor-te della ragione, in L. ORNAGHI,A. VITALE (a cura ài),Multàfor-mità ed unità della politica.Atti del Convegno tenuto in oc-casione del 70° compleanno diGian/ranco Miglio. 24-26 ot-tobre 1988, Giufirè, Milano1S92, pp. 256-271, specie pp.264-265.8. Sulla riflessione di Gianfran-co Miglio, devono comunque es-sere tenuti presenti i materialiraccolti in L. OENAGHI, A. VITALE(a cura di), MuUiformità edunità della politica, cit, le rico-struzioni di A. CAMPI, Schmitt,Freiend, Miglio. Figure e temi delrealismo politico europeo, Akro-polis-La Roccia di Erec, Firen-ze 1996; e. LOTTIERI, Trapoliti-ca e mercato. Ilfederalismo nelpensiero dì Gianfranco Miglio,in AA. w., Omaggio alProfessorGianfranco Miglio. Stato e Mer-cato. Partner o antagonisti?No-vità e speranze per la. Piccola eMedia impresa.Atti del Conve-gno, Vitta Olmo - Como, 6 di-cembre SODI, Associazione Pic-cole e Medie Imprese della Pro-vincia di Como, Como 2002, pp.21-33; ID., Gianfranco Miglio(1918-2001), in «Telos», 2002,n. 122, pp. 101-110; m., Gian-franco Miglio da Schmitt almercato. La logica di una con-
-versione, in «Quaderni padani»,VII (2001), n. 37-38, pp. 86-91;G. NOBILI, In ricordo di Gian-franco Miglio, storico dell'am-ministrazione, in «Ammini-strare», XXXI (2001), n. 3, pp.
e alle sue ipotesi. Molti anni dopo, nella eoHana^reana imperii, pubblicò pro-prio quel «libro 'bellissimo'» che Passerin d'Entrèves leggeva nel 19395, masoprattutto - curando insieme all'allievo Pierangelo Schierala celebre anto-logia sulle Categorie del 'politico'5 - contribuì, in modo probabilmente deci-sivo, a reintrodurre la riflessione schmittìana nel dibattito italiano e a inne-scare, così, una straordinaria fioritura di studi e riletture. A dispetto del ruo-lo cruciale che le ipotesi sulle «categorie del politico» ebbero sulla sua inda-gine, Miglio però riprese solo in parte - e con una prospettiva specifica - il con-
tributo di Schmitt, perché, in realtà, ne utilizzò al-cune ipotesi per elaborare, e dare sostegno, aun'impresa che puntava in una direzione diversa,oltre che senza alcun dubbio originale. Per tutti glianni Sessanta e Settanta - e cioè nella fase in cuiil confronto con il giurista tedesco divenne più fit-to - Miglio dedicò infatti buona parte dei proprisforzi a costruire una teoria capace di chiarire lastruttura del rapporto di obbligazione politica, in-teso come il nucleo profondo di ogni fenomeno diaggregazione politica. In questa impresa - in cuiconfidava di unificare le acquisizioni della tradizionedel realismo politico, e in cui riteneva di poter fis-sare le basi di una «scienza della politica» effetti-vamente realistica - Miglio inserì anche la riflessionedi Schmitt, o almeno quelle che riteneva fossero lesue componenti più significative'7. L'ipotesi sulla con-trapposizione fra amico e nemico fu così, in una cer-ta misura, 'inglobata' dentro un modello assai piùarticolato, in cui la dicotomia amicus-hostis di-ventava non solo un modo per cogliere la specifi-cità del 'politico', ma anche uno degli aspetti - ine-lirninabili - della struttura del vincolo politico.Le pagine che seguono si concentrano proprio sialateoria delTobbligazione politica elaborata da Gian-franco Miglio nel corso di un'intera carriera di stu-dio8. Ma l'obiettivo che queste note cercano di per-seguire non consiste tanto nel fissare le sequenze diun percorso che - a partire dalla fine degli anni Tren-ta - giunge sino agli ultimi anni del Novecento, quan-to nefl'isolare alcuni nodi irrisolti, persine alcune apo-rie che - all'interno di una riflessione per molti ver-si unitaria - non cessano di proporre nuovi quesiti edi richiedere ulteriori approfondimenti9. Continua-re a lèggere le sue pagine come quelle di un «classi-co», formulando nuove domande, capaci di mette-re in questione persine i risultati che parevano più sta-bilmente acquisiti, significa infatti proseguire nelmodo migliore - e forse anche nel modo più fedele
- sul sentiero che aveva imboccato. Uh sentiero assai poco frequentato, che - nelcorso di circa mezzo secolo - condusse Gianfranco Miglio direttamente alle ra-dici del 'politico', e al cuore di quelli che erano, ai suoi occhi, gli Arcana imperii.
329-331; L. ORNAGHI , Gian-franco Miglio, in «Annali diStoria moderna e contempora-nea», XV (2009), pp. 99-104, L.ROMANO (a cura di), R pensierofederalista, di Gianfranco Mi-glio: una lezione da ricordare,Consiglio regionale dd Veneto-Cierre Edizioni, Venezia-Som-macambagna 201O, pp. 19-31; R.w. RONZA, II diavolo e l'acquasanta. Le radici eatfoliche del li-bertarìsmo migliano, in «Qua-derni padani», VIE (2001), n. 37-38, pp. 74-85; R SCHIERA, Upro-blema dello "Stato' e detta sua'modernità'. Gianfranco Migliodalla storia atta scienza politi-ca, in e. MIGLIO, Genesi e tra-sformazioni del termine-con-
_ eetto 'Stato', Morcellìana, Broscia2007, pp. 5-38; ID., L'insegna-mento di Mìglio quarant'annidopo, in «Storia Amministra-zione Costituzione», XII (2004),pp. 35-39; A. VITALE, L'eredità diGianfranco Miglio, in «Qua-derni padani», VII (2001), n. 37-38, pp. 108-116, m., Alle radicidella politica, in «Ideazione», IX(2002), n. 5, pp. 203-214.9. Per alcuni versi, le note pro-poste in queste pagine svilup-pano una lettura già avviata inalcuni contributi, cui mi per-metto di rinviare: D. PALANO,L'eternità e la morte. I confinitemporali dett'obbligazìone po-litica (Appunti sulla riflessio-ne teorica di Gianfranco Mi-glio), in «Teoria politica»,XVIII (2002), n. 2, pp. 121-156; ID., Il cristallo dell'obbli-gazione politica. La scienzadel potere di Gianfranco Mi-glio, in ID., Geometrie del po-tere. Materiali per la storia del-la scienza politica italiana,Vita e Pensiero, Milano 2005,pp. 289-450; ID., GianfrancoMiglio. Un nuovo classico, in«Formiche», III (2006), n. 11,pp. 17-19.
DOSSIER MIGLIO
II nome e l'opera di Sehmitt divennero realmente importanti, per Miglio, di-versi anni dopo l'occasionale incontro del 1939, e in particolare dopo che ilgiovane studioso ebbe sperimento fino in fondo il fallimento dell'impresa teo-rica che aveva definito come Humana Respublica. A partire dai primi annidi guerra, subito dopo la conclusione della tesi di laurea, Miglio si era infat-ti gettato a capofitto in un progetto ambizioso, che poneva al centro le tra-sformazioni del sistema internazionale dal Medioevo all'età moderna e, so-prattutto, l'ipotesi di una regolazione giuridica delle controversie fra Stati. Ilprogetto palesava già come Miglio andasse allontanandosi da un'indagine stret-tamente giuridica per accostarsi alla prospettiva della storia delle istituzionie delle dottrine internazionalistiche. L'obiettivo al fondo della ricerca sulla Hu-mana Respublica era, infatti, la ricostruzione sistematica della «storia delleidee e delle dottrine politiche prodotte in Occidente circa i rapporti frale co-munità politiche organizzate», e, dunque, sulla guerra e la pace in una 'comunitàdelle genti' intesa non solo come insieme di unità politiche autonome, bensìanche come «estensione di un ordine giuridico unitario a tutta l'umanità»10.Un simile progetto doveva però essere ben presto accantonato da Miglio, in-sieme all'enorme materiale raccolto sistematicamente, di cui solo una partefu utilizzata per la sua prima monografia - dedicata nel 1942 a La controversiasui limiti del commercio neutrale fra Giovanni Lampredi e Ferdinando Ga-liani11 - e per il lungo saggio su Marsilio da Padova12, Le motivazioni alla basedella decisione furono naturalmente complesse, ma non dovette essere irri-levante il mutamento intervenuto nel clima politico. Se attorno alla metà de-gli anni Quaranta gli orrori della guerra avevano reso addirittura dramma-tica la domanda sulla possibilità di disciplinare il conflitto e di vincolare l'azio-ne degli Stati a regole e istituzioni, il passaggio alla realtà della Guerra fred-da dovette moderare gradualmente, fino a spegnere, gli entusiasmi dell'im-mediato Dopoguerra. «Pur vinte e distrutte le dittature aggressive», scrissein effetti Miglio ricostruendo questo passaggio, «l'esperienza post-bellica sta-va infrangendo le speranze di un ordine internazionale basato sulla 'regola didiritto'», perché, di fatto, «la legge della forza, e del dominio sugli altri, si eraimmediatamente imposta di nuovo, quasi senza soluzione di continuità»13. Ma,proprio mentre il giovane studioso abbandonava il progetto della Humana Re-spublica, per riscoprire la 'regolarità' tucididea della reversibilità delle parti,doveva anche imbattersi - e forse addirittura scontrarsi - con la lezione diSchmitt. E non tanto (o almeno non ancora) con l'autore di quel libro che Mi-glio aveva intravisto fra le mani di Passerin dTEntrèves, quanto con il teoricodelle «categorie del politico». Proprio la scoperta delle ipotesi formulate dal-lo studioso tedesco e il confronto con il suo celebre saggio sul Concetto del 'po-litico''1' indussero infatti Miglio a un radicale rovesciamento delle ipotesi" pre-cedenti. In altri termini, se Miglio aveva creduto, fino a quel momento, allapossibilità che il diritto riuscisse a 'imbrigliare' la realtà più cruda della poli-tica, a vincolare cioè la forza all'interno di un sistema di regole, l'incóntro conSchmitt introdusse invece all'interno della sua ricerca un presupposto nuo-vo, e senza dubbio radicale: un presupposto in virtù del quale la 'politica' nonè mai interamente racchiudibile all'interno di un assetto istituzionale, e in baseal quale la 'politica' è sempre - almeno allo stato potenziale (ma mai solo alivello teorico) - contrapposizione fra amici e nemici. E le parole dello stu-
10. G. MIGLIO, Considerazioniretrospettive, cit., p. XXVI.11. Cfìr. G. MIGLIO, La contro-versia sui limiti del commercioneutrale fra Giovanni Lam-predi e Ferdinando Galiani(1942), Aragno, Milano 2009.12. G. MIGLIO, La crisi dell'uni-versalismo politico medioeva-le e laformozìane ideologica delparticolarismo statuale mo-derno, in A. CECCHINI, N. BOBBIO(a cura di), Marsilio da Pado-va. Studi raccolti nel VI cente-nario della morte, Cedam, Pa-dova 1942, pp. 229-328, ora inID., Le regolarità della politica,cit, I, pp. 1-105,13. G. MIGLIO, Considerazioniretrospettive, cit., p. pp.XXXVin. Su questo passaggiodella riflessione migliana, efr, L.ORNAGHI, Nell'autunno del'juspublicum europaeum': Gian-franco Miglio e la politica in-ternazionale, in G. MIGLIO, Lacontroversia sui limiti del com-mercio neutrale fra GiovanniLampredi e Ferdinando Ga-liani, cit, pp. V-XL.14. Gir. e. SCHMITT, JberSegriffdes Politischen, in «Archiv farSozialwissenschaftund Sozial-politik», LVHI (1927), n. 1, pp.1-33; la prima traduzione ita-liana, condotta però su unaversione del saggio successivaalla prima, fu pubblicata in e.SCHMITT, Principii politici delNazionalsocialismo, a cura diD. Cantinieri, Firenze, Sanso-ni 1935.
17
RIVISTA DI POLITICA 3
18 15. e. MIGLIO, Considerazioniretrospettive, cit, p. XXXVII.16. Ivi, p. 600.17. Ibidem.18. Ibidem,
dioso comasco, sotto questo profilo, risultano ehiarifieatrici di un passaggiocruciale, in cui il confronto con Schmitt risulta effettivamente decisivo:
la sua teoria delle «categorie del politico» - la famosa antitesi «amicus- .hostis» - mi chiarì che ogni vera aggregazione politica, formalizzata ono, è sempre '.esclusiva'; crea una sfera 'esterna' contestualmente alla fon-dazione del rapporto 'interno': per riconoscersi 'amici'bisogna avere (oinventare) dei (potenziali) 'nemici'. In tale prospettiva, le relazioni «in-ternazionali» sono soltanto una delle infinite 'inclusioni-esclusioni', chenascono, si intersecano e si dissolvono come effetto della perennementemutevole aggregazione (e lotta) politica: ogni 'ordine politico' è desti-nato ad essere 'disordinato' dalla politica, e la conflittualità (la 'guerra')è la condizione naturale vigente nella sfera dei rapportila i gruppi più
415o meno organizzati
Al principio degli anni Settanta, proprio nella Presentoz'one alle Categorìe del'politico', Miglio palesava - forse per la prima volta in modo esplicito - il pro-getto di una nuova scienza dei fenomeni politici, all'interno della quale la sco-perta della 'regolare' contrapposizione fra amico e nemico doveva costituireuna delle acquisizioni di base, ossia «l'elementare punto di partenza per tut-ta una serie di ricerche complementari, la rudimentale testa di ponte versoun territorio vastissimo e sconosciuto ancora da esplorare»16. L'obiettivo pri-mario della scienza cui Miglio pensava consisteva, prima di tutto, nella defi-nizione ideal-tipica del vincolo politico e del vincolo contrattuale (non poli-tico). La nuova scienza, come scriveva, avrebbe dovuto, da un lato, chiarire qua-le fosse «la struttura delTobbligazione politica e della 'sintesi' che pone in es-sere», e, dall'altro, ricostruire la logica dei «rapporti dinamici fra l'obbligazionepolitica stessa e l'obbligazione-contratto (giuridica) definitivamente separa-te»17. Proprio guardando verso una simile meta, Miglio faceva così intravedereai lettori dell'antologia schmittiana quali fossero i contorni di un progetto altempo stesso ambizioso e affascinante:
è ormai possibile tentare - con una ipotesi più generale circa la strut-tura e la dinamica della 'sintesi politica' - l'unificazione, in un solo e com-prensivo sistema, delle 'verità parziali' di lucidide 0a 'regolarità' dellaricerca del dominio 'esterno'), di Machiavelli (la 'regolarità3 degli egoi-smi concorrenti) di Bodin (la 'regolare' presenza in ogni sistema poli-tico del capo decisivo), di Hobbes (il 'regolare' carattere fittizio di ognicomunità, e la radice ultima della rappresentanza politica), di Mosca ePareto (la 'regolarità' della 'classe politica'), di Tonnies (la 'regolarità' del-la antitesi Comunità-Società), di Weber (la 'regolarità' delle forme ideo-logiche di legittimazione), e infine di Schmitt (la 'regolarità' della con-trapposizione «amicus-hostis»)18.
Quando Miglio accennava alla possibilità di unificare le diverse «regolari-tà» della politica, si riferiva a un lavoro che aveva già iniziato a, intrapren-dere da più di un decennio, da quando cioè - per effetto dell'incontro teo-rico con Schmitt - aveva preso a ripensare interamente le linee della pro-pria indagine. Non si trattava soltanto della 'scoperta' della formidabile fun-zione aggregante del nemico, perché, in realtà, Miglio aveva già accennato
DOSSIER MIGLIO
a questa dinamica in un passaggio (incidentale, ma non trascurabile) del sag-gio su Marsilio19. Sulla scorta delle ipotesi sehmittiane, Miglio operò piut-tosto una vera e propria inversione di quella prospettiva che, negli studi gio-vanili, lo aveva indotto a concentrarsi sulla dimensione internazionale e acollocare su un piano secondario le dinamiche interne alle singole sintesi po-litiche. Mentre adottava il criterio della costante contrapposizione fra ami-co e nemico, Miglio mutò sostanzialmente la prospettiva analitica, fecaliz-zandosi non più sull'esterno, ossia sulle relazioni ira Stati e fra unità poli-tiche autonome, bensì sull'interno delle singole comunità. Le cause profondedell'instabilità internazionale, e persine le cause della guerra, dovevano es-sere dunque rintracciate, in questa nuova prospettiva, non nell'assenza diistituzioni condivise e capaci di neutralizzare l'anarchia del sistema, bensìnella stessa conflittualità - ineliminabile - che allignava dentro i confini diciascuna sintesi politica. Come scrisse, molto più tardi, si trattava di un'im-plicazione dalla portata radicale:
[... ] dall'accettazione deDe tesi schmittiane, discese per me anche un im-portante corollario. Se le cose stavano così, allora era inutile tentare dispiegare la storia della 'comunità delle genti', cercandone le 'cause1 nel-le relazioni fra le sue componenti; ciò che accadeva all'esterno degli ag-gregati umani era soltanto conseguenza della dinamica interna (lottapolitica) di ciascuno di essi: la pace e la guerra nascevano dentro e nonfuori da ogni sintesi politica. Da qui l'improvvisa caduta dei miei inte-ressi pìer la storia delle idee e delle istituzioni 'internazionali' e l'abbandonodel 'grande progetto': tutte le cose che avevo imparato o scoperto era-no destinate a rimanere sepolte nei cassetti dei miei schedali, e nei pal-chetti della mia biblioteca: li avrei utilizzati, in minima parte, soltantoventicinque anni più tardi, ma unicamente per dimostrare la validità,e chiarire le implicazioni, del realismo schmittiano, sviluppato e supe-rato in una nuova teoria generale dei fenomeni politici20.
Le tracce di questo mutamento prospettico e del nuovo sentiero imbocca-to da Miglio possono essere intraviste in quasi tutti gli scritti che lo studiosocomasco ebbe modo di pubblicare fin dalla metà degli anni Cinquanta. Nel-l'importante saggio sulla struttura ideologica della monarchia greca arcai-ca, Miglio, per esempio, poneva già al centro il nodo dell'obbligazione po-litica, un nodo che avrebbe costituito il cuore della sua indagine per i suc-cessivi tre decenni. Sviluppando la proposta weberiana sui tipi di legitti-mazione del potere, e riprendendo anche la lezione degli^imzna imperii diPietro De Francisci21, Miglio individuava infatti una specifica tendenza - cheriteneva propria dell'esperienza occidentale - a vincolare all'interno di re-gole la 'personalità' del comando, e, dunque, a 'spersonalizzare' il potere22.Due anni dopo, nella prolusione su&'Uhitàfondamentale di svolgimento del-l'esperienza politica occidentale, Miglio riprese questa tesi di fondo, ma ciòche è forse più rilevante è che già in questi due interventi la dimensione 'per-sonale' - il rapporto di comando e obbedienza - identificava la configura-zione originaria del fenomeno di aggregazione politica. Nella prolusione, peresempio, scorgeva nella storia del mondo occidentale i riflessi di una «ir-requieta e logicamente sempre contrastata ribellione all'autorità dell'uomosull'uomo»23; una ribellione che, sul piano istituzionale, si era tradotta nel
19. Cfr. G. MIGLIO, La crisi del-l'universalismo politico me-dioevale e laformazione ideo-logica del particolarismo sta-tuale moderno, cit, p. 76.20. G. MIGLIO, Considerazioniretrospettive, cit, p. XXXVIII.21. Cfr. P. DE FRANCISCI, u4reawaimperii, Giufirè, Milano 1947-1948, 3 voli. Molto più tardi,Miglio avrebbe ripreso la for-mnl&Arcana imperii per inti-tolare la collana di Scienza del-la politica avviata negli anni Ot-tanta presso l'editore Giufirè.De Jrancisci aveva invece usa-to quella formula «non solo perdesignare, sulle orme di Tacito,la trama segreta delle struttu-re politiche del principato, maanche per indicare [...] le for-ze generatóri di una serie di fe-nomeni politico-giuridici incui si ripete, sia pare con esitivarii e con conseguenze diver-se, la medesima antìtesi irre-ducibile o la medesima alter-nanza perenne fra due princi-pii che rispondono a diversecredenze, a diverse concezioni,a diversi atteggiamenti spiri-tuali» (ivi, I, p. 15).22. Cfr. G. MIGLIO, La strutturaideologica della monarchia gre-ca arcaica e il concetto 'patrì-Tnoniale' dello Stato nell'etàantica, in «Jus», VI (1955),pp. 1-64, poi in m., Le regolaritàdella politica, cit, I, pp. 139-241.23. Cfr. G. MIGLIO, L'unitàfon-da-msn.ta.le di svolgimento del-l'esperiensa politica occiden-tale, in UNIVERSITÀ CATTOLICADEL SACRO CUORE, Annuarioper l'anno accademico: 1956-1957, Vita e Pensiero, Milano1957, pp. 391-410, poi in io., Leregolarità della politica, cit., I,
•pp. 325-350, specie pp. 229-330.
19
RIVISTA DI POLITICA 3
20 24. M, p. 330.25. M,pp. 229-330,26. G. MIGLIO, La strutturaideologica della monarchici gre-ca arcaica e il concetto 'patri-moniale' dello Stato nell'etàantica, cit, pp. 144-145.27. G. MIGLIO, L'unità fonda-mentale di svolgimento del-l'esperienza politica occiden-tale, cit, p. 329.
tentativo di «spersonalizzazione del comando», oltre che nel «toccante ane-lito ad un ordinamento in cui soltanto regnino precetti impersonali, sottrattiall'arbitrio di ogni umana volontà»24. Ma, contemporaneamente, trovava pro-prio nel carattere personale del comando latracela visibile degli «aspetti na-turali e più genuini della stessa obbligatone politica»25. In altre parole, ben-ché la dimensione personale dei rapporti politici apparisse a Miglio, alia metàdegli anni Cinquanta, ancora raccìnudibile all'interno di regole giuridichee controlli istituzionali, ai suoi occhi era comunque già chiaro come propriola relazione di- carattere personale tra il capo e il gruppo dei seguaci costi-tuisse un rapporto in qualche modo, 'naturale', oltre che, in ogni caso, pre-cedente a ogni regolamentazione formale. Nel lavoro sulla monarchia gre-ca arcaica, per esempio, aveva osservato:
il potere dei duci primitivi deve aver assunto una tipica struttura cari-smatica: erano capi-gente guerrieri che, imponendosi per virtù perso-nali, guidavano un 'séguito' più o meno numeroso di armati (un grup-po gentilizio o una federazione di armati) nella tormentata e, per noi mo-derni, ancora tanto oscura vicenda delle prime migrazioni greche26.
Anche nella prolusione del '57, il rapporto di «obbigazione politica» si pro-filava, nella sua forma elementare, in presenza di.una «prepotente autori-tà 'carismatica'», strettamente vincolata alla «personalità» del potere. Al tem-po stesso, la base della «sintesi» politica - il «séguito» degli aiutanti e deiseguaci - veniva definito dalla relazione di obbedienza al leader. E proprioin questo tipo di relazione 'personale' fra capo e seguito, Miglio ritrovava dun-que la forma originaria (e più semplice) del rapporto di obbligazione poli-tica:
L'obbligazione politica - là dove essa è più semplice ed originale, cioèdove sorge dalla presenza di una prepotente autorità 'carismatica' - ap-pare strettamente vincolata alla personalità del potere. Il 'séguito', in cuisi traduce e si attua la sintesi politica, è soggezione ad un comando per-sonale, all'ascendente di un capo la cui facoltà di persuasione e la cui for-tuna soggiogano le più deboli volontà e trascinano le moltitudini. E ciòvale, come tutti sanno, tanto per il condottiero ed il dittatore, come peril «leader» parlamentare27.
A partire dagli anni Sessanta, mentre andava dipanando il suo progetto diunificazione delle 'regolarità' scoperte dai grandi autori del passato, Miglioavrebbe mutato su un punto sostanziale la visione esposta in questi due im-portanti contributi. Neppure troppo gradualmente, avrebbe infatti abban-donato - o quantomeno sensibilmente ridimensionato - la propria opinio-ne in relazione alla possibilità di imbrigliare effettivamente il rapporto diobbligazione politica, approdando così all'idea che la componente personale,al cuore delì'obbligazione politica, sia irriducibile a qualsiasi tentativo di com-pleta giuridizzazione. Al centro della riflessione compiuta da Miglio nellalunga stagione compresa tra il principio degli anni Sessanta e la metà de-gli anni Ottanta sarebbe stato d'altronde proprio il tentativo di portare fi-nalmente alla luce i caratteri strutturali delì'obbligazione politica e de!con-tratto-scambio.
DOSSIER MIGLIO
n disegno complessivo della teoria delle due obbigazioni doveva essere espo-sto in quelle Lezioni di politica pura che Miglio promise più volte ai suoi let-tori, senza però riuscire mai a portarne a termine non soltanto la stesura, quan-to, probabilmente, la stessa struttura definitiva. Per questo, nei contributi del-lo studioso comasco (che sono, in alcuni casi, addirittura trascrizioni di rela-zioni non riviste dall'autore), le riflessioni sulla struttura dell'obbigazione po-litica sono spesso solo accennate, in modo persine frammentario, e comun-que mai in modo organico, tanto che il quadro teorico.che Miglio aveva de-lineato affiora solo nei suoi contorni generali. Forse, la struttura di quelle chedovevano diventare le Lezioni di politica pura si può invece ritrovare - sep-pur solo in forma scheletrica - nei corsi che Miglio ebbe modo di tenere al-l'Università Cattolica, e soprattutto nel corso di Scienza della politica che svol-se per circa un ventennio, dal 1968 fino al 1989. Era infatti proprio nelle le-zioni universitarie, che Miglio esponeva la propria specifica visione della «scien-za della politica»: una scienza ovviamente piuttosto distante da quella poli-ticai science che era andata prendendo forma nei dipartimenti delle univer-sità nord-americane, e che, anche in Italia, al principio degli anni Settanta,muoveva i primi passi. La «scienza della politica», cui Miglio si riferiva, guar-dava piuttosto alla grande tradizione continentale del realismo politico. E, ben-ché nella sua visione fossero ben visibili (soprattutto a partire da un certo mo-mento) le tracce di una vocazione positivista, la sua concezione della scienzadei fenomeni politici fu sostanzialmente incardinata all'interno di un'impo-stazione storicista, diretta alla costruzione di grandi tipi ideali28. Nel corso del-le sue lezioni, dopo aver illustrato cosa si dovesse intendere per «scienza», Mi-glio passava a chiarire quale fosse l'oggetto specifico della disciplina, e a illu-strare - nel modo schematico richiesto da un'esposizione didattica - gli anel-li logici che tenevano insieme le «verità parziali» scoperte dai grandi realistidel passato, oltre che gli elementi che costituivano la teoria dell'obbligazio-ne politica. All'interno della sua costruzione, un posto ovviamente cruciale -addirittura fondativo - era occupato infatti proprio dai due tipi dell'obbliga-zione politica e del contratto-scambio (definita anche come obbìigazione-contratto). E, mettendo in guardia dal confondere il nucleo originario dellapolitica' con alcune delle sue manifestazioni storiche, Miglio si soffermava pun-tigliosamente sulla struttura delle due obbligazioni.La contrapposizione fra obbligazione politica e contratto-scambio - nei ter-mini in cui veniva illustrata da Miglio - si chiarisce soprattutto in relazionea quattro dimensioni principali: a) il soggetto, b) l'oggetto, e) la struttura ed) Voriszonte temporale29. Innanzitutto, nel modello teorico migliano, le dueforme di obbligazione differiscono per il numero dei soggetti coinvolti: men-tre l'obbligazione politica coinvolge «moltitudini», il contratto-scambio im-plica la partecipazione solo di un numero ristretto e determinato di indivi-dui. Se una sintesi politica richiede un elevato numero di membri (e risultaanzi tanto più efficace quanto più l'ampiezza si accresce), un rapporto con-trattuale richiede invece un gruppo molto ridotto di partecipanti, perché unnumero elevato di contraenti tenderebbe a indebolire il vincolo della re-sponsabilità individuale e, dunque, a rèndere meno sicura la garanzia degliimpegni assunti30. Al contrario, nella sfera specificamente politica, la de-terminazione della responsabilità è - per l'essenza stessa del rapporto poli-
28. A proposito del metodo, cfr.6. MIGLIO, Osservazioni meto-daìagiche intorno alla ricercastorica in materia politica, inAA.W., / contributi italianial IV Congresso mondiale diScienze politiche, Vita e Pen-siero, Milano I960, pp. 139-141,poi in ID., Le regolarità dellapolitica, cit, I, pp. 369-373. Maindicativi, per una concretaesemplificazione, sono anche idue contributi: G. MIGLIO, Gliaspetti amministrativi del-l'unificazione nazionale. Glistudi di storia arnmirasfraMua,in «Archivio dell'Istituto perlaScienza dell'Amministrazionepubblica», II (1962), pp. 1217-1238, e 133., Premesse ad unametodologia della storia am-ministrativa, in «Annali dellaFondazione italiana per la sto-ria amministrativa», II (1964),pp. 11-19, entrambi ripubblicatiin ID., Le regolarità della poli-tica, cit I, rispettivamente pp.375-402, e 403-418.29. Cfr., per questa sistematiz-zazione, la voce Obbligatonepolitica, in L. OKNAGHI (a curadi'), Politica. Vocabolario, JacaBook, Milano 1994, pp. 335-337.30. Sulla responsabilità indi-viduale, cfr. anche G. MIGLIO,Considerazioni sulla 'respon-sabilità', in «Synesis», II(1985), pp. 7-10, ora in ID., Leregolarità della politica, cit., II,pp. 999-1006.
2.Ì
22 31. G. MIGLIO, Oltre Sfamiti, inG. DOSO (a cura di), La politicaoltre lo Stato: Cari Schmitt,Arsenale, Venezia 1981, pp. 41-47, ora in ID., Le regolarità del-la politica, eit, II, pp. 751-760,specie p. 755.32. M, pp. 755-756.33. G. MIGLIO, Guerra, pace,diritto. Una ipotesi generalesulle regolarità del ciclo politi-co, in AA. W., Della guerra, Ar-senale, Venezia 1982, pp. 37-56,in ID., Le regolarità detta poli-tica, cit, pp. 751-790, specie p.770.
RIVISTA DI POLITICA 3
tico - impossibile, e proprio per questo motivo non è effettivamente prati-cabile ridurre i rapporti politici entro una regolazione giuridica. Una simi-le distinzione implica naturalmente che politica e diritto siano sempre logi-camente distinti. «Per inoltrarsi nel nuovo territorio della politologia», os-serva d'altronde Miglio nella sua famosa relazione Oltre Schmitt, «è neces-sario - a min avviso - liberarsi dall'idea che i rapporti politici possano esse-re convcrtiti in rapporti giuridici», perché «diritto e politica sono da sempredue realtà autonome ed eterogenee» e perché «tra di loro è estremamentedifficile - forse impossibile - scorgere legami che consentano di prospetta-re qualcosa di più che una interferenza strutturale»31. In altri termini/poli-tica e diritto sono per Miglio irriducibili l'una all'altro perché rimandano adue forme di obbligazione distinte e irriducibili:
La politica e le sue categorie affondano infatti le radici in un tipo di ob-bligazione che è irriducibile all'obbligazione da cui scaturiscono i rap-porti e le categorie giuridiche: l'impresa che la moderna teoria giuridi-ca si era proposta - trasporre ed esaurire la politica entro l'ordinamentogiuridico - si rivela del tutto utopica, e destinata, fin dal suo sorgere, alfallimento. La conseguenza teorica ditale differenziazione è di granderilievo è colpisce a morte tutta una nobile tradizione culturale: è con-traddittorio parlare di 'diritto pubblico', poiché il 'diritto' è, nella sua re-altà ed essenza, soltanto 'dirittoprivato', dal momento che si colloca in-teramente entro la dimensione definita da quella modalità del 'priva-to' che è la figura del contratto-scambio. Prendendo le mosse dal con-tratto-scambio non si perviene mai a raggiungere il patto che fonda l'ob-bligazione politica: il patto di fedeltà si colloca in un ambito nettamenteseparato ed è origine di comportamenti assolutamente diversi da quel-li che si inscrivono nell'area dischiusa dai rapporti contrattuali32.
In secondo luogo, l'obbligazione politica mostra la propria peculiarità in or-dine all'oggetto che si propone di garantire: mentre il contratto-scambioattiene alla soddisfazione di bisogni attuali, ben precisati fin dal principiodella transazione, l'obbligazione politica si assume il compito di soddisfa-re bisogni indeterminati e 'globali'. In sostanza, se un contratto fra due in-dividui identifica con precisione, prima della conclusione dell'accordo stes-so, le condizioni specifiche dell'oggetto della transazione, l'obbligazione po-litica è invece tanto più efficace quanto più l'oggetto che si propone di ga-rantire è 'globale' e, dunque, indeterminato nei suoi contorni. Da questo pun-to di vista, osserva Miglio in un altro dei suoi interventi più noti, «c'è unnesso di grande importanza che deve essere rilevato: è quello che lega le ca-tegorie del Politico (e quindi la conflittualità) all'oggetto (scopo) dell'ob-bligazione politica», uno scopo che «consiste nel garantirsi globalmente l'esi-stenza per il futuro»33. Ciò che gli esseri umani hanno cercato nella poli-tica non è infatti un beneficio puntuale, ma una protezione di carattere glo-bale contro le minacce future: minacce ovviamente tanto più indefinite, quan-to più risultano lontane dal profilarsi al momento della conclusione del pat-to. E, se un simile oggetto risulta connesso strettamente all'eventualità del-la guerra e alla tutela della sicurezza, esso rimanda, più in generale, ai ri-schi futuri, da cui l'obbligazione politica dovrebbe - per sua essenza - ga-rantire:
DOSSIER MIGLIO
Costituendo un vincolo di obbigazione politica, ognuno di noi, infatti(in modo più o meno consapevole e razionale), cerca di garantirsi il sod-disfacimento dei bisogni - positivi o negativi - che immagina potran-no emergere .nel SGOJuturo: esigenze non ancora concretamente pre- ..cisate, ma che costituiscono il prolungamento logico di quelle che ab-biamo sperimentato in passato o con le quali ci troviamo attualmentealle prese. [...] La molla che spinge gli uomini ad aggregarsi in organismi
. politici, è l'inquietudine circa HJuturo: una inquietudine la cui inten-sità cresce quanto più si moltiplicano le opportunità e le situazioni (benie prestazioni) che l'evoluzione della specie (industrialismo) ci proponeper dar significato all'esistenza; ma cresce anche quanto più la divisionedelle conoscenze consente di immaginare 'scenaxi'futuri34,
In terzo luogo, in ordine alla struttura, l'obbigazione politica si definisce perMiglio come un rapporto esclusivo e non reversibile. Ovviamente, il contratto-scambio è un rapporto flessibile, reversibile e non esclusivo, nel senso che vie-ne ridefinito di volta in volta, in occasione di nuovi transazioni o quando icontraenti intendano rivedere le condizioni dell'intesa iniziale, e nel sensoche chi intrattiene una relazione contrattuale con uno o più individui può co-munque - anche contemporaneamente - mettere in atto altre analoghe tran-sazioni. Al contrario, l'obbligazione politica è una relazione esclusiva, in quan-to richiede ai membri una fedeltà esclusiva, e in quanto considera gli estra-nei come potenzialmente nemici. È ovviamente qui - intorno alla definizio-ne della struttura stessa dell'obbìigazione politica - che Miglio ingloba l'ipo-tesi schmittiana sulla contrapposizione fra amicus e hostis. «Schmitt», scri-ve in questo senso lo studioso comasco al principio degli anni Settanta, «ha'scoperto' e dimostrato, quarantacinque anni fa, che ovunque c'è 'politica'làsi incontra l'antitesi 'amico-nemico', e che ogni raggruppamento politico sicostituisce sempre a spese di, e contro un'altra porzione di umanità»35. Ma3
ovviamente, Miglio non si limita a recepire l'idea con cui Schmitt proponedi ricondurre il 'politico' alla distinzione tra Freund e Feind, perché utilizzaquell'idea - dilatandone i contorni - per definire la stessa struttura dell'ob-bìigazione politica. Ai suoi occhi, sulla scorta del Begrìffdes Politischen, l'ob-bligazione politica si configura infatti come un rapporto chiuso, come un rap-porto che include i membri e che esclude tutti gli 'stranieri', ossia coloro chestanno al di fuori dei confini - materiali o immateriali - della sintesi politi-ca. Ciò, nel modello migliano, implica diverse conseguenze. Innanzitutto, com-porta che, all'interno di una sintesi politica, «nessuno può, per coerenza lo-gica, riconoscere a più di un titolare (classe politica) il 'monopolio della for-za legittima'», e che, dunque, «quando due gruppi di potere pretendono egual-mente il 'monopolio della forza legittima' - e quindi contendono per stabi-lire la sovranità dell'uno sull'altro - chi li segue non può che stare o con l'unoo con l'altro-»35. In secondo luogo, il carattere esclusivo dell'obbìigazione ri-chiede - nella sua struttura logica - che vi sia una decisione che stabilisce ilconfine fra il dentro eQJuori, Si tratta, ovviamente, di una decisione che nonpuò discendere dal contratto, ma che dipende direttamente dal vertice po-litico e dal suo potere 'straordinario'. «Il potere che scaturisce dal patto po-litico», secondo Miglio, «proprio in quanto indipendente dalla normalità delcontratto, si rivela allora essere potere 'straordinario'j potere che decide, conmezzi eccezionali, circa il caso di eccezione»37. E nella facoltà stessa di de-
34. G. MIGLIO, M tempo come ele-mento psicologico nel processopolitico (1981), in ro,, Le rego-larità della politica, cit, II,pp. 791-797, speda p. 793.35. G. MIGLIO, Le categorìe delpolitico (1972), in E)., Le rego-larità detta politica, cit, II,pp. 599-600.36. G. MIGLIO, La soluzione diun problema elegante. A pro-posito del 'pluralismo'in San-ti Romano, in E BISCABETTI DIROFJlA (a cura di), Le dottrinegiuridiche di oggi e l'insegna-mento di Santi Romano, Giuf-frè, Milano 1977, pp. 215-217,poi in ED., Le regolarità detta po-litica, cit., II, pp. 603-608,specie p. 606.37. a MIGLIO, Oto-e Schmitt, cit,p.757-
23
RIVISTA DI POLITICA 3
24 . 38. M p. 758.39. G. MIGLIO, Guerra, pace,diritto, eit., pp. 765-766.40. M, p. 768.41. G. MIGIIO, Oltre Schmitt, dì-,p. 758.42. G. MIGLIO, La sovranità li-mitata, in AA. w., n pensierostrategico, Ranco Angeli, Mi-lano 1985, pp. 381-433, poi inID., Le regolarità della politica,II, pp. 1007-1074, specie pp.1060.
cidere sull'«eccezione» - o persine di 'inventarla' - si ritrova il potere prin-cipale del 'capo' politico:
La creazione dello stato di eccezione e infatti rifondazione dell'obbi-gazione politica, è decisione in virtù della quale il 'capo' politico ripro-pone con la massima intensità possibile il suo ruolo e, procedendo al-l'identificazione dei suoi seguaci, viene a costituire un nuovo raggrup-pamento e nuove contrapposizione polemiche. L'eccezione, suscitandoun diverso nemico e un diverso fronte conflittuale, consente di rinno-vare i criteri dell'aggregazione politiea e di renderla più compatta e com-battiva38.
In virtù di tali caratteristiche, l'obbligazione politica potrebbe apparire cosìcontraddistìnta, al tempo stesso, da una struttura piramidale, ossia da un rap-porto verticale fra capo e seguaci, e da una forma circolare, che circoscrive ̂ in-terno distinguendolo dall'esterno. Proprio per questo motivo, Miglio preferi-sce rappresentare graficamente il rapporto di obbìigazione politica come unasfera, ben delimitata rispetto allo spazio esterno, e tenuta insieme da un nu-cleo forte, coincidente con il 'capo politico', detentorc del potere sovrano. Ladistinzione fra il dentro e & fuori corrisponde, ovviamente, al confine tra l'areadella sicurezza e della pace e l'area dell'insicurezza e (potenzialmente) dellaguerra, «II carattere 'esclusivo3 di ogni aggregazione politica», scrive infatti Mi-glio, «genera l'esistenza 'normale3 di due aree ben distinte»: se «in quella in-tema alla sintesi politica regnano la pace e il diritto, di modo che ogni con-flitto, ogni contrasto viene obbligatoriamente risolto dalle istituzioni giudi-ziarie create e garantite dal potere politico, oppure da procedure arbitrali»,«l'area esterna è, invece, quella del conflitto senza limiti, quella in cui non ildiritto e la giudicatura valgono, ma la forza»39.All'interno di questo schema, altrettanto importante è, forse, proprio l'elementodella decisione del capo politico, l'elemento che chiarisce un aspetto impor-tante della struttura del vincolo politico. «Il potere di decidere chi sia il 'ne-mico' (e quindi chi siano gli alleati e gli 'amici')» costituisce infatti «la primae la suprema delle quattrojunzionifondamentali di ogni autorità sovrana»*0',perché proprio dalla capacità di ricreare costantemente la tensione fra den-tro e fuori, fra noi e loro, fra amici e nemici, discende la possibilità di rinsal-dare il seguito dei fedeli, prevenendo l'insorgere di conflittualità e dissidi in-terni. «La politica», secondo Miglio, è, infatti, «lotta contro un nemico e, in-sieme, lotta per assicurarsi uno stabile seguito di 'fedeli'»41. La coesione del-la sintesi politica richiede perciò, necessariamente, la polarizzazione controun nemico esterno:
a) ogni 'sintesi politica' è, per struttura intrinseca, esclusiva: coloro chela compongono diventano 'amici' ('cittadini', 'compagni', 'camerati',ecc.) solamente quando scoprono (o decidono) di avere gli stessi nemi-ci (nemicipubblici: «hostes»);b) essendo la coesione interna di una 'sintesi politica5 proporzionale algrado di 'polarizzazione' esterna dell''ostilità, i membri di ogni 'sintesipolitica' che goda di buona salute (sia cioè efficiente), sono spinti, pernatura, a crearsi dei 'nemici', a vincerli e ad assoggettarli: cioè ad esten-dere il proprio dominio, finché non trovano un 'nemico' più forte di loro42.
DOSSIER MIGLIO
La polarizzazione contro un nemico esterno non si riferisce necessariamen-te alla distinzione fra la sfera domestica e la sfera degli affari internazionali,almeno per come queste due dimensioni vengono abitualmente assunte, fl con-fine fra interno ed esterno, per Miglio, non richiede in altre parole che esistanofrontiere che separano il territorio soggetto alla sovranità di uno Stato da unterritorio.esterno. Dal momento che discende da una decisione, la demarca-zione fra interno ed esterno non è infatti mai stabile, 'naturale', determinatada elementi 'fisici3, ma sempre mutevole, tanto che Miglio individua «un'al-tra faccia essenziale del 'cristallo' della 'sintesi politica'» nella «relatività deiconcetti di 'esterno' ed 'interno'», ossia nella loro «convertibilità illimitata-»^.Nella riflessione del politologo comasco, lo spazio interno può così essere de-finito anche solo da confinì simbolici, da linee di separazione del tutto im-materiali, che però dividono chiaramente lo spazio dei seguaci da quello deinemici. Esiste però, secondo Miglio, una relazione molto stretta fra la pola-rizzazione con l'esterno e la forza del dominio del capo politico: non soltan-to perché tali due dimensioni sono necessariamente correlate, ma anche per-ché proprio la crescita della polarizzazione con l'esterno determina una pres-sione ulteriore alla verticizzazione interna dell'aggregazione politica. In so-stanza, quando la lotta contro un nemico diventa più intensa, e quando la po-sta del conflitto tende ad alzarsi, proprio allora dentro la classe politica si de-termina una spinta alla costituzione di un'ancora più ferrea gerarchla inter-na. Ciò significa, dunque, che, «quando una semplice frazione di classe po-litica' lotta realmente per il potere», come scrive Miglio, «essa si Veitìcizza'(cioè organizza al suo interno un meccanismo decisionale stabile)», e, per ef-fetto di questa strutturazione, «si forma un gruppo ristrettissimo di veri capipolitici (al limite una sola persona)», mentre «il resto della consorteria si di-spone come 'aiutantato', distribuito in cerchi concentrici»4*.Anche per Miglio la presenza del nemico è dunque fondativaper il rapportodi obbligazione politica. Inoltre, dal momento che solo la lotta contro un BS-mico (reale o inventato) consente di saldare il seguito dei fedeli attorno allafigura del capo, il rapporto di obbligazione politica non può estendersi oltreun certo limite. E, soprattutto, se Schmitt esclude con forza la realizzabilitàdi un'«unità politica» del mondo45, anche per Miglio iì rapporto di obbliga-zione politica non può in alcun modo dilatare i confini fino ad abbracciare l'in-tero genere umano, se non al prezzo di smarrire del tutto la coesione internae avviarsi, così, verso la dissoluzione:
al limite si può avere soltanto un minimo di due sintesi politiche, in re-ciproca opposizione e tensione: mai una sola (perché quando ciò si av-vera - testimone la sorte dell'Impero romano - il sistema politico 'uni-co' si autodistrugge, generando, dal suo interno, nuove 'polarizzazioni')46.
Infine, l'ultimo elemento che distingue l'obbligazione politica dal contratto-scambio emerge a proposito del tempo, ossia dell'orizzonte temporale in re-lazione al quale si qualificano i due tipi di obbligazione. In linea generale, os-serva Miglio nel denso intervento sul Tempo come elemento psicologico nel pro-cesso politico, «nel rapporto di contratto-scambio (privato) l'attesa - vale a direla quantità di tempo che si conviene debba intercorrere fra l'obbligo assun-to (promessa fatta) e la sua realizzazione (promessa mantenuta) - tende a ri-dursi a zero»*1. In sostanza, dunque, il contratto-scambio risulta tanto più ef-
43. G. MIGLIO, Guerra, pace,diritto, cit., p. 775.44. G. MIGLIO, "Classe politica'e'ideologia'. Due superabilijron-tiere nella, teoria maschianadel rapporto governanti-go-vernati, in E. A. ALBEETONI (acura di), Governo e governabi-lità nel sistema politico e giu-ridico di Gaetano Mosca, Giuf-frè, Milano 1983, pp. 11-17, poiin ID., Le regolarità della poli-tica, cit., II, pp. 833-843, spe-cie p. 838.45. «L'unità politica presup-pone la reale possibilità delnemico e quindi un'altra unitàpolitica coesistente», scrivevaper esempio Schmitt negli anniVenti, e, pertanto, «l'unità po-litica per sua essenza non puòessere universale». Cfr. e.SCHMITT, // concetto del politi-co (1927), in ED, Posizioni e con-cetti. In lotta con Weimar-Gi-nevra-Versailles. 2923-1939, a •cura di A. Caraeciolo, Milano,Giuffrè 2007, pp. 105-117, spe-cie p. 114. Ma si veda anche n>.,L'unità del mondo (ISSI), in nx,L'unità del mondo e altri saggi,a cura di A. Campi, Roma, Pel-licani, 1994, pp. 303-319.46. G. MIGLIO, Guerra, pace,diritto, cit., p. 788.47. G. MIGLIO, II tempo come ele-mento psicologico nelprocessopolitico, cit., pp. 794-795.
25
RIVISTA Dì POLITICA 3
26 4,8. M, p. 795.49. Ibidem.50. G. MIGJUO, Obbligandone po-litica, cit.: p. 337.51. a MIGLIO, Oltre Schmitt, cit,p. 760.
ficace, quanto più sono precisate le condizioni temporali della sua validità, equanto più la sua stessa vigenza è circoscritta nel tempo. Se «i contratti i qua-li meglio funzionano sono quelli pattuiti ed esauriti (onorati) 'hic et nunc'»,«più i comportamenti promessi (e i relativi 'diritti5) si protraggono nel tem-po, e più aleatoria (improbabile) diventa Teffettualìtà del contratto»48. Per l'al-tro verso, l'obbligazione politica tende invece per sua natura a proiettarsi ver-so un orizzonte temporale estremamente lontano. Ciò non deriva soltanto dalfatto che ogni potere sovrano si definisce come sostanzialmente 'eterno' (nelsenso che non si impone limiti temporali predefiniti), ma discende, soprat-tutto, da uno dei caratteri fondamentali del vincolo politico, ossia dal fatto cheil rapporto di obbigazione politica si propone di offrire una garanzia 'globa:
le' per tutti i bisogni futuri. E, se tali bisogni futuri non possono che essere sem-pre indeterminati nei loro contorni, è piuttosto scontato che la garanzia piùefficace del loro soddisfacimento differito debba derivare dalla coercizione fì-sica, o quanto meno dalla possibilità di utilizzare misure coercitive:
in effetti la politica è il regno non solo [...] del 'differito' contrappostoall'Immediato1: ma anche del 'garantito'. [...] 'Garantito', infatti, può es-sere solo un evento che non si è ancora prodotto, ma il cui awerarsi/ìi-turo si vorrebbe assistito da un alto grado di probabilità. Ma nessuna'garanzia', circa il comportamento dei nostri simili, è maggiore di quel-la offerta da una 'forza coercitiva', cioè dalla possibilità di costringerli- anche se non lo vogliono - a comportarsi in quel determinatomodo49.
In ordine alla proiezione temporale, dunque, l'obbligazione politica non sop-porta alcun vincolo temporale, ed effettivamente, sotto questo profilo, la po-litica «pare poter essere signora del tempo e della storia»50. Ciò, però, non si-gnifica soltanto che il potere politico tende a garantire, mediante la propriaforza, i bisogni che si presenteranno nel futuro. Implica anche - e questo è unaspetto cruciale della proposta migìiana - che la sintesi politica risulta tan-to più salda e coesa, quanto più viene tenuta desta l'attenzione per il futuro,e, cioè, quanto più viene alimentata la percezione di insicurezza futura:
La 'garanzia' sul futuro costituisce infatti il tratto di fondo defl'obhugazionepolitica: ci si obbliga politicamente soltanto in vista di una garanzia 'glo-bale' circa la soddisfazione dei bisogni che si immaginano incombere nelnostro avvenire. Un sistema politico conosce tanta più tensione versol'unità interna e tanta più aggressività verso l'esterno, quanto più è te-nuta desta l'attesa per il futuro; e il differimento nel tempo dei vantag-gi e delle fruizioni si accompagna alla persuasione che soltanto in tal modol'uomo possa realmente soddisfare tutti i suoi bisogni futuri51.
Non è casuale che Miglio insista con tanta forza sulla dimensione tempora-le dell'obbligazione politica. Benché non dedichi molti scritti a questo aspet-to, proprio l'ipotesi di una garanzia sui bisogni futuri costituisce d'altrondel'autentico perno attorno al quale ruota il modello dell'obbligazione politica,e a cui si connettono alcuni elementi fondamentali della riflessione migìia-na, come l'immagine dell'articolazione della classe politica, l'attenzione spe-cifica riservata agli aiutanti e il ruolo giocato dalle ideologie. Dato che lapre-
DOSSIER MIGLIO
senza del futuro è così importante, diventa infatti decisivo, per Miglio, com-prendere chi. produca le visioni alternative del futuro, come queste riescanoa imporsi e cosa venga effettivamente garantito ai seguaci da parte della sin-tesi politica.Ovviamente, il primo tassello che - almeno logicamente - struttura concre-tamente il rapporto di obbìigazione politica è costituito dal capo politico e, insenso lato, dalla classe politica. Quando riflette sulla forma assunta dal ver-tice politico, Miglio tende a-riprendere la tripartizione weberiana sulle formedì legittimazione del potere, e, in particolare, assegna .una priorità storica -nello sviluppo di ogni sintesi politica - al potere carismatico. Nello schemadella genesi della leadership - esposto agli studenti delle sue lezioni - Miglioriprende in sostanza le sequenze di formazione della comunità politica adot-tate nel dibattito tedesco dei primi decenni del Novecento. Secondo un simileschema, quando gli esseri umani hanno la possibilità di vivere gli uni accan-to agli altri, finiscono con influire reciprocamente sul loro modo di compor-tarsi e di pensare, e proprio per questo - per Miglio, come già per Georg Jel-Imek- giungono a formarsi delle «unità teleologiche», ossia rappresentazionicollettive, percepite come 'oggettive', che raffigurano un gruppo umanocome un'unità. È proprio a questo punto che, secondo Miglio, interviene laformazione della leadership, perché, all'interno di un gruppo già contrasse-gnato da una certa omogeneità in termini di valori e opinioni, un determinatoindividuo può emergere grazie alle capacità di persuasione. E infatti il mec-canismo della persuasione che consente l'adesione di un numero rilevante diseguaci. E, così, proprio la persuasione, proveniente dal 'centro', consente l'in-staurazione di quella coesione fra 'capo e 'seguito' che - come Miglio stessochiarisce in un breve ma importante scritto della metà degli anni Ottanta -costituisce il nucleo più robusto, e originario, di ogni aggregazione politica:
Ogni classe politica (o frazione di classe politica, o 'équipe' di potere) vedela sua 'presa' sulla storia, e quindi la sua fortuna, legate al grado dellapropria coerenza interna, vale a dire all'intensità della solidarietà e del-la disciplina che collegano i diversi strati e gruppi in cui essa si artico-la. Tale coerenza è certamente influenzata o determinata da una seriealtamente variabile di condizioni esterne, ambientali e storiche: ma essadipende sempre, in misura decisiva, dal fatto che, all'interno della clas-se politica, si instauri un processo centripeto di persuasione e di ade-sione: vale a dire che i diversi e diffusi momenti di «leadership» setto-riale, funzionino come canali di trasmissione di un messaggio unitario,emanato dal centro e accettato da tutto il sistema. Il processo di ag-gregazione prende dunque l'aspetto di una convergenza verso il centro,per effetto di una persuasione esercitata da chi 'sta al centro' della sin-tesi politica52.
Naturalmente, Miglio tende a considerare la leadership come individuale, nelsenso che, anche qualora al vertice dell'aggregazione politica si trovi un grup-po e non un singolo, «il numero ristretto di uomini» - a suo avviso - «agiscesinergicamente soltanto se accetta, in modo sufficientemente stabile, le de-cisioni prese abitualmente da uno di loro-»53. Al di sotto del vertice politico,sta però il complesso della classe politica, che Miglio - rivisitando la lezionedi Gaetano Mosca - suddivide in due diverse componenti, raffigurabili anche
52. G. MIGLIO, Monocrazia, in«L'umana avventura», I (1986),pp. 54-56, ora in nx, Le rego-larità della politica, cit., II,pp. 1081-1094, speda p. 1093.53. Ibidem. In altri termini,sottolinea ancora Miglio: «Larazionalità del pensiero e del-l'azione è sempre individuale:non è un prodotto 'collettivo':può essere soltanto condivisa.'Consentire'significa, del resto,accettare qualcosa proposta daaltri» (ibidem).
27
28 54. G. MIGLIO, 'Classe politica' e'ideolotga'. Due superabili fron-tiere nella teoria moschianadel rapporto governanti-go-vernati, cit., p. 837-55. G. MIGLIO, Genesi e trasfor-mazioni del termine-concetto'Stato', in AA.W., Stato e sensodelia stato oggi in Italia, Vita ePensiero, Milano 1981, pp. 65-86, ora in ID., Le regolaritàdella politica, cit., II, pp. 799-832, specie pp. 815-816.56. G. MIGLIO, 'Classepolitica'e'ideologia', cit., p. 838.57. Ivi, p. 839.58. M, p. 841.
RIVISTA DI POLITICA 3
cóme due cerchi concentrici, disposti attorno al nucleo della sintesi politica.In primo luogo, Miglio intravede la vera e propria «équipe di governo», os-sia «il gruppo ristretto di coloro che concretamente lottano per il ottenere, epoi per gestire, il potere»3*. Si tratta di un gruppo piuttosto esiguo, la cui esem-plificazione più nitida può essere rintracciata nel ristretto circolo di personeche Machiavelli - secondo la lettura di Miglio - in'dicava con il termine «Sta-to» : «gli aiutanti fidati che esercitano T'imperio' con il principe, e sono auto-rizzati a prendere decisioni capitali»; dunque, la «frazione di classe politica- uomini e interessi, come mezzi per l'esercizio del potere - che costituisce ilduro nocciòlo aggregante di ogni principato, di ogni 'repubblica'»55. In secondoluogo, frar«équipe di governo» e l'insieme dei governanti, Miglio - e qui stal'innovazione rispetto alla teoria moschiana - colloca uno strato intermedio,«costituito dai 'seguaci attivi' che, in veste di 'sottocapi', di 'capi subordinati',fungono (specialmente nelle sintesi politiche molto affollate) da legame in-dispensabile tra la vera classe politica e il 'séguito'»56. Per questo, Miglio puòallora scrivere di una «struttura ternaria» della sintesi politica, definita daitre livelli - o dai tre cerchi concentrici - delP«équipe di governo», defl'aiutantatoe, infine, del vero e proprio seguito.Nel modello migliano, il ruolo degli aiutanti è d'altronde estremamente im-portante non soltanto perché, in questo modo, è possibile 'aggiornare' la no-zione moschiana di classe politica, inadeguata a dar conto della contempo-ranea proliferazione degli incarichi politici. Gli aiutanti infatti sono rilevan-ti anche perche Miglio assegna a questa categoria il compito specifico di ela-borazione delle ideologie, un compito da un certo punto di vista addiritturacruciale per la coesione interna della sintesi politica. L'ideologia - definita, intermini ampi, come «il complesso delle mterpretazioni della realtà, delle at-tribuzioni di valore, e delie conseguenti scelte operative, che costituiscono la'dottrina' di ogni aggregazione politica» - risulta infatti fondamentale per ogniaggregazione politica:
L"ideologia' è indispensabile ad ogni 'classe politica' (ed alle sue frazioni)non soltanto come "bandiera di combattimento', intorno alla quale racco-gliere i seguaci; ma anche come strumento per 'auto-identifìcarsi' e di-stinguersi dalle altre. [...] l'elaborazione delle ideologie (e la loro trasfor-mazione in teologie) è un compito specifico delT'aiutantato', dagli strego-ni-sacerdoti delle società primitive, alle 'teste d'uovo', agli intellettuali 'or-ganici' dei giorni nostri. Ma i veri capi politici si riservano sempre la de-cisione circa i valori ultimi, costitutivi e discriminanti di ogni ideologia57.
La funzione di produzione ideologica è d'altronde importante per diversi mo-tivi. Innanzitutto, Miglio considera le ideologie non tanto come costrutti fi-losofici, più o meno elaborati, quanto come dottrine che 'guidano' effettiva-mente l'azione politica. Addirittura infatti - e questo è un aspetto che con-trassegna tutta la sua attività di studioso - le dottrine sono considerate sem-pre in stretta connessione con le istituzioni, perché queste ultime sono «le strut-ture concrete in cui una 'classe politica' storica traduce il suo 'credo' (e con lequali consolida il suo potere)»58. Inoltre, Miglio attribuisce un ruolo così si-gnificativo alla produzione di ideologie, perché sono le stesse ideologie a de-finire la fisionomia della sintesi politica, sia individuando i contorni del ne-mico contro cui lottare, sia proiettando la comunità verso una determinata meta
! i
DOSSIER MIGLIO
futura. Da un certo punto di vista, per quanto la sintesi politica prenda cor-po solo grazie alla costruzione del rapporto di fedeltà tra 'capo' e 'seguaci', talerapporto si può però costituire solo nella misura in cui adotti una determi-nata rappresentazione 'ideologica' della realtà, capace di propórre una defi-nizione dé&'hostis e una visione deliuturo. La lotta politica, infatti, «si accendecostantemente mediante l'invenzione di ideologie capaci di costitiiire un si-curo punto di riferimento' e di dare risposte univoehe e conclusive a tutti i pro-blemi che la situazione consente di sollevare»39. «I raggruppamenti 'amico-riemieo'», allora, «si costituiscono per mezzo di ideologie che mettono in gio-co le radici stesse dell'esistenza umana, mostrano il pericolo costante cui que-sta è esposta e, insieme, indicano la via seguendo la quale l'uomo può riac-quistare sicurezza circa la propria vita e il proprio destino»60. E, infine, le ideo-logie non possono che rivelarsi tanto più efficaci quanto più spostano in avan-ti, verso un futuro lontano, il momento di effettiva conclusione della lotta con-tro il nemico. «In politica», nota Miglio in-questo senso, «non conta tanto rea-lizzare il progetto (l'utopia) proclamato (anzi: in genere questo non si verifi-ca mai), quanto piuttosto comportarsi 'come se1 quel progetto dovesse, ad uncerto punto, diventare compiuta realtà»61. Proprio l'ideologia, dunque, nel mo-mento in cui differisce temporalmente il raggiungimento dei fini principalidel gruppo, mostra uno dei caratteri distintivi del fenomeno politico:
'Stare per', 'combattere per' sono così una manifestazione essenziale del.differimento temporale in politica; mentre è chiaro chel'obbiettivo verodi chi 'fa politica' non è quello di raggiungere la meta vagheggiata e chiu-dere la partita, ma è lo 'schierarsi', il lottare' senza fine 'per' una ipote-tica realtà che si allontana nel tempo (la 'giusta società', il Vero sociali-smo', il 'destino imperiale', ecc.)62.
Ovviamente, Miglio non ritiene affatto che le ideologie debbano riflettere fe-delmente la realtà, perché la loro efficacia non risiede affatto nel loro valorescientifico. Uno degli aspetti essenziali delle ideologie è invece quello di co-struire 'maschere', in grado non tanto (o non solo) di 'occultare' la realtà, quan-to di 'eostruirne' una determinata rappresentazione. Per un verso, infatti, leideologie, mentre costruiscono le grandi «finzioni», riescono ad 'astrarre' ilpotere, ossia a rappresentare il soggetto 'personificato' (come per esempio lo«Stato», ma anche la «classe», la «nazione», la «razza») come un'«entità di-stinta da chi umanamente la rappresenta»63. Per un altro, le ideologie inglo-bano al loro interno delle «antirealtà», «valori ricorrenti» che, però - comeavviene per le idee di eguaglianza, libertà o pace - «appaiono tutti rivolti a ne-gare altrettanti elementi costitutivi dell'obbligazione politica»64. Pertanto, leideologie non devono rappresentare in modo realistico il mondo, ma devo-no solo essere in grado di assicurare la coesione della sintesi politica e, allo-ra, la coesione del rapporto fra leader e seguaci. La loro efficacia può esseremisurata, dunque, solo in rapporto alla capacità di persuadere, di creare (e ri-creare costantemente) la contrapposizione con i nemici e con l'esterno. E, perquesto, le ideologie diventano strumenti politici solo quando vengono im-pugnate dal 'capo' e dal ristretto gruppo dei capi:
La forza traente delle valutazioni 'proposte a credere' e delle decisioniassunte, non dipende normalmente da Verità oggettiva'; ma nasce dal-
59. G. MIGLIO, Oltre Schmitt, cit,pp. 758-759,60. M, p. 759.61. G. MIGLIO, II tempo come ele-mento psicologico nel processopolitico, cit., p. 796.62. Ibidem. Su questo punto, sivedano le considerazioni di M.TRONTI, La personalità nellaGrande Politica, in «Bollettinodel Centro di Ricerche di Psi-cologia Politica e Geopoliti-ca», 2011, n. 1, pp. 44-58, spe-cie pp. 49-r50.63. G. MIGLIO, Genesi e trasfor-mozioni del termine-concetto'Stato', cit., p. 822. .64. G. MIGLIO, 'Classe politica'e'ideologia', cit, p. 841.
29
RIVISTA DI POLITICA 3
3O 65. G. MIGLIO, Monocrazia, cit,p. 1093.66. Cfr., per esempio, e.SCHMITT, L'unità del mondo ealtri saggi, cit.; Io., Il concettod'Impero nel diritto interna-zionale. OrdinamerOo dei gran-di spazi con esclusione dettepotenze estranee (1941), Istitu-to Nazionale di Cultura Fasci-sta, Roma 1941.6?. C. SCHMTTT, Terra e mare.Una considerazione sulla storiadel mondo (1942), Graffii, Mi-lano 1986.68. c, SCHMITT, II nomos dellaterra nel diritto internaziona-le dello «Jus Publieum Euro-paeum» (1951), Adelphi, Mila-no 1991.
la capacità persuasiva, o dalla posizione legittima, di chi assume quel- .le valutazioni e quelle decisioni. Al limite, importante è.che ci sia chi de-cide, non come decide: ciò che conta è la presenza dellafunzione55.
Per quanto le ideologie spostano la meta in un futuro lontano, e sebbene l'ob-bligazione politica si qualifichi proprio come garanzia contro minacce futu-re indeterminate, c'è però - secondo Miglio - un beneficio che spetta im-mediatamente al seguito, o quantomeno al gruppo degli aiutanti. Ed è a que-sto proposito che Miglio introduce il tassello delle rendite politiche. Un ele-mento teorico fondamentale, con il quale viene a distanziarsi - in mòdo espli-cito - dall'ipotesi schmittiana. Ma anche un elemento attorno al quale si ag-grovigliano una serie di nodi problematici, oltre che, forse, di vere e proprieaporie.
cui
Per quanto Miglio conosca in modo approfondito l'intera riflessione diSchmitt e ne segua costantemente gli sviluppi, i punti che realmente interessanolo studioso comasco sono quelli fissati negli scritti degli anni Venti e Trenta.In altre parole, ciò che, della proposta schmittiana, Miglio intende realmen-te ed esplicitamente inglobare è proprio l'ipotesi sul concetto del 'politico' ela-borata nella stagione weimariana. Ciò nondimeno, la sua teoria delTobbliga-zione politica si avvicina anche - seppur con una differenza sostanziale - allariflessione sul fondamento spaziale della politica condotta dal giurista tede-sco a partire dagli anni Quaranta. Perché, in effetti, la teoria migliana arrivaa proporre un'immagine della sintesi politica molto simile (non solo grafica-mente) a quella che emerge dagli scritti schmittiani sul rapporto fra terra epolitica.Se, infatti, le pagine delBegrìffdesPolitischen sembrano ricondurre l'imma-gine del rapporto politico a una sorta di struttura piramidale, la successiva ri-flessione di Sehmitt intorno al 'politico' e ai suoi elementi specifici si prestameno a essere rappresentata in questi termini. L'ipotesi enunciata origina-riamente viene in seguito arricchita da Schmitt, sia negli scritti sull'«unità delmondo»65 e sulla contrapposizione fra terra e mare67, sia, soprattutto, neliVb-mos derJ3rdee&. Proprio in questo celebre testo, infatti, il giurista tedesco de-linea nel modo più completo l'ipotesi intorno al legame costitutivo fra terrae politica, ossia, fra l'appropriazione di un territorio e la costituzione di unacomunità politica. Ma, in generale, in questa seconda stagione teorica il ter-ritorio appare a Schmitt sempre necessariamente connesso alla dimensionepolitica e alle sue valenze partitone. In altre parole, è soltanto l'occupazionedi terra, seguita dalla sua divisione, che consente a una comunità di esistere.E, soprattutto, è soltanto in seguito a tale occupazione che può essere effet-tivamente costruito uno «spazio» politico. I presupposti fondamentali per lastessa esistenza di una comunità politica consistono infatti nell'insediamen-to su un territorio, nella sua delimitazione mediante confini (più o meno sta-bili e definiti nel tempo) e nella loro difesa contro ogni minaccia (reale o po-tenziale) proveniente dall'esterno. Senza l'insediamento in un determinato ter-ritorio, e senza la possibilità di tracciare sul terreno la cruciale delimitazio-ne fra interno ed esterno, non esiste - secondo Schmitt - neppure là possi-
DOSSIER MIGLIO
bilità che un gruppo di esseri umani possa effettivamente costituire una verae propria «comunità politica». Per questo, il «confine» - il limite fra internoed esterno, tìsicamente fissato nel terreno e difeso con le armi da ogni possi-bile minaccia esterna - diventa una componente essenziale per la comunitàpolitica, E dunque - come avviene, almeno in parte, anche nella riflessionedi Miglio - la strattura della sintesi politica può essere rappresentata non tan-to come una piramide, quanto, piuttosto, come un'area circolare, o, meglio,come uno spazio con un centro politico e confini definiti.In modo più o meno esplicito, Sdamiti e Miglio sembrano allora ricondurre
. la struttura elementare della sintesi politica a una forma circolare, qualifica-ta dalla contestuale presenza di un centro e di un perimetro esterno, e in que-sto non è forse del tutto fuori luogo intravedere un'influenza della grande so-ciologia tedesca. D'altronde, la riflessione di Miglio suìT«obbligazione politi-ca» si definisce anche grazie a un confronto costante con il dibattito sulla for-ma dei gruppi sociali condotta in Germania nei primi tre decenni del Nove-cento, una riflessione di cui è possibile intravedere - seppur in filigrana - letracce anche nelle pagine di Schmitt. Quando infatti il giurista di Pìettenberg- forse dietro sollecitazione di uno scritto giovanile di Hans Morgenthau69 -modifica la propria originaria definizione del 'politico', sembra proprio allu-dere, implicitamente, alla riflessione sulle 'forme' della vita sociale. E, in par-ticolare, quando Sehrmtt riconduce la distinzione fra amico e nemicoalT«estremo grado di intensità di un'unione o di una separazione, di un'as-sociazione o di una dissociazione»70, sembra davvero istituire un confrontocon la riflessione condotta da Georg Sirnmel sul rapporto tra 'forma' e 'vita so-ciale'. Anche perché, nella riflessione di Simrael, la figura dello straniero - altempo stesso vicino e lontano rispetto alla comunità - si colloca proprio nelquadro di un'indagine sullo spazio, sugli ordinamenti spaziali della società esul ruolo costitutivo dei confini71.Nella teoria dell'obbligazione politica di Miglio, questi elementi non solo nonvengono meno, ma, si potrebbe dire, risultano addirittura enfatizzati. Non sol-tanto perché Miglio istituisce un confronto più esplicito con la sociologia te-desca della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, ma anche perché lostudioso italiano tende a mettere in discussione l'idea - cruciale invece perSchmitt - che una sintesi politica richieda necessariamente un radicamentoterritoriale. In corrispondenza di questo nodo, Miglio prende infatti più vol-te le distanze da Schmitt. Già nel 1972, per esempio, scrive che il giurista te-desco, persine nel Begriffdes Politischen, mostra in modo evidente «la rilut-tanza ad intendere lo 'Stato moderno' come una soltanto delle manifestazio-ni della politicità, come realtà storicamente limitata, transeunte», tanto chefinisce con l'assumere «un atteggiamento non del tutto avalutativo, ma anziappannato da certo residuo moralismo, verso la 'guerra civile' (cioè proprioverso il tipo.di guerra in cui meglio si esplicano le 'categorie del politico')»72.Per quanto Schmitt abbia come obiettivo il superamento dell'esperienza po-litica dell'Occidente moderno, e nonostante punti dunque a storicizzare quel-la specifica fórma di organizzazione del potere che è lo Stato (moderno), il suotentativo, secondo Miglio, non riesce a mantenere effettivamente le promes-se. E il motivo principale di questo fallimento consiste, per il politologo ita-liano, neU'impossibilità di prendere atto, effettivamente, della sostanziale an-tinomia logica fra politica e diritto, oltre che della irresolubilità dell'una nel-l'altro. In altre parole - come nota in Oltre Schmitt - lo studioso tedesco, sen-
69. Cfr. itti particolare H. i. MOR-GENTHAU, H concetto delpoliti,-eo. «Contro» Schmitt, a cura diA. Campi e L. Cimraino, Rub-bettino, Savana Mannelli 2009.70. C.SCHMITT, II concetto di'politico', eit, p. 109.71. Cfr. G. SIMMEL, Sociologia(19O8), Comunità, Milano,1981, e in particolare il famosoExcursus sullo straniero, pp.580-598.72. G. MIGLIO, Le categorìe delpolitico, cit, p. 595.
RIVISTA DI POLITICA 3
32 73. G. MIGLIO, Oltre Schmitt, eit,p. 755.74. P.P. FOKTINARO, La, teoriapo-litìca contemporanea e il pro-blema dello Stato, in A. PANE-BIANCO (a cura <K), L'analisi del-lapolitAca. "Pradi^ioni di ricer-ca, modelli, teorie, il Miilino,Bologna 1989, pp. 319-335,specie p. 326. Ma, in un quadropiù generale, cfr. anche ID.,Materiali per una staricimia-zione della coppia amico-ne-mico, in G. MIGLIO (a cura di),Amicus (Inimieus) Hostìs, Leradici concettuali detta con-
flittualità "privata'e detta con-flittualità 'politica', Giuffrè,Milano 1992, pp. 219-310.75. Sul punto, si devono però ri-cordare anche le osservazioniparzialmente critiche di o.BRUNNER, Terra epotere. Strut-ture pre-statuali epremodernenella storia costituzionale del-l'Austria medievale (1939),Giufirè, Milano 1983.76. e. scHMrrr, Appropriazione/Divisione/Produzione (1953),in no., Le categorìe del 'politico',cit, pp. 295-312.
za 'reìativizzare' interamente lo Stato, non riesce ad abbandonare l'idea di unordine politico che sia anche, al tempo stesso, un ordine capace di raggiun-gere la 'spoliticizzazione' grazie al diritto :
La figura classica dello Stato, ossia lo Stato in quanto monopalio dellapolitica e, insieme, in quanto progetto di spoliticizzazione, svanisce tra-scinando nel suo declinare la stessa 'civiltà giuridica', La politica si espri-me ormai oltre lo Stato e lo Stato rivela essere soltanto una transitoriae già superata manifestazione della politica. Per quanto Schmitt sia cer-to della verità di questo esito, egli non sa liberarsi della nostalgia per l'equi-valenza di Stato e politica, non sa rinunciare definitivamente alle sicu-re evidenze razionali che tale equivalenza garantisce: la sua cultura giu-ridica lo tiene ancora legato all'orizzonte classico disegnato dallo Sta-to moderno europeo e non gli consente di dare per irrevocabile il crol-lo dello «jus publicum europaeum»73.
Per un verso, secondo Miglio, la proposta di Schmitt, cercando di distingue-re in modo netto la dimensione del «politico» e la dimensione dello «Stato»,rompe l'equivalenza di «poh'tico» e «statale» che contrassegna la riflessionedei giuristi e dei teorici ottocenteschi, e mostra come lo Stato non sia altro cheuna specifica e storicamente determinata manifestazione del «politico». Perl'altro verso, però, mentre identifica il criterio del politico con la distinzionefra amicus e hostis (il nemico pubblico), Schmitt non può non reintrodurre,seppur solo surrettiziamente, un lascito della vecchia immagine dello Stato,ossia l'idea del suo carattere 'pubblico'. Così - come osserva Pier Paolo Porti-naro - il giurista torna «inavvertitamente a presupporre, con l'assunzione delcarattere della pubblicità di una associazione o dissociazione che voglia dir-si politica, la nozione di Stato come necessario correlato della sua definizio-ne»74. In altri termini, più che la distinzione fra amicus e hostis, è allora l'im-plicita distinzione fra hostis e inimieus (insieme a quella fra nemico pubbli-co e criminale) a palesare l'esitazione di Schmitt a liberarsi definitivamentedello spettro ingombrante dello Stato75.La divaricazione di Miglio non si limita però alla semplice registrazione del-la nostalgia di Schmitt per il vecchio jus publicum europaeum, ma procede benoltre, fino a investire il cuore stesso della visione dei fenomeni di aggregazio-ne politica. Quando Miglio segnalale difficoltà del giurista a prendere atto del-la strutturale antinomia fra politica e diritto, allude infatti anche alla teoriadel nomos che Schmitt elabora a partire dagli Quaranta, e che per molti ver-si contrassegna - in modo quasi ossessivo - la stagione della sua maturità teo-rica. Proprio negli anni in cui si concentra sul problema del fondamento spa-ziale della politica, Schmitt ritrova nel termine-concetto nomos il nucleo di unateoria capace di dar conto della stretta, originaria, costitutiva relazione fra ter-ritorio e politica. Ricostruendo le trasformazioni del termine greco nomos,Schmitt viene a mostrare infatti come esso derivi dal verbo greco nemein, incui individua tre significati connessi ma differenti; «prendere/conquistare»,«spartire/dividere», e «coltivare/produrre»*5. Ognuna ditali attività, scri-ve Schmitt, «appartiene completamente all'essenza di ciò che finora, nella sto-ria umana, è apparso come ordinamento giuridico e sociale», perché «in ognistadio della vita associata, in ogni ordinamento economico e di lavoro, in ognisettore della storia del diritto, finora, in un modo o nell'altro, si è preso, divi-
DOSSIER MIGLIO
so e prodotto»77. Benché ciascuna delle tre attività sia ovviamente fondamentale,all'interno della teoria schimittiana, il nehmen detiene una priorità logica neiconfronti degli altri momenti: ìlprendere è cioè l'indispensabile presuppostotanto della divisione, quanto della possibilità di avviare il pascolo e l'agricol-tura, ossia qualsiasi genere di.attìvità produttiva stanziale. II nomos rimandadunque, prioritariamente, al momento costitutivo dell'appropriazione, un'ap-propriazione che è per Schmitt un'appropriazione di terra:
La storia dei popoli, con le loro migrazioni, colonizzazioni e conquisteè una storia di appropriazione della terra. Quest'ultima è appropriazionedi terra libera, cioè di suolo fino a quel momento privo di padrone, op-pure conquista di terra nemica, sottratta al precedente proprietario invirtù del titolo giuridico della guerra esterna oppure redistribuita coi me-todi del bando, della privazione dei diritti e della spoliazione per cau-se politiche interne. In ogni caso sempre l'appropriazione di terra è l'ul-timo titolo giuridico per tutte le divisioni e distribuzioni successive e quin-di per ogni successiva produzione78.
Miglio non può però concordare con Schmitt a questo proposito, perché pro-prio attorno al nodo del significato originario del nomos si gioca, al di là di unacontesa di carattere etimologico, il confronto tra due visioni distinte dei fe-nomeni di aggregazione politica. Quando Miglio si accosta all'ipotesi di Schmitt,nel breve ma denso contributo Sul concetto di «nomos», non si limita così aesaminare la fondatezza della ricostruzione proposta dallo studioso tedesco,ma viene a espii citare uno dei punti chiave della sua teoria dell'obbigazionepolitica, ossia l'idea di una connessione originaria fra obbigazione politica erendita politica.Nella propria lettura, Miglio sostiene infatti che le origini più remote del no-mos vadano ricercate non nell'attività di divisione delle terre (rilevante soloa partire dall'introduzione dell'agricoltura), ma nella spartizione della predadi caccia. A monte della divisione del bottino di guerra - secondo questa in-terpretazione - sta dunque, come momento cruciale per la fondazione e il fun-zionamento della comunità politica, «la distribuzione delle parti dell'anima-le catturato e ucciso, ad opera del capo caccia»79. E, in questo senso, la radi-ce indoeuropea *nem- sarebbe allora da ricondurre al «momento finale e sa-liente della 'caccia grossa'», la «forma elementare e più antica di organizza-zione ed attività 'politica'»80. Il legame con il suolo - a differenza di quantoavviene nella teoria di Schmitt - appare dunque non come un aspetto costi-tutivo della politica, ma solo come un aspetto che emerge con il passaggio allasocietà agricola. In qualche modo, Miglio ritiene allora che l'attività di spar-tizione del bottino, caratteristica delle società di cacciatori, possa illustrare lalogica originaria che presiede alla formazione delle aggregazioni politiche, eche, lungo questa via, si possa correggere «il difetto di prospettiva cui soggiaceanche Schmitt quando considera la terra come l'oggetto primario della ap-propriazione-divisione»81. Nelle forme più semplici di organizzazione socia-le, la comunità politica, per quanto già orientata chiaramente al conflitto bel-lico (e dunque già caratterizzata da una divisione fra noi e loro), non risultainfatti insediata su uno specifico territorio, deHmitato da confini netti. Più sem-plicemente, come si è visto, tali confini secondo Miglio sono del tutto 'mobi-li': confini che definiscono uno spazio immateriale, uno spazio che non coin-
77. M, p. 299.78. Ivi, p. 300.79. G- MIGLIO, Sul concetto di«nomos» (1983), in p. p. PORTI-MARO, Appropriazione, distri-buzione, produzione. Materia-li per una teorìa del «nomos».Con una lettera di GianfrancoMiglio, Branco Angeli, Milano1983, pp. 169-171, poi in ro., Leregolarità deUapolìtica, cit., I,pp. 943-950, specie p. 948.80. Ibidem.81. Ivi, p. 947.
33
RIVISTA DI POLITICA 3
cide con un determinato territorio, ma che si riproduce ovunque si spostinoeffettivamente i membri dell'aggregazione politica. Ma non è solo l'assenza diun legame esclusivo col territorio che Miglio punta a sottolineare. Quando af-ferma che il possesso della terra non è «la sola risorsa», e che, soprattutto, «nonè il tipo originario di spoglio»82, intende anche sostenere che l'attività delladistribuzione delle parti dell'animale ucciso, ad opera del capo-caccia, esem-plifica la struttura elementare del rapporto di obbligatone politica. Un rap-porto che - come si è visto - richiede la costituzione di uno stabile rapportogerarchico fra capo e seguito, ma che prevede anche una redistribuzione di
34 sa. M, p. 948. rendite politiche da parte del leader:83. Ibidem.84. M, p. 949.
Se si discende [...] verso il tempo presente è facile rilevare che esiste unnesso chiarissimo fra la «distribuzione del bottino» consacrata da yépw-vó[ioq, e la moderna gestione-assegnazione di quelle che io chiamo le Ven-dite politiche' (paghe pubbliche, redditi di posizione, profitti comunquegarantiti e non ottenuti dall'alcatorietà di un 'mercato'). Se Agamennoneè l'erede del capo-caccia dell'età paleolitica, discendente di quest'ulti-mo è anche il capo-partito, l'uomo politico che ai nostri giorni sparti-sce-distribuisce fra i suoi seguaci i frutti del potere: cioè le parti dèliapreda («spoil»)83.
Sulla base di questa esplorazione, Miglio corregge allora Schmitt su un pun-to non marginale, perché ritrova nell'evoluzione del termine-concetto nomosuna conferma alla teoria delle due forme antitetiche e originarie di obbliga-zione. Se per Schmitt l'appropriazione di terra è il precedente logico e stori-co di ogni 'economia', per Miglio, invece, esistono due forme di 'appropriazione':da un lato, «quella che si realizza per mezzo della distribuzione (spartizione)di beni procurati (con la forza) dalla aggregazione politica'», e, dall'altro, «quel-la che si concreta per l'azione autonoma del singolo individuo (sulle 'res nul-lius', e sui beni prodotti dal Weiden'- comprendendo in questo anche lo scam-bio)»8*. In altre parole, il punto importante su cui Miglio insiste con forza -e rispetto al quale diverge dal pensatore tedesco - è relativo al carattere ori-ginario di entrambe le due forme di appropriazione. Per lo studioso comasco,infatti, obbh'gazione politica e contratto-scambio sono due tipi di relazione lo-gicamente irriducibili Tuna all'altra, due tipi di relazione che riflettono duemodalità differenti di 'appropriazione':
I due modi coni quali il singolo può 'appropriarsi' di qualche cosa, cor-rispondono ai due tipi fondamentali di relazioni inter-umane: il rapportodi contratto-scambio (privato) e l'obbligazione politica (pubblico). Inquanto tali, sono rispettivamente irriducibili. Se talvolta sembra il con-trario (sono i casi storici ai quali allude Cari Schmitt, dell'economia 'col-lettiva', e dello Stato che 'trasferisce' coattivamente risorse da privato aprivato) ciò accade perché non essendo possibile, di fatto, un ordinamentogiuridico (che garantisca gli effetti dell'appropriazione autonoma) sen-za il supporto di una sanzione (cioè di una forza coercitiva legittima')ed essendo questa forza, normalmente, appannaggio di coloro i quali de-tengono il potere, così costoro, mediante il sistema istituzionale - ori-ginariamente sempre fondato, come si è visto, sulla spartizione-ap-propriazione dei profitti 'politici' - non trovano ostacolo ad incorpora-
DOSSIER MIGLIO
re le risorse veramente 'private3 (autonomamente acquisite) fra le 'pre-de' da redistribuire (anziché garantirle)85.
L'enfasi posta sul carattere originario di entrambi i tipi di appropriazione èmolto importante nella riflessione di Miglio, perché in questo modo egli in-tende rafforzare l'idea, assolutamente cruciale, per cui obbigazione politicae contratto-scambio sono forme di relazione sociale del tutto autonome, ol-tre che irriducibili l'una all'altra. Non si tratta però di un'idea del tutto privadi ambiguità, anche perché, in alcuni punti, Miglio avverte che l'obbìigazio-ne politica fornisce una garanzia di ultima istanza anche alle transazioni dicarattere 'privato', in quanto essa salvaguarda con la minaccia della coercizioneil principio poeta sunt servando,. Nel suo intervento Oltre Schmitt,peT esem-pio, pare sostenere che, dato che ogni obbligazione-eontratto si fonda sulla re-gola poeta sunt servanda, anche le relazioni contrattuali devono in qualchemisura presupporre una base politica, che renda effettivo il rispetto dei pat-ti. Da questo punto di vista, sembrerebbe allora che, per Miglio, l'obbligazionepolitica preceda - quantomeno storicamente - Tobbligazione-contratto, o che,quantomeno, la relazione contrattuale non sia del tutto 'originaria', dal mo-mento che la sua vigenza richiede una condizione 'politica' esterna alla volontàdei contraenti:
È chiaro infatti che tutte le figure del 'contratto', fatta salva la loro au-tonoma realtà e non politicità, essendo stipulabili sxillabase della regola«pacta sunt servanda», hanno bisogno di riferirsi alTobbligazione po-litica e da questa dipendere, mentre l'azione che la «leadership» poli-tica svolge a favore degli 'amici' pacificati è il garantire la regola «pac-ta sunt servanda» e rendere così possibile il contratto. lutti i contrattiche implicano prestazioni da assolversi nel futuro richiedono un'ester-na garanzia politica, possono cioè realizzarsi solo entro un'area prece-dentemente pacificata e stabilmente assoggettata alla regola fondamentalesecondo cui ogni promessa deve essere mantenuta. Tutti i rapporti cheimplicano uno scambio protratto nel tempo rinviano, oltre di sé, ad unapreordinata protezione politica86,
Se una simile ambiguità sembra rendere meno nitida la distinzione fra ob-bligazione politica e contratto-scambio, ulteriori elementi problematici sem-brano affiorare nell'illustrazione dell'ipotesi delle due forme di appropriazione,e in particolare con il riferimento al momento della spartizione originaria del-la preda. Quando, nel saggio sul nomos, si richiama alle attività della caccianell'età paleolitica, Miglio non propone infatti una considerazione inciden-tale, ma esplicita un.nodo che, nel suo quadro teorico, diventa sempre più im-portante fra gli anni Settanta e Ottanta, e che dimostra un'attenzione sempremaggiore verso discipline come la paleontologia, l'etologia e la sociobiologia.Benché il suo metodo di indagine sia sostanzialmente incardinato nello stu-dio della storia, sull'esame approfondito della connessione fra dottrine e isti-tuzioni, sulla decostruzione delle «maschere» della politica, oltre che sulla co-struzione di grandi 'tipi ideali'87, Miglio inizia infatti a guardare con convin-zione al modello delle scienze naturali, è alla possibilità di guadagnare il pas-saggio «dallo studio prevalentemente letterario-fflosofieo (metafisico) dell'uomo,allo studio scientifieo-naturalistieo dello stesso»88. A ben vedere, già a parti-
85. Ivi, pp. 949-950.86. M, pp. 756-757.87. Secondo Panebianco, figlioricorre invece a «tipi reali»,nell'accezione di Cari Menger:«mentre il 'tipo ideale' è un co-strutto immaginario, il 'tipoideale' è ottenuto induttiva-mente e rappresenta regolari-tà osservate nei fenomeni con-creti purificati dalle loro .spe-cificità» (A. PANEBIANCO, Rela-zione, in L. ORNAGHI, A. VITALE[a cura di], Unità e multifor-mità della politica, cit, p. 244).88. G. MiGUO,L'Ì7isegnamentodelle scienze, in AA. w., Scuolaitaliana, professionalità e in-segnamento détte scienze, Qua-derni della Regione Lombar-dia, Milano 1977, pp. 19-21,ora in ID., Le regolarità detta po-litica, II, pp. 661-661, specie p.656.
35
RIVISTA DI POLITICA 3
3S 89. Si vedano al proposito lenote di A. QBADRIQ ARISTARCHI,Intervento, in L. OENAGHI, A. VI-TALE (a cura di), Mutèifonffità edunità della politica, cit, pp.317-326. Ma, su questo aspettodeBa ricerca migliarla, cfr. ancheL. OKNAGHI, D. PALANO, ASCESO, O
decadenza delle società e dette ci-viltà. Un nodo tra psicologia epolitica in alcuni scrìtti di-menticati, in P. CATELLAM (acura di), Identità e apparte-nenza nella società globale.Scritti in onore di Assunto Qwa-drioAristarchi, Vita e Pensiero,Milano 2005, pp. 239-296.90. G. MIGLIO, Uh diritto unpo'storto, in «L'Espresso», 11 no-vembre 1979, p- 45, ora, con iltitolo / novant'anni di CariSeìimitt, in ID., Jl nerbo e le brì-glie delpotere, pp. 95-100, spe-cie p. 100.91. G. MIGLIO, Una cascata discienza, intervista a cura diLuigi Geninazzi, «n Sabato», 9-15 agosto 1980, n. 32, poi, confl tìtolo Max Wéber (intervista),in E)., IL nerbo e le briglie delpo-tere. Scritti brevi di crìtica po-litica (1945-1988), Edizione delSole 24 Ore, Milano 1988, pp.111-112 (in particolare p. 112).92. a MIGLIO, Sua figlia, labiopolitica, «L'Espresso», 9 di-cembre 1979, p. 49, ora, con iltitolo Dall'etologia alla socio-biologia, in ID., Il nerbo e k brì-glie del potere, cit., pp. 101-102, specie p. 101.93. Una rilettura critica propriodi questa parte delle lezioni uni-venatarie di Miglio è stata di re-cente proposta in un intervento,ricco di sollecitazioni, F. COLOM-BO, L'ipotesi del padre. Per unajbndazione antropologica dellastona delle istituzioni politi-che, in «Cahiers Adriana Pe-tracchi. Quaderni di studi sto-rici», I (2010), pp. 129-161. Macfr. anche, sul medesimo nodo,Io., Un bagliore di civiltà: atteradici di casa,famiglia e potere,in A. PIVA, E. CAO (a cura di), Pro-gettare con la coscienza delpro-prìo tempo e della stona, Gan-gemi, Roma 2009, pp. 137-147.
ré dagli anni Sessanta, Miglio aveva palesato, in diverse occasioni, il propriointeresse per la possibilità di un nuovo incontro fra la scienza dei fenomenipolitici e la psicologia89. Ma, nel decennio seguente, questo interesse si espli--cita sempre di più, e per Miglio diventa addirittura possibile profilare una sin-tesi tra la Vecchia1 scienza politica europea di stampo realista e le nuove ac-quisizioni offerte dall'etologia e dalla sociobiologia. Ai suoi occhi, si tratta di«un'alleanza che promette di farci vedere (per usare un'espressione di Lorenz),Faterà faccia dello specchio'», ossia «le profonde radici, istintive e irraziona-li, dei nobili valori e della loro pretesa razionalità»90; Secondo Miglio, infat-ti, le nuove scoperte - conseguite «nelle aree di frontiera, fra le tradizionalidiscipline storico-sociali e i rami derivati dalla zoologia e dalla biologia» 91 -sembrano consentire la possibilità di fondare a un livello più profondo la teo-ria dell'obbligazione politica. E, da questo punto di vista, è quasi paradigmaticoquanto Miglio osserva in un intervento del 1979, in cui allude proprio alla pos-sibilità di «scorgere le radici 'naturali5 delle fondamentali regolarità a cui ob-bedisce il comportamento politico dell'uomo» :
gli studi recenti sui branchi di macachi giapponesi permettono ormaidi scorgere le radici «naturali» delle fondamentali regolarità a cui ob-bedisce il comportamento politico dell'uomo: il potere carismatico, lastratificazione dei ruoli di dominazione e di aiutantato, la funzione ag-gregante del nemico. Ma, su di un piano più alto, bisogna riconoscereche l'ipotesi formulata da Wilson nelle prime pagine di Sodóbiology, perla quale tutti gli organismi viventi sarebbero soltanto lo strumento concui l'acido desossiribonucleieo (Dna) riesce a conservarsi (utilizzandosoprattutto il meccanismo limbico-ipotalamico in cui sigenerano i no-stri sentimenti), è di una bellezza abissale: perché potrebbe ricondur-re tutte le «regolarità» biologiche alla fondamentale «regolarità» fisi-ca della conservazione della materia92.
Al di là delle implicazioni che l'avvicinamento a queste discipline comportaper il metodo della scienza dei fenomeni politici, è piuttosto scontato che Mi-glio possa trovare negli studi etologici e soeiobiologici uno strumento per af-finare la propria teoria dell'obbligazione politica e, soprattutto, per fornire unfondamento 'etologico' all'idea della rendita politica. Per quanto siano rela-tivamente pochi, o piuttosto generici, gli accenni che si possono rintraccia-re negli scritti del periodo, il sostegno offerto da questo di tipo di indagini di-venta infatti fondamentale per Miglio, tanto che nell'architettura delle lezioniuniversitarie il passaggio dei primi gruppi umani all'attività della caccia gros-sa viene a delineare l'espressione paradigmatiea del rapporto di obbh'gazio-ne politica93. In questo senso, lo studioso italiano attinge a un autore comeEdward O. Wilson, ma anche alle pagine di un efficace divulgatore scienti-fico come Robert Ardrey. In particolare, Miglio ricorre infatti alle argomen-tazioni di Ardrey - che sintetizzano i risultati conseguiti dalla ricerca etolo-gica degli anni Sessanta e Settanta - per ricostruire la struttura delle «formepiù elementari di aggregazione politica», e, proprio seguendo la tesi crucia-le svolta in The HuntingHypotesis (un testo peraltro accolto nella collanayìr-ca.no, imperii), giunge a rintracciare nella caccia (e soprattutto nella caccia-grossa) un supporto fondamentale per la sua teoria; Secondo Ardrey, infat-ti, la caccia ha un ruolo estremamente significativo nella storia evolutiva, per-
DOSSIER MIGLIO
che, oltre a stabilire un discrimine fra esseri umani e scimpanzè, innesca ilpassaggio a quelle forme cooperative che rappresentano, a livello embrionale,una vera e propria organizzazione sociale. Come scrive Ardrey in un passaggiosignificativo:
La caccia non solo implicava necessariamente nuove attività e nuovi tipidi cooperazione, ma modificava il ruolo del maschio adulto nel gruppo.Tra i primati vegetariani, i maschi adulti non spartiscono il cibo. Essisi scelgono le zone migliori'dal punto di vista del nutrimento e posso-no anche sottrarre il cibo ad animali in posizione meno dominante. Co-munque, dal momento che dividere la preda costituisce il comportamentonormale di molti predatori, la responsabilità economica dei maschi adul-ti e la pratica di spartire il cibo nel gruppo furono probabilmente il ri-sultato dell'essere carnivori; Esattamente le stesse attività che fecero sìche l'uomo fosse temuto dagli altri animali, condussero alla spartizio-ne del cibo, a una maggiore cooperazione ed alla indipendenza econo-mica94.
Il passaggio alla caccia, sempre secondo la sintesi di Ardrey, produce una se-rie di conseguenze cruciali, come lo sviluppo delle funzioni cerebrali (graziein particolare a un'alimentazione a base di carne rossa), la costruzione di unlinguaggio sempre più articolato, una rigida divisione sessuale dei compiti,la definizione di un'embrionale gerarchla sociale e politica, con l'affermazio-ne di un capo e dei suoi aiutanti più abili nell'attività venataria.Proprio grazie alle ricerche sul comportamento animale e a ipotesi come quel-la di Ardrey, Miglio può così superare quelle 'esitazioni' che ravvisa invece nel-la riflessione di Schmìtt. In particolare, infatti, mentre ingloba all'interno delproprio schema (e delle proprie lezioni) ì'«ipotesi del cacciatore», viene a farcoincidere la struttura delTobbligazione polìtica con la struttura di quella sor-ta di orda originaria di cacciatori, raccolti attorno a un capo e a un gruppo divalorosi aiutanti93. E, inoltre, arricchisce la struttura ideal-tipica dell'obbHgazionepolitica, inserendo - come elemento qualificante - la redistribuzione di unarendita. In questo modo, l'obbìigazione politica - oltre al rapporto tra capoe seguito, al carattere esclusivo, alla polarizzazione contro un nemico ester-no e alla proiezione verso il futuro - viene infatti a qualificarsi anche per ladistribuzione al seguito di una rendita 'garantita' politicamente. Così, per esem-pio, nel saggio sulla guerra scrive:
L'etologia (e prima ancora la paleontologia) hanno dimostrato la con-tinuità strutturale fra la primitiva 'caccia grossa' e la guerra fatta dal-le organizzazioni politiche più evolute, come procedure per procurarsisicuro sostentamento. Dal punto di vista istituzionale si passa pro-babilmente dal nemico divorato (perché assimilato alle altre prede ani-mali), al nemico ucciso (perché concorrente pericoloso), al nemico ri-sparmiato per utilizzare il suo lavoro (farsi mantenere dallo schiavodi guerra). Storicamente il 'prigioniero di guerra' è inizialmente sol-tanto un nemico risparmiato. E dal 'prigioniero' evolve la figura del-lo 'schiavo' in tutte le sue forme. Non per caso il sovrano, nelle primi-tive strutture politiche, è, per definizione, 'protettore del nemico vin-to'; poiché è toccato a lui decidere se risparmiare la vita del nemico,
94. R. AKDREY, L'ipotesi del cac-ciatore. Una conclusione per-sonale sulla natura evolutivadell'uomo, Giuffrè, Milano1986, pp. 30-31.95, A proposito di questo pas-saggio, Colombo ha ricordato:«"Eccolo" - chiosava Gianfran-co Miglio al termine della sualezione - 'il momento di gene-si del potere poEtieo. Ecco l'em-brione da cui nasce l'intermi-nabile succedersi di forme or-ganizzative del comando e del-la corrispettiva sottomissione diun gruppo numeroso al capocarismatico e ad una élite ri-stretta di derisori. Da lì in poi,a governare, saranno sempre ipiù forti, i più coraggiosi, piùarditi o semplicemente coloroche riusciranno a far credere diesserlo, perché destinati daliato, perché di origine sopran-naturale, perché unti dal Si-gnore, perché eredi di chi in-superabile ha dimostrato diesserlo in passato» (P. COLOM-BO, L'ipotesi del padre, cit, p.138).
37
RIVISTA DI POLITICA 3
33 96. G. MIGLIO, Guerra, pace,diritto, eit, pp. 769-770.97. P. SCHIERA, Ilproblema del-lo 'Stato'e della sua 'moderni-tà', eit., pp. 5-6.98. Cfr. e. BALLI, GianfrancoMiglio: la sfida politologica, inL. OBN&GHI, A. VEC&LE (a cura di),Unità e multiformità detta po-litica, eit., p. 312.99. Per questa formula, efr. L.ORMAGHI, II biologo della poli-tica, in «lì Sole 24 Ore», 6agosto 2006, p. 35. Ma, a pro-posito di questa componente,Ornaghi osserva anche come il«riduzionismo» di Miglio rap-presenti «la ragione principa-le dell'irrompere - che a moltipare ancora eccentrico, e chetalvolta inquieta - dell'etologiae della sociobiologia entrol'analisi della politica» (L. OR-NAGHI, II disordine detta poli-tica, cit, pp. 256-257).100. Cfr. G. MIGLIO, Genesi e tra-sformazioni del termine-con-cetto "Stato', cit., e nx, Le tra-sformazioni del concetto di rap-presentanza, in AA. w., La rap-presentanza politica, Pitagora,Bologna 1985, in ID., Le rego-larità della politica, eit., II,pp. 971-997-101. In tal senso, è anche scon-tato che Miglio, come granparte del pensiero realista, deb-ba incardinare la propria teo-ria «in una particolare antro-pologia, in una particolare con-cezione della natura dell'uomoassunta come invariante neltempo e nello spazio (presup-posto necessario, evidente-mente, di una ricerca delle re-golarità)» (A. PANEBIANCO, Re-lazione, cit, p. 245).
così egli diventerà più tardi il protettore istituzionale degli stranieridomiciliati («meteci») sul territorio occupato dalla comunità politi-ca. La titolarità della sovranità, come si estrinseca nella possibilità discegliere il nemico, si esplica anche nel diritto di risparmiare e pro-teggere il nemico vinto96.
A dispetto delle straordinarie suggestioni che propone, l'interesse 'di Miglioper l'etologia e per la sociologia è, molto probabilmente, uno degli elementipiù criticati, della riflessione di Miglio. Pierangelo Schiera, per esempio, alludea tale componente quando biasima la «mania per le scorciatoie scientifiche»,di cui Miglio diede prova «via via che cresceva la sua certezza nella possibi-lità di rintracciare una 'purezza' delle leggi che regolano la politica e addirit-tura anche di applicare tali leggi alla probabilistica del comportamento po-litico degli uomini»37. E, più in generale, Carlo Galli osserva che la «sfida po-litologica» di Miglio non può che divergere dalla riflessione filosofica - cen-trata sulla ricostruzione e decostruzione delle categorie «solo all'interno di unospecifico universo di discorso» - nel momento in cui si volge al campo delleNaturwissenschqften9*. D'altronde, è proprio sul terreno segnalato da Galli chesi palesa uno dei rischi principali della proposta migliana.Il rischio della deriva 'positivista' imboccata dal «biologo della politica»99 - unaderiva cui, ovviamente, Miglio non si abbandona interamente, dal momentoche, proprio nello stesso periodo, pubblica alcune delle Sue ricerche più im-portanti sulle trasformazioni di due «finzioni» capitali, nell'esperienza moderna,come «Stato» e «rappresentanza»100 - non risiedè infatti nella ricerca delle 're-golarità' di comportamento. La ricerca di simili uniformità caratterizza infat-ti, fin dalle origini, quella riflessione che - a partire da Tucidide - intende stu-diare la 'realtà effettuale' della politica101. Il rischio riguarda invece la possibi-lità che, proprio intersecando il sentiero della scienza della politica con quel-lo delle scienze 'naturali', e in particolare con quello delle scienze che studia-no il comportamento animale, si perda ciò che caratterizzala dimensione spe-cificamente 'umana' del potere e della politica. In altre parole, il rischio è che,pur guadagnando acquisizioni preziose sulle dinamiche di gruppo, si finiscacon l'affogare l'universo simbolico degli esseri umani in uno schema determi-nista. E un esempio emblematico emerge proprio a proposito delTinterpreta-zione migliana del nomos. •Quando infatti Miglio riconduce il significato del nomos alla struttura origi-naria dell'obbligazione politica e all'attività di spartizione del bottino effettuatadal capo-caccia, accosta evidentemente il nemico alla preda, ossia all'anima-le che viene spartito. In questo modo - mentre assume la possibilità che il ne-mico non sia un essere umano, bensì un animale - compie un passaggio cheindebolisce non poco la coerenza della sua riflessione. Ma, soprattutto, fini-,sce con l'ignorare una tappa essenziale, che scandisce invece in modo rilevantela storia dei gruppi umani. In altre parole, Miglio sembra rimuovere il mo-mento in cui la lotta fra gruppi umani inizia a diventare una lotta fra nemi-ci, ossia fra esseri umani che possono essere uccisi legittimamente, a cui però- a differenza di quanto avviene per le prede di caccia - viene riconosciuta lanatura di 'esseri umani'. In questo modo, Miglio pare dunque dimenticare chela. politica - come dimensione specificamente umana r- prevede sia ìa co-struzione di un confine fra esterno e intemo, in grado di individuare un di-scrimine tra amico e nemico, ma anche, implicitamente, la creazione di uno
DOSSIER MIGLIO
spazio simbolico - che è anche uno spazio del 'sacro' - in cui la vita degli uo-mini viene riconosciuta, al tempo stesso, come umana e come ucciditele.
4. §9 sacrificio © la rendita
I rischi che si annidano nella tentazione positivista non sono però gli unici cheminano la costruzione teorica di Miglio. Un'aporia ancora più insidiosa puòessere infatti rintracciata nella sua visione della rendita politica: una visioneche, per un verso, pare incardinarsi coerentemente all'interno della teoria del-l'obbligazione politica, ma che, per un altro, introduce un elemento che fini-sce col minacciare la stabilità dell'intero edifìcio.Nella teoria di Miglio, la concezione della rendita politica - come rendita spar-tita dal capo a beneficio dei seguaci - non è un elemento secondario102. Nel-l'interpretazione delle trasformazioni della società italiana (e occidentale), ilpolitologo espone, d'altronde, già nel corso degli anni Settanta, l'idea che ven-ga prendendo corpo una tendenza generale verso la crescente 'politieizzazio-ne' dell'economia, la quale innescherebbe la caduta della produttività e del-l'innovazione. In un saggio del 1976, individua per esempio una sorta di mo-.vimento oscillatorio fra 'politica' e 'mercato', che è anche un movimento oscil-latorio frale motivazioni psicologiche che spingono gli individui verso la 'ga-ranzia' delia rendita o verso iì 'rischio' del mercato. In sostanza, secondo Mi-glio, dopo che l'economia (e cioè la rendita conseguita mediante transazionidi mercato) ha consentito il raggiungimento di elevati livelli di benessere, gliindividui tendono a volgersi verso la ricerca di una più stabile garanzia, e cosìinizia a dilatarsi l'area delle rendite politiche103. «Il sistema industriale'avanzato'», a questo punto, «finisce necessariamente (ma non definitivamente)nell'economia 'collettiva'», ossia «nella sostituzione di rendite 'politiche'(cioè basse ma garantite") ai redditi di 'mercato' (cioè alti ma aleatorii, attra-verso una eccezionale espansione della piccola borghesia e del così detto set-tore 'terziario', ed una imponente moltiplicazione dei legami 'politici'»104. AMiglio pare dunque che il successo dell'economia del benessere inneschi, pa-radossalmente, un movimento opposto di allontanamento dal rischio mercantilee, così, una dilatazione consistente dell'area della rendita garantita:
Poiché la preoccupazione per l'avvenire è proporzionale alla quantità dibeni di prestazioni di cui si sospetta che si avrà bisogno per non sentirsiinfelici, cosile grandi economie 'di mercato' [...] finiscono normalmenteper far scattare la ricerca generalizzata deEa protezione politica. Que-sta infatti garantisce un certo livello di vita (rendita politica) e ristabi-lisce la gerarchla dell'arrampicata sociale, contemporaneamente-/rena?zdola crescita dello 'sviluppo*105.
Sulla scorta di questo impianto, Miglio ritiene che, alla metà degli anni Set-tanta, la stagione dèlio sviluppo sia ormai esaurita e che le società occiden-tali abbiano già incominciato una nuova «Lunga Grande Frenata»106. Sem-pre sviluppando una simile ipotesi interpretativa, in un saggio del 1980 isti-tuisce anche un'analogia fra le società post-industriali e le società antiche delMediterraneo, la cui economia non conobbe mai rilevanti innovazioni tec-nologiche. La motivazione che Miglio individua è sostanzialmente politica, ol-
102. Su questo punto, si veda-,no le osservazioni di L. ORNA-Gffl, Oltre la rendita politica: lavocazione originaria dell'im-presa, in AA. w., Stato e Mer-cato. Partner o antagonisti?,cit., pp. 34-41.103. Cfr. G. MIGLIO, Le trasfor-mazioni dell'attuale sistemaeconomico, cit., p. 616.104. Ivi, p. 614. ,105. Ivi, p. 620.106. JW,pp. 638-639-
39
RIVISTA DI POLITICA 3
4O 107. G. MIGLIO, Ciclo storico e in-novazione scientifico-tecnolo-giea. Il caso della, tarda anti-chità, ÌHAA.W.J Tecnologia eco-nomica e società nel mondoromano, s.e., Como 1379, pp. 9-20, ora in ID., Le regolaritàdella politica, cit, II, pp, 731-749, specie p. 743.108. G. MIGIIO, Una repubblicamediterranea?, in AA, w.,Un'altra Repubblica? Perchécome quando, Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 110-118, ora inID., Le regolarità della politica,àL, II, pp. 1005-1104, specie p.1100.109. M p. 1101.
tre che, al tempo stesso, 'culturale'. «Le civiltà mediterranee», ai suoi occhi,«furono tutte caratterizzate da una schiacciante preponderanza dell'area 'po-litica', e delle rendite 'politiche', rispetto all'area del 'privato5 e dei redditi 'dìmercato'»107. In altre parole, se obbligatone politica e contratto-scambio sonodue tipi 'originali' di relazione, le singole società manifestano una predispo-sizione 'culturale' per l'una o per l'altro, perché, in ognuna di esse, risultanopiù consolidate la ricerca di una garanzia 'politica' o la propensione al rischioindividuale.Anche quando la situazione delle economie occidentali sembra migliorare, in-torno alla metà degli anni Ottanta, Miglio non rinuncia d'altronde a questachiave di lettura. Così, nel suo breve saggio Una repubblica 'mediterranea'?,rileva come il sistema politico italiano - benché la Costituzione sia ispirata alprincipio dell'impersonalità del comando - manifesti una «realtà effettualeispirata all'opposto modello del 'comando personale', e quindi articolata in com-pagini clientelali ed in rapporti di patronato e di fedeltà»108. Oltre alla ten-denza a 'privatizzare' l'amministrazione pubblica, è infatti soprattutto la pro-liferazione di legami clientelali a testimoniare una preferenza per la prote-zione, per la ricerca di rendite garantite, a scapito delle rendite di mercato.Come scrive a questo proposito, infatti:
II secondo fatto, che prova la vocazione della società italiana per la 'per-sonalità del comando' e per la dipendenza dell'uomo da un altrouomo, è ben noto a tutti:'è la grande difiusione delle relazioni e dei co-stumi che si usano denominare 'clientelali'. [...]. Relazioni 'clientelali'- da patrono benefattore a seguace fedele in attesa di favore - sono allabase della dilatazione abnorme dei partiti, e dell'invasione, da parte diquesti ultimi, di ogni altra istituzione: i partiti (e i loro notabili) non sa-rebbero diventati i titolari onnipotenti della vera autorità, se schiere dicittadini-postulanti non cercassero ogni giorno di ottenere dalla loro pro-tezione - e a titolo di grazia particolare, ricambiata con il voto e con lacomplicità - ciò che la legge non consente o riserva ad altri109.
Per quanto appaia coerente (e forse persine convincente), la teoria della ren-dita politica in realtà inserisce nel quadro teorico di Miglio un elemento pro-blematico non secondario. La questione principale non consiste tanto nel-l'interpretazione del singolo caso italiano, o nefla spiegazione della proliferazionedi legami clientelali, quanto, a un livello più generale, nel fatto che una similevisione della rendita politica introduce nella teoria migliana un tratto 'eeo-nomicistico' che non può non entrare in contraddizione con la raffigurazio-ne del rapporto di obbigazione politica.Benché l'obbligazione politica richieda una fedeltà assoluta da parte dei se-guaci nei confronti del leader carismatico - una fedeltà che, come si è visto,è del tutto irriducibile a una relazione contrattuale e a motivazioni di tipo 'eco-nomico' - la teoria della rendita di fatto implica un elemento del tutto dif-ferente. Quando Miglio considera la distribuzione di una rendita garantitacome uno degli elementi caratterizzanti il rapporto di obbligandone politica,allude infatti - in modo piuttosto chiaro - a una serie di motivazioni utili-taristiche e individualistiche. In altre parole, quando ritiene che la ricerca diuna rendita garantita spieghi l'oscillazione dal 'rischio' implicito nel contratto-scambio alla sicurezza dell'obbligazione politica, adotta una prospettiva che
DOSSIER MIGLIO
considera la propensione dei singoli individui, i quali - sempre con finalitàutilitaristiche - puntano a ottenere una rendita bassa ma garantita oppureun 'profitto' più elevato ma aleatorio. Anche se i fattori 'culturali1 hanno un'in-fluenza notevole nello spingere i singoli verso la rendita politica e verso la reni-dita di mercato, in ogni caso la scelta sembra sempre essere operata dai sin-goli individui sulla base di un calcolo razionale. Secondo la teoria della ren-dita, e secondo la sua ipotesi sul significato originario del nomos, le finalitàche muovono la Gefolgschqft, i seguaci del capo politico, sono sostanzialmenteutilitaristiche: i seguaci si aggregano attorno al capo con l'obiettivo di par-tecipare alla spartizione del bottino di caccia e, così, di ottenere una rendi-ta, non cospicua ma 'sicura5. In questo senso, Miglio di fatto riprende la vec-chia tesi di Mosca, secondo cui la classe politica è composta da quanti vivo-no delle rendite connesse all'esercizio del potere, anche se, a differenza del-lo studioso siciliano, comprende, fra i membri della classe politica, anche l'am-pio strato intermedio degli «aiutanti»110. Ma questa ambiguità inizia solo amostrare i profili problematici della teoria della rendita. In modo ben più evi-dente, questi aspetti emergono infatti a proposito delle motivazioni che spin-gono, all'azione politica, e a proposito dei moventi che spìngono i seguaci asostenere il leader.Se infatti, per un verso, Miglio considera la ricerca della rendita garantita comeuno dei tratti costitutivi dell'obbigazione politica, per un altro tende a pre-sentare il rapporto di fedeltà dei seguaci nei confronti dei capo nei termini diun rapporto quasi religioso, ossia come un rapporto che può persine condurrealla conseguenza estrema del sacrificio. Tanto che, anche nella trascrizione del-le sue lezioni, si può leggere:
Gli aggregati politici più forti sono [... ] quelli che chiedono all'aderen-te il sacrificio della vita: usque ad effasionem sanguìnis, fino a versareil suo proprio sangue. Il patto di fedeltà più coerente implica quindi lastessa disponibilità a rinunciare all'esistenza. I grandi parliti politici com-patti del nostro tempo, così come le aggregazioni politiche del passato,si presentano tutti in questo modo111.
Mentre Miglio evoca la possibilità estrema del sacrifìcio, riprende un moti-vo che scaturisce piuttosto coerentemente dall'idea secondo cuil'obbligazio-ne politica è, per sua natura, esclusiva, e secondo cui essa è tanto più solidaquanto più polarizzata verso l'esterno. Ma, ovviamente, l'idea che la fedeltàal capo da parte dei seguaci possa anche richiedere restremo sacrificio dellavita non può in alcun modo risultare coerente con una visione utilitaristicae soprattutto individualistica della rendita. In termini sintetici, è infatti piut-tosto evidente che, se la motivazione del seguito è di tipo utilitaristico, se laspinta a seguire un determinato leader è data dalla prospettiva di ottenere unarendita garantita hic etnunc, la richiesta del sacrificio estremo dovrebbe dis-solvere la stessa sintesi politica, allontanando i seguaci dal leader.D'altro canto, l'idea di una fedeltà estrema può essere sostenuta solo abban-donando l'assunto che i membri della sintesi politica (e soprattutto i membridel seguito) adottino il criterio dell'utilità individuale. Per esempio, come fe-cero molti degli studiosi positivisti ed evoluzionisti di fine Ottocento, l'ideadella fedeltà del singolo al gruppo e al capo può essere sostenuta ipotizzan-do che i membri siano spinti a determinate azioni non dalla razionalità in-
no. Come ha notato AngeloPanebianco, Miglio, «assu-mendo l'invarianza degli scopidei capi e dei capi potenziali dauna parte, e dei gregali dall'al-tra», di fatto adotta «uno sche-ma di base £...] almeno altret-tanto semplice e coerente diquel modello deìrhonao ceeo-nomicus'con cui lavorano leteorie economiche» (A. PANE-BIANCO, Relazione, cit., p. 247).111. e. MIGLIO, Lezioni di poli-tica. I. Scienza detta politica, acura di A. Vitale, il Mulino, Bo-logna 2O11, p. 177.
4i
RIVISTA DI POLITICA 3
42 112. In sostanza, Ardrey so-stiene infatti che la violenza,umana non. sia un prodottosociale una patologia psicolo-gica, bensì una tendenza istin-tuale, necessaria alla sopravvi-venza della specie: cfr. peresempio, u. ARDRE?, L'istinto diuccidere. Le origini e la naturaanimale dell'uomo (1961), Fel-trinelli, Milano 1968. Ma sitrattava, a ben vedere, dellastessa soluzione cui ricorreva-no molti dei cultori positivisti(ed evoluzionisti) della 'psico-logia collettiva' di fine Otto-cento: cfr. a questo proposito D.PALANO, II potere della molti-tudine. L'invenzione dell'in-conscio collettivo nella teoriapolitica e nelle scienze socialiitaliane tra Otto e Novecento,Vita e Pensiero, Milano 2002.113. C. SCHMITT, II concetto di'politico', eit., p. 157-
dividuale (e non comunque da una razionalità individualista) ma da compo-nenti istintuali, che impongono a eiascun individuo - prima che la salvaguardiadella vita - la salvaguardia del gruppo e, dunque, della specie"2. Oppure, lastessa idea può essere sostenuta assumendo che - al di sopra dell'individuoe delle sue motivazioni personali - agiscano grandi forze collettive (reali o per-cepite), come il Volk, la nazione, la razza, la classe, la patria, che impongonoai membri sacrifici necessari per la realizzazione di un destino storico. Ov-viamente, in tutti questi casi non si tratta di motivazioni che possano esserericondotte a una concezione individualistica dell'agire politico. Ed è anche perquesto motivo che Schmitt - nel Begnffdes Politìschen - si scaglia contro ogniconcezione integralmente liberale, incapace di cogliere, proprio a causa del-la deformazione individualistica, il fatto che un'associazione politica - o, me-glio, un'associazione effettivamente politica' - possa anche richiedere il sacrificioestremo della morte, per garantire la propria integrità:
II pensiero liberale sorvola o ignora, in modo sistematico, lo Stato e lapolitica e si muove invece entro una polarità tipica e sempre rinnovan-tesi di due sfere eterogenee, quelle cioè di etica ed economia, spirito ecommercio, cultura e proprietà. La sfiducia critica nei confronti delloStato e della politica si spiega facilmente in base ai principi di un sistemaper il quale il singolo deve rimanere termimts a qua e terminus ad quem.In casi determinati l'unità politica deve pretendere il sacrifìcio della vita:questa pretesa non può in alcun modo essere fondata e sostenuta perl'individualismo del pensiero liberale. C-..] Per il singolo in quanto talenon vi è nessun nemico col quale si debba combattere per la vita e perla morte, se egli personalmente non lo vuole: costringerlo alla lotta con-tro il suo volere è in ogni caso, dal punto di vista dell'individuo priva-to, mancanza di libertà e violenza. Tutto il pathos liberale si ribella allaviolenza e alla mancanza di libertà. Ogni pregiudizio, ogni minaccia allalibertà individuale, in via di principio illimitata, alla proprietà privatae alla libera concorrenza significa 'violenza' ed è eo ipso qualcosa di cat-tivo. Ciò che questo liberalismo salva dello Stato e della politica si riduceall'assicurazione delle condizioni della libertà e all'eliminazione dei di-sturbi alla libertà113.
È inoltre significativo che anche Max Weber escluda che il rapporto fra un lea-der carismatico e i seguaci possa essere ricondotto a qualsiasi finalità utilita-ristica e a qualsiasi calcolo economico, sia da parte del capo, sia da parte delsuo seguito. Se infatti il capo carismatico, scrive Weber, «disprezza e respin-ge l'utilizzazione economica del dono di grazia, come fonte di reddito», ancheil seguito ha in spregio «l'economia ordinaria di carattere tradizionale o ra-zionale». E, per quanto il capo e i seguaci possano puntare a conquistare unapreda, non è un semplice interesse economico a muoverli:
H condottiero e il suo seguito cercano preda [...] Ciò che tutti disprez-zano [...] è l'economia ordinaria di carattere tradizionale o razionale,con l'obiettivo di 'introiti' regolari conseguiti mediante un'attività eco-nomica continuativa diretta a tale scopo. [...] Considerato dal punto divista di un'economica razionale, esso è una tipica potenza 'anti-econo-mica'; e ciò poiché rifiuta ogni immissione nella vita quotidiana. Esso
RIVISTA DI POLITICA 3
42 112. In sostanza, Ardrey so-stiene infatti che la violenza,umana noa sia un prodottosociale una patologia psicolo-gica, bensì una tendenza istin-tuale, necessaria alla sopravvi-venza della specie: cfr. peresempio, u. AKDEEY, L'istinto diuccidere. Le origini e la naturaanimale dell'uomo (1961), Fel-trìnelli, Milano 1968. Ma sitrattava, a ben vedere, dellastessa soluzione cui ricorreva-no molti dei cultori positivisti(ed evoluzionisti) della 'psico-logia collettiva' di fine Otto-cento: cfr. a questo proposito D.PALANO, // potere della molti-tudine. L'invenzione dell'in-conscio collettivo nella teoriapolitica e nelle scienze socialiitaliane tra Otto e Novecento,Vita e Pensiero, Milano 2002.113. C. SCHMTTT, // concetto di'politico', cit, p. 157-
dividuale (e non comunque da una razionalità individualista) ma da compo-nenti istintuali, che impongono a eiascun individuo - prima che la salvaguardiadella vita - la salvaguardia del gruppo e, dunque, della specie112. Oppure, lastessa idea può essere sostenuta assumendo che - al di sopra dell'individuoe delle sue motivazioni personali - agiscano grandi forze collettive (reali o per-cepite), come il Vblk, la nazione, la razza, la classe, la patria, che impongonoai membri sacrifici necessari per la realizzazione di un destino storico. Ov-viamente, in tutti questi casi non si tratta di motivazioni che possano esserericondotte a una concezione individualistica dell'agire politico. Ed è anche perquesto motivo che Schmitt - nel Begrìffdes Politischen - si scaglia contro ogniconcezione integralmente liberale, incapace di cogliere, proprio a causa del-la deformazione individualistica, il fatto che un'associazione politica - o, me-glio, un'associazione effettivamente 'politica' - possa anche richiedere il sacrificioestremo della morte, per garantire la propria integrità:
II pensiero liberale sorvola o ignora, in modo sistematico, lo Stato e lapolitica e si muove invece entro una polarità tipica e sempre rinnovan-tesi di due sfere eterogenee, quelle cioè di etica ed economia, spirito ecommercio, cultura e proprietà. La sfiducia critica nei confronti delloStato e della politica si spiega facilmente in base ai principi di un sistemaper il quale il singolo deve rimanere termimts a qua e terminus ad quem.In casi determinati l'unità politica deve pretendere il sacrificio della vita:questa pretesa non può in alcun modo essere fondata e sostenuta perrindividualismo del pensiero liberale. C...] Per il singolo in quanto talenon vi è nessun nemico col quale si debba combattere per la vita e perla morte, se egli personalmente non lo vuole: costringerlo alla lotta con-tro il suo volere è in ogni caso, dal punto di vista dell'individuo priva-to, mancanza di libertà e violenza. Tatto il pathos liberale si ribella allaviolenza e alla mancanza di libertà. Ogni pregiudizio, ogni minaccia allalibertà individuale, in via di principio illimitata, alla proprietà privatae alla libera concorrenza significa 'violenza' ed è eo ipso qualcosa di cat-tivo. Ciò che questo liberalismo salva dello Stato e della politica si riduceall'assicurazione delle condizioni della libertà e all'eliminazione dei di-sturbi alla libertà113.
È inoltre significativo che anche Max Weber escluda che il rapporto fra un lea-der carismatico e i seguaci possa essere ricondotto a qualsiasi finalità utilita-ristica e a qualsiasi calcolo economico, sia da parte del capo, sia da parte delsuo seguito. Se infatti il capo carismatico, scrive Weber, «disprezza e respin-ge l'utilizzazione economica del dono di grazia come fonte di reddito», ancheil seguito ha in spregio «l'economia ordinaria di carattere tradizionale o ra-zionale». E, per quanto il capo e i seguaci possano puntare a conquistare unapreda, non è un semplice interesse economico a muoverli:
H condottiero e il suo seguito cercano preda [...] Ciò che tutti disprez-zano [...] è l'economia ordinaria di carattere tradizionale o razionale,con l'obiettivo di 'introiti' regolari conseguiti mediante un'attività eco-nomica continuativa diretta a tale scopo. [...] Considerato dal punto divista di un'economica razionale, esso è una tipica potenza 'anti-econo-mica'; e ciò poiché rifiuta ogni immissione nella vita quotidiana. Esso
DOSSIER MIGLIO
può soltanto partecipare, con assoluta indifferenza inteijore, a occasionalipossibilità di guadagno114.
In modo forse ancora più sistematico, anche De Francisci esamina a fondo illegame fra capo e seguito, classificando - ad apertura del suo Arcana impe-rii - i «tipi primari dell'organizzazione politica». E, discutendo criticamen-te il dibattito tedesco, che aveva visto protagonisti, oltre allo stesso Weber, an-che studiosi come Heinrich Triepel e Werner Sombart, riconduce il potere eser-citato dal leader carismatico alla specifica figura del «Ductor». Come scrivein passaggio importante, infatti:
Nel ductus (autentico) politico, l'attività del Ductor si manifesta attra-verso l'esercizio di una potestà di comando, che trova la sua giustifica-zione nell'autorità personale (carisma) del Ductor medesimo. Con l'eser-cizio di tale potestà il Ductor viene ad imporre al gruppo dei suoi seguaciuna serie di norme di condotta, norme la cui validità dipende dall'au-torità originaria riconosciuta al Ductor. In tal modo il Ductor compo-ne in unità, plasma, foggia il gruppo originario (il eomitatus originario),del quale egli, essendo il capo, fa parte. Ma nel Ductor autentico da taleordinamento rimangono sempre escluse l'autorità e la potestà del Duc-tor: non queste dall'ordinamento, ma l'ordinamento da quelle trae basee giustificazione115.
Esplorando il rapporto tra capo e Gefolgschqft, De Francisci enfatizza inoltre,in modo particolare, come il nucleo più profondo della Fùhrung coincida nonsolo con «il formarsi di una unità», ma preveda soprattutto «un rapporto dicomunione morale, fondato (almeno inizialmente) soltanto sulla lealtà e fe-deltà reciproca»"6. In altre parole, il rapporto tFaFùhrung-Gesellschaftsi rea-lizza, secondo De Francisci, solo «quando entro e al di sopra di un aggrega-to sociale (la cui natura, estensione e differenziazione possono esse varie) siaffermi, in virtù delle sue qualità personali, che vengono riconosciute dai se-guaci come preminenti ed esemplari, un capo, la cui personalità si impongaalle altre e le domini con la sua energia cosciente e creatrice e, dominando-le, le componga in unità, le plasmi, le coordini, le diriga, dando all'aggrega-to la struttura adeguata ai fini che il Ductor, nell'interesse comune, vuole rea-lizzare»117. Anche per questo, dunque, quando si interroga sulle motivazionipsicologiche che muovono i seguaci afl'obbedienza nei confronti del Ductor,De Francisci non può che sottolineare come la caratteristica fondativa, e ine-liminabile, del fenomeno della Fùhrung, sia rappresentata dalla «credenza»nell'autorità personale del capo:
non basta perché sorga il rapporto Fuhrer-Gefolgschqft che vi sia da unlato la coscienza della propria debolezza e la volontà di ordine e dall'altrouna personalità superiore. Perché i seguaci si affidino al capo per otte-nere difesa e tutela impegnandosi al tempo stesso a prestargli obbedienzae devozione è indispensabile che essi credano nelle sue qualità eccezionali,che essi si abbandonino a lui nella convinzione che la sua guida e dire-zione sono un mezzo necessario per l'integrazione e l'elevazione dellaloro personalità, per la realizzazione della loro libertà. Questa creden-za, questa convinzione, questo riconoscimento, del carisma è l'elemen-
114. M. WEEER, Economia e so-cietà (1922), Comunità, Mila-no 1961,1, p- 207.115. P. DE ERANCISCI, Arcanaimperii, cit., I, p. 80.116. M, I,p. 71.117. Ivi, I, pp. 71-72.
43
RIVISTA DI POLITICA 3
44 118. M I, p. 69.119. Cfr., su questo aspetto, G.MIGLIO, Le origini della, scien-za deU'amTTtinistrasdone, inAA.w., La scienza dell'ammini-strazione, Giuffrè, Milano 1957,pp. 7-62, ora in ID., Le regola-rità della, politica, cit, I, pp.255-324, in particolare pp.301-306.120. G. MIGLIO, Oltre Schmìtt,cit., p. 756. Miglio, come si è vi-sto, aveva peraltro già accen-nato a Tonnies e «alla 'regola-rità' della antitesi Comunità-Società» anche in Io., Le cate-gorie del politico, cit, p. 597 ep. 600.121. F. TÓNNIES, Comunità esocietà (1887), Comunità, Mi-lano 1963, p. 57.
to psicologico fondamentale generatore del rapporto di Fuhmng; e l'au-torità personale e quindi la potestà del Fuhrer dipendono in ultima ana-lisi dalla persistenza di quella credenza, da cui scaturiscono l'ossequio,la fede, l'entusiasmo dei seguaci"8.
Sotto questi profili, l'immagine dell'obbligazione politica che Miglio costrui-sce non appare affatto divergente rispetto a quanto sostengono Weber e DeFrancisci: in effetti, il vincolo politico - per quanto concerne l'oggetto, i sog-getti^ la struttura e la proiezione temporale - non solo sembra essere coerentecon l'idea di una piena fedeltà al leader, ma richiede addirittura un simile ele-mento, strettamente connesso - in un rapporto direttamente proporzionale- con il livello di polarizzazione rispetto all'esterno. Ed è anche per questo che,nella costruzione dei due tipi dell'obbligazione politica e del contratto-scambio, Miglio riprende (e modifica) la dicotomia di Gemeinschqft e Gesel-Ischaft elaborata da Ferdinand Tonnies sul finire dell'Ottocento.Se la distinzione fra obbigazione politica e contratto-scambio risulta per unverso influenzata dalla contrapposizione fra 'Stato' e 'Società' individuata daLorenz von Stein119, Miglio dichiara infatti in diverse occasioni di aver mutuatol'idea di una dicotomia tra due forme originarie di relazione sociale proprioda Tonnies. In Oltre Schmitt, per esempio, quando espone l'ipotesi delle dueobbligazioni, osserva che «già Tonnies aveva intravisto questa struttura ed ave-va contrapposto la Gemeinschqft alla Gesellschqft», pur notando che «il suoerrore fu [...] di intendere le due forme di rapporto associativo come successivel'una all'altra in senso storico, mentre esse sono da intendere come grandez-ze perennemente intrecciate, le quali solo nell'intreccio rivelano il loro si-gnificato»120. In sostanza, secondo Miglio, mentre la distinzione del sociolo-go tedesco si regge sull'idea di una successione storica innescata dall'avven-to della società moderna, la dicotomia di obbligazione politica e contratto-scambio raffigura due tipi di relazione non soltanto fra loro irriducibili, maanche compresenti in ogni società e in ogni epoca. Ma, al di là di questo, Mi-glio si allontana da Tonnies anche a proposito di un altro elemento, che con-cerne il carattere più o meno originario della Gemeinschqft, Quando esami-na i diversi tipi di comunità (le comunità di sangue, di luogo, di spirito), il so-ciologo tedesco sottolinea che, al loro interno, «gli esseri umani sono legatireciprocamente in modo organico dalle loro volontà e si affermano l'uno difronte all'altro»121. Ma, soprattutto, Tonnies tende a considerare i legami co-munitari come legami 'originali', 'naturali', ed è in corrispondenza di questopunto che Miglio non può che imboccare una direzione differente. Per il po-litologo italiano, infatti, l'obbligazione politica non è solo antitetica rispettoal contratto-scambio, ma deve essere anche pensata come un tipo di legame'non naturale', dal momento che - seguendo lo schema del potere carismati-co elaborato da Weber e ripreso da De Francisci - si crea solo in determina-te circostanze, ossia in presenza di un leader capace di raccogliere attorno asé un gruppo compatto di seguaci. Ed è probabilmente per questo motivo cheMiglio - seppur in modo non esplicito - tiene presente, oltre alla distrazio-ne di Tonnies, anche la categoria sociologia del Bund, delineata da HermannSchmalenbach al principio degli anni Venti.La proposta di Schmalenbach si inserisce in effetti all'interno del dibattito cre-sciuto sulla dicotomia tonniesiana di Gemeinschqft e Gesellschqft. In-sostan-za, per quanto Schmalenbach non contesti la validità generale di quella di-
DOSSIER MIGLIO
cotoinia, si sofferma piuttosto sull'influsso che la temperie romantica avreb-be esercitato sulla stessa fissazione dei tratti della 'comunità' e della 'società'.«Le nozioni di Tonnies», scrive per esempio Sehmalenbaeh, «sono sorte daamore e odio», e «il suo entusiasmo esaltato, attraverso il quale egli vede nelcuore dei fenomeni, propende teneramente per la comunità e proibisce la so-cietà»122. L'influenza romantica è così all'origine, secondo Schmalenbaeh, diuna concettualizzazione ambigua sia della Gemeinschqft, sia della Gesellschqft,e, soprattutto, è all'origine di una distorsione teorica esiziale, perché ha fini-to con ì'oscurare quello spazio intermedio fra l'una e l'altra in cui dovrebbeessere collocata una terza forma di assoeiativa, ossia il Bund. Per Tonnies -argomenta Schmalenbach - l'esempio paradigmatico della comunità è la fa-miglia, e «preferibilmente la famiglia di tipo contadino o piccolo-cittadino»123,in quanto egli classifica come 'comunità5 ogni associazione sociale fondata «sul-la base di affinità 'connaturatamente naturali'»124. Partendo proprio da que-st'ultimo carattere della comunità, Schmalenbach nota però come non tuttele forme associative usualmente definite come Gemeinschaft mostrino effet-tivamente, alla loro base, «affinità 'connaturatamente naturali'», e, soprattutto,osserva come ne risultino del tutto prive le unioni di giovani usciti dalla fa-miglia, quali, per esempio, il Bund formatosi attorno al poeta Stefan George.Il punto più significativo è che Schmalenbach non considera i caratteri 'qua-si religiosi' di queste unioni come un'anomalia, o come un tratto di ciò che Ton-nies aveva ricondotto alla Gemeinschaft: si tratta, a suo avviso, proprio del ca-rattere distintivo della categoria del Bund. «Per l'aspirazione [...] verso ciò chesi chiama per lo più comunità, allo stesso modo per il 'culto dell'amicizia' deiromantici [...] sarà sempre caratteristico che vi si colleghino - e in manieramolto stretta - passioni religiose», e per questo, scrive, «vi è sempre, sopra iBunde che si reputano più profondamente 'santi', un qualcosa che ha una 'to-nalità emotiva religiosa' (che tuttavia sono ben lontano dal chiamare religio-ne)»125. Ma soprattutto, osserva, «tutte le affinità 'connaturatamente natura-li'vengono lacerate da Bunde che così si costituiscono»126.Sulla base di questa riflessione, Schmalenbach propone allora di inserire - inuna posizione intermedia (ma logicamente autonoma) rispetto ai due poli del-la Gemeinschaft e della Gesellschqft - un'ulteriore modalità di associazione,costituita appunto dal Bund: una modalità di associazione che, pur avendoalcune caratteristiche simili alla comunità, risulta però irriducibile a quest'ultimain quanto si basa su un fondamento 'non naturale', perché si tratta diun'unione che si crea - in determinate circostanze - in seguito all'incontro dipiù persone. Al tempo stesso, il legame alla base del Bund non può essere ri-condotto neppure alla Gesellschqft, la seconda forma assoeiativa individuatada Tonnies: la 'società', infatti, non riesce in alcun modo a dare origine a quel-l'unione psicologica che contrassegna il Bund, In altri termini, nella 'società',i singoli individui conservano sempre una «separatezza.essenziale», e ciò si-gnifica che la componente emotiva rimane fortemente controllata dalla com-ponente psicologica razionale. «L'ethos della 'fredda riservatezza'», nota a que-sto proposito, «è lo 'spirito' che 'anima' la società»127. Nel Bund, invece, dopol'incontro, fra gli individui avviene qualcosa di diverso, perché i singoli - comescrive Schmalenbach - si 'fondono' organicamente nel nuovo gruppo:
Anche i compagni di un Bund non hanno al principio niente a che farel'uno con l'altro. Il Bund 'nasce' solo quando si incontrano (anche nel
122. H. SCHMALENBACH, La ca-tegoria sociologica del Bund.Comunità, società e socialità(1922), Ipermedium, Caserta2006, p. 69.123. M, p. 70.124. M, p. 71-125. M, p. 73.126. Ivi, p. 7*.127. M, p. 98.
45
RIVISTA DI POLITICA 3
46 128. Ivi, pp. 98-99.129. Ivi, p, 100.130. M, p. 103.131. «Ovunque i JBunde sussi-stono a lungo o debbono esi-stere a lungo»; riconosce infettiil sociologo e filosofo tedesco,«assumono in parte da sé,spontaneamente, in parte in-tenzionalmente, caratteri pro-pri da uà Iato della società,dall'altro defla comunità» (ivi,p. 104), e si richiama esplicita-mente proprio alla distinzionefra «setta» e «Chiesa» e al ruo-lo del battesimo.132. P. DE FRANOSO, Arcana, im-perii, cit, I, p, 241.
' caso in cui dovesse essere già presente una comunità). Le 'esperienze vis-sute' che lo 'fondano' sono eventi 'individuali'. Se qui il Bund appare piùvicino alla società, una volta realizzatosi si avvicina di più alla comufii-tà. L'amico è l'«altro io». Noi sentiamo la sua gioia e la sua sofferenzacome la nostra 'propria' gioia e la nostra 'propria' sofferenza. L'infiac-chirsi di tale legame ci squarcia l'anima. Certo non si può parlare di 'con-crescenza9 [Verwachsungeri], ma è legittimo dire 'fusione', il che è for-se ancora più intenso. Certo vi è a diversissimi livelli, e tuttavia a tuttii livelli - e in linea di principio - la 'separazione' vera e propria è pie-namente eliminata328.
L'incontro cui allude Schmaìenbach evoca esplicitamente la formazione di unsentimento prima inesistente, che trascina i singoli individui in una vera e pro-pria fiammata sentimentale. Lo stesso carattere fondante del Bund costitui-sce d'altronde anche la causa principale della sua labilità. «Le ondate emoti-ve, più o meno inebrianti», osserva Schmaìenbach, «sono per loro natura pas-seggere», «l'ebbrezza svanisce, le affezioni della 'coscienza' sbiadiscono o ven-gono scacciate da altre»129. Ma è proprio l'elemento della labilità che spiegal'istituzione del giuramento e dei rituali, che tendono a fissare nel tempo lostato emotivo earatteristico della «fusione» e che preludono a una trasfor-mazione del Bund in qualcosa di differente:
anche il Bund, attraverso le forme del giuramento, eoi quale i compa-gni si promettono solennemente fedeltà, viene trasformato già ai pri-mi inizi, da un lato in società, dall'altro in comunità. E fra queste for-me se ne incontrano persine alcune che mostrano tale senso con ancormaggiore chiarezza, in quanto i compagni stringono 'patti di sangue', dan-do ad intendere, col bere alcune gocce l'uno del sangue dell'altro, di fon-dare una comunità di coesistenza paragonabile a quella dei legami disangue. Il nome 'fratello' ('fratello di Bund1) è preferito (anche nelle ver-sioni più tarde e rarefatte del fenomeno) come designazione dei com-pagni uniti in una 'eomum.ta-.Bwnc?»330.
II consolidamento del Bund, secondo Schmaìenbach, non comporta una suasostanziale trasformazione, ma, quando riesce a imporsi effettivamente neltempo, e dunque a sottraisi al logoramento della tensione emotiva, esso nonpuò più essere considerato come qualcosa che nasce dal semplice incontro dipiù individui. Come mostra infatti il caso della trasformazione di una setta re-ligiosa in una Chiesa istituzionalizzata, il Bund si presenta alle nuove gene-razioni come una comunità, ossia come qualcosa che già esiste, nonostantela componente emotiva di 'ingresso' nel Bund venga simbolicamente rinno-vata dalle cerimonie rituali come il battesimo131.Nella sua riflessione sul «cristallo» dell'obbligazione politica, Miglio ha ov-viamente ben presente le pagine weberiane sul potere carismatico del leader,e, soprattutto, la tesi secondo cui i seguaci obbediscono al capo carismaticoin quanto credono nelle sue capacità straordinarie (e, comunque, mai per con-siderazioni di carattere economico)132. Quando specifica che il rapporto di ob-bedienza si basa sulla capacità di persuasione esercitata dal leader, ha inol-tre presente anche l'esame delle tesi weberiane svolto da De Erancisci, con cuiil politologo comasco si era confrontato nel saggio sulla monarehia greca ar-
DOSSIER MIGLIO
caica. Ma, probabilmente, Miglio tiene conto anche della riflessione sulla ca-tegoria di Schmalenbaeh, non solo perché in quegli anni la categoria del JBundè adottata dalla teoria dei movimenti di Francesco .Alberoni, ma anche.per-ché quella nozione propone in effetti un'immagine molto simile a quella de!Tla genesi dell'obbligazione politica133. In entrambi i casi, infatti, non ci si tro-va dinanzi a un legame 'tradizionale' fra capo e seguito, e neppure a un lega-me giuridicamente 'formalizzato', bensì a un legame che trae la propria for-za da un'estrema intensità emotiva: un'intensità che scaturisce dal carisma delleader e dalla piena fedeltà del seguito nei confronti di un capo percepito comeeccezionale, se non proprio come divino. Per questo, la sagoma del Bund puòeffettivamente arricchire - e specificare - l'immagine del rapporto di obbi-gazione politica. Ma, ovviamente, Miglio non può certo ricondurre la temperiedell'obbigazione politica - almeno nella fase della genesi del rapporto tra Fii-hrerschqft e Gefolgschaft - a una razionalità di tipo utilitaristico. La fedeltàdei seguaci nei confronti del capo carismatico - coerentemente a quanto so-stengono tanto Weber quanto De Erancisci - è infatti una fedeltà di caratte-re 'religioso', perché i membri stretti da questo vincolo sono in qualche modo«rapiti» da un sentimento comune, che li 'infiamma' e li trascina134.Pur pienamente consapevole di questo carattere 'religioso' del vincolo politi-co, Miglio tende però a proporre un'immagine nettamente diversa, nel mo-mento in cui formula l'ipotesi - peraltro centrale nella sua teoria - di una con-nessione costitutiva fra obbligazione politica e rendita. Quando introduce l'ideadella rendita garantita - una rendita che diventa l'obiettivo primario del se-guito - la dimensione carismatica del potere non può che essere collocata inun secondo piano, mentre la stessa fedeltà - lungi dall'essere piena e incon-dizionata - tende ad assumere i contorni di una sorta di vantaggioso contrattodi assicurazione. Da questo punto di vista, non è affatto casuale che, nel sag-gio sulla «repubblica mediterranea», Miglio trovi l'esemplificazione para-digmatica del rapporto di obbligazione politica - e, dunque, dello scambio trafedeltà e protezione - nelle istituzioni manose. Come scrive in questo senso,in un passaggio spesso frainteso:
è sopra tutto nel comportamento e nelle istituzioni 'mafiose' che il prin-cipio della fedeltà e dell'obbedienza dell'uomo ad un altro uomo, trovala sua espressione più completa. Il termine 'mafia' è stato probabilmentecaricato di significati drammatici ma in fondo collaterali ed improprì:io qui mi limito ad osservare che: a) la 'mafia' (come la 'camorra', la 'ndran-gheta', ecc.) costituisce un caso estremo di rapporto clientelare, e di "per-sonalizzazione' dell'autorità e o) che se si censiscono e si accorpano tot-te le manifestazioni di questo stile, presenti ormai nel tessuto del pae-se - dall'economia pubblica e privata alla politica, all'amministrazione- diventa poi molto difficile considerarli come patologici (mere viola-zioni del diritto) e non piuttosto un modo diverso di concepire e prati-care le relazioni umani. Al di là di tua certo limite quantitativo, tutte lederoghe diventano 'istituzione'. Del resto già Santi Romano dimostrò cheanche l'associazione a delinquere è, a suo modo, un «ordinamento»: eprobabilmente (da siciliano) pensava proprio alla 'mafia"135.
L'ipotesi accennata da Miglio a proposito del carattere 'politico' della mafiaviene ripresa da un recente lavoro di Marco Santoro, nel quadro di una ride-
133. Negli anni Sessanta e Set-tanta il suggerimento diSchmalenbaeh influenza in-fatti - più o meno direttamen-te - la teoria dei movimenti ela-borata da Francesco Alberoni.Cfr. in proposito F. ALBERONI,Sociologia del comportamentocollettivo, in Questioni di so-ciologia, La Scuola, Broscia1966,1, pp. 681-778, ro., Statunascenti. Studi suiprocessi col-lettivi, il Mulino, Bologna 1968,e nx, Movimento e istituzione.Teoria generale, il Mulino, Bo-logna 1977- Alberoni riprendela nozione di Bund soprattuttodalle pagine di TSnnies, che af-frontò la questione nella sestae nella settima edizione di Ge-seUschaft und Gemeinschqft;cfr. F. TÒNNIES, Comunità e so-cietà, cit, p. 57. Si veda, però,anche F. TÒNNIES, Gemeinschqftund Gesellschqft, in A. VIER-KANDT (a cura di), Handwor-terbuck der Sociologie, Stutt-gart, Enke 1932, pp. 180-192.134. Fra gli individui, sostene-va Schmalenbaeh, «divampail Bund non appena coloro chesono stati 'rapiti', al principiosolo singolarmente, si incon-trano e si accorgono della di-rezione identica e comune delloro 'sentire' e, 'sulla base' diesso, si infiammano a vicenda:il Bund sorge solo qui, e sorgeattraverso un nuovo 'sentire'che ora, solo ora, è un sentire'sociale', di Bund» (H. SCHMA-UENBACH, La categoria sociolo-gica del Bund, cit., p. 90).135. G.MIGLIO, Unarepubblica'mediterranea'?, cit/pp. 1101-1102.
47
RIVISTA DI POLITICA 3
48 136. M. SANTORO, La voce delpadrino. Mafia, cultura, poli-tica, Ombre corte, Verona2008, p. 10.13?. Ibidem.138./m, p. 11.139. Cfr. L. PAOLI, Protetti di ma-fia, il Mulino, Bologna 1398, ol-tre che, per la definizione dei«contratti di status», M. WEBEE,Economia e società, Comunità,Milano ISSO, III, p. 23.140. M. SANTORO, La voce delpadrino, eit, p. 104.
finizione del fenomeno mafioso che, utilizzando gli strumenti della sociolo-gia della cultura, pone una grande attenzione proprio alle connessioni fra ilfenomeno mafioso e l'associazione 'politica'. L'influsso migliano - peraltro di-chiarato esplicitamente da Santoro - affiora sia per il rilievo assegnato alla com-ponente 'culturale', sia per l'idea che al cuore dei fenomeni di aggregazione po-litica si trovino rapporti personali di obbedienza e protezione. In questo sen-so, Santoro richiama infatti la concezione migliana del 'politico', secondo cuiquest'ultimo coincide con «quella sfera primordiale dell'esistenza umana incui è in questione la sottomissione degli uomini ad una qualche istanza di co-mando»136; una subordinazione che inoltre, secondo Miglio, è però anche, «persua natura di tipo personale, basata dunque sul vincolo che lega ogni uomoad un altro uomo, vincolo che si esprimerebbe da una parte nell'obbìigo di fe-deltà e dall'altra nel dovere di protezione»137. Su queste basi, allora, la vicinanzatra la mafia e il 'politico' - una vicinanza che peraltro Santoro articola in unavariante specifica, ben lontana da qualsiasi determinismo - non può che emer-gere in modo quasi scontato, portando alla luce i caratteri irriducibili e ine-liminabili deir«obbligazione politica»;
la mafia poteva allora forse leggersi come quella manifestazione insie-me fenomenica e istituzionale di un «altro modo di concepire le rela-zioni umane», più rispondente alla struttura elementare deìl'obbliga-zione politica, più naturale forse, in ogni caso diversa se non alternati-va al modo di rappresentare e realizzare la politica che era prevalso nel-la modernità (in quanto epoca dello «stato moderno»), con tutte le dif-ficoltà, le contraddizioni e i limiti di cui quella stessa mafia nella sua em-pirica esistenza era però spia, notevolissima Mafia che poteva intendersia quel punto non come semplice residuo premoderno, bensì come in-carnazione istituzionale - storicamente data - di un modo diverso di or-ganizzare e, ancor prima, concepire la vita politica; diverso dalla formaStato ma non necessariamente a questa disfunzionale: perché si pote-va ipotizzare che solo grazie alle molte piccole e grandi deviazioni dalsuo modello astratto, giuridicamente immaginato, lo Stato in quanto or-dinamento politico concreto potesse poi funzionare138.
Partendo dalle ipotesi migliane, Santoro giunge a formulare la tesi secondocui la mafia può essere considerata come un tipo specifico di «subcultura po-litica territoriale», ma, all'interno della sua discussione, recupera anche la vec-chia categoria sociologica delJBund. Al contrario di altri studiosi, che - comeper esempio Letizia Paoli - considerano il fenomeno mafioso come una va-riante di quelli che Weber definisce come «contratti di status»139, Santoro ri-tiene però che l'elemento della «fratellanza», così importante nelle retorichemafiose, non possa essere ricondotto a una relazione contrattuale: «l'effettodel ricorso alla nozione weberiana di 'contratto di status'», scrive a questo pro-posito, «è infatti quello di un surrettizio ripiegamento su una visione ancorauna volta privatistica (e quindi, al fondo, economicista) della mafia, e al con-tempo di un suo confinamento inevitabile al mondo istituzionale premoder-no (primitivo'), di cui la mafia non potrebbe che essere quindi residuo destinatoa scomparire»140. Nel momento in cui adotta la categoria del Bund, Santorocerca dunque di sfuggire a questi limiti, e, al tempo stesso, di ricondvirre lastessa mafia a uno specifico «tipo istituzionale». Anche per Santoro, infatti,
DOSSIER MIGLIO
il JBund riesce a esplicitare i caratteri che rendono la mafia molto prossima auna forma di obbligatone politica, in quanto anche la mafia - lungi dal limitarsia proporre un do ut des - configura una protezione indeterminata, condizio-nata a un'obbedienza altrettanto indeterminata, da cui derivano obblighi sper
citici e più o meno formalizzati. •Con le sue numerose sollecitazioni, e con le domande che sottopone al dibattito,l'indagine di Santoro indica senza dubbio una declinazione molto interessantedella teoria di Miglio, anche perché invita a considerare la 'cultura' - e la di-mensione 'politica' della cultura - in una prospettiva notevolmente distanteda quella adottata dalla politicai science degli anni Cinquanta e Sessanta141.Al di là di questo, però, i rilievi che Santoro muove all'accostamento fra 'ma-fia' e «contratti di status» non possono che attirare l'attenzione sulla stessa strut-tura dell'obbligazione politica delineata da Miglio. Quel «surrettizio ripiega-mento su una visione ancora una volta privatistica (e quindi, al fondo, eco-nornicista)», che Santoro scorge nella proposta weberiana dei contratti di sta-tus, può essere infatti intravisto, senza eccessive difficoltà, anche nella teoriadella rendita politica elaborata da Miglio.Quando sviluppa la propria teoria della rendita politica, partendo daH'«ipo-tesi del cacciatore» e dalla rilettura del termine-concetto nomos, Miglio ten-de infatti a sovrapporre due tipi di relazione che non sono propriamente coin-cidenti, non tanto perché in uno di essi venga meno l'elemento 'personale' delvincolo, quanto perché si tratta di legami 'personali' differenti. Sotto un pri-mo profilo, Tobbligazione politica che Miglio considera in via prioritaria - pro-prio nella misura in cui la sua proposta 'ingloba' il concetto di 'politico' di Schmitt,l'idea weberiana del potere carismatico e, infine, seppur meno esplicitamen-te, la categoria sociologica del Bund - sembra infatti escludere che i seguacisiano animati da un interesse 'economico' o, in generale, di tipo 'privatistico'.La fedeltà del seguace è una fedeltà 'ideologica', è cioè una fedeltà che si raf-forza nella polarizzazione con il nemico e che identifica (più o meno totalmente)il perseguimento di un obiettivo ideale nel futuro con la sottomissione a un capodotato del charisma. Sotto il secondo profilo, anche il diente è legato da un rap-porto personale di obbedienza al capo politico, ma, in questo caso, le sue mo-tivazioni appaiono decisamente privatistiche, se non effettivamente economiche.E, proprio in questo senso, Vittorio Emanuele Parsi nota come clientela e ob-bligazione politica abbiano alla base motivazioni molto diverse:
L'elemento diadico, caratterizzante - assieme a quello personale - il le-game di clientela, configura infatti quest'ultimo come una categoria asé rispetto alle altre relazioni inter-individuali e, soprattutto, rispetto aquel particolare tipo di relazioni umane che porta alla formazione del-le sintesi politiche. I partecipanti a una relazione clientelare non riesconoa sentirsi compartecipi di una comune 'avventura', non riescono, in al-tri termini, a sviluppare nessun tipo di aggregazione che, per quanto te-nue possa essere, caratterizza dì necessità qualsiasi sintesi politica. C-.JLa struttura 'stellare', tipica delle clientele, e l'assenza di un benché mi-nimo legame ideologico impediscono la nascita di un sentimento 'soli-daristico' o di un qualsiasi altro spirito di aggregazione tra i clienti. Intal modo, essendo assente una identificazione delle mete del cliente conquelle del patrono, ogni vincolo clientelare risulterà radicalmente diversoda quello del politico1*2.
141. Sui motivi di interesse of-ferti dalla proposta di Santoroe suDe domande che suggerisce,mi permetto di rinviare a D. PA-LANO, Questione di cultura.Una proposta postcómporta-mentista per lo studio dellamafia, in «Teoria politica»,XXV (2009), n. 1, pp. 206-220.142. v.E. PAESI, La clientela. Peruna tipologìa del legami per-sonali inpolitica, in «Filosofiapolitica», II (1988), n. 2, pp.411-434, specie pp. 427-428.
49
RIVISTA DI POLITICA 3
SO 143. Cfr. G. MIGLIO, tt tempocome elementi} psicologico, cit.Al ruolo della proiezione tem-porale erano riservati alcunidei saggi compresi in A. Q.UA-DRIO ARISTARCHI (a cura di),Questioni di psicologia politi-ca, Giufftè, Milano 1984, unvolume edito nella collana^4r-cana imperii, diretta dallostesso Miglio: cfr., per esempio,A. QUADRIO ARISTARCHI, D. BER-
. TI, Considerazioni psicologickeButta dimensione tempo in po-litica, ibi, pp. 59-81. Queste ri-flessioni sono state successi-vamente riviste e aggiornate:Cfr. A. QUADRIO ARISTARCHI, A.
GALARDI, Considerazioni psi-cologiche sulla dimensione«tempo», in A. QUADRIO ARI-STARCHI (a cura di), Nuovequestioni di psicologìa politi-ca, Giuffrè, Milano 1999, pp.89-102.144. G. MIGLIO, Lezioni di poli-tica. II. Scienza della politica,eit, p. 465.145. v. E. PARSI, La clientela, cit,p. 428.146. Ibidem. «Chi beneficiaper primo della prestazione»,precisa Parsi, sempre a propo-sito del ruolo del tempo nellarelazione clientelare, «si senteobbligato per il futuro nei con-fronti dell'altro e, soprattutto,chi ha offerto -può contare suleredito presso chi ha ricevuto.Ma questo iato - a differenza diquanto succede nell'obbliga-zione politica - non può esten-dersi all'infinito, o per un lun-go tempo, senza marinare irapporti tra i due soggetti del-la relazione» (ibidem}.147. In effetti, la dicotomia diobbligatone politica e con-tratto-scambio potrebbe es-sere addirittura ricondotta alladistinzione, individuata daLeoni, fra un rapporto politi-co e un rapporto economieo-produttivo: cfr., per esempio,B. LEONI, Le pretese e i poteri.Le radici individuali del di-ritto e della politica, a cura diM. Stoppino, Società Aperta,Milano 1997.
Quando Miglio considera l'idea di una 'rendita garantita' come elemento strut-turale dell'obbìigazione politica, tende dunque a introdurre, nel tipo 'puro' delvincolo politico, un elemento specifico del legame clientelare, ossia di un le-game che, come tale, ha evidenti tratti in comune con il contratto-scambio.Ma questo comporta anche una conseguenza ulteriore, perché l'idea della ren-dita politica - l'idea di una rendita 'garantita' che viene spartita dal capo alproprio seguito di clienti - non può che entrare in conflitto con la tesi cen-trale, secondo cui l'obbligazione politica si caratterizza per la proiezione ver-so un futuro lontano e incerto.A ben vedere, infatti, quando Miglio considera la proiezione temporale comeun elemento fondamentale del rapporto di obbligazione politica, pare riferirsia due dimensioni beri differenti della temporalità. Per un verso, laddove esa-mina il ruolo delle ideologie, tende riferirsi a una temporalità sostanzialmenteutopistica, e ricorre così all'esempio delle utopie rivoluzionarie del Novecen-to, che spostano in un eterno 'domani' il traguardo irraggiungibile dell'egua-glianza socialista143. Da questo punto di vista, Miglio allude a una dimensio-ne che pare molto distante dalla ricerca di un beneficio, e dunque dalla ricercadi una garanzia da godere immediatamente: piuttosto, sembra che ogni be-neficio possa essere differito talmente lontano da non essere mai effettivamentecorrisposto, anche perché il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato del-l'ideologia - per esempio, la realizzazione del socialismo, la completa pacifi-cazione del genere umano, la conquista di un impero mondiale, ece. - non puòche far scemare la polarizzazione con l'esterno e, dunque, condurre alla ra-pida dissoluzione della sintesi politica. Così, osserva per esempio che «le ag-gregazioni politiche più salde sono proprio quelle che più riescono a 'differi-re* nel futuro e a quietare, a ridurre le pretese di vantaggi immediati nei se-guaci, tenendoli uniti nell'attesa di una grande vantaggio futuro»144. Ed è ar-ticolando questa prima visione della temporalità che Miglio ammette che lafedeltà dei membri di un'associazione politica può spingersi fino alla richie-sta del sacrifìcio del vita.Per un altro verso, quando sviluppa la teoria della rendita, Miglio sembra in-vece riferirsi a una ben distinta visione della proiezione temporale deìl'ob-bligazione politica. In questa seconda versione, Miglio tende infatti a pensa-re non a un futuro lontano e indeterminato, bensì al presente, o, meglio, a unpresente dilatato nel tempo. «I clienti», nota Parsi a questo proposito, «al con-trario dei seguaci del leader, sono perfettamente in grado di effettuareun'analisi .comparata dei costi e dei benefìci che ricavano dalla loro permanenzanella clientela», tanto che, «dove non intervengano fattori esterni C...], il ri-sultato negativo di una tale analisi preluderà alla rescissione del rapporto clien-telare»1*5. In sostanza, dunque, «nello scambio delle prestazioni tra patronoe cliente - e a differenza di quanto accade tra leader e seguace - non è possi-bile rimandare all'infinito il feed-back delle prestazioni»1*6. La fedeltà del clien-te sembra allora tutt'altro che incondizionata, o condizionata al perseguimentodi un obiettivo 'ideologico1 molto lontano, perché, piuttosto, pare finalizzataallo scambio - in fondo utilitaristico - tra obbedienza e protezione.Mentre sviluppa la teoria della rendita, Miglio tende a far emergere la fermaimpostazione liberale che senz'alto contrassegna la sua personalità intellet-tuale, tanto che, da un certo punto di vista, sembra addirittura accostarsi alleconclusioni di un autore come Bruno Leoni147. Proprio in corrispondenza diquesta ipotesi, affiora però anche - in modo ancor più evidente che altrove -
II
DOSSIER MIGLIO
un'opzione yaloriale, se non propriamente ideologica, che conduce a raffigu-rare la rendita politica nei termini di una rendita parassitaria e, dunque, a raf-figurare tutti coloro che percepiscono rendite politiche - la classe politica, ilpersonale della burocrazia statale, i militari, i dipendenti delle arnministra1-zioni pubbliche, ogni beneficiario di misure di welfare - come destinatali disussidi politici garantiti, che vanno inevitabilmente a detrimento del merca-to. In questo modo, Miglio non finisce soltanto con l'accogliere il limite del-le visioni liberali del 'politico' - quel limite individualistico rimproverato cosìenergicamente da Schmitt - perché, in realtà, introduce anche nel proprio edi-ficio una contraddizione dirompente, forse persine esiziale.La teoria della rendita politica finisce infatti col revocare in dubbio quasi tut-ti gli elementi che Miglio pure considera come qualificanti della struttura del-l'obbligazione politica. Innanzitutto, la componente emotiva che spinge il se-guace a sostenere il leader carismatico non può-che venir meno, perché vie-ne meno il riferimento a una componente che 'annulla' la razionalità utilita-ristica del seguace e lo 'trascina' in una sorta di comunità 'in fusione'. Quan-do svolge la tesi secondo cui il cuore profondo dei fenomeni di aggregazionepolitica deve essere ritrovato nella spartizione del bottino da parte del capo-caccia, Miglio sembra inoltre degradare il 'politico' a una ricerca di protezio-ne, non da un pericolo oscuro e indeterminato, bensì contro le incertezze quo-tidiane; così, l'obbligazione politica viene a perdere i contorni del patto nonreversibile, 'per l'eternità', trasformandosi in una sorta di 'contratto assicurativo',che consente al seguace di risolvere agevolmente le ordinarie esigenze dellavita. Inoltre, nel momento in cui Miglio - implicitamente - tramuta la terri-ficante e incombente presenza del nemico in una più generica inquietudinesul benessere individuale, anche il carattere esclusivo del rapporto politico per-de molta della propria salienza, perché la saldezza della sintesi politica nonpare più dipendere dalla polarizzazione contro una potenza minacciosa, e dun-que dall'assoluta esigenza di difendere la sicurezza della vita (dei singoli e del-la comunità), bensì solo dalla capacità di redistribuire convenienti rendite aiseguaci. Infine, la proiezione temporale, che pure spinge verso un futuro lon-tano - e persine irraggiungibile - la meta finale della lotta costantemente com-battuta dalla sintesi politica, non può che smarrire gran parte del proprio si-gnificato, fino a tramutarsi in una protezione i cui vantaggi vengono pretesie ottenuti nel presente. In sostanza, l'idea di una rendita garantita - il cui be-nefìcio è goduto Me, et nune - tende allora ad accorciare notevolmente la pro-iezione temporale verso un futuro estremamente lontano, appiattendo addi-rittura il futuro sul presente.A partire dagli anni Ottanta, Miglio tende a insistere progressivamente sul-l'elemento della rendita politica, in coincidenza non casuale con un passag-gio storico che vede seguire, alla elevata conflittualità sociale degli anni Set-tanta, l'esasperazione delle pratiche clientelali che segnano la fase termina-le della 'Prima Repubblica'. Lo spostamento dell'attenzione di Miglio dal con-flitto alla rendita non può però non comportare anche una graduale modifi-cazione della sua concezione: una modificazione che, in effetti, non attiene tan-to al maturare di posizioni federaliste o neo-federaliste (che a ben vedere han-no radici molto più lontane)148 e all'adozione di una più radicale visione liberale(anch'essa consolidata), quanto proprio allo stesso mutamento dell'immagi-ne defl'obbligazione politica e del 'politico'. Da un lato, mentre tende a ricondurrel'obbligazione politica alla redistribuzione di rendite garantite, Miglio deve an-
148. Sulla continuità (e sui mu-tamenti) nella prospettiva fe-deralista di Miglio, si vedano leannotazioni di L. ORNAGHI, Fe-deralismo 'interno' e federali-smo 'intercomunitario' nellosviluppo della teoria politica diGianfranco Miglio, in L. RO-MANO (a cura di), M pensiero fe-deralista di Gianfranco Mi-glio: una legione da ricordare,cit., pp. 19-31.
51
RIVISTA DI POLITICA 3
52 149. G. MIGLIO, DùobbedienzaCivile, in G. MIGLIO, H. D. THO-REAU, Disobbedienza civile, Li-bero, Milano 2008, p. 23 (I ed.Mondadori, Milano, 1993).Suquesti aspetti, cfr. anche le an-notazioni di M. CACCIACI, La. le-zione di un eretico, in «La Re-pubblica», 12 agosto 2001, e ro,II mio amico Miglio e Usuo so-gno del contratto sovrano, in«Quaderni padani», VII(2001), n. 37-38, pp. 24-28.150. Questo punto torna infat-ti nell'ultima riflessione di Mi-glio, ed è connesso al venirmeno dell'eventualità della«vera guerra»; «La fine dellaguerra, che verrà sostituita daiconflitti di tipo economico», os-serva per esempio, «segna dun-que la liquidazione dello Statomoderno, e io credo che l'av-vento di un sistema contrat-tuale sia a questo punto una ne-cessità storica» (G. MIGLIO, A.BARBERA, Federalismo e seces-sione. Uh dialogo, Libero, Mi-lano 2008, p. 31; I ed. Monda-dori, Milano 1997)151. Per esempio, alla metà de-gli anni Novanta Miglio os-serva: «Lo Stato è in crisi: sicontesta il primato della normaoggettiva, 'della nonna-imperio'e si sostituisce alla 'norma-im-perio' il contratto. [...] Oggi loStato Moderno muore di con-tratto. Muore perché il con-tratto prevale sulla legge insenso formale e sul concetto delprimato della norma. E in que-sto contesto, allora, quello cheva in crisi è proprio il patto fon-damentale in quanto patto po-litico, su cui essa poggia» (G.MIGLIO, Lapraspettiva teoricadei-nuovo federalismo, in «Fe-deralismo & Libertà», 2001, n.5-6, p. 24). Ma cfr, anche G. MI-GLIO, M. VENEZIANI, Podania,Italia. Lo Stato nazionale èsoltanto in crisi o non è mai esi-stito?, a cura di M. Ferrazzoli,Le Lettere, Firenze 1997; G.MIGLIO, Oltre lo stato-nazione:l'Europa delle città, in «Idea-zione», Vili (2001), n. 2, pp.93-108.
che ricondurre il contratto-scambio all'immagine romantica di una relazio-ne di scambio mercantile fra pari (dimenticando tra l'altro che, per buona par-te della storia occidentale l'economia mercantile si regge su, e richiede, ele-menti di dominio personale, non 'politici' ma 'naturali' e 'tradizionali'). Ma,al tempo stesso, dato che di fatto viene a considerare la relazione politica sem-pre più come una sorta di contratto assicurativo schiacciato sul presente, Mi-glio tende anche ad assegnare una rilevanza sempre maggiore al fattore 'cul-turale', con implicazioni per nulla trascurabili. Quando Miglio viene a consi-derare la ricerca di una rendita garantita - in contrasto con il carattere alea-torio della rendita di mercato - come la motivazione psicologica principaleche spinge i seguaci a stringere un patto di obbligazione politica, compie in-fatti un'operazione piuttosto significativa per la concezione del 'politico'. Pereffetto di questa ridefinizione, infatti, il 'politico' non è più un elemento con-nesso al carattere necessariamente conflittuale dell'uomo, nel senso che non.è più inteso - almeno prioritariamente - come una componente 'inelimina-bile' della natura umana. Al contrario, dato che appare legato alla ricerca diuna rendita 'garantita', il 'politico1 può essere ricondotto a una condotta in-fluenzata da fattori 'culturali': fattori, mutevoli nel tempo e nello spazio, chepossono indurre gli individui - in modo più o meno continuativo - a cerca-re di ottenere-rendite parassitarie, garantite politicamente, piuttosto che a get-tarsi nel rischio dell'intrapresa economica. In questo modo, Miglio non assumesoltanto una visione impoverita del 'politico', che finisce col replicare i limitidelle visioni liberali (e col generare una serie di ambiguità intorno all'effetti-va autonomia dei rapporti contrattuali dal patto politico), ma imbocca ancheuna deriva che conduce addirittura all'ipotesi di una soppressione delie relazionispecificamente politiche. In sostanza, dopo aver ricondotto l'obbligazione po-litica alla rendita garantita, e dopo aver ritrovato delle motivazioni 'cultura-li' alla base della preferenza per la rendita politica, è scontato infatti che Mì-glio possa ritenere che eventuali trasformazioni - economiche, sociali, tec-nologiche - vengano a spostare le preferenze individuali a favore della ren-dita di mercato. E, dunque, che arrivi di fatto ad annullare non solo l'area del-la rendita garantita, ma anche la stessa dimensione del 'politico'. Lungo que-sta traiettoria, che segue la direzione indicata dalla teoria della rendita, è al-lora comprensibile che Miglio, al principio degli anni Novanta, possa scrive-re, sintetizzando l'idea alla base del progetto neo-federale:
L'idea nuova è [.. J quella che ormai ogni coesistenza politica non pos-sa basarsi più su patti di fedeltà - giurati per la vita e per la morte, e quin-di 'eterni' - ma laicamente su 'contratti' a tempo determinato, 'condi-zionati' e dunque destinati, ad un certo momento, a essere •rinegoziati,oppure a sciogliersi e a lasciar libere le parti149.
Negli anni Novanta, Miglio finisce infatti con l'approdare all'idea secondo cuil'obbligazione politica è destinata a essere intéramente 'assorbita' dal contratto150,e cioè a un'idea per cui sembra addirittura che - insieme allo Stato - sia de-stinato ormai a venir meno anche lo stesso «patto politico»151. E così, benchél'esito sia senza dubbio paradossale, proprio Gianfranco Miglio - quello stes-so studioso che aveva celebrato in Cari Schmitt lo scopritore della 'regolari-tà' in base alla quale «ovunque c'è 'politica' là si incontra l'antitesi 'amico-nemico', e per cui «ogni raggruppamento politico si costituisce sempre a spe-
DOSSIER MIGLIO
se di, e contro un'altra porzione di umanità»152; quel medesimo studioso cheaveva affermato «dovunque esiste politica, esiste anche conflittualità» 1SS3 che«ogni 'ordine politico' è destinato a essere 'disordinato' dalla 'politica'» e che«la conflittualità (la. 'guerra') è la condizione naturale vigente nella sfera deirapportila gruppi più o meno organizzati»15* - arriva infine a prevedere lasenescenza stessa del 'politico'.
Non è forse del tutto incidentale che, al cuore della riflessione di GianfrancoMiglio - proprio dentro il nucleo strutturale del «cristallo» dell'obbligazio-ne politica - si nasconda una contraddizione teorica così rilevante e persinodirompente come quella che si è tentato di portare alla luce in queste pagi-ne. «Queste fondamentali e flagranti contraddizioni», osservava d'altronde Han-nah Arendt a proposito di Marx, «raramente si presentano negli scrittori disecondo piano», mentre «negli scritti dei grandi autori conducono al vero cen-tro dell'opera»155. In effetti, proprio questi nodi irrisolti ci conducono non soloal «centro dell'opera» di Miglio, ma continuano riproporci i motivi di fondodella sua ricerca sul 'politico'. Quei motivi che, se da un lato lo spingono co-stantemente a presentire «i segni di una nuova, diversa 'classicità'»156, dall'altrolo costringono a riaprire instancabilmente gli interrogativi di partenza, e così,forse anche ad allontanare la meta di una reine Theorie der Politile, proprionel momento in cui pareva ormai più vicina.A ben vedere, d'altronde, per quanto con la teoria della rendita politica Mi-glio introduca nel cuore della propria riflessione un'aporia dirompente, è mol-to probabile che non si tratti di un problema insolubile. Una via d'uscita po-trebbe consistere forse nel riconoscere che Miglio, mentre elabora la propriapersonale concezione della rendita, finisce di fatto con l'appiattire l'una sul-l'altra due visioni della politica ben diverse. Per un verso, infatti, quando ri-flette sul «cristallo» dell'obbigazione politica, e quando ne ricostruisce gli ele-menti strutturali, Miglio pare riferirsi a una concezione Torte' della politica,una concezione che - seguendo la proposta di Alessandro Pizzorno - può es-sere definita come «assoluta»; in questo senso, Miglio sembra alludere dun-que a una politica che emerge in periodi eccezionali, che ridefinisce (o addi-rittura costruisce) delle identità collettive e che - avendo come finalità prin-cipale la «partecipazione espressiva» da parte dei seguaci - risulta del tuttoirriducibile a finalità utilitaristiche o di tipo privatistico157. Per un secondo ver-so, invece, mentre scorge nel nomos la spartizione originaria del capo-caccia,e mentre espone la teoria della rendita politica, tende a pensare a una polì-tica «minima», ossia a una politica che si riassume nell'amministrazione (piùo meno 'ordinaria') delle rendite di posizione, nella contrattazione e nello scam-bio fra 'gruppi corporati', nella distribuzione di redditi 'garantiti' ai clienti cheoffrono appoggio al patrono. In altre parole, Miglio, riconducehdo all'unicotipo deU'obbligazione politica due logiche d'azione ben diverse, finisce col di-menticare quella strutturale ambivalenza, per cui - come scrive Pizzorno - «èla materia stessa della politica che è fatta di calcoli simili a quelli economicifino a un certo tratto», per alimentarsi, «più in là, di sentimenti simili a quel-li religiosi»158. Se si riconosce che «politica assoluta» e «politiea minima» de-finiscono due dimensioni differenti, forse diventa invece plausibile anche ipo-
152. G. MIGLIO, Le categorie del'politico', cit., pp. 599-600.153. G. MIGLIO, Guerra, pace, di-ritto, cit, p. 764.154. G. MIGLIO, Considerazioniretrospettive, eit, p. XXXVII.155. H. ARENDT, Vita dativa
(1958), Bompiani, Milano 1997,p. 74.156. L. ORNAGHI, II disordinedella politica, cit., p. 268.157. Cfr- A. PIZZOSNO, La poli-tica assoluta e altri saggi, Fel-trinelli, Milano 1993. Per unaripresa della distinzione tra«politica assoluta» e «politicaminima», riferita alle differen-ti modalità di studio dei feno-meni politici, cfr. anche L. OR-NA.GHI, Scienza della polìtica,Jaca Book, Milano 1993.158. A. PIZZORNO, La politica as-soluta e altri saggi, cit., p. 14.
53
RIVISTA DI POLITICA 3
tizzare che, proprio in una posizione logicamente intermedia fra obbligazio-ne politica e contratto-scambio, si trovi lo spazio specifico della clientela, o,meglio, di un tipo ideale di relazione che - pur conservando gli elementi diun rapporto personale di obbedienza e comando - presenta però anche ele-menti propri del contratto, tra cui soprattutto il riferimento all'interesse pri-vatistico dei contraenti e a un orizzonte temporale schiacchiato sul 'qui e ora'.Forse, proprio percorrendo questo sentiero, e ponendosi ulteriori interroga-tivi, diventerebbe allora possibile riesaminare sotto una nuova prospettiva ladistinzione migliana fra 'politica' e 'amministrazione', oltre che ripensare la
54 distinzione fra il tipo carismatico e il tipo istituzionale formulata da De Fran-cisci.D'altronde, fissare in un quadro organico, cristallizzato e privo di interne in-coerenze il pensiero di Gianfranco Miglio - come stabilirne una versione 'or-todossa', o magari trasformarlo nel pittoresco comprimario di un più o menoimprovvisato presepe ideologico - significherebbe tradire la sua eredità in-tellettuale. Ripartire, ancora una volta, proprio da quei nodi problematici dacui il giovane studioso dell'Università Cattolica prese le mosse negli anni Cin-quanta, e puntare lo sguardo sui problemi irrisolti - forse persine sulle apo-rie - della sua riflessione, significa invece proseguire effettivamente sul sen-tiero della sua ricerca. E, soprattutto, significa raccogliere davvero la sfida diuno studioso che dedicò le proprie energie intellettuali a una costante, ine-sausta, interminabile esplorazione dentro il cuore più impenetrabile degli^r-cana imperii.