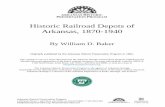L’ insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940. «Të venduemt e...
Transcript of L’ insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940. «Të venduemt e...
EPARCHIA DI LUNGRO
STORIA, RELIGIONE E SOCIETÀTRA ORIENTE E OCCIDENTE
(SECOLI IX-XIX)
Raccolta di saggi con studio introduttivoa cura di Attilio Vaccaro
Vaccaro vol I 5-12-2013 10:50 Pagina 3
Volume pubblicatocon il patrocinio dell’Eparchia di Lungro
© 2013, 2014 ARGO s.c.r.l.Via San Lazzaro, 8 - 73100 Lecce - Italia
tel. [email protected]
Vaccaro vol I 27-02-2014 21:05 Pagina 4
IndIce
Mons. donato olIverIo Presentazione .............................................................................................................. pag. 9
attIlIo vaccaro Studio introduttivo ...................................................................................................... pag. 13
MassIMo BIdottI Il culto di Atanasio d’Alessandria dalle origini e la sua venerazione nelle comunità italo-albanesi di Calabria pag. 29
GrIselda doka Francescani d’Albania: p. Marin Sirdani O. F. M. (1885-1962) cultore di storia e letteratura ........................................................................................ pag. 57
Italo costante FortIno Giuseppe Angelo Nociti. Uno studio filologico inedito pag. 77
steFano ParentI
Qualche osservazione sui codici greci del Collegio di S. Adriano trasferiti a Grottaferrata .................................................... pag. 103
MarIarosarIa salerno
«Fra cielo e terra»: Gioacchino e i Florensi tra vita religiosa e pratiche economiche pag. 113
Italo sarro
I cattolici al bivio nell’Albania turca ........................................................................... pag. 137
P. MarIn sIrdanI o.F.M.L’insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940. «Të venduemt e Françeskanvet neper vise të ndryshme të Shqypnís 1240-1940». Nota introduttiva e traduzione di Griselda Doka ....................................................... pag. 153
GIoacchIno strano
Valore militare e cultura religiosa nella formazione del perfetto generale bizantino ............................................................ pag. 175
attIlIo vaccaro
Appunti e note su alcune pergamene di età medievale nell’Archivio di Stato di Cosenza ................................................................................ pag. 189
attIlIo vaccaro P. Giuseppe Lottelli (1632 ca. - 1702): un esempio di moderno metodo storiografico per la storia di Squillace ............................ pag. 227
attIlIo vaccaro
S. Benedetto Ullano detto anche «S. Benedetto dell’Abbadia» tra medioevo ed età moderna (secc. XI-XVI) pag. 257
attIlIo vaccaro
Italo-greci e Italo-albanesi: differenze etniche ed ecclesiologiche nei loro vari stabilimenti nel Mezzogiorno d’Italia dal medioevo all’età moderna .......... pag. 285
attIlIo vaccaro
Medioevo albanese: «L’Albania e gli Albanesi», un saggio poco conosciuto di p. Marin Sirdani O.F.M. (1885-1962) .......................... pag. 343
153
P. MarIn sIrdanI o.F.M.
L’ insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940. «Të venduemt e Françeskanvet neper vise të ndryshme të Shqypnís 1240-1940».
Nota introduttiva e traduzione di Griselda Doka
[Nota introduttiva.Nelle citazioni delle fonti e della bibliografia ho mantenuto le forme originali utilizzate dall’autore. Le mie integrazioni sono precedute dalla sigla n.d.t. (nota della traduttrice).Per rendere più soddisfacenti in italiano i fatti narrati da p. Marin Sirdani, ho voluto precisare meglio il testo di arrivo, rispettando ovviamente l’approccio comunicativo del testo di partenza, in modo da far conoscere pienamente le peculiarità espressive di questo autore. Sono certamente cosciente del fatto che nel testo albanese alcune espressioni possano sembrare alquanto essenziali, quindi poco adattabili per una traduzione in una lingua complessa come quella italiana, ma ciò è normale quando non si condivide lo stesso codice linguistico; l’importante è che l’interpretazione rientri nel significato trasmesso. Inoltre ricordo che la varietà linguistica utilizzata dall’autore è il dialetto del nord dell’Albania (Geg), caratterizzato da molte espressioni concise e metaforiche.Visto che il Sirdani consulta spesso gli Acta et Diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, per offrire al lettore un eventuale approfondimento dei documenti citati in questa importante fonte storica curata da L. Thallóczy - C. Jireček - E. von Sufflay (I, Typis Adolphi Holshausen, Vindobonae 1913), ho inserito in nota - sempre contrassegnata con la sigla n.d.t. - il testo completo del documento, riprendendolo direttamente dagli Acta. Si tenga presente che alcune di queste fonti sono state ricopiate dai Registri della Cancelleria Angioina, prima dell’incendio dell’Archivio di Stato di Napoli, com’è noto causato dai tedeschi nel settembre del 1943. Gli Acta sono stati citati qui con la dicitura Acta et Diplomata; e poiché in alcuni casi, per errore materiale, il Sirdani sbaglia l’indicazione dei numeri corrispondenti ai documenti, è stata mia cura registrare, laddove si è verificata questa incongruenza, i numeri esatti. Sarebbe stato troppo lungo inserire nella loro forma completa le altre fonti che il nostro autore cita, lascio questo lavoro di verifica a uno studioso di buona volontà. Per la cronotassi dei vescovi ho fatto riferimento in nota alla Hierarchia Catholica di Conrad Eubel. Ricordo - come già scritto nel mio precedente articolo alla nota 23 - che il saggio qui tradotto era stato pubblicato dal Sirdani in lingua albanese con il titolo: Të venduemt e Françeskanvet neper vise të ndryshme të Shqypnís 1240-1940, in «Hylli i Dritës», 16 (1940), pp. 65-83.
G.D.].
***
154 P. Marin Sirdani O. F. M.
La storia dei Francescani in Albania, sia dalle origini, sia nella descrizione dei periodi storici in cui essa si è sviluppata, è molto complessa e avvolta nel buio. Quelle poche notizie sparse qua e là, da cronisti dell’Ordine e da storici stranieri, ricavate negli archivi in diverse zone, non bastano per schiarire la nebbia che ha coperto la nostra terra per secoli e secoli. Ma per questo motivo non si tireranno indietro coloro che hanno presente la misera situazione dei nostri sotto il Turco che, come si sa, barbaro è arrivato e barbaro è uscito dopo secoli. In un contesto simile va da sé che nessuno abbia potuto elaborare un lavoro buono e favorevole, ed è per questo che ciò che fu si sciolse come il sale nell’acqua, e tutto andò in ruina come scrive il principe Gjon Muzaka1.Ciò nonostante crediamo che anche in questo labirinto si sia riusciti a far splendere qualche raggio di luce, fino a un certo punto; quel po’ che serve per affinare il lavoro degli studiosi albanesi e poter fare delle ricerche più approfondite. Ma essendo andate le cose nel verso in cui si è detto prima, sembra incredibile che anche gli inizi dei francescani in Albania, come quelli di molte società, tribù e popoli antichi, siano avvolti nella leggenda. E poiché molte volte le leggende indicano il sentiero alle ricerche storiche, non potendo trascurarle, iniziamo con esse. Secondo la leggenda, la prima presenza dei Francescani in Albania inizia con il Santo Fondatore. Questi, tornando dalla Siria (1219), si ferma ad Alessio, dove, accolto con onori dal popolo che aveva sentito parlare di lui, fondò il suo Ordine in Albania2.Durante i pochi giorni che rimase in quella città, con la sua vita santa conquistò i cuori di molti, e fra altri, anche quello del parroco della città, un tale Don Lleshi, il quale si fece mettere la tonaca della penitenza proprio dalle mani del Santo. Don Lleshi, con l’elemosina che raccolse tra i benefattori, successivamente costruì un convento e una chiesa, nel luogo e come gli aveva indicato lo stesso Santo con un bastone di pino, portato in seguito con sé come ricordo a Venezia. «Lì lo conficcò nel suolo di quell’eremo della città (Deserto)3, e attecchì, crebbe e miracolosamente diventò albero grande. E fino a oggi, se vogliamo credere alla leggenda popolare, si conserva il fusto secco circondato da protezioni in modo da non essere tagliato o trasportato, conosciuto come
1 Charles Hopf, Chroniques Gréco-Romanes, Berlin 1873, p. 276.2 De Gubernatis, Orbis Seraphicus, de Missionibus Apostolicis Fratrum Minorum ad infideles a Sacra Congrega-tione de Propaganda Fide dependentibus, Tomus secundus, Typ. Colleg, S. Bonaventure, Quaracchí, 1886. Lib. V, n. 47, p. 414, in nota P. Donato Fabianich, M. O. Storia dei Frati Minori dai primordi della loro istitu-zione in Dalmazia e Bosnia, fino ai giorni nostri, Zara 1864, parte seconda, vol. II, VIII, p. 337.3 N.d.t. Si tratta del convento di San Francesco a Venezia (detto Convento di San Francesco del Deser-to), dove il santo frate è andato per la prima volta, portando dall’Albania, dalla città di Lezhë (Alessio) un ramo di pino, che poi piantò e durò per cinque secoli. Cfr. qui G. doka, Francescani d’Albania: p. Marin Sirdani O.F.M. (1885-1962) cultore di storia e letteratura.
155L’insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940
“Pino di San Francesco”, dal quale si concedono minuzzoli per devozione»4. Sull’importanza che ha potuto avere questa leggenda, noi non ci esprimiamo; solo per curiosità nei confronti di coloro che desiderano partire dal racconto come pretesto per fare nuove ricerche storiche, ricordiamo che anche dopo tanti secoli, quel luogo sacro, dove i francescani operano da sempre, è chiamato dalla gente: «La Chiesa di Don Llesh». Anche la già ricordata leggenda relativa al bastone di pino, ricorre ancora oggi a Venezia (Deserto)5.Inoltre, interessa soffermarci un po’ su questo racconto. Forse il suddetto «Don Lleshi» non era un prete, ma un principe dei Dukagjin o di qualche altra famiglia nobile del posto che, probabilmente, diede in dono ai francescani il castello o la «Kulla»6. Esso si ergeva di fronte alla città di Alessio, sulle colline che oggi sono chiamate «colline di Marleka». Oppure possiamo supporre che il principe l’abbia forse costruito per i frati a sue spese? Dato che il titolo di «Don» fu riservato solo successivamente ai preti, non ci meraviglia il fatto che il popolo stesso abbia trasformato tale leggenda attribuendola al parroco del luogo. C’è da fare il punto su un’altra cosa. La Chiesa in questione porta sull’architrave questa iscrizione: «Hoc templum Frat. Minor. aedificatum est anno MCC40»7. Se qualcuno avesse raccolto sufficienti prove sull’autenticità della stessa e sull’antichità dell’edificio, avremmo potuto attestare anche la presenza dei francescani in quella città sin dalle origini, ma l’iscrizione risale sicuramente a un
4 De Gubernatis e Fabianich, come sopra.5 Vedi De Gubernatis e Fabianich, come sopra. Nel periodico «Missioni Francescane», anno II, vol. II, fascic. IV, si trova pubblicata una poesia estratta da un vecchio manoscritto sull’arrivo di San Francesco a Lezha. Non essendo la sede adatta, ripubblichiamo qualche strofa qua e là, - «Sull’ Albana spiaggia un dì fu visto - Fermarsi e sospirar lungo la via - Forse andando a più felice acquisto? ... Di più silvestro un ramoscel, che colto - Da Francesco sul suolo di Venezia - Trasportato, benché dal tronco sciolto, - Crebbe tosto in si nobil forma egregia - E poi sempre fiorì di nuove foglie - Che ancor del fusto quel terren si pregia... E forse in cima al collicel scoscese, - Le cui falde si bagnano nel Drino, - E che dalle procelle tien difese, - Le reliquie d’Alessio a lui vicino - Sorger fra brieve forse colà vede - Dell’Ordin de’ Minor, un bel mattino - La prima ai figli suoi sicura sede - E un nuovo tempio che a Lui sacro, poi - Sarà fonte di grazia e di mercede - In ogni tempo agli devoti suoi, - Che sicuro conforto ai loro affanni - I posteri n’avranno fino a noi... ». N.d.t.: l’autore riporta direttamente la poesia in italiano.6 N.d.t. Abitazione tipica dell’entroterra del nord dell’Albania a forma di torre. Da sempre queste abi-tazioni sono state utilizzate anche come rifugi per ripararsi dalle vendette di sangue. Sono abitazioni di larghe dimensioni adatte alle esigenze di grandi famiglie per linea paterna. Per buona parte del tempo uomini e donne vivevano in casa in spazi differenti. Le strette finestre sono usate soprattutto a scopi difensivi. La kulla non è solo una casa, ma anche una fortezza. Inoltre, è un luogo carico di significato e simboli come la pazienza, l’orgoglio, il coraggio e la resistenza. Scrive a tal proposito George Castellan: «La kullë urbana era propria dell’Albania del nord e del Kossovo. Era antica e sin dal XVII secolo servi-va a difendere le case feudali dall’anarchia allora regnante. Ma ce n’erano anche nel sud, e Argirocastro ne era un esempio. Decorate e rivestite, queste case erano divise in due zone: l’abitazione degli uomini - selamlik - che comprendeva anche gli ambienti per gli ospiti, e l’harem, che era destinato alle donne. In queste case, grandi o piccole, abitavano delle famiglie che venivano designate col termine shtëpia, la “casa”, o vatra, il “focolare”». Cfr. G. castellan, Storia dell’Albania e degli Albanesi, Lecce 2012, 70-71. 7 Cfr. De Gubernatis e Fabianich, come sopra.
156
periodo successivo, come si legge dalla data. Ciò detto, in ogni caso non siamo d’accordo con qualche «nuovo arrivato» secondo il quale l’iscrizione non solo è apocrifa, ma anche aggiunta recentemente da qualche frate, con lo scopo, forse, di provare l’antichità dell’edificio. Lasciando da parte le dicerie, è storicamente attestato che il convento di Alessio era abitato dai francescani almeno dal 14648 e sicuramente la chiesa non risale a un periodo successivo. Da quanto apprendiamo dai nostri predecessori, l’attuale iscrizione non è originale, perché era precedentemente riportata in greco. Fino ad oggi il primo che ne parla è P. Lorenzo di Santa Croce, provinciale della provincia albanese che, nel 1720, certo dell’autenticità dell’iscrizione, così scrive: «La provincia francescana dell’Albania è una delle più antiche dell’ordine come si può ricavare dalla costruzione del convento di Santa Maria di Alessio, oltre la costa del Drin, sull’architrave del quale si trova questa iscrizione in latino, tradotta da un’altra che era in greco: “Hoc templum Fratrum Minorum aedificatum est anno Domini 1240”»9. La causa di questa modifica dell’iscrizione, forse rovinata, danneggiata nel tempo o chissà per quali altre ragioni, non c’è la dicono né il cronista appena citato né altri. Sia la chiesa sia il convento, anche se di continuo bruciate dal Turco e recentemente (1918) dall’esercito austriaco, conservano ancora tracce che ci riconducono al XIII sec. Forse ci siamo soffermati un po’ sulla leggenda della chiesa di Alessio, ma l’abbiamo fatto per la ragione qui sopra esposta. Passiamo ora al racconto storico della presenza e della diffusione dei francescani in diversi territori dell’Albania, tema questo che vorremmo sviluppare attraverso il presente studio. Proprio nel periodo in cui iniziavano ad agire i frutti spirituali prodotti grazie allo zelo dei francescani e dei domenicani in Dalmazia del nord e in Bosnia, la Serbia e l’Albania del nord, regioni che erano sotto la giurisdizione di una devota cristiana, con l’aiuto dei religiosi di questi due nuovi ordini, iniziarono a essere ripulite dalle eresie di quei tempi. Era questa una delle nipoti di Enrico Dandolo, che prima di andare in sposa al Gran Župan Stefano Nemanja, aveva convinto quest’ultimo a rientrare in seno alla Chiesa Cattolica10.
8 Cfr. Fr. Virgilius Greiderer, Germania Franciscana, L. II, T. I, n. 55.9 Cfr. De Gubernatis, Lib.IV, p. 414; Fabianich, VIII, p. 337. Questo registro che si conserva nel nostro archivio provinciale testualmente riporta così: «La Provincia de’ Minori Osservanti di Albania è delle antiche dell’ Ordine, come si scorge dalla fondazione del Convento di S. Maria di Alessio oltre il fiume Drino, nella facciata della cui chiesa trovasi questa iscrizione latina tradotta da altra che v’è in greco idioma: Hoc templum Fratrum Minorum aedificatum est anno Domini MCC40». Il registro in questione porta questo titolo: Registro della Provincia Osservante d’Albania 1720 - In tempo del P. M. R. Lorenzo di santa Croce Ministro Provinciale l’anno 1720. N.d.t.: testo originale virgolettato in lingua italiana.10 N.d.t.: si tratta di Anna Dandolo (? - 1220 ca.), regina di Serbia. Nipote del doge Enrico Dandolo, fu terza moglie di Stefano Primo Coronato (1196-1227), re di Serbia che, grazie anche a questo matrimo-
P. Marin Sirdani O. F. M.
157
La regina, dopo la morte del marito e con l’approvazione dei cognati, invitò un numero considerevole di francescani e domenicani. «A fare questo passo fu spinta dallo zelo dimostrato da quei pochi religiosi arrivati dalla Dalmazia e dai frutti della loro attività nei paesi di confine»11. Questo accadeva intorno agli anni 1232-1235.Da una lettera che papa Gregorio IX inviava nel 1236 al responsabile dei domenicani della Provincia romana, nella quale si dice di mandare frati del suo ordine come inquisitori nell’arcivescovato di Antivari, si legge tra le altre cose che lì si trovavano «alcuni religiosi arrivati in quella regione di recente»12. Non sembra chiaro a quale ordine appartenessero questi religiosi, ma restando nel contesto della lettera, si possono escludere i domenicani e sostenere che si trattava, probabilmente, di francescani i quali, com’è noto, in quel tempo si stavano diffondendo nei Balcani. Nonostante l’attività che cercavano di svolgere i rappresentanti dei due ordini sopra citati e l’attenzione della devota regina, era difficile raccogliere i frutti a causa di conflitti interni ed esterni. Ma a mettere ordine nella disciplina ecclesiastica, da tempo tralasciata, e a ostacolare in modo permanente lo sfascio della tradizione cristiana, ci voleva una mano forte, e papa Innocenzo IV la trovò nel francescano Giovanni da Pian del Carpine13. Costui nel 1248 fu nominato arcivescovo di Antivari14, con
nio, orientò la sua politica verso Venezia e il papato, ottenendo nel 1217 la corona reale.11 Fabianich, k.II, p. 46.12 Dr. Ivan Markovic, Dukjansko - Barska metropolija; Zagreb, Tisak Antuno Scholza, k.VII, p. 98. Farlati, IIlyricum sacrum, L. VII. p. 35.13 N.d.t.: «Joannes de Plano Carpinis. O. Min. 1248-1252…Nuntius apost. sedis ad schismaticos in Asia min. et ad Tataros missus erat ». Cfr. c. euBel, Hierarchia catholica medii aevi, 1, Monasterii 1913, Patavii 1960, 92 e n. 3.14 Dr. Ludovicus Thallóczy, Acta et Diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia. Vindobonae MCMXIII, Typis Adolphi Holshausen, vol. I, p. 38 [ma p. 58 n.d.t.], n. 191. Qui egli il 12 gennaio 1249 scrive del suo passaggio a Ragusa, diretto a insediarsi come arcivescovo di Antivari (pro parando ad archiepis copatum antivarensem). Dato che citeremo più volte questa opera del Thallóczy, la indichiamo con le seguenti lettere: A Alb, da poterla distinguere dall’altra opera, Illyrisch - Albanischer Forschungen (Verlag von Duncker et Humblot, München und Leipzig 1916), che indicheremo come segue: I. A. Forschungen. N.d.t.: «1249, 12. ianuarii. Ragusii. In praesentia prioris et plurium fratrum Praedicatorum commo-rantium Ragusii, plurium Venetorum, Petri diaconi Antibarensis, presbiteri Pascalis notarii, diaconi Mathei Teophili Ragusini, “frater Johannes de Plano Carpini de ordine fratrum minorum, archie-piscopus Antivarensis transiens per Ragusium pro parando ad archiepiscopatum Antivarensem, occasione questionis, quae est inter ecclesiam archiepiscopatus ragusini et ecclesiam Antivarensem”, propter bonum pacis se venire vel per procuratorem cum nuntiis capituli et communitatis Antibarensis privi-legia ecclesiae Antibarensis, “Cataro vel ad Sanctum Michaelem in culfo Catari, ubi melius videbitur domino archiepiscopo Ragusino” mittere promittit. Et illuc veniet archiepiscopatus Ragusinus. Et dicti archiepiscopi vel procuratores eorum cum procuratoribus capitulorum et nuntiis civitatum ibi privile-gia legant, ascultent rescripta eisdemque viceversa sigilla archiepiscopi, capituli, civitatis apponant. “Si Antivarense capitulum et commune vellent prohibere, quod dominus archiepiscopatus Antivarensis supradicta non faceret, promittit archiepiscopatus Antivarensis, quod eos per censuram ecclesiasticam cohercebit”. “Et finita colocutione ambe partes ire debeant ad dominum papam infra terminum quat-tuor mensium”. “Item promittit frater Johannes archiepiscopus antivarensis, quod non molestabit epi-
L’insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940
158
l’incarico di occuparsi delle diocesi dell’Albania del nord e della Serbia e dei suoi confratelli che si trovavano in quei territori15.Questo noto religioso, che aveva promosso la missione francescana in Oriente e in Tartaria16, rispose bene alle aspettative riposte su di lui dal Papa, applicando le leggi ecclesiastiche, ostacolando il coraggio degli oppositori e degli scapestrati, portando in seno alla Chiesa eretici e scismatici, tanto che alla sua morte (1252) furono scelti per quella sede, uno dopo l’altro, tre confratelli del suo Ordine17. Quest’uomo, per il suo valore, dopo morto, fu proclamato «Beato»18.
scopum Ulcinensem nec capitulum per excommunicationem vel interdictum.” - Scripsit Petrus Dente presbyter s. Bassi et notarius…». Cfr. L. thallóczy- c. JIreček - e. von suFFlay, Acta et Diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia. I, Typis Adolphi Holshausen Vindobonae 1913, pp. 58-59 (d’ora in poi cit. Acta et Diplomata).15 Fabianich, k. II, p. 48.16 Fabianich, k. II, pp. 48-49.17 Per poter capire l’importanza che aveva l’arcivescovato di Antivari, bisogna tener presente il grande territorio che occupava, avendo sotto controllo oltre alle diocesi della Serbia, anche le diocesi di Scu-tari, Dulcigno, Shas, Pult, Drivasto, Sarda, Sapë, Lezhë, Dêja, Bales e di Prizren.18 S Thallóczy, A Alb parla di lui nel volume I, n.191, 194 -198, 200, 207, 208, 210 - 212, 214, 216 - 222.N.d.t.: Come in precedenza riporto qui di seguito i testi dalle fonti originali. Per il n. 191 v. supra n. 13. «(1250) 22. aprilis. Lugduni. Innocentius IV. papa (Johannis) archiepiscopi Antibarensis statutum con-firmat, quod ille in concilio provinciali contra pravam consuetudinem civium Antibarensium edidit, qui, “cum Antibarensis archiepiscopus decedebat, bona eius mobilia occupantes inter se temere divi-debant”. Secundum hoc statutum scilicet canonice est ordinanda, “a capitulo cuiuslibet ecclesie ipsius provincie ecclesiastica persona, que vicarii nomen gerens omnium rerum vacantis ecclesie post prelati discessum curam habeat”…». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 59, n. 194. «(1250) 22 aprilis. Lugduni. Innocentius IV. papa (Johanni) archiepiscopo antibarensi committit, ut nonnullos clericos et laicos suae provinciae “propter iniectionem manuum usque ad levem effusio-nem sanguinis in seculares clericos et etiam regulares personas” excommunicatos, quia “tum propter locorum distantias, tum etiam propter expensarum defectum nequeant apostolicam sedem adire”, absolvat, “dummodo gravis non fuerit et enormis illorum excessus”». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 59, n. 195. «(1250), 22 aprilis. Lugduni. Innocentius IV. papa (Marco) Dulcinensi et.. Suacinensi episcopis mandat, ut secundum propositum (Johannis) archiepiscopi Antibarensis omnia, quae de bonis Antibarensis et ecclesiae et mensae archiepiscopalis a praedecessoribus dicti archiepiscopi alienata invenerint illicite et distracta, ad ius earundem legitime revocent». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 59, n. 196. «(1250) 23 maii Lugduni. Innocentius IV. papa (Salvio) episcopo Tribuniensi mandat, ut fratrem Jo-hannem de ordine Minorum episcopum (!) Antibarensem…una cum Bosnensi, Buduanensi, Dulci-niensi, Suacensi, Scodrinensi, Drivastensi et Polatensi episcopi et praefatum archiepiscopum Ragusi-num ad se apostolico conspectui infra octo menses praesentandum invitet». Cfr. Acta et Diplomata, cit., pp. 59-60, n. 197.«1250, 1 maii Lugduni. Magister Guillelmus Parmensis capellanus papae ac eiusdem contradictarum auditor declarat Leonardum de Tervisio procuratorem (Johannis) archiepiscopi Ragusini “cum Petrus de Assisis clericus procurator (Johannis) archiepiscopi Antivarensis pro ipso impetrasset” tres litteras apostolicas (v.n. 194-196), in audientia publica sibi depactum esse, ut Ragusinae ecclesiae “nec super questione que committitur in sede apostolica inter Ragusinam et Antibarensem super Antibarensi et quibusdam aliis ecclesiis cathedralibus, quas idem Ragusinus dicit sibi iure metro politico esse su-
P. Marin Sirdani O. F. M.
159
Un’opera simile, con lo scopo di rinnovare la vita cristiana, iniziata con successo
biectas, nec super eo, quod Antibarensis vocet se archiepiscopum, per predictas litteras preiudicium generetur”». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 60, n. 198. «(1250) 8 augusti. Lugduni. Innocentius IV. papa (Johanni) archiepiscopo Antibarensi committit, ut - cum “in Grecie partibus quedam habeatur provincia, que Arbania nuncupatur cuius episcopus” se ecclesiae Romanae indissolubili vinculo coniungere velle dicatur - dictum episcopum, si nulli prelato Latino fuit unquam aut esse debet de iure subiectus, vice nostra sollempniter ac publice ad graciam et communionem sedis “apostolicae resumat”, cum super hoc ab ipso fueris humiliter requisitus, decer-nens eundem nulli preterquam Romano pontifici debere perpetuis temporibus subiacere». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 60. n. 200.«1251, 2. octobris. Ragusii. Dioecesis et communitas Ragusina “pro honore, utilitate et negotiis neces-sariis civitatis et ecclesie” Johanni archiepiscopo Ragusino potestatem dat tantae pecuniae mutuandae, quanta ei fuerit necessaria pro expensis faciendis “eundo Ragusio ad curiam, stando et moram facien-do in dicta curia et redeundo Ragusium, donec causa” cum Antibarensi et Bosnensi et aliis episcopis terminata fuerit». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 62, n. 207.«1251, 11. Octobris. “In castello Ragusii”. Johannes archiepiscopus Ragusinus ad sedem apostolicam “pro causa, quam ecclesia Ragusina habet super Antibarensem, Dulcinensem, Bosnensem et super alios episcopos suffraganeos”, pergens sequentia “brevilegia” ecclesiae Ragusinae a procuratoribus sanctarum reliquiarum et dictorum brevilegiorum suscipit: singula Benedicti VIII., Gregorii VII., Pa-scalis II., Callixti II. duo, singula Innocentii II., Anastasii IV., Adriani IV., Alexandri III., Urbani III., Clementis III., Gregorii IX., “exemplar brevilegii pape Zaharie, cartam episcopi Pauli Dulcinensis, cartam consecrationis Brataslavi episcopi Bosnensis, cartam de sacramento Marci episcopi et capituli Dulcinii et alias litteras Alexandri pape”. - Scripsit presbyter Pascalis communis notarius iuratus». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 62, n. 208.«1252, 11. ianuarii (Perusii.). Legitur “quedam cedula in publica audientia litterarum domini pape”, qua Petrus de Barro electus Sabinensis mandat, “quod si sunt aliqui procuratores in curia pro Entranensi, Dulcianensi, Suacensi, Scodrinensi, Drivariastensi, et Pollatensi episcopis die veneris proxime venturo compareant post nonam” coram eo Johanni archiepiscopo Ragusino de iustizia responsuri. - Scripsit Petrus Brunus apostolica auctoritate notarius». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 62, n. 210.«(1252), 25. Februarii. Perusii. Johannes, archiepiscopus Ragusinus commune Ragusii per nuntios certius facit, se Perusii in curia pontificis “cum presbytero P. Sabino et Blanco et tota familia” mo-rari ibique res Ragusinas viriliter promovere. Post eiectionem Junii de Cereva, qui nomine Sclavae eum in causam coram summo pontifice super vinea [in Celapec posita] attraxerit, procurationem dic-tae Sclavae a “praelato Antibarensi” ostensam esse. Dictum praelatum diffamationes contraclerum et populum Ragusinum super captione eiusdem proposuisse et a se “duo millia yperperorum pro absolutione excommunicationis super captione ipsius” petere. “Super negotio prelati [Antibarensis] contestati sumus litem” et per iuramentum ultra centum diximus: [in provincia] Ragusina sunt posita tria regna videlicet regnum Zachulmie, regnum Servilie, quod est Bosgna (!) et regnum Tribunie. Et regnum Zachulmie extenditur usque ad provinciam Spalatensem, regnum Servilie extenditur usque ad provinciam Collocensem, regnum Tribunie extenditur usque ad provinciam Dirachinam. Et prelatus Antibarensis inter multa et inaudita dixit per suum iuramentum, quod in tota Dalmacia ab antiquo non fuerunt nisi duo archiepiscopatus videlicet Salona et Dioclea. Et in loco Salone est Spaletum et in loco Dioclee est Antibarum. Et episcopus Ragusinus subiacet archiepiscopio Spalatensi». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 62, n. 211.«1252, mense martio - maio. Perusii. Quomodo Johannes archiepiscopus Ragusinus et eius procurator huius archie-piscopi in praelatum Antibarensem ius metropolitanum defenderint.(Leonardus de Tarvisio) procurator (Johannis) archiepiscopi Ragusini “intendit probare” Andream archiepiscopum Pitauritane ecclesiae a Zacharia papa pastorem in Zachulmie regno et regno Servilie Tribunieque regno, civitati namque Catarinensi seu Rose atque Buduanensi, Avarorum, Liciniatensi
L’insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940
160
dal del Carpine, e successivamente diffusa dai suoi confratelli, non era vista di buon occhio da alcuni malvagi. Essi erano coloro che facevano di tutto per impedire l’attività dei francescani in Dalmazia e in Albania. Per attenuare il loro coraggio, papa Alessandro IV ordinò agli arcivescovi di Zara e Antivari di sostenere i francescani nella lotta contro questi personaggi (a malignorum incursibus defendant)19.
atque Scodrinensi nec non Drivastensi atque Polatensi constitutum esse. Privilegium super hoc cum omnibus privilegiis ecclesiae, sicut haec notoria sunt “in partibus illis” a “rege Rascie”, qui civitatem Ragusinam cepisset, “a septuaginta annis circa” ablatum esse. Non prescribatur, [quia] non est pro-batum, quod ab illo tempore circa ecclesia Antibarensis ab aliquo sit possessa; unde non habet locum probare interrupcionem». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 63, n. 214.« (1252), 20. aprilis. Perusii. Innocentius IV. papa (Centiberio) episcopo Catharensi mandat, ut epi-scopum Arbanensem suffraganeum (Johannis) Antibarensis archiepiscopi, qui obedientiae illi debitae se subduxerit eique oboedire deneget, “quamquam nullo super hoc exempcionis privilegio a sede apostolica sit munitus”, moneat, ut ei oboedientiam exhibeat, renuente vero illo praefigat ei terminum, quo per se vel procuratores compareat coram papa dicto archiepiscopo responsurus». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 66, n. 216.«(1252), 20. aprilis. Perusii. Innocentius IV. papa (Johanni) archiepiscopo Antibarensi facultatem con-cedit nonnullos, qui in eius provincia “decimas de animalium nutrimentis, de frugibus aliisque fructi-bus terre ac lucris licite acquisitis ecclesiis debitas” subtraxerint, ad solvendum eadem per censuram ecclesiasticam compellendi». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 66, n. 217« (1252), 22 aprilis. Perusii. Innocentius IV. Papa (Johanni) episcopo Anconitano mandat, ut in lite inter (Johannem) Ragusinum archiepiscopum ex una et (Johannem) Antibarensem episcopum (!) ac Buduanensem (ect. Sicut sub nr.212)». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 66, n. 218.«1252, 29. aprilis. Perusii, “in palacio s. Florencii”.Johannes Bonus episcopus Anconitanus statim postquam “frater Johannes archiepiscopus Antibaren-sis pro se et procuratorio nomine Buduanensis Dulcinensis, Drivariastensis (!), Scodrensis, Suacensis et Pollatensis episcoporum ex una parte et Leonardus plebanus s. Johannis de Triusio procurator Johannis archiepiscopi Ragusini ex altera «eidem litteras apostolicas (de 1252. 22 aprilis nr.218) praesen-taverint, Cosmae” cappellano et notario suo receptionem testium, quos in causa prefata introducere voluerint partes dicte “committit dictisque partibus, terminum per totum mensem iunii ad comparen-dum apud Ragusiam coram Cosma predicto” statuit. - Testes: Bernardus prior ecclesiae s. Florencii, Vivanus dompni Philippi de Ancona, Bonacursus familiaris archiepiscopi Antibarensis. - Scripsit Jaco-bus Andree Cicute imp. auct. notorius». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 66, n. 219.«1252, 29. aprilis. Perusii, “in palacio s. Florencii”. Johannes Bonus episcopus Anconitanus “statuit ter-minum perentorium fratri Johanni archiepiscopo Antibarensi pro se et procuratorio nomine Budua-nensis, Dulcinensis, Drivariastensis (!), Scodrensis, Suacensis et Polatensis episcoporum ex una parte et Leonardo plebano s. Johannis de Trivisio procuratori Johannis archiepiscopi Ragusini ex altera hinc ad tres dies ante kalendas ianuarii proxime venturi ad comparendum coram summo pontifice ad sen-tentiam audiendam”. Testes et notarius iidem qui sub n° 219». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 66, n. 220.«1252, 1. maii. Perusii. Coram Johanne de Camezan domini papae et eiusdem contradictarum au-ditore Leonardus de Tervisio procurator (Johannis) archiepiscopi Ragusini litteris, quas (Johannes) Antibarensis archiepiscopus pro se impetraverat (1252. 20. apr. Nri. 216, 217) contradicens easdem “ea condicione absolvit, quod” in lite inter dictos archiepiscopos mota, “nullum eidem archiepiscopo Ragusino per predictas litteras preiudicium generetur”». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 66, n. 221.19 Thallòczy, A Alb, v.I, p.70, n. 244, - Fabianich, k.II, p. 57.N.d.T.: «(1258) 13. Februarii. Viterbii. Alexander IV. Papa (Laurentio) Jadertino et (Laurentio) Antiba-rensis archiepiscopis mandat, ut fratres ordinis fratrum Minorum in provincia Slavoniae a malignorum
P. Marin Sirdani O. F. M.
161
La storia francescana di quei tempi ci segnala anche un’altra regina, di nome Elena, nota come grande benefattrice dell’Ordine in Albania. Rimasta vedova dopo essersi sposata con Stefano Uroš I re di Serbia, conduceva una vita piena di difficoltà. Infatti, oltre alle responsabilità dovute alla sua posizione, soffriva anche per la vita dissoluta dei suoi due figli, Stefano Dragutin e Uroš Milutin, che spesso cercavano di agire lontani dalla vista della madre e frequentemente avevano a che fare con uomini combattenti e feroci. Ignorando la fede, costoro sembravano destinati a mandare tutto a rotoli. La regina, dopo aver interpellato l’arcivescovo di Antivari fra’ Lorenzo d’Orte20, cercò di farli riflettere e non ottenendo risultati, decise di chiedere l’intervento e l’autorità dello stesso papa Niccolò IV. Quanto ci tenesse alla richiesta della regina, il Papa lo dimostrò inviando due legati francescani - Cipriano di Antivari e Marino di Cattaro - con due lettere indirizzate alla stessa. In esse si diceva, a proposito dei due principi, di trattarli come uomini di valore e di stare loro vicina: per educarli, consigliarli e rimproverarli a seconda delle circostanze21.La regina e i suoi li accolsero con onore e riverenza e così in poco tempo i due principi si misero sulla retta via con grande gioia della madre e degli amici22.Col tempo l’opera dei francescani si diffuse sempre più nei Balcani tant’è che i figli dell’Ordine collaborarono strettamente con i domenicani, pronti a portare a termine i voleri del Papa con gioia senza trovare difficoltà nell’impegnarsi per il bene dell’umanità e della religione, e a diffondere dappertutto la civiltà e la fede, godendo della simpatia dei grandi e dei piccoli, dei ricchi e dei poveri, portando nel gregge del Signore, popoli e tribù, avvolti dalle tenebre dell’ignoranza e del peccato. Alla luce di tutte queste attività i Papi avevano posto grandi speranze nei francescani, come dimostreremo più avanti. Il 2 settembre del 1254 papa Innocenzo IV ordina al provinciale della Calabria, Giovanni d’Aversa, di incaricare come arcivescovo di Crotone, magistrum Nicolaum de Durachio23.Il 1 Marzo 1291 papa Nicolò IV incarica Michele, arcivescovo metropolita di Anti-vari24, di scegliere un vescovo per la diocesi di Sarda; con il parere del responsabile
incursibus defendant». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 70 n. 244.20 N.d.t.: «Laurentius (Hortanus) O. Min. 1255…Alias de Portugallia». Cfr. euBel, Hierarchia catholica medii aevi, cit., 92 e n. 4.21 Entrambe le lettere sono state pubblicate da Fabianich, VI, pp. 98, 99.22 R. Fabianich, k. III. pp. 66 - 67. - Fr. Sigismondo da Venezia, Bio grafia serafica degli uomini illustri per santità, dottrina e dignità, sec.I, f.91.23 Thallòczy, A Alb.; v.I, p. 69, n. 235, scrive: «1254, 2 sep tembris Anagniae: - Innocentius IV papa Johanni de Aversa ministro in Calabria Ord. Minorum mandat, ut “Magistrum Nico laum de Durachio camere apostolice clericum in latina et grece lingua peritum” Crotonensi ecclesiae in Episcopum praeficiat».N.d.t.: «Nicolaus de Durachio, nag., cam. apost. Clericus1254… In lat. et graeca lingua peritus». Cfr. euBel, Hierarchia catholica medii aevi, cit., 213 e n. 2; e qui il mio articolo precedente sul Sirdani.24 N.d.t.: «T., quo mortuo, Michael can. Catharen., el., prov….1282-1301». Cfr. euBel, Hierarchia catho-lica medii aevi, cit., 92.
L’insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940
162
dei domenicani e del p. guardiano dei francescani di Ragusa (de consilio et assensu prioris Predicatorum et guardiani Minorum Fratrum Ordinum Ragusinorum)25.Nello stesso anno, l’11 giugno, Nicolò IV ordina al suddetto metropolita di approvare de consilio dei due superiori sopra citati, il sacerdote (di nome Pietro) scelto come vescovo di Sapa, diocesi questa rimasta da anni senza pastore perché rovinata e distrutta dalle guerre26.Papa Bonifacio VIII il 29 aprile 1298 ordinava al provinciale francescano di Schiavonia27 di scegliere due frati del suo ordine come inquisitori, capaci di combattere le eresie nelle regioni della Serbia, Rascia, Dalmazia, Croazia, Bosnia e d’Istria e anche negli arcivescovati di Durazzo, Antivari, Ragusa, Spalato e Zara (contra haere ticos, fautores et defensores eorum exequantur)28.Lo stesso ordine dato dal Papa, riguardo ai medesimi luoghi, lo rinnovava fortemente papa Giovanni XXII il 1 luglio 132729.
25 Thallòczy, A. Alb., v. I, p.153, n. 515. N.d.t. «(1291) 11. Iunii. Apud Urbem Veterem. Nicolaus IV. papa (Michaeli) archiepiscopo antibarensi mandat, ut - cum e litteris eiusdem et Elenae reginae Serbiae acceperit, “quod in Albanie partibus iuxta Sclavos quedam abetur civitas Sava nomine, que iam longi temporis spatio destructioni succubi eius in-colis per diversa loca dispersis, sed de novo in civitate predicta quam plures viri catholici de incolarum ipsorum progenie, ut dicitur existentes et alii etiam diversarum partium convenerunt moramque in illa continuam contrahunt episcopum cum instantia postulantes, propter quod predicte civitatis clerici ad electionem procedentes episcopi quendam presbyterum Petrum nomine virum utique catholicum et fidelem in suum et eiusdem civitatis elegerunt episcopum petendo a te utpote metropolitano, ut electionem huiusmodi auctoritate tibi tradita confirmare” - de consilio prioris Praedicatorum et guardiani Minorum de Ragusio eidem electo, si electionem canonice invenerit celebratam, munus consecrationis impendat…». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 153, n. 515.26 Lo stesso come sopra, p. 153, n. 515. 27 La provincia di Schiavonia o della Dalmazia aveva quattro custodie. La custodia di Ragusa incluse per lungo tempo anche i conventi dei francescani di Durrazzo, Dulcigno, Scutari e Antivari (Fabianich, k.VII, p. 145, - I. A. Forschungen: Im Jahre 1283 gehörten ihre Missionen in Cattaro, Antibari, Dulcigno und Durazzo unter die «Custodia Ragusina».28 Thallòczy, A Alb, v.I, p.157, n. 530 «Patarenorum (Bogumili) haeretica labe, que intecta Bosnia, nunc in Epi-rum quoque serpere coeperat». N.d.t.: quest’ultima frase è alla fine del testo n.530 ma il Sirdani non riporta ciò che segue cioè la fonte di riferimento, ossia: «v. Rački, Rad 7 (1869) ss. Cf. Friedrich, über Paulikianer in Sitzber, der Münche-ner Akad. Phil. Kl. 1896, 67-111. Karapet, Die Paulikianer im byzant. Kaiserreiche 1898 pass.». N.d.t.: per quanto riguarda il brano n. 530, è il seguente: «(1298) 29. Aprilis. Romae, apud s. Mariam. Bonifacius VIII. papa “ministro provinciali ordinis fratrum Minorum in administratione provinciae Sclavonie” mandat, eligat duos fratres sui ordinis idoneos, qui ad extirpandam letiferam pestem hae-reticae pravitatis inquisitionis officium in “partibus Servie, Rasie, Dalmatie, Croatie, Bosne atque Istrie provincie Sclavonie” et in “archiepiscopatibus Duracensi, Antibanensi, Ragusino, Spalatensi et Jadren-si” contra haereticos, fautores et defensores eorum exequantur. “Licet et omnibus”...». Cfr. Acta et Diplo-mata, cit., p. 157, n. 530.29 Thallòczy, AAlb., v. I, p. 250, n. 724. N.d.t.: «(1327) 1. Iulii. Avenione. Johannes XXII. papa nolens derogare litteris Bonifacii VIII., qui-bus ordini fratrum Minorum officium datur inquisitionis contra haereticos “in partibus Servie, Rasie,
P. Marin Sirdani O. F. M.
163
In realtà, non sono solo questi i fatti che dimostrano chiaramente il passato dell’attività dei francescani in Albania, ma anche altri che non lasciano dubbi sul loro operato che ebbe inizio sin dagli albori dell’Ordine come la frequente scelta dei religiosi destinati alle diverse sedi vescovili dell’Albania sin dalla metà del XIII secolo30; e la fama delle virtù di alcuni francescani albanesi sin dalle origini dell’ordine31, nonché le dichiarazioni dei papi sulle loro opere maestose. Parlando solo del primo secolo di vita francescana, conosciamo undici figli di quest’Ordine onorati dalla Santa Sede con la dignità vescovile in Albania. Essi sono: Giovanni da Pian del Carpine, arcivescovo di Antivari (1248-1252); Goffredo..., arcivescovo di Antivari (1253-1255)32; Lorenzo d’Orte, arcivescovo di Antivari (1255-1260); Pietro Tiburtino, arcivescovo di Antivari (1260-1276)33; Bonaventura, vescovo di Arban (1273...); Martini... arcivescovo di Antivari (1304...)34; Antonio de Baosoni, arcivescovo di Durazzo (1305...)35; Andrea I..., arcivescovo di Antivari (1307...)36; Martini..., vescovo di Arban (1304...); Federico Germani, arcivescovo di Scopia (1317...)37; Francesco… vescovo di Valona (1319...)38.
Dalmatie, Croatie, Bosne atque Istrie et in archiepiscopatibus Duracensi, Antibarensi, Ragusino” etc., litteras suas ordini praedicatorum “in regno Ungarie et provincia Sclavonie” super inquisitione contra haereticos Bosnenses concessas revocat». Cfr. Acta et diplomata, cit., p. 215, n. 724. 30 Thallòczy, I. A. Forschungen, p. 268 dice: «Zwischen 1240 -1370 entnahm die Kurie fast alle albanischen Prälaten diesen zwei Orden».31 Cfr. Martyrologium Franciscanum: «Quarto calendas Februarii. In Delmatia, Beati Michaëlis Albanensis, vitae austeritate et prodigiis spectabilis. “Septimo calendas Ianuarii; Berberiae in Dalmatia, Beati An-dreae Albanensis Confessoris, cuius santitatem quamplurima post mortem miracula declarant”. “Idibus Augusti: Tragurii in Dalmatia, Beati Ioannis a Bucca (Albanensis) Confe ssoris, vitae austeritate ac mira-culorum gratia illustris”. Decimo quarto kalendas Junii, Uriae, in Apulia, beati Francisci Dirrachini Laici et Confessoris, qui mira abstinentia et signis inclitus fuit».32 N.d.t.: «Goffridus O. Min. jam cons. a S.P. ». Cfr. euBel, Hierarchia catholica medii aevi, cit., 92.33 N.d.t.: «T. [Tiburtino] quo mortuo, Michael can. Catharen., el., prov…». Cfr. euBel, Hierarchia catho-lica medii aevi, cit., 92.34 N.d.t.: «Marinus, adiac. ips. eccl., el. prov. 1301-1307…Et renunt. Gregorii epi. Suacen. in aepum. Anbar. postul.». Cfr. euBel, Hierarchia catholica medii aevi, cit., 62 e n. 7.35 N.d.t.: «Antonius (1296, 1301), Petrus 1303, 1304…Apud Gams ad a. 1305-1318 alter Antonius (O.min.) recensetur, qui nobis idem esse videtur atque Antonius supradictus, nisi forte idem habendus est atque ille Antonius, qui a. 1349 succedit». Cfr. euBel, Hierarchia catholica medii aevi, cit., 232 e n. 3.36 N.d.t.: «Andreas O.min., lector in conventu Jadren…Jam cons. a.s.a.; antea capell. Belae IV et Stepha-ni V regum Hungariae fuisse dicitur». Cfr. euBel, Hierarchia catholica medii aevi, cit., 92 e n. 8.37 N.d.t.: manca in Eubel.38 Su questi vescovati vedi Schematismus almae Provinciae Mis sionariae Albaniae 1908, p. 21, eccetto per Bonaventura, vescovo di Arban, e Francesco vescovo di Valona, dei quali non ne parla proprio. Di loro parla Thallòczy (AAlb) nel v. I, p. 87, n. 301; del secondo nel v.I, p. 194, n. 644. Thallòczy differisce da Schematismus. Secondo lui Pietro Tiburtino era vescovo di Sarda e non arcivescovo di Antivari (v.I, p. 72, n. 249) e Martino, arcivescovo di Antivari, lo chiama Marin (v.I, p.163, n. 533, 534). [N.d.t. ma nn. 553, 554. L’autore non segnala sullo stesso argomento il n. 531 a p. 157 che parla appunto di Marin e che qui riportiamo]. N.d.t.: «(1273) 18 mai. Apud Urbem Veterem. Carolus I. rex ballivo Andegavensi mandat, ut fratri Bonaventurae,
L’insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940
164
Gli storici dell’ordine francescano: Wadding, Gonzaga, De Gubernatis, Civezza, Fabianich, Holzapfel ecc., sono del parere che i frati si insediarono in Albania sin dalla nascita dell’Ordine. L’ultimo citato, Holzapfel, dice che «si trovavano lì almeno dal 1240»39.In realtà, se sappiamo con certezza della loro esistenza attorno all’Albania, intendo
neocreato episcopop Albanensi ad sedem apostolicam profecturo, equitaturas offerat. Pro frate Bonaventura. Scrip-tum est ballivo in Andegavia et decano Sancti Martiri Andegavensi. Cum Cum nos de promozione venerabilis patris fratris B(onaventure), quondam generalis ministri ordinis Minorum in episcopum Albanensem electi ingenti repleti gaudio nostras super hoc ei licteras dirigamus eius ad apostolicam sedem celerem expectantes adventum, - volumus et districte vobis precipimus, quatenus, sicut nostram caram habetis graciam, statim receptis presenti bus ex parte nostra nostra equitaturas ac expensas omnes necessarias ad iter ipsius sibi offerre gratanter et honorifice, si eas receperit, ministrare curati nullam in hiis commissuri negligenciam vel defectum, sicut indignacionem nostram cupitis evitare. Datum aput Urbem Veteram per eundem Johannem XVIII madii prime indictionis. Reg. Ang. (1269) fol. 64…». Cfr. Acta et diplomata, cit., p. 87, n. 301. N.d.t.: «1319. 13. aprilis Neapoli. Licentia datur Francisco episcopo Avellonensi ex Apulia CC salmas frumenti ad portum S. Flaviani extrahendi. Pro episcopo AvellonenseKarolus illustris Jerusalem et Sicilie regis Roberti primogenitus, dux Calabriae ac eius vicarius generalis magistris portulanis Apulie devotis nostris salutem et dileccionem sinceram. Scire vos volumus, quod nos ad supplicis petitionis instanciam venerabilis in Christo patris, fratris Francisci de ordine fratrum Minorum, episcopi Avelonensis devoti nostri noviter nobis facte et provise duximus concedendum, quod extrahi facere possiti de portu Manfridonie salmas frumenti ducentas ad generalem regni men-suram de thuminis scilicet octo per salmam, quos de fructibus et redditibus cuiusdam tenimenti siti in Apulie partibus sibi provenisse asseruit ad portum sancti Flaviani libere devehendas. Quam ob rem volumus et devocioni vestre vicariatus qua fungimur auctoritate mandamus, quatenus nuncium dicti episcopi presentes vobis licteras acisgnantem (!) extrahere seu extrahi facere de dicto portu Manfri-donie predictas salmas frumenti ducentas ad dictam generalem regni mensuram ferendas per mare ad prenominatum portum sancti Flaviani cum barcis parvis a centum salmis infra capacibus libere a iure quolibet extiture et tareni atque dohane, siquid de predictis fructibus et redditibus frumentum huiusmodi ut predicitur provenit, eidem iuxta tenorem regii capituli super hoc editi sine contradic-cionem aliqua permittatis. Recepta prius per vos ab extrahente seu extrahentibus frumentum ipsum ydonea fideiussoria caucione, quod illud non alio quam ad dictum portum Sancti Flaviani vehatur quodque de exoneracione ipsius inibi facienda ab archipresbitero et portolanis dicte terre Sancti Fla-viani nec non a mercatoribus de Bardorum, Peruciorum, Aczarellorum societatibus de Florencia vel statutis eorum in partibus Aprutinis morantibus infra mensem unum a die extraccionis ipsius in antea numerandum idonea vobis deferant sive mictant litteras responsales (aliis ommissis). Datum Neapoli in [camera nostra] anno Domini M°CCCXVIIII° die XIII° aprilis II° indictionis regnorum dicti domini patris nostris anno X°. Reg. Ang. 223 (1319 C), fol. 439 v.». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 194, n. 644.N.d.t.: «(1303) 18. novembris. Laterani. Benedictus XI. papa Marino archiepiscopo Antibarensi com-mittit, ut corriget et reformet ecclesiasticos et religiosos homines, qui omni disciplina contempta vitiis et sceleribus diffluunt «in Arbano, Polato, Canavia, Duratio, Cataro, Dulcigno, Suatio, Scodro, Driva-sto, Antibaro et quibusdam aliis locis sub dominio Andronici imperatoris Grecorum ac Orosii regis Servie et fratris eius S(tephani) nec non carissime in Christo filie Elene matris eorum regine Servie illustris positis». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 163, n. 554. 39 «Minoritae primum in Albania et Montenegro laborasse videntur; inveniuntur saltem ibi iam anno 1240». Cap. IV, § 49, p. 218.
P. Marin Sirdani O. F. M.
165
dire in Dalmazia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Grecia e perfino in Romania, e tenendo conto anche della distanza dall’Italia, anche se non avessimo avuto nessun’altra prova storica, non ci sarebbe stata ragione di dubitare della loro presenza nel nostro paese in quei tempi. Da quanto detto si prova la presenza dei francescani in Albania sin dalle origini dell’Ordine, ma non è ancora del tutto chiaro come si insediarono nella nostra terra. Sembrerebbe che per un po’ di tempo, come del resto era successo anche in altre zone, i francescani, dove più dove meno, compresa l’Albania, abitarono in case private lasciate dai benefattori, e solo successivamente, constatando il bisogno del posto e accorgendosi della speranza che il popolo albanese poneva sempre di più in loro, negli anni, insieme a dei benefattori, si misero a costruire conventi e chiese per loro stessi. Affermiamo ciò in considerazione del fatto che anche nel periodo in cui troviamo i francescani che si affaticano per rinnovare la vita sociale in Albania, essi non sono menzionati da nessuna parte come comunità. Il documento più antico trovato fino ad oggi è quello del 1283, in cui per mezzo di una legazione pontificia si menzionano le abitazioni dei francescani a Cattaro, Antivari, Dulcigno e Durazzo: «Desa uxor condam Tollisclavii de Pracovizio... cuilibet loco fratrum Minorum custodie Ragusine videlicet Cata ri, Antibari, Ulcinii et Dyrachii, hyperpera tria legat»40.Sempre in un documento del 18 gennaio 1284, intendo dire un anno dopo, vengono menzionate le abitazioni dei francescani come scritte sopra «[y]perperi quinque pro quolibet loco»41. Con ciò si dimostra storicamente che tra il 1283-1284 i francescani si erano insediati a Cattaro, Antivari, Dulcigno e Durazzo. Pochi anni dopo, nel 1288, Elena, regina di Serbia, insieme alla sorella Maria de Chau, costruirono per i francescani la chiesa e il convento di Santa Maria a Scutari e il convento di San Marco a Dulcigno: «Helena, Regina Serbiae (una cum sorore sua Maria de Chau) templum et coenobium S. Mariae in urbe Scodrensi et Monasterium S. Marci de Dulcinio a se exstructa fratribus ordinis S. Francisci ab Observantia nuncupatis habitanda et possidenda tradit»42.
40 Thallóczy, A Alb, v.I, p.144, n. 479. N.d.t.: «(1283) 25. Novembris. Ragusii. “Desa uxor condam Tollisclavi de Pracovizio” (inter alia) cuili-bet loco fratrum Minorum custodie Ragusine vide licet Catari, Antibari, Ulcinii et Dyrachii hyperpera tria legat». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 144, n. 479.41 Lo stesso come sopra, in nota.N.d.t.: «hoc loco aliud quoque testamentum adducimus muliebri cuiusdam Ragusine a. 1284, 18. Ia-nuarii, in quo “per loca fratrum Minorum videlicet Catari, Antibari, Ulcinii et Dyrachii yperperi quin-que pro quolibet loco”, fratribus autem Minorum de Ragusio 20 hyperpera legantur. (Diversa canc. Smičklas VI, 462, n. 385 et 465 n. 387)». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 144, n. 479 (in nota).42 Lo stesso come sopra p. 151, n. 509.
L’insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940
166
Da quel codice che si conserva a Cattaro si testimonia che contemporaneamente ai due suddetti concili furono costruiti un convento a Cattaro e un altro ad Antivari: «Factum fuit anno 1288 [n.d.t. ma MCCLXXXVIII] monasterium Sanctae Mariae in Scutari [n.d.t. ma in Scutaro], et monasterium Sancti Francisci de Antibaro, et monasterium Sancti Francisci de Catharo [n.d.t. ma et monasterium Sancti Francisci de Catharo, et monasterium Sancti Francisci de Antibaro] et monasterium Sanctae Mariae de Dulcigno per Dominam Mariam de domo Chiutiz de Francia, Reginam de Zenta, hoc est Myssiae inferioris in partibus Albaniae. Quae regina iacet sepulta in templo S. Mariae (al. S. Marci) de Dulcigno coram altare maiore sub pavimento cum Anselmo eius filio»43.Per quanto riguarda il convento di Antivari nell’opera di Mauro Orbini (Storia degli Slavi) troviamo queste parole: «Helena Regina extrui iussit in suburbio Antibari, Coenobium sancti Francisci, et rebus omnibus necessariis, instruc tum Fratribus Franciscanis donavit».La costruzione di questi conventi c’è chi l’attribuisce a Elena, moglie di Stefano Uroš I (1280-1307), chi a sua sorella Maria de Chau che per molti anni visse a Dulcigno dove lì morì e fu sepolta44. Questi conventi sono spesso menzionati nelle fonti fino al tempo in cui quei luoghi non vengono conquistati dal Turco. Sappiamo pochissimo invece sugli altri conventi costruiti nell’entroterra dell’Albania. Gli autori antichi parlano dell’attività dei francescani all’interno dell’Albania, ma oltre al convento di Alessio45, non menzionano nessun altro. Dicono solo che i conventi sopra menzionati dal loro insediamento fino al 1402, furono sotto la custodia di Ragusa46, e successivamente si collocano all’interno di una Custodia indipendente di nome «Custodia Dyra china». Invece i conventi costruiti nell’entroterra si inserirono all’interno di una provincia indipendente chiamata «Pro vincia Macedoniae»47, all’interno della quale nel 1484 confluirono anche quelle della Custodia di Durazzo. Non si sa con certezza quando si divisero dalle provincie di Romania e di Grecia, con le quali erano unite prima di convergere in una provincia indipendente. Si sa solo che con l’invasione turca, essendo superstiti solo quattro conventi, questa provincia si trasformò in custodia
43 Thallóczy, A Alb, v.I,, p. 151, n. 509, in nota.44Secondo Thallòczy, A Alb, si potrebbe trattare di tempi più recenti, tenendo conto della tomba di Maria e dei figli. I successori hanno attribuito a lei la costruzione delle chiese, che forse sostenevano la sorella Elena (sic). Su quest’ultima non ci sono dubbi riguardo alle sue opere di devozione. (Helenam reginam uxorem Stephani Uros I... donationes pias fecisse quam plurime satis aperte constat). Un esempio di queste costruzioni è anche la chiesa di Shirq sulle coste del fiume Buena, la cui grandezza si può contemplare ancora oggi. Essa presenta anche un’iscrizione sulla porta centrale con la data 1290.45Greiderer, Lib. II, T.I. n. 55.46 Thallòczy, A Alb, v.Il, p. 215, n. 280, I A. Forschungen, vedi anche le legazioni che abbiamo citato sopra nella p. 712. N.d.t.: «(1272) 28. augusti. Apud Montem Fortem. (Carolus I rex Siciliae) castellano castri Aversae mandat, ut “sex obisdes de partibus Albanie, qui fuerunt in nostra curia usque modo” custodiendos accipiat. Reg. Ang. 17 (1275 XV ind.) fol. 15». Cfr. Acta et Diplomata, cit., p. 80, n. 280.47 Gonzaga, pp. 623 - 624.
P. Marin Sirdani O. F. M.
167
(Custodia Albaniae)48. Vorremmo sottolineare che la ragione per cui nei conventi litorali sono state conservate molte iscrizioni, al contrario di quelli dell’entroterra, si trova nei rapporti più frequenti con gli stranieri. Infatti, questi conventi, per più di un secolo risultarono sotto la Custodia di Ragusa. Quelli dell’entroterra, invece, non avendo continui rapporti con gli stranieri ed essendo indipendenti, con l’arrivo del Turco, scomparvero insieme agli archivi privati e statali, e così anche il ricordo di quei tempi. La verità è che erano rimasti ignoti in altri conventi anche quei documenti sopravvissuti nel nostro paese. Una volta che i francescani si erano stabiliti nei territori albanesi, il loro numero si incrementò sempre di più, tanto che, non solo i conventi dell’Albania, ma anche quelli della Dalmazia e della Puglia, si erano riempiti di francescani albanesi. Parlando di Ragusa, Dr. M. Sufflay, nella sua opera «Forschungen» dice che sin dal 1340 era piena di sacerdoti, di frati domenicani e francescani albanesi49.Per poter elencare i nomi di tutti i conventi francescani, che nei tempi sono stati costruiti dappertutto in Albania, ci rifacciamo al documento più antico che parla di loro direttamente. Si tratta del «Registro provinciale di Lezha» redatto nel 1720 da P. Lorenzo Maria di Santa Croce50. In questo registro troviamo i nomi dei conventi come segue: 1. Alessio, Santa Maria, la Natività *51
2. Veglia, S. Salvatore3. Rubigo, S. Salvatore*4. Corbino, S. Veneranda*5. Laçi - Sebaste, Nostra Signora Annunziata6. Priska, San Andrea7. Troshan, Assunzione della Nostra Signora*8. Kaçinár, Santa Maria9. Bisht -Muzhel (Capo Rodoni), S. Maria Assunta52
48 Lo stesso come sopra.49 Thallòczy, I A. Forschungen I, p. 266.50 Questo registro è conservato nel nostro archivio provinciale. Dato che fino ad oggi, da quello che sappiamo, la nota che segue non è stata mai pubblicata nella forma integrale e originale, ci sembra corretto riportarla ad litteram: «In tempi più felici fu anche ella più fertile di Conventi, ma dopo la fatale morte del valorosissimo, ed invittissimo Principe Giorgio Castriotto detto Schanderbech, cadute que-ste Province in mano de’ Principi Ottomani, rimase la maggiore e miglior parte de’ Conventi destrutta, abbruciata, e abbandonata da’ Religiosi per sottrarsi dalle insoffribili furibonde persecusioni de’ nuovi Conquistatori. Tuttavia anco sotto il presente Dominio ne’ tempi a noi non tanto lontani fu più nume-rosa di Conventi, di quello si trova presentemente, come potrà osservarsi dalla serie che ho trovato, e che qui sotto si trascrive, affinchè s’abbia notizia de’ Conventi, che prima che le presenti calamità inondassero più validamente il Paese, erano da’ nostri Religiosi tenuti; e doppo si pone la nota de’ soli quattro, che presentemente sono in piedi, e che attualmente vengono da’ Religiosi abitati».51L’asterisco segna dove il sito sì è conservato meglio o peggio.52«Chi vorrà aver più distinta notizia di tutti gli Conventi che appartengono a questa Provincia prima
L’insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940
168
10. Durrës, S. Maria degli Angeli11. Croia, S. Maria12. Ulqin, S. Giovanni13. Nderfandena, S. Maria, la Natività14. Brosca, S. Lucia15. Scuttari, S. Maria16. Cheraba, S. Salvatore17. Antivari, S. Antonio18. Bretesta (?), S. Salvatore19. Martanesh (Macedonia), S. Martino20. Mirdita (Orosh), S. Alessandro* 21. Kallmet, S.Eufemia* 22. Nenshat (Sarda), S. Michele*23. Bria, S. Pellegrino24. Dervendo, S. Maria*25. Mret (paese nei dintorni di Croia), S. Maria 26. Malagi (nei dintorni di Elbasan), S. Barbara27. Suteri, S. N.N.
dell’invasione, come di quelli parimente ch’è convenuto abbandonare dopo essersi tenuti anco in tem-po del presente Governo, sarà necessario ricorra alle Croniche, ed Annali antichi dell’ Ordine, o agli archivi di Roma, non avendo io potuto trovare di ciò qua alcuna precisa notizia non ostante le molte diligenze da me con tutta attenzion praticate, forse perchè le scritture antiche della Provincia saranno state disperse ne’ vari e diversi saccheggi, ai quali più volte hanno dovuto soccombere gli nostri com-battuti Conventi.Serie de’ Conventi che per qualche tempo anco doppo l’invasione degl’ Ottomani si sono tenuti in questa Osservante Provincia di Albania. Alessio, S. Maria, la Natività (?); Veglia, S. Salvatore; Rubigo, S. Salvatore; Corbino, S.Veneranda; Seba-ste, S. Maria, La Nunciata; Prisca, S. Andrea; Trosciani, S. Maria; Caccinari, S. Maria; Capo Rodoni, S. Maria; l’Assunta; Durazzo, S. Maria degli Angeli; Croia, S. Maria; Dulcigno, S.Giovani; Nderfandena, S. Maria, La Natività; Brosca, S. Lucia; Scuttari; S. Maria; Cheraba, S. Salvatore; Antivari, S. Bretesta, S. Salvatore; Sopra Macedonia, S. Martino; Miridita, S. Alessandro; Calametti, S. Eufemia.I soprascritti Conventi alcuni sono in piedi, de’ quali cinque tenuti anco al presente da’ nostri Religiosi; ed alcuni altri tenuti da diversi Sigri. Paroci del Clero secolare, e due servono di Residenza ai due Mon-sigri. Illu.mi Prelati essendo gli rimanenti, a affatto destrutti, o almeno deserti. Gli cingue che sono al presente in potere de’ Frati sono gli seguenti, cioé: Alessio, S. Maria; Rubigo S. Salvatore; Sebaste, S. Maria; Capo Radoni, S. Maria; Trosciani, S. Maria.Altri de’ Conventi antichi di questa Provincia de’ quali ha ricavata con qualche stento la notizia il F.M. ... Michelangelo di Masnaga nel varij giri, da lui fatti... Albania; Sapa, S. Michele; Bria, S. Pellegrino; Dervendi, S. Maria; Mreti, S. Maria villa abitata ora da Turchi vicino a Croia; Malaghia, S. Barbara sopra Elbassano; Scuteer S... sopra Tirana, ove erano molti ulivi fruttiferi...Nella Macedonia detta ora Matia vi erano 12 Conventi, e se si faranno altre diligenze, si faranno anche altre scuoperte».
P. Marin Sirdani O. F. M.
169
Oltre a questi, si legge nel registro menzionato, ci furono anche molti altri conventi, ma col tempo sono caduti in oblio. In diverse opere di altri autori ci imbattiamo di nuovo in alcuni nomi di conventi che mancano nel registro di Alessio. Essi sono:
28. Bogonian (Bokjani), S. Barbara29. Durazzo, S. Nicola30. Bellenian (Blàjë ?), S. Illia 31. Binet (?), S. Maria32. Tamade (nella regione di Elbasan), S. Marco33. Gjonem (Kurbi), S. Giovanni34. Kavagne (Kavajë ?), S. Clara 35. Ocrida, S. Giorgio36. Preveza, S. Maria delle Grazie 37. Memeli (Mamli) S. Pietro53.
Un numero davvero impressionante questo dei conventi francescani in Albania che ci fa vedere in modo più chiaro la vastità della loro opera in quei tempi beati e la grande speranza che il popolo albanese poneva in loro. Quello che colpisce di questi conventi è il loro santo patrono, che non risulta sempre lo stesso. Potremmo dire che questa complessità si spiega in due modi: forse nel corso del tempo davvero cambiava il santo patrono, oppure, i conventi venivano chiamati dal popolo con il nome del santo a cui più erano devoti, e i cronisti li trascrivevano erroneamente. Affermiamo questo perché altrimenti il numero dei conventi si sarebbe incrementato di più a quanto pare. Con ciò non vorremmo dichiarare che in qualche centro potesse esistere più di un convento francescano. Possiamo confermare, probabilmente, che Antivari e Durazzo ebbero rispettivamente due conventi. Secondo il codice di Cattaro e di Mauro Orbino, come abbiamo ricordato in precedenza, dal 1288 i francescani avevano il convento di San Francesco (monasterium S. Francisci); Wadding (Annales Ord. Frat. Min.) nel 1399 (T.IX, n. 38), 1453 (TAL n. 47), 1577 (T.XI, 29) [sic.] ci menziona il convento di San Nicola (conventus S.Nicolai); così lo chiama anche papa Gregorio XII, in una lettera che inviava al guardiano di quel convento54. Vorrei aggiungere che questo convento si ergeva fuori dalle mura della città, come dimostra anche Thallòczy (domus S. Nicolai extra muros civitatis Antibarensis ordinis fratrum Minorum). Per quanto riguarda Durazzo, sappiamo con certezza che
53 Questo convento a «Memelij», il Gonzaga, p. 624, lo riconosce come uno dei cinque conventi che erano rimasti ai francescani in Albania nel 1592.54 Fabianich, k.XII, p. 257.
L’insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940
170
i francescani possedevano all’interno della città «Coenobium S. Mariae Angelorum»55 e un altro, (Coenobium S. Francisci)56, su di un colle57. All’interno di uno di questi conventi era conservato lo statuto della città (cap itula triginta quinque statutorum suorum reperta apud fratres s. Francisci)58.«Durante i secoli XIV-XV, la mancanza di sacerdoti del posto a Ragusa - dice Jirecek59
55 Orbis Seraphicus, I, II, p. 413.56 Thallòczy, A Alb, v.II, p.171, n. 275.57 Su questi conventi Fabianich (k.XII, p. 270) così si esprime: «Il convento di Durazzo eretto sopra uno di que’ deliziosi poggi che alla città fanno meravigliosa corona, tenuto per santuario e rifugio de navigatori... l’altro dentro le mura di questa città dai primordi del serafico istituto; quello di Antivari, che ramentava le pie opere di Elena de Valois: conventi più che provinciali ragguardevoli nell’orbe cattolico». N.d.t.: la nota virgolettata è in italiano.58 Thallòczy, A Alb, v.II, p.171, n. 610, Lo stesso in I A. Forschungen, 1, p. 280, scrive: «In Durazzo wurde 1398 das städtische Originalstatut bei den Franziskaner (apud fratres S. Francisci) bewahrt».59 «In Ragusa wird im XIV und XV Jahrh. sogar ein Mangel einheimischen Klerikern bemerkbar, in Klöstern und Kirchen begegnen wir deshalb zahreichen Priestern und Mönchen aus den katholischen Nordalbanien» A Alb. v. I p.199, n. 659).N.d.t.: «1320 27. ianuarii. Capuae. Carolus vicarius regni Siciliae iustitiariis Ydronti et Bari mandat, ut pro com-pensatione damni iudici Eustasio a Dyrrhachiensibus illati res Dyrrhanchiensium confiscent. Pro iudice Eustasio Sarraceno.Karolus etc. iusticiario terre Ydronti et capitaneo terre Bari presentibus et futuris regiis fidelibus atque suis salutem etc. Iudex Eustasius Saracenus de Matera (!) iuris peritus paternus fidelis et noster sua exhibita nobis peticione monstravit, quod dum ipse per spectabilem virum dominum Philippum Tarentinum principem patruum nostrum carissimum creatus iudex in civitate Duracii ad eandem civitatem cum pecunia libris vasis argenteis et suppelectilibus suis aliis personaliter se contulisset, homines dicte terre contra reverendum dominum genitorem nostrum et dictum principem spiritu rebelionis assumpto se detestabiliter rebellarunt et fideles quoslibet regios existentes ibi hostiliter (!) persequendo exponentem ipsum disrobaverunt auferentes eidem pecuniam libros vasa argentea et res mobiles alias valentes auri uncias sexaginta; propter quod dictus supplicans habens ad excellenciam nostram inde recursum provisionis nostre suffragium humiliter imploravit. Nos autem volentes sibi in premissis oportune prospicere quamquam ubi esset eidem exponenti tuta facultas adeundi universitatem predicte terre Duracii et rectorem ipsius prefati rector et homines universitatis eiusdem, ut resarcirent seu resarciri facerent dampna et ablata restitui exponenti iam dicto, forent racionabiliter per nostras licteras requirendi et in eorum contumacia vel neglectu contra ipsos per nos represalie concedende, - quia tamen regiis nostrisque fidelibus quos hostes reputant ad dictam terram adcedere non est tutum, volumus et fidelitati vestre vicariatus qua fungimur auctoritate presencium tenore commictimus et mandamus quatenus vos ad quos presentes pervenerint de disrobacione ipsa summaria fide sumpta bona omnia hominum dicte terre Duracii, que in iurisdicione vestra nunc vel successive postmodum inveniri continget, capi et deponi penes aliquem virum idoneum bonorum curatorem ad hoc per vos prestitum faciatis, qui bona ipsa facto ex eis inventario puplico distinguente ipsa particulariter et distincte manuteneat et conservet; et deinde constito vobis de prefatis rebus ablatis et exstimacione racionabili huiusmodi dampni data, dominis bonorum ipsorum huiusmodi coram vobis presentibus competenti termino per vos dato et aliis eciam hominibus dicte terre Duracii simili termino per edictorum proposicionesm in famosis locis eiusdem provincie stabilito ad restitui faciendum supplicanti predicto omnia sibi ut premictitur sic in debite seu violenter ablata expensas interesse et dampna alia, que idem supplicans propterea incurisse dignoscitur, - nisi vobis constiterit infra statutum terminum a vobis pro dicta satisfactione prefixum fore leso supplicanti predicto de
P. Marin Sirdani O. F. M.
171
- fu colmata con preti e frati provenienti dall’Albania del nord»; Dr. M. Sufflay60 aggiunge e scrive: «Durante l’anno della peste di cui abbiamo parlato, troviamo tanti sacerdoti albanesi a Ragusa, i conventi di questa città sono pieni di frati albanesi. Sia il guardiano sia il custode dei francescani di quel tempo erano di Scutari e il superiore dei domenicani era di Dulcigno». Nel 1385, provinciale dei francescani della Schiavonia era un albanese: «Fratre Minore de Duracio sac. theol. Mag.»61.Bisogna evidenziare anche un altro aspetto. La nostra scarsa conoscenza non è legata solo al tempo della costruzione dei conventi (eccetto il tempo dei pochi che abbiamo indicato sopra), ma ha a che fare anche con il periodo che i francescani furono in possesso e ne usufruirono. Di sicuro, alcuni di essi, come ad esempio Robigo, Orosh, Bogonian, Nderfandena e Corbino, furono prima di proprietà dei benedettini. Il convento di Capo Rodoni che nel 1324 lo troviamo dedicato a S. Anastasia, forse lo stesso che nel 1418 ci viene presentato con il nome S. Maria62, nel 1488 venne ceduto ai francescani63. Di questo convento si possono vedere il sito e la chiesa intera, ma in condizioni pietose, conosciuta dagli abitanti del luogo con il nome di «Chiesa di S. Antonio», che si attesta, come dice Thallòczy, come uno dei monumenti più belli del medioevo in Albania64. Ma tempi difficili si stavano disponendo per la provincia francescana d’Albania che allora fioriva così tanto. A causa di bande di barbari turche, che si erano scagliate
ipso dampno et violencia satisfactum, - vos per curatorem ipsum tamquam personam legitimam tantum de ipsis et aliis bonis huiusmodi dicte terre Duracii que ad manus vestras pervenerint, vendi quo meliori poteritis precio faciatis, quod usque ad quantitatem dictorum ablatorum et dampnorum ascendat; et precium quod inde perceptum fuerit sepedicto supplicanti usque ad ipsam concurrentem ut premictitur quantitatem iubeatis absque diminucione persolvi vel res ipsas in solutum dicto supplicanti racionabiliter assignari, ut exponens ipse ad nos venire propterea ulterius non gravetur. Actente proviso quod huiusmodi capcio et arrestacio bonorum et eorundem civium terre Durachii et districtus ipsius per vos auctoritate presencium facienda sic provise ac ordinate procedat, quod in aliquam usurpacionem non transeat et via prosecucionis iusticie comercium illicitum non producat. Presentibus post oportunam inspecionem earum remanentibus presentanti ad vestrum singulos efficaciter in antea valituris. Datum Capue per dominum Bartholomeum de Capua logothetam et prothonatarium regni Sicilie anno domini MCCCXX° die XXVII ianuarii III indictionis regnorum dicti domini patris nostri anno undecimo. Reg. Ang. 222 (1319 C), fol. 282v. Existebat etiam in Reg. Ang. Vol. deperdito 1319 D. fol. 162v.». Cfr. Acta et Diplomata, cit., pp. 199-200, n. 659.60 «In dem erwähnten Pestjahre, wo wir so viele albanische Pries ter in Ragusa antreffen, sind auch schon alle ragusi-nischen Klöster von albanischen Mönchen besetzt. Der Guardian und auch der Kustos des Minoriten klosters waren damals Scutariner, der Prior des Domenikanerklosters ein Dulcignote». (I. A. Froschungen, p. 266).61 Vedi il periodico franc. «Luce e amore» 1911, anno VIII, n. 7-8, p. 425.62 Thallòczy, A Alb, v. I. p. 207, n. 694.N.d.t.: «1324, 23. Ianuarii. Ragusii. Consilium rogatorum statuit, ut ambae naves communis “mittantur usque Durachium et a Durachio usque Sasnum” ad persequendum quoddam lignum piratarum, quod intravit culfum et quod dicitur visum fuisse apud s. Nastasiam a li Rodoni». Cfr. Acta et Diplomata, cit., pp. 207-208, n. 694.63 Theiner, Monumenta Slavorum, 1, 524 .64 Thallòczy, I. A. Forschungen, p. 281.
L’insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940
172
contro l’Albania, i domenicani, come avevano fatto prima di loro anche i benedettini e gli altri Ordini, uscirono dall’Albania; i francescani invece si insediarono in quei luoghi dove i cristiani si sentivano un po’ più liberi. «I francescani erano coloro, dice Thallóczy, che dopo l’invasione turca si impossessarono delle parrocchie e dei conventi abbandonati e spopolati dei benedettini; rimasero in guardia e rifugiati nel nord dell’Albania, anche quando su questo paese l’Europa non mostrò mai nessun interesse, e quando l’invasione turca faceva di tutto per distruggere ogni segno del cristianesimo, loro riuscirono a tenere viva la religione cattolica fino ai giorni nostri»65 . Nessuno potrebbe raccontare ciò che hanno dovuto subire e sopportare, per l’amore della fede e dell’umanità questi eroi di Cristo durante il dominio turco. Quanto sangue fu versato, quanto la Chiesa fu danneggiata, quanti conventi furono incendiati e quanto lavoro e fatica furono sprecati.Nonostante ciò, come nei primi secoli del cristianesimo, anche in Albania le persecuzioni dei turchi non furono sempre intense. I francescani che avevano in cuore il destino del popolo e che avevano completamente abbracciato la sua causa, cacciati da una parte, andavano in un’altra, spesso vestiti come la gente semplice, si vedevano ora in un luogo, ora in un altro, sempre tra la gente, persino nelle carceri; oppure pativano nelle montagne e nelle grotte per consolare e supportare, chissà, quanti fuggiaschi, attendendo lì che si calmassero un po’ le burrasche, per poi ritornare a riunirsi nei conventi danneggiati, che ricostruivano modestamente per non lasciarli nello squallore. Da qui si diffondevano dappertutto, con fatica e incuranti del pericolo si esercitavano a evangelizzare. Attraverso tale attività loro affrontavano l’apostasia che andava raccogliendo sempre più consenso. Sin dai tempi del p. Generale Francesco Gonzaga (1585) a loro era toccato di ricostruire cinque conventi dove si riunivano insieme a quaranta frati. Questi conventi erano quelli di Laç (Sebaste), Alessio, Rubigo, Memeli e quello di Capo Rodon66.Ma una vera provincia non esisteva più: accadde, come dice il p. Generale già ricordato sopra, che questa provincia nota si trasformasse in Custodia (Minoritica Macedoniensis Provincia tanta dignitate tantoque hono re excidens, in Custodia redigeretur), ma in ricordo della sua precedente dignità, era stata lasciata sotto la gestione e il dominio dello stesso p. Generale (in praeteritae dignitatis memoria)67 . Con tutte le disgrazie che i francescani dovettero subire dal Turco, dopo un po’ di anni, con fatica riuscirono a ricostruire altri quattro conventi, e allora nel Capitolo Generale redatto a Napoli nel 1592, troviamo la Custodia dell’Albania divenuta nuovamente Provincia. (ex Custodia Provincia proclamatur, cum omnibus juribus ac privilegiis
65 Gonzaga, De origine Saraphicae religionis Franciscanae, Vene tiis, 1603, p. 624. 66 Lo stesso come sopra. 67 Lo stesso come sopra.
P. Marin Sirdani O. F. M.
173
quibus antea gaudebat)68. I quattro nuovi conventi furono ricostruiti a Veglia, Mirdita (Orosh), Cheraba e a Corbino69. Monsignor Marin Bici nella relazione che presentò a papa Paolo V nel 1610 sulla visita apostolica che aveva effettuato in Albania, così si esprimeva sull’opera dei francescani di quel tempo: «…ora quei pochi preti che sono rimasti, non negano il loro servizio e operano dove possono, soprattutto con l’aiuto dei frati osservanti che possiedono in Albania undici conventi, nei quali non si trovano più di ottanta frati: tra di loro, ci sono alcuni che hanno studiato in Italia, provinciale dei quali era Fr. Giovanni Koleci di Croia, uomo intelligente e saggio. E questi sono gli unici che attraverso le prediche e l’esempio vanno fino dove possono, rispondendo ai bisogni, risolvendo conflitti, affrontando disordini e mantenendo viva la religione…»70.Nonostante tutta quest’opera dei preti e dei francescani del luogo, si sentiva fortemente la mancanza del clero perché non poteva in nessun modo sostenere i fedeli nei bisogni spirituali e fisici in un paese così indebolito. Il popolo, a volte per ignoranza, a volte per necessità o per interesse stava abbracciando in massa la fede dello stato. Per affrontare questo pericolo la Congregazione di Propaganda Fide si curò di inviare preti e frati missionari stranieri. De Gubernatis racconta che nel 1634, missionari francescani stranieri, erano entrati in Albania, scegliendo come campo d’azione soprattutto le alte montagne dell’Albania del nord71. In una statistica generale del cattolicesimo che D. Urbano Cerri, segretario della Congregazione della Propaganda nel 1677 inviava a papa Innocenzo XI, si esprime così sul tema in questione: «La congregazione ha mandato in quelle parrocchie molti sacerdoti laici con potere missionario e con aiuti annuali. Ha anche fondato una Missione di frati riformati che conta dodici sacerdoti, sparsi in quei territori, per amministrare i sacramenti a quei poveri cristiani, e oltre a questi missionari che dipendono direttamente dalla congregazione, sono sparsi in tre conventi frati osservanti con un provinciale»72 .Successivamente i missionari francescani allargarono il cerchio d’azione anche in Kossovo e in Macedonia e trattarono quattro prefetture apostoliche, che sono: Pult, Kastrat, e quella di Serbia (Kossovo) e Macedonia.
a) La Prefettura di Pult includeva l’intera diocesi nota con questo nome e aveva in quel tempo i centri operanti: Shala, Shosh, Toplana, Dushman, Plan, Nikaj e Mertur.
68 Lo stesso come sopra. 69 Starine Jugoslavenska Akademija Znanosti i umjetnosti Knjiga XX, u Zagrebu 1888, p. 50.70 Orbis Seraphicus, Historia de tribus Ordinibus, a Seraphico Patriarcha Francisco institutis, per Fratrem Domi-nicum de Gubernatis. Edit, ad Claras Aquas, Typ. Colleg. S. Bonaventurae, 1886: Tom. II, Lib. IV, p. 414.71 Orbis Seraphicus, Lib. IV, p. 414.72 Orbis Seraphicus. Lib. IV, p. 414 in nota.
L’insediamento dei Francescani nei diversi territori dell’Albania 1240-1940
174
b) La Prefettura di Kastrat era quella che includeva la zona montana di Scutari, intendo dire: Kastrat, Rashpa, Traboina, Bajza, Gruda, Selca e Vukel.
c) La Prefettura della Macedonia si estendeva nella diocesi di Durazzo e aveva tre centri operanti: Lura, Baz e Pishkah. Facevano parte di quella diocesi anche le parrocchie di Giannina e Preveza e nella diocesi di Alessio un ospizio a Pedhana (l’antica Basana).
d) La Prefettura della Serbia ossia del Kossovo, nell’arcidiocesi di Scopia, aveva la parrocchia di Zymb e il santuario di S. Antonio da Padova a Gjakova.
Nel 1832, con la supervisione della provincia albanese, a queste Prefetture fu aggiunta anche quella di Epiro, composta da frati noti come «Osservanti». Questa Prefettura includeva le parrocchie di Biza e Laç nell’arcidiocesi di Durazzo; Llesh e l’ospizio di Rubigo, nella diocesi di Alessio, e Troshan nella diocesi di Zadrima. Nel 1895 si era annessa a questa Prefettura la parrocchia di Peja, con cinquantadue comuni nell’arcidiocesi di Scopia. Così, in quell’anno, alla Prefettura di Epiro, si aggiungevano altre quattro parrocchie situate tra le montagne di Sapa, intendo dire: Iballja, Berisha, Fjerza e Dardha. Un anno dopo, confluiva in questa Prefettura anche la parrocchia di Gomsiqe, situata nell’abbazia di Mirdita. Bisogna aggiungere che nel 1861 i frati missionari riformati avevano un ospizio centrale a Gjuhadol (Scutari), e sempre nella stessa città, a Arra e Madhe, i frati osservanti sin dal 1887 ne avevano un altro73.
Questa suddivisione della Missione francescana in Albania in cinque Prefetture apostoliche permase fino al 1898, anno in cui la missione si congiungeva sotto un Commissario generale «Provincialis ad instar». Nel 1909 si ricostruiva nuovamente la Provincia Francescana in Albania e così la missione godeva di una nuova organizzazione.
Questa è in breve la storia nei secoli dell’insediamento e della diffusione dei francescani in diversi territori dell’Albania, i quali furono «pionieri del Cattolicesimo» come li chiama Dr. A. Hudal nella sua opera «Die Serbisch-Orthodoxe Nationalkirche» (Graz, 1902).
73 Nella Prefettura di Pult si erano successivamente aggiunte anche le parrocchie di Palc, Raja, Prêkal e di Currajve. Così come nella Prefettura della Serbia o del Kossovo, le parrocchie di Sllokuqan e Gllogjan, e in quella di Kastratit e di Vuksanlekajvet. In mancanza del clero secolare i francescani servirono temporaneamente di più nelle parrocchie dell’Albania e del Montenegro.
P. Marin Sirdani O. F. M.