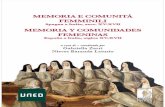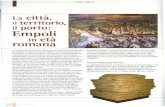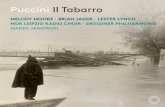I conventi francescani a Piazza Armerina: architettura e trasformazione
Il complesso mondo delle donne. Indagine sugli insediamenti "francescani" femminili nelle Marche...
Transcript of Il complesso mondo delle donne. Indagine sugli insediamenti "francescani" femminili nelle Marche...
FranciscanaBollettino della
Società internazionale di studi francescani
XIV2012
FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDISULL’ALTO MEDIOEVO
SPOLETO
INDICE
ALFONSO MARINI, Storia contestata: Francesco d’Assi-si e l’Islam ............................................................ pag. 1
ALEKSANDER HOROWSKI, Sermoni su san Francescodel ms. C.41.sup. dell’Ambrosiana e le loro fonti » 55
FRANCESCA BARTOLACCI, Il complesso mondo delledonne. Indagine sugli insediamenti “francesca-ni” femminili nelle Marche durante il pontifica-to di Gregorio IX .................................................. » 121
EMORE PAOLI, Venanzio da Fabriano e la costruzionedella memoria agiografica di Giacomo dellaMarca: una questione preliminare ..................... » 151
SEAN L. FIELD, A Newly Discovered Copy of theColumbinus Prophecy in Saint-Omer MS 283 .. » 187
PIETRO MOCCIARO, La penna del santo: l’edizione deiB. P. Francisci Opuscula di Luke Wadding(1623) ................................................................... » 205
ENZHE DUSAEVA, San Francis of Assisi in the Russianscholastic tradition of 19th-21st centuries ........... » 255
ANTONIO RIGON, Gli studi francescani di un “nonfrancescanista” .................................................... » 273
INDICEVI
BOLLETTINO
CRONACHE
Seminario di formazione in Storia religiosa e Studifrancescani (secoli XIII-XV) (Assisi, 26 giugno-6luglio 2012) (Marcello Proietto) .......................... pag. 287
I frati osservanti e la società in Italia nel secolo XV(Assisi, 11 ottobre - Perugia, 13 ottobre 2012)(Sara Fasoli) ........................................................ » 293
I Monti di Pietà di Perugia (1462) e Assisi (1468)(Assisi, ottobre 2012) (Paola Monacchia) ...........
» 305
INDICE DEI NOMI a cura di FRANCESCO DOLCIAMI ............. » 311
FRANCESCA BARTOLACCI
Il complesso mondo delle donne.Indagine sugli insediamenti “francescani”
femminili nelle Marchedurante il pontificato di Gregorio IX
All’interno del “movimento religioso femminile” che attra-versa l’Europa tra XII e XIII secolo (pur con tutti i limiti che iltermine, coniato da Herbert Grundmann 1, possiede, non ulti-mo un certo anacronismo che tende a dare al “movimento” al-cuni caratteri di uniformità che invece non gli appartengo-no 2) può a buon diritto essere inserito il “francescanesimofemminile” delle origini in tutte le sue declinazioni 3. Una in-
1 H. GRUNDMANN, Movimenti religiosi nel Medioevo. Ricerche sui nessi stori-ci tra l’eresia, gli Ordini mendicanti e il movimento religioso femminile nel XIIe XIII secolo e sui presupposti storici della mistica tedesca, Bologna, 1980 (2aedizione). Ringrazio sentitamente i direttori e il personale tutto degli Archividi Stato di Ascoli Piceno, Macerata e della Biblioteca comunale di Matelica.
2 M.P. ALBERZONI, Chiara di Assisi e il francescanesimo femminile, in Fran-cesco d’Assisi e il primo secolo di storia francescana, Torino, 1997, pp. 203-205.Ma si veda a questo proposito anche G. CASAGRANDE, La regola di Innocenzo IV,in Clara claris praeclara, Atti del Convegno Internazionale (Assisi, 20-22 no-vembre 2003), [= Convivium Assisiense 1, VI (2004)], pp. 71-82. Il saggio, conaggiornamenti bibliografici, compare ora in EAD., Intorno a Chiara. Il tempodella svolta: le compagne, i monasteri, la devozione, S. Maria degli Angeli-As-sisi, 2011, pp. 81-94, a cui si farà riferimento d’ora in poi.
3 Le tappe evolutive del francescanesimo femminile, con un rigoroso riferi-mento alla cronologia e alle istituzioni, sono in R. RUSCONI, L’espansione delfrancescanesimo femminile nel secolo XIII, in Movimento religioso femminile efrancescanesimo nel secolo XIII, Atti del VII Convegno internazionale (Assisi,11-13 ottobre 1979), Assisi, 1980, pp. 265-313, segnatamente alle pp. 268-270.
FRANCESCA BARTOLACCI122
dagine che abbia come oggetto le fondazioni riconducibili aquesto fenomeno deve necessariamente confrontarsi con alcuniostacoli 4 che derivano sia dalla appartenenza di tali comuni-tà femminili ad un contesto di rinnovamento spirituale nonancora sufficientemente indagato, sia dalle loro eterogeneemodalità costitutive – frutto di una lunga sperimentazione daparte delle Sede apostolica – ma anche da una lettura storio-graficamente orientata che ha spesso ricondotto alle originifrancescane insediamenti di altra natura.
Il “francescanesimo femminile” rientra infatti nell’ambitodel fluido e complesso mondo di mulieres religiosae 5 di cui ri-sulta poco agevole, almeno per parte del XIII secolo, definire iconfini di appartenenza, le eventuali regole professate e gliambiti ideali di riferimento dei singoli insediamenti ma chesembra avere come cifra comune l’attenzione ferma e costantedella Sede apostolica 6. In questa direzione vanno lette le tap-pe istituzionali che dal 1218 l’allora cardinale Ugo d’Ostia 7
segue in un progressivo, seppure progettualmente non compiu-tamente definito, tentativo di istituzionalizzare le novae reli-giones femminili provando ad unire alcuni insediamenti – le
4 Si veda a questo proposito RUSCONI, L’espansione del francescanesimofemminile cit., pp. 267-268.
5 A. BENVENUTI, La fortuna del movimento damianita in Italia (sec. XIII):propositi per un censimento da fare, in Chiara d’Assisi, Atti del XX Convegnodella Società internazionale di Studi Francescani (Assisi, 15-17 ottobre 1992),Spoleto, 1993, pp. 59-106; M.C. MARANO, Le clarisse nelle Marche. Gli insedia-menti del XIII secolo, in Collectanea Franciscana 67 (1997), pp. 105-166.
6 Si veda il recente M.P. ALBERZONI, La memoria delle origini nei monasteridi Clarisse, in Le origini e la loro immagine: momenti di storia del Francesca-nesimo nelle Marche, Atti del Convegno di Studi (Fabriano, Oratorio della Ca-rità, 24 ottobre 2009), a cura di F. BARTOLACCI [= Picenum seraphicum, XXVIII(2010)], pp. 99-126.
7 Da abbandonare la tradizionale dizione Ugolino, del resto mai presentenelle fonti: M.P. ALBERZONI, Dalla domus del cardinale d’Ostia alla curia diGregorio IX, in Gregorio IX e gli Ordini mendicanti, Atti del XXXVIII Conve-gno internazionale (Assisi, 7-9 ottobre 2010), Spoleto, 2011, pp.75-121.
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 123
cui dinamiche fondative erano cronologicamente e ‘program-maticamente’ dissimili – in un Ordine monastico direttamentecollegato alla Sede apostolica 8. I monasteri “ugoliniani”, lacui denominazione peculiare si va modificando nel tempo –transitando da un primitivo accento sulla paupertas ad uno,poi prevalente, sulla clausura 9 – già nell’atto di fondazionevengono provvisti di documento di esenzione dall’ordinario dio-cesano e seguono una forma vitae modellata sulla spiritualitàbenedettina e cistercense. Più incisivi e di segno marcatamen-te giuridico saranno gli interventi di Gregorio IX che intendo-no normalizzare monasteri « sorti in tempi diversi, con punti
8 Tale era l’indirizzo normalizzatore per le monache, ma anche per le don-ne appartenenti a comunità penitenziali, seguito, con scarso successo, già daInnocenzo III e poi da Onorio III: ALBERZONI, Chiara di Assisi cit., pp. 204-206e 211-213; EAD., Sorores Minores e autorità ecclesiastica fino al pontificato diUrbano IV, in Chiara e la diffusione delle Clarisse nel secolo XIII, Atti delConvegno di Studi in occasione dell’VIII centenario della nascita di santaChiara (Manduria, 14-15 dicembre 1994), a cura di G. ANDENNA e B. VETERE,Galatina, 1998, pp. 165-194, qui p. 167. Lo stesso saggio è raccolto in EAD., Lanascita di un’istituzione. L’Ordine di S. Damiano nel XIII secolo, Milano,1996, pp. 108-152.
9 Nel torno di un decennio dalla primitiva denominazione di religio paupe-rum dominarum e sorores pauperes, gradualmente diviene comune la defini-zione di sorores pauperes inclusae, pauperes moniales reclusae, per passare poiall’Ordo pauperum monialium reclusarum e all’Ordo Sancti Damiani, varia-zioni che costituiscono « un indice significativo della sperimentazione in atto »:M.P. ALBERZONI, Le Congregazioni monastiche:le Damianite, in Dove va la sto-riografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vi-ta monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio, Atti delConvegno internazionale (Brescia-Rodengo, 23-25 marzo 2000), a cura di G.ANDENNA, Milano, 2001, pp. 379-401, la citazione è a p. 393, n. 56. Sul presun-to tatticismo di Ugo d’Ostia che avrebbe inizialmente sposato la causa dellapaupertas delle fondazioni femminili solo per « inglobare all’interno delle isti-tuzioni ecclesiastiche questi fenomeni di vita religiosa spontanea » per poicambiare direzione subito dopo si veda RUSCONI, L’espansione del francescane-simo femminile cit., pp. 286-287. Riguardo l’influenza esercitata dai Cistercen-si su Ugo in questo ‘orientamento’ claustrale cfr. M. P. ALBERZONI, Chiara e ilpapato, Milano, 1995, pp. 47-48.
FRANCESCA BARTOLACCI124
di riferimento differenti, mentre il progetto ugoliniano-grego-riano andava definendosi » 10 e che tentano di collegarli con lacomunità di Chiara a S. Damiano, con cui fino a quel momen-to non vi erano stati punti di contatto istituzionale 11.
Solo in un secondo momento, e per tappe progressive, l’or-do monastico creato dal cardinale Ugo subirà un « processo difrancescanizzazione » 12, per altro non riuscendo ad esaurire erisolvere in sé tutti gli aspetti del “francescanesimo femmini-le”, ad ulteriore conferma della complessità di tale esperienzae dell’impossibilità di considerarla come un fenomeno unitariogià dalle sue origini 13. Rimangono fuori da questo ambito isti-tuzionale, almeno in una prima fase, gli altri aspetti del “fran-cescanesimo femminile” che si rifanno più direttamente alla fi-gura di Francesco e allo spirito pauperistico-penitenziale: lesorores Minores e la comunità di S. Damiano. L’istituzionaliz-zazione di questi “aspetti” del francescanesimo femminile nel-l’Ordo Sancti Damiani – le cui prime attestazioni risalgonoagli inizi degli anni Trenta del XIII secolo 14 – e, dal 1263, nel-l’Ordo sanctae Clarae, non fu un processo lineare e tantomenogovernato da semplici automatismi.
Il termine sorores Minores compare per la prima volta inuna lettera di Giacomo da Vitry del 1216 15: il passo, assai fa-
10 ALBERZONI, Chiara di Assisi cit., p. 222.11 Ibid., p. 213.12 I modi ed i tempi di tale processo sono illustrati in modo schematico ed
efficace in ALBERZONI, Le Congregazioni monastiche cit., pp. 379-401.13 ALBERZONI, Sorores Minores cit., p. 169. Per esemplificare questa tenden-
za storiografica significativo è il riferimento dell’autrice a GRATIEN DE PARIS, Hi-stoire de la fondation et de l’évolution de l’Ordre des Frères mineurs au XIIIsiècle, con aggiornamenti bibliografici a cura di MARIANO D’ALATRI e S. GIEBEN,Roma, 1982, pp. 593-596.
14 RUSCONI, L’espansione del francescanesimo femminile cit., p. 285, ma siconfronti con ALBERZONI, Chiara e il papato cit., p. 28, n. 39 e p. 69, n. 101.
15 Lettres de Jacques de Vitry (1160/1170-1240), évêque de Saint-Jean-d’A-cre, edizione critica a cura di R. B. C. HUYGENS, Leiden, 1960. Il rimando d’ob-bligo è ad ALBERZONI, Sorores Minores cit., pp.165-194, ma si veda anche O. VAN
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 125
moso, pone in rapporto speculare fratres e sorores Minores sot-tintendendo un legame tra le due realtà. L’impressione che sipuò ricavare dal testo è che la locuzione sorores Minores siauna reductio ad unum di un mondo poco definito, posta in unarelazione di equivalenza con una realtà maschile che, vicever-sa, in quegli anni si era già strutturata e possedeva un unico ericonosciuto centro di irradiazione 16. Maria Pia Alberzoni fanotare a questo proposito che se il termine fratres Minores ri-mane pressoché invariato nel tempo, proprio perché rispon-dente ad una realtà ben definita, lo stesso non accade con so-rores Minores 17. Tuttavia certa storiografia, anche in tempirelativamente recenti, ha identificato, per un processo di assi-milazione con l’Ordine maschile, le sorores Minores con le cla-risse attribuendone inoltre la fondazione alla stessa Chiara. Inrealtà queste prime comunità erano molto più vicine all’esem-pio di vita evangelica seguita da Francesco e dai suoi fratresda cui ricevevano anche assistenza, godendo con molta proba-bilità di un legame non istituzionalizzato con l’Ordine dei Mi-nori 18. La crescente fortuna delle sorores Minores è testimo-niata indirettamente dall’intervento di papa Gregorio IX nelfebbraio del 1241 contro quelle donne che, simulando nell’abitola loro appartenenza all’Ordine di S. Damiano, vivevano fuoridalla clausura. Il fenomeno evidentemente era di una portatatale da non poter più essere ignorato dalla Sede apostolica emostra un disagio da parte dell’Ordine dei frati Minori, o al-meno di una sua parte consistente, nei confronti di questedonne a cui i frati dovevano fornire la cura e che in qualche
ASSELDONK, Sorores minores e Chiara d’Assisi a San Damiano. Una scelta traclausura e lebbrosi?, in Collectanea Franciscana, 63 (1993), pp. 399-421.
16 ALBERZONI, Sorores Minores cit., pp. 168-169; A. BARTOLI LANGELI, I Peni-tenti a Spoleto nel Duecento, in Collectanea Franciscana, 43 (1973), pp. 303-330, ora anche in Esperienze religiose e opere assistenziali nei secoli XII e XIII,a cura di G. G. MERLO, Torino, 1987, pp. 163-192.
17 ALBERZONI, Sorores Minores cit., p. 169.18 Ibid., p. 178.
FRANCESCA BARTOLACCI126
modo usurpavano il loro nome. L’ambito non istituzionalizzatoin cui vivevano le sorores Minores rende comprensibile le diffi-coltà che si possono trovare nel ricostruire la storia degli inse-diamenti. Non esistono infatti documenti che comprovino lemodalità della loro fondazione se non nel caso di trasferimentoo chiusura delle comunità 19.
L’altra comunità di donne dotata una forte “autocoscienza”minoritica e che sentiva come vitale il legame con i frati Mino-ri era quella ubicata ad Assisi, presso S. Damiano 20. Il rap-porto tra Chiara d’Assisi, S. Damiano e il papato è già statoaffrontato 21, tuttavia sarà necessario ripercorrere le fasi fon-damentali della quaestio, privilegiando la riflessione su alcuneambiguità terminologiche che sono uno degli esiti di quel com-plesso rapporto.
Per Ugo d’Ostia, poi Gregorio IX, la comunità di S. Damia-no avrebbe dovuto rivestire un ruolo importante nel perfezio-namento dell’Ordo di sua creazione, costituendo l’unica comu-nità di donne a cui Francesco aveva promesso « curam diligen-tem et sollicitudinem specialem » 22. L’intenzione di Gregorioera infatti quella di legare il suo Ordo a quello dei frati Mino-ri, che ne avrebbero dovuto assumere la cura. Tale intentocoincideva solo in parte con gli orientamenti di Chiara e delle
19 Ibid., pp. 182-188.20 M. BARTOLI, Chiara d’Assisi, Roma, 1989, p. 121.21 Mi limito a citare alcuni fondamentali studi rinviando alla bibliografia in
essi contenuta: ALBERZONI, Chiara e il papato cit.; EAD, Chiara di Assisi cit.;EAD. Papato e nuovi Ordini religiosi femminili, in Il papato duecentesco e gliOrdini mendicanti, Atti del XXV Convegno internazionale (Assisi, 13-14 feb-braio 1998), Spoleto 1998, pp. 207-261; EAD, Chiara e San Damiano tra Ordi-ne minoritico e curia papale, in Clara claris praeclara cit., pp. 27-70. In unaprospettiva storiografica che privilegia « Clare of Assisi’s ambiguous positionin the development of female Franciscanism as an istitution » si veda L. S.KNOX, Creating Clare of Assisi. Female Franciscan identities in later MedievalItaly, Leiden-Boston, 2008, in particolare pp. 3-5 e 19-55.
22 Forma vivendi sanctae Clarae data, in Fontes Franciscani, a cura di E.MENESTÒ E S. BRUFANI, S. Maria degli Angeli-Assisi, 1995, p. 119.
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 127
sue consorelle di S. Damiano e la risultante fu, nel 1228, l’ac-coglimento della forma vitae del cardinale Ugo da parte dellacomunità 23, che tuttavia mantenne la peculiarità della pau-pertas e di un legame diretto e non limitato agli aspetti usualidella cura monialium con i Minori 24. Sebbene la fondazione dimonasteri ad opera delle compagne di Chiara sia certamentefenomeno da ridurre e sfumare in rapporto ad un’attenta ana-lisi documentaria 25, le decisioni del 1228 sanzionarono l’esi-stenza di « due diversi ambiti istituzionali » 26 che sono statidefiniti dalla storiografia più recente 27 rispettivamente “cla-riani” (o damianei) e damianiti, risolvendo una ambiguità ter-minologica – che è anche comprensione di una profonda diver-sità originaria del “francescanesimo femminile”, l’una in rap-porto con la volontà di Chiara, l’altra mediata dalla Sede apo-stolica. L’ambiguità originaria tra il monastero di S. Damianoe l’Ordine eponimo viene resa più profonda dalla nuova regoladi Innocenzo IV per le damianite (1247), che fa implicitamentederivare l’Ordine dalla volontà dello stesso Francesco 28 e an-
23 G. G. SBARAGLIA, Bullarium franciscanum romanorum pontificum, I, Ro-mae, 1759, pp. 242-244. Tale accoglimento viene definito formale in ALBERZONI,Chiara e il papato cit., p. 66.
24 Si tratta in sostanza del cosiddetto privilegium paupertatis concesso aChiara da papa Gregorio IX nel 1228. Cfr. ALBERZONI, Chiara e il papato cit.,pp. 59-80; EAD., Chiara di Assisi cit., pp. 216-218; nello stesso saggio si vedaanche l’evoluzione del monastero di Praga: ibid., pp. 220-221. Sui monasteri diMonteluce a Perugia e di Monticelli a Firenze in rapporto con il privilegiumpaupertatis vedi ALBERZONI, Le congregazioni monastiche cit., p. 394. Sul falsoprivilegium paupertatis attribuito ad Innocenzo III si veda W. MALECZEK, Das“Privilegium paupertatis” Innocenz’ III. und das Testament der Klara von As-sisi. Überlegungen zur Frage ihrer Echtheit, in Collectanea Franciscana, 65(1995), pp. 5-82.
25 RUSCONI, L’espansione del francescanesimo femminile cit., pp. 274-277.26 ALBERZONI, La memoria delle origini cit., p. 107.27 ALBERZONI, Chiara e il papato cit. pp. 28-29; CASAGRANDE, La regola di In-
nocenzo IV cit., pp. 82-83.28 SBARAGLIA, Bullarium franciscanum cit., I, pp. 476-483. Innocenzo IV
emana il 6 agosto 1247 una nuova regola in cui si sostituisce quella di san Be-
FRANCESCA BARTOLACCI128
cora, dopo la morte di Chiara, dalla nascita dell’Ordo SanctaeClarae (1263) 29, che assorbirà, normalizzandolo, il “complessomondo” del “francescanesimo femminile”.
Alla luce di quanto detto sarà dunque necessario rivedere idati tradizionali della storiografia francescana 30 relativi allefondazioni femminili, avvalendosi delle nuove acquisizioni sto-riografiche e documentarie, in modo da evitare confusioni e ri-sultati incerti 31. Da tempo e da più parti si è sentita a questoproposito l’esigenza di avere a disposizione un primo censi-mento complessivo 32, pur con la consapevolezza che le conclu-
nedetto, imposta da Ugo e poi da Gregorio IX ai nuovi monasteri femminili,con la regola di san Francesco. CASAGRANDE, La regola di Innocenzo IV cit., pp.87-90; un passaggio molto significativo della Chronica XXIV generalium ripor-ta che Filippo da Perugia, intendendo che fosse scritta per le monache dell’Or-do sanctae Clarae, attribuisce la composizione della regola per S. Damiano adUgo e Francesco congiuntamente. Ma la regola sarebbe riuscita « così rigidache il buon Ugolino, mentre la scriveva, avrebbe versato fiumi di lacrime perla compassione ». Nel De conformitate, Bartolomeo da Pisa sottintende che laregola data da Francesco a Chiara, dunque per S. Damiano, sia la stessa rego-la data da Urbano IV: ALBERZONI, La memoria delle origini cit., pp. 110-111.
29 SBARAGLIA, Bullarium franciscanum cit., II, Romae, 1761, p. 509.30 Tali dati vengono definiti « del tutto inutilizzabili e persino sospetti »:
RUSCONI, L’espansione del francescanesimo femminile cit., pp. 267-268. ALBERZO-NI, Chiara e il papato cit., pp. 15-17; a proposito della rappresentazione e au-torappresentazione del francescanesimo si vedano le osservazioni di A. RIGON,Il francescanesimo e le sue caratterizzazioni locali, in Le origini e la loro im-magine cit, pp. 11-13.
31 Il meritorio censimento di Maria Cristina Marano delle clarisse nelleMarche nel XIII secolo, per cui la stessa studiosa dice di essersi servita quasiesclusivamente di dati già disponibili nella storiografia precedente, non èesente da alcune critiche e i risultati devono essere usati con prudenza. MARA-NO, Le clarisse nelle Marche cit., pp. 105-166.
32 RUSCONI, L’espansione del francescanesimo femminile cit., pp. 310-313,che però mette in guardia da indagini metodologicamente troppo anguste senon poste in relazione con la vita religiosa femminile del XIII secolo; BENVENU-TI, La fortuna del movimento damianita, pp. 59-106 propone una dimensionedi « approfondimento locale e regionale »; MARANO, Le clarisse nelle Marche cit.;
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 129
sioni potrebbero essere « assai meno definitive di quanto avve-nuto per il primo Ordine » 33. Questa esigenza, tuttavia, è lon-tana dall’essere soddisfatta e non solamente per la mancanzadi rilevazioni complessive; piuttosto si impone una riflessionepreliminare, di natura metodologica, sulle modalità ed i limitidi un’operazione conoscitiva così tipizzante in un contesto ete-rogeneo. Non è un caso che indagini sugli insediamenti france-scani maschili abbiano avuto successo, giungendo a risultati“definitivi”: una forte autocoscienza e consapevolezza istituzio-nale hanno portato il “primo” Ordine ad avere una vera e pro-pria strategia insediativa, a pensare a se stesso in maniera or-ganizzata. I monasteri femminili, fatta forse eccezione per S.Damiano e per i pochi monasteri clariani, hanno minore possi-bilità di assumere un profilo identitario, essendo unificati intempi diversi in un Ordine papale, prescindendo dal francesca-nesimo – o dal non-francescanesimo – delle origini 34. Inoltre,se la questione dell’adozione della regola benedettina da partedelle comunità ugoliniane, su cui molta storiografia ha dibat-tuto, può essere considerata un problema superato 35, ben piùcomplessa, per un eventuale censimento, è la mobilità di alcu-ni monasteri che, come S. Giacomo di Colle Luce a Cingoli, in
LU. PELLEGRINI, Premessa, in I Francescani nelle Marche. Secoli XIII-XVI, a cu-ra di LU. PELLEGRINI E R. PACIOCCO, Cinisello Balsamo, 2000, pp. 9-11.
33 BENVENUTI, La fortuna del movimento damianita cit., p. 68. Il riferimentoè a LU. PELLEGRINI, Insediamenti francescani nell’Italia del Duecento, Roma,1984.
34 Sulla mancanza di “coscienza comune” di Ordo, almeno fino alla nascitadelle clarisse, si veda BENVENUTI, La fortuna del movimento damianita cit., p.70.
35 RUSCONI, L’espansione del francescanesimo femminile cit., p. 278. I termi-ni e la cronologia del dibattito sono in ALBERZONI, Le congregazioni monastichecit., in particolare alle pp. 379-385. La stessa autrice definisce i Bollandisti egli studiosi che difendevano strenuamente le origini francescane delle clarissevittime dei complessi disegni riformatori di Ugo-Gregorio IX e sottolinea chel’Ordo Sancti Damiani, considerato nella sua autonomia, ha una genesi bene-dettina. Ibid., p. 401.
FRANCESCA BARTOLACCI130
un preciso momento storico vengono definiti con la terminolo-gia ritenuta caratteristica dell’ambiente francescano, ma chenon seguiranno l’iter del passaggio all’Ordo Sanctae Clarae,divenendo invece di area benedettina a tutti gli effetti.
I dati relativi ai loci francescani femminili di inizio Due-cento, ricavati giustapponendo i risultati di una lunga tradi-zione storiografica interna all’Ordine, sono stati spesso posti aconfronto con la prima statistica fatta approntare nel 1316 dalcapitolo generale dei frati Minori a Napoli 36 relativa ai mona-steria Sanctae Clarae, riscontrando che tali dati discordano siaper numero di monasteri che per dislocazione geografica 37.Questo deve certo invitare a non servirsi pedissequamente deidati storiografici, ma anche a porre particolare attenzione allaquestione terminologica e alla dimensione temporale. Nelle Se-ries Capituli Neapolitani vengono infatti riportati i monasteriche nel 1316, dopo la spinta normalizzatrice della bolla BeataClara del 1263, potevano definirsi di clarisse a tutti gli effetti,ma non, evidentemente, quelli che non erano arrivati a questotraguardo pur essendo transitati in un determinato periodo inambiente francescano. La possibilità di un censimento degliinsediamenti femminili di area francescana nel XIII secolo de-ve dunque essere calibrata su questa molteplicità che coinvol-ge sorores pauperes, pauperes dominae inclusae o moniales or-dinis sancti Damiani in ogni possibile declinazione ed evolu-zione, non considerando questi termini come “approdi sicuri”ma come variabili di una realtà in fieri, almeno fino al 1263.
36 G. GOLUBOVICH, Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell’Orien-te francescano, II, Quaracchi, 1913, pp. 245-249.
37 BENVENUTI, La fortuna del movimento damianita cit., p. 71, che invita co-munque a prendere i dati storiografici con beneficio di inventario. Credo siainvece da respingere l’invito di Maria Cristina Marano a non prendere perbuoni i numeri della Series Neapolitana perché smentiti dall’evidenza delladocumentazione: MARANO, Le clarisse nelle Marche cit., pp. 160-161. Per la va-lidità della Series Neapolitana si veda RUSCONI, L’espansione del francescanesi-mo femminile cit., p. 270, n. 17.
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 131
A partire da questa consapevolezza si propone, nelle pagineseguenti, un primo contributo dedicato ai casi di alcuni mona-steri femminili delle Marche che, sorti nel torno di un decen-nio (tra il 1227 e il 1239 circa), sono stati censiti come “france-scani” nella più recente rilevazione di Maria Cristina Marano.Riprendendo il filo delle testimonianze documentarie e rive-dendo le linee di ricostruzione storiografica, sarà possibile mo-strare che per la gran parte di essi i percorsi sono ben piùcomplessi, diversificati nelle modalità fondative, nella loro evo-luzione e negli esiti.
« DOMINE VOLENTES MORARI IN CAPITE PLACZE INSULE »:S. GIACOMO DI COLLE LUCE A CINGOLI
Il primo caso è costituito dal monastero di S. Giacomo diColle Luce di Cingoli. Già dalla fine del XII secolo in questalocalità sono documentate donne che vivono negli ospedali ubi-cati presso le porte della cinta urbana e nel territorio circo-stante 38, ma la prima presenza legata in qualche modo al“francescanesimo femminile” è costituita – secondo la rileva-zione della Marano – dal monastero di S. Giacomo di Colle Lu-ce, che pure non risulta mai citato dalla storiografia erudita
38 S. BERNARDI, Esempi di assistenza a Cingoli nel secolo XIII: gli ospedalidi Spineto e Buraco, in Cingoli dalle origini al sec. XVI. Contributi e ricerche,Atti del XIX Convegno di Studi Maceratesi (Cingoli, 15-16 ottobre 1983), [=Studi Maceratesi, 19 (1983)], pp. 257-288; EAD., Ancora sull’assistenza a Cin-goli nei secoli XIII e XIV, in Assistenza e ospitalità nella Marca medievale, At-ti del XXVI Convegno di Studi Maceratesi (San Ginesio 17-18 novembre 1990)[= Studi Maceratesi, 26 (1990)], pp. 535-545; EAD., Monasteri femminili di Cin-goli (secc. XIII-XIV), in Santità femminile nel Duecento. Sperandia patrona diCingoli, a cura di G. AVARUCCI, Ancona, 2001, pp. 315-346; nello stesso volumesi veda M. SENSI, Comunità penitenziali tra Due e Trecento tra Umbria e Mar-che, pp. 165-207, ora anche in ID., « Mulieres in ecclesiae ». Storie di monache ebizzoche, Spoleto, 2010, pp. 437-480.
FRANCESCA BARTOLACCI132
francescana. È vero che nella descrizione dello stato di tutti iconventi approntata per la Congregazione, riunitasi a Jesi il28 dicembre 1899, da Padre Candido Mariotti in qualità di Mi-nistro Provinciale dei Minori delle Marche, trattando del con-vento di S. Giacomo apostolo a Cingoli, si afferma che « eraprima un piccolo Monastero di Monache » ma non si dice, né silascia intendere, che si trattasse di monache in qualche modolegate all’Ordine dei Minori, diversamente da quanto alcunistorici hanno creduto di poter inferire 39. La storiografia civilecingolana dal XVII secolo, d’altra parte, ritiene che S. Giacomonasca come monastero benedettino e segua poi la riformacistercense 40.
La prima notizia di una comunità di donne a Colle Luce, oPlacza Insulae, risale al 1233, quando Benvenuto di Grimaldodi Gozo riceve una terra « nomine dominarum volentium mo-rari in capite Placze Insule, videlicet Marabilie, Iacobine, Ac-toline, Margarite, Agathe, Agnetis et alie », donata da Atto diRolando e da altri esponenti di famiglie eminenti cingolanepro redemptione animae 41. Nell’anno 1234 sono almeno tre ledonazioni di terre e diritti che riguardano le dominae existen-tes in Placza de Insula ad honorem Dei et beati Jacobi apostolie nel 1235 le stesse dominae sono dette commorantes in domoCollis Lucis 42. Si tratta con ogni probabilità di una comunitàdi tipo penitenziale, ubicata non troppo distante dalla cintamuraria, che in pochi anni acquisisce, con il sostegno di figurerilevanti della società cingolana, alcuni beni e una domus 43.
39 Stato passato e presente della Provincia dei Minori nelle Marche. Gen-naio 1900, Jesi, 1900, p. 16. Il monastero rientra nel censimento della Maranoche equivoca l’affermazione di p. Mariotti che non parla affatto di damianite oclarisse: MARANO, Le clarisse nelle Marche cit. pp. 122-123.
40 O. AVICENNA, Memorie della città di Cingoli, Iesi, 1644, pp. 200-201.41 MACERATA, Archivio di Stato, Archivio Comunale di Cingoli, Fondo S. Ca-
terina, perg. n. 856.42 BERNARDI, Monasteri femminili cit., pp. 334-335.43 SENSI, Comunità penitenziali cit., pp. 458-459. Cfr. con i casi illustrati in
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 133
Nel 1239, in una indulgenza concessa dal vescovo Sinibaldo acoloro che avessero fatto donazioni per la ecclesia e il locus diColle Luce la cui costruzione era da poco iniziata, le dominaedi S. Giacomo vengono definite renclusae, denominazione chesuggerisce ancora una appartenenza all’area penitenziale 44.
L’unica evidenza documentaria che può far riferire S. Gia-como di Colle Luce ad un ambito “francescano” è costituita daldocumento di esenzione dalla giurisdizione episcopale, emessonel 1240, che reca nell’intestazione: Rainaldus divina provi-dentia Auximanus Episcopus dilectis in Christo filiabus Abba-tissae ac sororibus reclusis monasterii Sancti Jacobi de PlajaInsulae e prosegue indicando le sorores come appartenenti al-l’Ordo pauperum monialium reclusarum 45, in linea con la si-stemazione di religiosae mulieres operata in quegli anni daUgo-Gregorio IX 46. Il documento, che non possediamo in origi-nale, risulta chiaramente esemplato su di un formulario 47, maha una storia e una “fortuna” diverse rispetto a diplomi diesenzione concessi a comunità di donne poi divenute “france-
A. BENVENUTI PAPI, « In castro poenitentiae ». Santità e società femminile nell’I-talia medievale, Roma, 1990.
44 Cfr. M. SENSI, Storie di bizzoche tra Umbria e Marche, Roma, 1995, pp.3-17. Non possediamo il documento in originale ma in copia, fatta fare dal giu-dice Compagnone di Attone nell’anno 1248, nel momento in cui ha inizio lacontroversia con il vescovo di Osimo: P. COMPAGNONI, Memorie istorico-critichedella Chiesa e de’ vescovi di Osimo, V, Appendice, Roma, 1782-83, pp.64-65, n.XXXVIII.
45 Ibid., pp. 65-66, n. XXXIX. Il documento non reca datazione ma è riferi-bile all’anno di insediamento del vescovo Rinaldo cioè il 1240: nel dicembredello stesso anno, o nel gennaio del 1241, la sede osimana viene infatti sop-pressa e al suo posto eretta quella di Recanati.
46 Si vedano i casi esaminati in SENSI, Storie di bizzoche cit.47 Il formulario conserva la struttura, pur con tutte le differenze terminolo-
giche e le opportune modifiche, di quello fatto redigere da Ugo d’Ostia per lafondazione dei “suoi” monasteri. Il testo è in G. LEVI, Registri dei cardinaliUgolino d’Ostia e Ottaviano degli Ubaldini, Roma, 1890, ma anche in ALBERZO-NI, Chiara e il papato cit., pp. 117-118 con rimando alle pp. 45-47 per alcuneosservazioni.
FRANCESCA BARTOLACCI134
scane” a tutti gli effetti, e deve la sua tradizione unicamenteal fatto di essere parte di un dossier costruito dal giudice delcomune di Cingoli nel 1341 per la lunga querelle riguardantel’esenzione dall’ordinario diocesano 48. L’evoluzione del proget-to ugoliniano, sfociato in alcuni casi nella “francescanizzazio-ne”, sembra non potersi cogliere per il monastero di Cingoli einfatti, già nel 1248, l’esenzione episcopale, parte integrantedell’ingresso nell’Ordine creato da Ugo d’Ostia, viene messa indiscussione da un successore di Rainaldo e la rettris et capita-nea sororum sive dominarum di S. Giacomo 49 si vede costrettaa nominare due procuratori per ottenerne la conferma 50, riba-dita nel 1253 da papa Innocenzo IV 51. Non sembra inverosi-mile pensare che le donne penitenti di S. Giacomo abbiano ac-cettato una adesione formale all’Ordo pauperum monialiumreclusarum, ottenendo in cambio l’esenzione, pur continuandoa praticare “consuetudini” penitenziali e suscitando in questomodo il richiamo del vescovo. La lotta con l’ordinario diocesa-no, durata più di un secolo, conterà tra i protagonisti alcunetra le famiglie eminenti di Cingoli che erano state tra le pro-motrici della fondazione della comunità di placza insulae: ne-gli anni Settanta del XIV secolo, all’annuncio della visita delvescovo a S. Giacomo per verificare l’osservanza della clausu-ra, molti loro esponenti protestarono in maniera vivace riven-
48 MACERATA, Archivio di Stato, Archivio Comunale di Cingoli, Fondo S. Ca-terina, pergg. n. 513, 1085. Per l’esenzione del monastero di S. Maria e Gior-gio di Ascoli Piceno, allegata in copia al documento papale di conferma e ri-portata dal Bullarium Franciscanum, si veda sotto, testo corrispondente allenote 76-77.
49 I termini rettrice e capitanea, e non badessa, rimandano di nuovo aduna comunità di tipo penitenziale. Si veda SENSI, Storie di bizzoche cit., pp.8-9.
50 MACERATA, Archivio di Stato, Archivio Comunale di Cingoli, Fondo S. Ca-terina, perg. n. 241.
51 Ibid., perg. n. 28, per cui si veda BERNARDI, Monasteri femminili cit., p.336.
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 135
dicando il diritto di esenzione di cui godeva il monastero 52.Nel 1311, in una lettera di Clemente V, il monastero vienedetto appartenente all’Ordo Sancti Benedicti 53 senza menzio-nare alcun legame, presente o passato, con ambienti “france-scani”. Il passaggio all’ambito cistercense evidenziato dallastoriografia locale cingolana si verificò alla fine del XIV secolo,quando il monastero, reso vulnerabile dal declino economico edalla penuria di presenze, fu soppresso, e ne venne decretata,nel 1395, l’unione con il monastero cistercense di S. Caterinade Cingulo 54.
Il monastero di S. Giacomo non può dunque essere definitostrictu sensu damianita e a nessun titolo di clarisse 55, ma, conla consapevolezza di compiere una valutazione anacronistica,potrebbe essere annoverato tra quei monasteri “ugoliniani” checontinueranno a seguire la regola benedettina abbandonandoper sempre l’iter “francescano”. Ponendo particolare considera-zione alla questione terminologica, appare degno di nota che, aquella altezza cronologica, quando prevale da almeno un de-cennio il nome di Ordo Sancti Damiani, l’istituzionalizzazionedi un monastero avvenga con una denominazione – Ordo pau-perum monialium reclusarum – diffusa per lo più in periodoprecedente 56.
52 MACERATA, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Cingoli, prot. n. 1, no-taio Bartoluccio di Silvestro di Bartolo, 28 dicembre 1371. Cfr. SENSI, Comuni-tà penitenziali cit., pp. 458-459.
53 COMPAGNONI, Memorie istorico-critiche cit., V, Appendice, pp. 65-66, n.XXXIX. Nel dossier fatto approntare dal giudice di Cingoli nel 1341, accantoal diploma di esenzione e senza soluzione di continuità è riportato il privilegiodi Clemente V del 1311 a conferma di omnes libertates et immunitates conces-se in precedenza al monasterium Sancti Jacobi de Collibus Lucis Ordinis San-cti Benedicti.
54 MACERATA, Archivio di Stato, Archivio Comunale di Cingoli, Fondo S. Ca-terina, pergg. n. 57, 60, 62, 64. BERNARDI, Monasteri femminili cit., pp. 338-339.
55 Come invece viene affermato in MARANO, Le clarisse nelle Marche cit. pp.122-123 e p. 166.
56 Si veda sopra alla nota 9 e testo corrispondente alla nota 14. F. BARTO-
FRANCESCA BARTOLACCI136
S. MARIA MADDALENA A MATELICA
Questo secondo caso riveste un particolare interesse ancheperché il monastero di S. Maria Maddalena di Matelica è statoal centro di un dibattito storiografico che nel XIX secolo hacoinvolto l’erudizione marchigiana in una discussione sull’ap-partenenza della comunità, e dunque anche della beata Mat-tia, patrona di Matelica, all’area francescana o benedettina 57.Del resto, anche solo prendendo in considerazione gli studi piùrecenti relativi a S. Maria Maddelena, è possibile cogliere lecontraddizioni e i risultati controversi connessi con la storiadel monastero 58.
I primi documenti riferibili a questa comunità sono datatisettembre 1233 e consistono in donazioni di terreni e beni alledominae che dimorano in Cupu Rumano 59. L’ubicazione di taleluogo, determinata attraverso le confinazioni, viene a coincidere
LACCI, Articolazione e sviluppo delle reti insediative francescane nelle Marche.Una ricostruzione informatica e alcuni esempi, in Le origini e la loro immagi-ne cit., pp. 31-49, in particolare pp. 43-48.
57 Per la vita della beata Mattia (1253-1320 ca.) si rimanda a S. PEDICA,Nazzarei Mattia, in Bibliotheca Sanctorum, IX, Roma, 1967, coll. 785-786. Peril dibattito si veda ALBERZONI, Le congregazioni monastiche cit., pp. 380-381.
58 A. TALAMONTI, Cronistoria dei Frati Minori della Provincia Lauretana delleMarche, VII, Monasteri delle clarisse, Sassoferrato, 1962, pp. 55-126; G. PARISCIA-NI, I luoghi della clausura clariana nelle Marche, in G. CORSINI-F. MARTELLI-G. PA-RISCIANI, Con santa Chiara nelle Marche, Falconara, 1994, pp. 180-182; M. SENSI,Clarisse e ‘minorete’ nei secoli XIII-XV. L’esempio marchigiano, già in Istituzioni esocietà nelle Marche (secc. XIV-XV), Atti del Convegno (Ancona-Camerino-Anco-na, 1-2-3 ottobre 1998), Ancona, 2000 [= Atti e memorie della Deputazione di Sto-ria patria per le Marche, 103 (1998)], pp. 493-517 ora in ID. « Mulieres in eccle-siae » cit., pp. 355-436; MARANO, Le clarisse nelle Marche cit., pp. 114-115. In que-sti studi S. Maria Maddalena viene annoverato tra i monasteri che a buon dirittopossono essere definiti di clarisse, pur seguendo formalmente la regola benedetti-na; unica eccezione Mario Sensi che lo considera clariano, cioè tra i monasteri cheseguirono in senso stretto la regola di santa Chiara.
59 C. TOMASSINI, Le pergamene della beata Mattia di Matelica, in Quadernidell’Archivio storico arcivescovile di Fermo, 26 (1998), pp. 5-39, qui p. 8.
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 137
o comunque ad avere una posizione contermine alla successivaubicazione del monastero di S. Maria Maddalena che si presentaperò in un primo momento senza alcun titolo e senza alcun ac-cenno alla regola seguita. Sembrerebbe trattarsi di un gruppo direligiosae mulieres, di donne penitenti, non legate istituzional-mente né ai benedettini né agli Ordini mendicanti. L’intitolazio-ne a Maria Maddalena compare in un documento più tardo (ante1237), quando il vescovo di Camerino Filippo invita i fedeli a fareelemosine per la costruzione dell’Oratorio e del Monastero ad ho-norem Dei et beatae Mariae Magdalenae che la Abbatissa et So-rores avevano già iniziato ad erigere 60. Anche in questo docu-mento manca un accenno alla regola seguita ma è significativa lascelta dell’intitolazione che ci riporta ad una attrazione verso“l’orbita claustrale” del movimento laico della penitenza femmini-le, che comprendeva anche tutta quella marginalità più espostaalla prostituzione 61.
Del 1237 è la professione religiosa di Rosa che, entrando nelmonastero di S. Maria Maddalena, a cui dona i suoi consistentibeni, promette obedientia e reverentia a frate Pietro, MinistroProvinciale dei Minori 62. Tale presenza viene considerata da cer-ta storiografia argomento dirimente per stabilire l’appartenenzadi S. Maria Maddalena all’ambito francescano liquidando i nu-merosi successivi riferimenti al suo legame istituzionale con l’Or-dine benedettino come « il solito equivoco tra regola o forma divita » 63. In realtà la questione si presenta assai più complessa enon priva di alcune implicazioni. La presenza del Ministro Pro-vinciale a Matelica infatti non è più attestata nelle successiveprofessioni religiose femminili, e l’obedientia viene prestata al
60 C. ACQUACOTTA, Memorie di Matelica, Ancona, 1838, p. 72, d. 21.61 Per alcuni esempi cfr. BENVENUTI PAPI, « In castro poenitentiae » cit., ad
indicem.62 TOMASSINI, Le pergamene della beata Mattia cit., pp. 8-9.63 PARISCIANI, I luoghi della clausura cit., pp. 180-181; TOMASSINI, Le perga-
mene della beata Mattia cit., pp. 5-6.
FRANCESCA BARTOLACCI138
sindicus, spesso un presbitero, del monastero 64. Finalmente, nel1256 si fa menzione per la prima volta della regola seguita nelmonastero di S. Maria Maddalena, cioè quella di S. Benedetto,un’appartenenza che da questo momento verrà ripetuta in ognidocumento e confermata nel 1263 da papa Urbano IV 65.
Le origini di S. Maria Maddalena sembrano quindi essere ri-feribili a quelle di una comunità di tipo penitenziale con un rap-porto diretto con i frati Minori pur nell’assenza di una regola:una comunità assimilabile alle sorores Minores dunque, non com-presa entro i « rigidi confini del monachesimo gregoriano-damia-nita » e senza l’esigenza di privilegi di protezione da parte dellaSede apostolica 66. La documentazione superstite suggerisce, apartire dagli anni Cinquanta del XIII secolo, un progressivo al-lontanamento tra sorores e frati Minori – rilevato dalla assenzadi questi ultimi nelle professioni religiose – proprio negli anni incui la Sede apostolica tentava di imporre alle comunità di donnenon istituzionalizzate il passaggio all’Ordine di S. Damiano o aduna delle regole comprese dal IV Concilio lateranense. In questocaso non è possibile ricostruire le dinamiche che portarono ledonne di S. Maria Maddalena a fare il loro ingresso nell’OrdoSancti Benedicti ma è possibile rilevare che questo avviene inuna significativa contiguità cronologica con la prima attestazionedella presenza intra moenia dell’Ordine dei frati Minori che hacome termine ante quem l’anno 1256.
ASCOLI PICENO
Il terzo caso, quello di Ascoli, presenta un elemento di ulte-riore complessità perché nella città picena più di un monaste-ro femminile gravita in area francescana.
64 Ibid., pp.10-13.65 Ibid., pp. 13-15.66 ALBERZONI, Sorores minores cit., p. 179.
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 139
1. S. Maria e S. Giorgio o S. Maria delle Donne o Nova
Fuori Porta Romana, in un area in cui erano già presentiun monastero benedettino ed un ospitale 67, viene fondato ante1235 un convento di moniales inclusae de Ordine Sancti Da-miani intitolato alla Vergine e a S. Giorgio. Il diploma di esen-zione, con cui si confermano i beni già posseduti dal monaste-ro, è tradito solo in copia – senza data – in quanto inserito nelprivilegio Religiosam vitam eligentibus dell’agosto 1235 68. Aquesto proposito, lo storico ascolano Francesco Antonio Mar-cucci afferma che « si mossero gli Ascolani a supplicar il nostroVescovo Conte Marcellino per la fondazione in città di un Mo-nistero di quelle sì sante Religiose », monastero fondato, sem-pre secondo lo storico, nel 1232. In seguito, nel 1234, essendoil monastero ormai compiuto « fu cura del Prelato spiccar da S.Damiano di Assisi due di quelle fervide monache a venir nel
67 Per la collocazione dei primi insediamenti francescani in zone suburbanecon presenze ospitaliere si veda ALBERZONI, Chiara e San Damiano cit., p. 34.R. GIORGI, Le Clarisse in Ascoli, Fermo, 1968, pp. 60-62. Raniero Giorgi, nellanota introduttiva (ibid., p. 8) rileva, con un tono velatamente polemico, chenello studio di Riccardo Pratesi sulla clarisse (R. PRATESI, Le clarisse in Italia,in Santa Chiara d’Assisi. Studi e cronaca del VII Centenario [1253-1953], As-sisi, 1953, pp. 339-377) non compaiono quelle ascolane che pure padre Ferdi-nando Diotallevi, incaricato di mandare notizie per le Marche, non poteva nonconoscere. Cfr. anche PARISCIANI, I luoghi della clausura cit., pp. 156-157.
68 SBARAGLIA, Bullarium franciscanum cit., I, 1235 26 agosto, d. CLXXX; L.WADDING, Annales Minorum seu trium Ordinum a S. Francisco institutorum,II, Romae, 1732, p. 465, pp. 711-712; cfr. GIORGI, Le Clarisse cit., p. 70 e p. 136che riporta, con alcune imprecisioni, il documento. I primi monasteri damiani-ti ebbero solitamente l’intitolazione alla Vergine Maria, mentre il titolo di S.Giorgio è fatto risalire da J. R. H. MOORMAN (Medieval Franciscan Houses, St.Bonaventure, New York, 1983, p. 546) all’unione di due diversi monasteri. Neldocumento di concessione di Tancredi, priore del monastero benedettino di S.Maria di Offida, datato 1236 e finalizzato alla costruzione di un monastero da-mianita, si dice che il nuovo monastero dovrà godere della piena immunità co-me quella di cui godono i monasteri di Ascoli, Perugia, Siena: SBARAGLIA, Bulla-rium franciscanum cit., I, 1245 23 ottobre, d. CVII, pp. 389-392.
FRANCESCA BARTOLACCI140
nuovo nostro Monistero a far la Fondazione » 69. Di queste af-fermazioni tuttavia, ancora oggi citate come “fonte” relativa al-la fondazione del monastero, non si ritrova alcun riscontro do-cumentario. Non aiuta a chiarire la questione un documentodel 1233, in cui il papa Gregorio IX, rivolgendosi al Vescovoascolano, si pronuncia relativamente ad una controversia ere-ditaria riguardante le sorores inclusae Monasterii de Esculo, inparticolare Cecilia eiusdem Monasterii Monialis, ma senza fa-re riferimento alla eventuale regola seguita 70. Questo rendeincerta l’identificazione della comunità cui si riferisce il docu-mento con S. Maria e S. Giorgio, perché ciò implicherebbe cheil cenobio femminile preesistesse alla fondazione damianita.Pare peraltro esclusa una identificazione con S. Angelo Magnoche a quella altezza cronologica è ancora un conclamato mona-stero benedettino. Ancora più incerta risulta, ad un esame piùravvicinato, la questione delle monache chiamate, secondoMarcucci, nel 1234 da S. Damiano “a far fondazione” o, contermine tecnico, a ‘informare’ il monastero ascolano; Marcucciè infatti il primo tra gli storici ascolani a proporre una conti-nuità fondativa tra Assisi ed Ascoli 71, citando come unica fon-
69 F. A. MARCUCCI, Saggio delle cose ascolane e de’ vescovi di Ascoli nel Pice-no dalla fondazione della città sino al corrente secolo decimottavo, Teramo,1766, p. 242.
70 I parenti di Cecilia, che alla morte del padre aveva ereditato tutti i benipoi portati con sé in monastero, rivendicano tale eredità poiché, affermano, do-po l’ingresso in monastero Cecilia mortua est mundo. Ma il papa si pronunciaa favore di Cecilia e quindi del monastero ascolano: SBARAGLIA, Bullarium fran-ciscanum cit., I, 1233 marzo 28, d. XCVI, p. 100 (lo Sbaraglia alla nota e iden-tifica il monastero con quello di S. Angelo Magno, che poi corregge in S. Mariae S. Giorgio. Ibid., p. 795); GIORGI, Le Clarisse cit., p. 66, n. 10; MARANO, Le cla-risse nelle Marche cit., pp. 119-120.
71 In ciò seguìto da Raniero Giorgi, che considera il monastero di Ascoliuna “copia” del Protomonastero assisiano adducendo come prove stringenti lacollocazione topografica (entrambi fuori della cinta muraria e vicino ad unospedale) e l’intitolazione (a S. Giorgio). Cfr. GIORGI, Le Clarisse cit., pp. 66-67;MARANO, Le clarisse nelle Marche cit., pp. 119-120.
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 141
te il cosiddetto ‘Continuatore di Lino’, di cui nessun altro stori-co ascolano sembra essere a conoscenza 72. L’esistenza di Linoe del suo continuatore e l’attendibilità dei passaggi riportatida Marcucci appaiono piuttosto dubbi anche perché altre affer-mazioni riprese da quella fonte, alla luce di una ulteriore e piùrigorosa indagine, sono risultate prive di fondamento 73. Purnella provata mobilità delle damianee di Assisi, che per espli-cita volontà di Chiara furono inviate ad ‘informare’ altre co-munità secondo il loro stile di vita 74, sembra quindi quantomeno poco prudente – come recentemente hanno fatto alcunistorici – assumere queste informazioni come dati affidabili re-lativi al monastero di damianite di S. Maria e S.Giorgio 75. Peraltro neppure quanto sappiamo dello status patrimoniale di
72 Secondo quanto dichiarato dal Marcucci, Lino Diacono nel XII secolocompendierebbe la Cronaca del vescovo Trasmondo di Ascoli. Il compendio sichiuderebbe con l’anno 1190 e sarebbe stato continuato fino al 1242 da quelloche Marcucci chiama appunto ‘Continuatore di Lino’. Cfr. MARCUCCI, Saggiodelle cose ascolane cit., pp. 159-160, 226-227.
73 G. PAGNANI, I viaggi di s. Francesco d’Assisi nelle Marche, Milano, 1962,p. 55; ID., Il più antico convento francescano di Ascoli, in Picenum seraphicum,VII (1970), pp. 194-208, citazione a p. 200. A. FRANCHI, Ascoli Imperiale. DaCarlo Magno a Federico II (800-1250), Ascoli Piceno, 1995, p. 126. AntoninoFranchi osserva che Lino Diacono e il suo continuatore, se fossero stati coeviai fatti narrati come afferma Marcucci, non avrebbero potuto commettere, co-me invece avviene, errori macroscopici su avvenimenti importanti (ad esempiole visite dell’imperatore Enrico VI) e dunque tutte le notizie sono poco attendi-bili e da leggere con forte riserva. Su questo argomento si veda anche F. CAP-PELLI, La Cattedrale di Ascoli nel Medioevo. Società e cultura in una città del-l’Occidente, Ascoli Piceno, 2000, pp. 34-35. Per una valutazione della storio-grafia di Francesco Antonio Marcucci si veda M. CAMELI, Saggio di bibliografiastorico-ecclesiastica ascolana, in Picenum seraphicum, XXV-XXVI (2006-2008),pp.197-316, qui pp. 203-204 e 222-227.
74 Z. LAZZERI, Il processo di canonizzazione di S. Chiara d’Assisi, in Archi-vum franciscanum historicum, 13, (1920), pp. 403-507; C. GENNARO, Chiara,Agnese e le prime consorelle: dalle “pauperes dominae” di S. Damiano alle cla-risse, in Movimento religioso femminile cit., pp. 169-191, con riferimento allepp. 174-175; ALBERZONI, Chiara e San Damiano cit., pp. 51-52.
75 MARANO, Le clarisse nelle Marche cit., pp. 119-122.
FRANCESCA BARTOLACCI142
questo monastero pare rimandare alle scelte che caratterizza-vano le non molte comunità damianee. Per quanto lo storicoascolano Raniero Giorgi parli più volte della povertà che afflig-geva la comunità di S. Maria 76, in realtà, in accordo con le di-sposizione date da Gregorio IX riguardo il possesso di beni im-mobili per l’Ordine di sua creazione, il monastero ascolano vie-ne dotato di beni già nel momento della sua fondazione. Neldocumento di esenzione dall’ordinario diocesano, che segnal’ingresso di S. Maria nell’Ordo Sancti Damiani, il vescovoconferma al monastero il possesso di viginti modioli terrae eviginti modioli silvae, nonché dei beni che verranno acquisitiin futuro, disposizioni poi ribadite nel 1235 da papa GregorioIX nella bolla Religiosam vitam eligentibus 77. Nei decenni suc-cessivi sono documentati numerosi lasciti testamentari che ri-guardano S. Maria, detta anche S. Maria Dominarum 78, e lastessa comunità riceve i beni del soppresso ospedale di S.Pamfilo, versando poi i diritti che spettavano a S. Spirito inSassia a Roma e a S. Spirito Nuovo ad Ascoli per lo stessoospedale 79. Soprattutto il monastero di S. Maria possiede al-cuni mulini, a causa dei quali, nel corso degli anni Ottanta delXIII secolo, quando ormai compare nei documenti come appar-
76 GIORGI, Le Clarisse cit., p. 79. Il riferimento di Giorgi, sommario e nonesente da errori, è ad un documento del 1° dicembre 1263 (o 1264) dove Simo-ne Paltanieri, cardinale prete di S. Martino e legato della Sede apostolica,scrive da Perugia al vescovo di Ascoli, ordinando di non esigere il versamentodelle procurationes da parte dei monasteri di S. Maria e S. Angelo, avendoquesti ricevuto privilegi a causa della loro povertà. Per il documento si vedaora M. CAMELI, Codice diplomatico ascolano (secoli XI-XIII), Ascoli Piceno,2012, p. 132, d. 177.
77 SBARAGLIA, Bullarium franciscanum cit., I, 1235 26 agosto, d. CLXXX.78 GIORGI, Le Clarisse cit., p. 79; MARANO, Le clarisse nelle Marche cit., p.
121; E. CALILLI NARDINOCCHI, Insediamenti degli Ordini Mendicanti in Ascoli Pi-ceno, in Picenum Seraphicum, XV (1979-80), pp. 213-238, in particolare pp.230-238.
79 GIORGI, Le Clarisse cit., p. 79; MARANO, Le clarisse nelle Marche cit., p.121.
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 143
tenente all’Ordine di Santa Chiara, sorgerà un aspro contrastocon il comune di Ascoli 80.
2. S. Angelo Magno
S. Angelo Magno di Ascoli, che in precedenza era stato mo-nastero benedettino 81, riceve il 24 maggio 1239 la lettera diGregorio IX, indirizzata all’Abbatissa et Moniales MonasteriiSancti Angeli Asculani Ordinis Sancti Damiani. A questa data
80 Per i contrasti sorti a causa dello statuto che proibiva l’uso di mulini chenon fossero di proprietà comunale si rimanda alla efficace sintesi di MARANO,Le clarisse nelle Marche cit., pp. 121-122. Raniero Giorgi afferma che nel Ca-tasto di Ascoli del 1381 S. Maria delle Donne risultava proprietaria di mulinie case e aveva così accumulato un piccolo patrimonio. Pur sapendo che nei re-gistri del Catasto ascolano non risultano i beni ecclesiastici perché non sogget-ti ad imposta, a meno che non vengano elencati nella descrizione di un posses-so come confinanti, ed essendo al momento non praticabile un controllo sull’in-tera fonte, mi limito a riportare l’affermazione di Giorgi in nota. GIORGI, LeClarisse cit., p. 80; A. FRANCHI, Ascoli Pontificia, II (dal 1244 al 1300), Regestia cura di L. CIOTTI, Ascoli, 1999, p. 209, doc.189; p. 213, doc. 193. Inoltre si ve-da A. RIGON, Conflitti tra comuni ed ordini mendicanti sulle realtà economiche,in L’economia dei conventi dei frati minori e predicatori fino alla metà del Tre-cento, Atti del XXXI Convegno internazionale (Assisi 9-11 ottobre 2003), Spo-leto, 2004, pp. 339-362, in particolare pp. 347-348 anche in relazione ai mulinidi S. Angelo Magno.
81 Il Marcucci lo dice fondato già nell’VIII secolo, anche se tale affermazio-ne è da prendere con le dovute cautele: MARCUCCI, Saggio delle cose ascolanecit., p. 208. Per la storia ed i beni del monastero di S. Angelo Magno si riman-da a GIORGI, Le clarisse cit., pp. 71-75 e 78-133; PARISCIANI, I luoghi della clau-sura cit., pp. 157-158; MARANO, Le clarisse nelle Marche, pp. 128-130; FRANCHI,Ascoli imperiale cit., ad indicem e al recente Il Quinternone di Ascoli Piceno, acura di G. BORRI, Spoleto, 2009, ad indicem. In particolare vorrei fare riferi-mento ad un privilegio concesso a S. Angelo da Enrico VI, confermato nel1228 da Federico II, in cui si prende sotto la protezione imperiale detto mona-stero con tutti i suoi uomini, beni e possedimenti che detiene ad Ascoli e comi-tato, a Fermo e comitato e nel distretto dell’abbazia di Farfa. FRANCHI, Ascoliimperiale cit., pp. 220-224.
FRANCESCA BARTOLACCI144
dunque le “potenti contesse” di S. Angelo avevano già effettua-to il transitus verso l’Ordine di S. Damiano 82. Il documento,che contiene una versione della forma vitae di Gregorio IX, ap-pare ancor più significativo dovendosi riferire ad un monasterogià benedettino e ricco di storia 83.
Il testamento di Beldea di Ruggero, noto alla storiografiaper essere la più antica menzione della presenza minoritica adAscoli, potrebbe in qualche misura costituire una attestazionedi una fase del passaggio dalla realtà benedettina a quellafrancescana. Beldea infatti il 9 novembre 1237 decide di faretestamento habens in proposito intrandi monasterium SanctiAngeli de Esculo 84: la dote e altri suoi beni, con il consensodella madre, vengono concessi al monastero che viene costitui-to suo erede, e Beldea può fare l’ingresso a tutti gli effetti nel-la comunità. È probabile che S. Angelo a questa altezza crono-logica non sia più un monastero benedettino in senso stretto,visto che nel testamento di Beldea, oltre ad un legato per lamadre, le uniche altre due istituzioni menzionate coincidonocon le “presenze francescane” attestate ad Ascoli: i Minori diCampo Parignano e le damianite di S. Maria. Non sfugge, e misembra più di una suggestione, un esplicito favore di Beldeaverso la realtà francescana.
Non appare facile rendere ragione di questo transitus: cer-tamente la fama delle damianite di S. Maria ebbe il suo pe-
82 SBARAGLIA, Bullarium franciscanum cit., I, pp. 263-267.83 ALBERZONI, Le congregazioni cit., pp. 397-398: l’uso del termine discretio
nell’arenga sembra infatti suggerire un intento polemico nei confronti del mo-nachesimo tradizionale. Si veda ora G. BOCCALI, La “Cum omnis vera religio”del cardinale Ugolino. Forma vite primitiva per San Damiano ed altri mona-steri (Bruxelles, Bibliothèque Royale, Ms. IV.63), in Frate Francesco, 74 (2008),pp. 435-477.
84 ASCOLI PICENO, Archivio di Stato, Archivio di Sant’Angelo Magno, cass. IV,perg. n. 29, trascritta da CALILLI NARDINOCCHI, Insediamenti degli Ordini Men-dicanti cit., pp. 230-231.
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 145
so 85, ma la possibilità per una istituzione che vantava forsecinquecento anni di storia di non seguire il declino delle formetradizionali del monachesimo e di trarre nuova linfa da nuoveforme di vita claustrale, pur conservando le forme del propriopotere, mi sembra possa costituire un’altra possibile chiave dilettura, opportunamente suggerita da Maria Cristina Mara-no 86. Anche il monastero di S. Angelo, che già dal 1266 com-pare nei documenti come appartenente all’Ordo Sanctae Cla-rae 87, risulta coinvolto verso gli anni Ottanta del XIII secolonella controversia con il comune di Ascoli per l’uso dei muli-ni 88. Nel 1460 il monastero di S. Angelo Magno viene soppres-so ed unito a S. Maria 89.
3. S. Spirito e S. Chiara
Le uniche notizie sulle origini di questo monastero sonoquelle che riferisce Francesco Antonio Marcucci, rifacendosi
85 PARISCIANI, I luoghi della clausura cit., pp. 157-158. Si vedano a questoproposito le vicende di alcuni monasteri della regione padana in M. P. ALBER-ZONI, L’ordine di S. Damiano in Lombardia, in Chiara e il secondo Ordine. Ilfenomeno francescano nel Salento, Atti del Convegno di Studi in occasione delVIII centenario della nascita di santa Chiara (Nardò, 12-13 novembre 1993), acura di G. ANDENNA - B. VETERE, Galatina, 1997, pp. 117-157, già in EAD., Lanascita di un’istituzione. L’Ordine di S. Damiano nel XIII secolo, Milano,1996, pp. 52-107 e in G. M. VARANINI, Per la storia dei Minori a Verona nelDuecento, in Minoritismo e centri veneti nel Duecento, a cura di G. CRACCO,Trento, 1983 [= Civis. Studi e Testi, 7 (1983)], pp. 92-125.
86 MARANO, Le clarisse cit., pp. 128-129.87 L’edizione del documento in cui il vescovo Rinaldo concede « monialibus
inclusis monasterii Sancti Angeli Esculani ordinis Sancte Clare » l’esenzioneper il monastero di S. Angelo e per tutti i beni, chiese e persone che da questodipendono da ogni diritto e obbligo vescovile è in M. CAMELI, La chiesa scritta.Documentazione e autorappresentazione dei vescovi di Ascoli Piceno tra XI eXIII secolo, Caselle di Sommacampagna (VR), 2009, pp. 193-197, n. 20.
88 FRANCHI, Ascoli Pontificia, II cit., docc. 187-188, pp. 207-208.89 PARISCIANI, I luoghi della clausura cit., pp. 157-158.
FRANCESCA BARTOLACCI146
ancora una volta al cosiddetto Continuatore di Lino 90. A causadel gran numero di donne che volevano fare il loro ingressonei monasteri, nel 1238 la popolazione ascolana si sarebbe ri-solta a supplicare il vescovo affinché sopprimesse la rettoria diS. Spirito presso Porta Cartara, e la convertisse in un mona-stero per damianite. Due anni dopo le monache di S. Mariadelle Donne furono inviate a ‘fare’ la nuova fondazione 91. Laricostruzione dello storico ascolano è verosimile sebbene anco-ra una volta non supportata da nessun riscontro documentarioaffidabile.
D’altra parte, anche per il periodo immediatamente succes-sivo rimangono scarne le attestazioni documentarie riferibili aS. Spirito, le cui vicende storiche hanno condizionato in ma-niera particolarmente pesante la tradizione del materiale do-cumentario 92. Il primo riferimento alle pauperes moniales diS. Spirito dell’Ordine di S. Damiano è costituito da una letteradi Innocenzo IV, in data 8 gennaio 1250, in cui si accoglie sot-to la protezione apostolica il monastero con tutti i suoi beni,seguita a pochi giorni di distanza da una indulgenza legata al-la costruzione di un nuovo edificio 93. A distanza di cinque an-ni le damianite di S. Spirito sono impegnate nella edificazione
90 Si veda sopra, testo corrispondente alle note 71-73.91 MARCUCCI, Saggio delle cose ascolane cit., pp. 245-246. Le notizie fornite
dal Marcucci sono riprese da GIORGI, Le Clarisse cit., pp. 76-77 e da MARANO, Leclarisse cit., pp. 130-131.
92 I documenti di S. Spirito migrarono con le monache nel monastero bene-dettino di S. Onofrio ad Ascoli. Molti di questi documenti andarono perdutidopo il 1630 e la parte restante confluì a Roma, presso il monastero della Con-gregazione Sublacense. Ringrazio la dottoressa Laura Ciotti dell’Archivio diStato di Ascoli Piceno per aver sciolto alcuni dubbi su tali vicende documenta-rie.
93 FRANCHI, Ascoli Pontificia, II cit., docc. 24-25, pp. 35-36. Bisogna tenerepresente che, nella sua raccolta documentaria, Antonino Franchi inserisce an-che regesti di documenti che non ha potuto consultare perché da tempo di-spersi. In questi casi le informazioni dipendono esclusivamente dalle indica-zioni di Francesco Antonio Marcucci.
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 147
di una nuova chiesa, dedicata a S. Chiara 94, e nel 1257 sonoautorizzate da Alessandro IV a ricevere somme di denaro pro-venienti da restituzioni di usure e rapine 95. Essendo il mona-stero direttamente soggetto alla chiesa romana, il papa conce-de nello stesso anno a S. Spirito l’esenzione dal pagamento didecime sulle sue terre e proprietà e l’anno seguente Alessan-dro IV ribadirà in più riprese il divieto di costruire edifici reli-giosi entro 400 passi dal monastero stesso 96. L’inserimento inarea francescana si rivela tuttavia di breve durata. Nel 1272infatti, quando nelle carte farà di nuovo la comparsa il mona-stero di S. Spirito, risulterà appartenente a tutti gli effetti al-l’Ordo Sancti Benedicti 97. Lo stato della documentazione nonpermette di ricostruire neppure per via ipotetica le motivazio-ni per cui S. Spirito, al contrario di quanto avviene per gli al-tri monasteri damianiti di Ascoli (S. Maria e Giorgio e S. An-gelo), non sia confluito nell’Ordo Sanctae Clarae.
MONTESANTO, ORA POTENZA PICENA
Il quarto caso, quello del monastero di Montesanto (già in-titolato a S. Tommaso, poi a S. Francesco e in seguito a S.Chiara), risulta esemplare della condotta politica di GregorioIX rispetto alle fondazioni femminili. Pur non essendo nota ladata della fondazione, nell’ottobre del 1227 Gregorio IX defini-sce le monache di Montesanto pauperes moniales inclusae e lepone sotto la protezione della Sede apostolica 98. Nel corso de-gli anni Trenta, in linea con quanto stava avvenendo nell’OrdoSancti Damiani, Gregorio decide di dotare le pauperes monia-
94 FRANCHI, Ascoli Pontificia, II cit., docc. 64, 65, 70, pp. 77-78, 83.95 FRANCHI, Ascoli Pontificia, II cit., doc. 104, p. 119.96 Ibid., doc. 112, p. 127; docc. 114, 115, 118, pp. 129, 130, 133.97 Ibid., docc. 140, 141, 239, pp. 157, 158, 263.98 PARISCIANI, I luoghi della clausura cit., pp. 196-197.
FRANCESCA BARTOLACCI148
les inclusae di beni immobili: ed infatti è del maggio 1231 unabolla destinata ancora alle monache di Montesanto affinchésiano presi provvedimenti per sostenerle nelle loro necessità 99.Nel 1246 vengono affidate alla cura dei frati Minori 100 e nel1292 il monastero, destinatario di una indulgenza, viene dettodell’Ordine di Santa Chiara 101.
CONCLUSIONE
Lo scopo del presente contributo non vuole e non può esseresemplicemente di fare chiose critiche all’articolo della Marano;sulla base di una pur limitata campionatura si è evidenziato chei monasteri femminili presenti in quel censimento hanno intrat-tenuto, nel corso del XIII secolo, relazioni di tipo molto diversifi-cato con il mondo francescano. In un caso il legame è decisamen-te labile: S. Giacomo di Colle Luce è stato coinvolto, in un certomomento della sua storia, in un progetto istituzionale di Ugod’Ostia-Gregorio IX, che in alcuni casi ha subito poi un processodi “francescanizzazione”. Il monastero di Cingoli non ha peraltroconosciuto tale tipo di evoluzione. Nel caso di Matelica si eviden-zia un legame di natura “personale” con i frati Minori, che non sitraduce però in un nesso di tipo istituzionale. Più stretto inveceil legame nei casi delle tre istituzioni ascolane, che per vie diver-se confluiscono nell’Ordo Sancti Damiani. Due di esse, S. Giorgioe S. Maria e Sant’Angelo Magno, divengono monasteri di clarissementre S. Spirito, già nel 1272, appartiene all’Ordo Sancti Bene-dicti. Della comunità di Montesanto, pur ignorandosi le origini, siconstata una evoluzione per così dire lineare dall’aggregazione alprogetto di Gregorio IX e infine all’entrata nell’Ordo SanctaeClarae.
99 Ibidem.100 SBARAGLIA, Bullarium franciscanum cit., I, p. 414.101 SBARAGLIA, Bullarium franciscanum cit., IV, Romae, 1768, p. 322.
IL COMPLESSO MONDO DELLE DONNE 149
Se ne possono trarre alcune conseguenze in vista di futuri– sempre auspicati – censimenti di insediamenti femminili; lanecessità di differenziare diverse altezze cronologiche alle qua-li viene compiuta la rilevazione documentaria, per non creareuna artificiosa impressione di continuità. Per evitare invece diunire in modo forzoso realtà differenti, non si potrà non porrela massima attenzione alle diversificazioni di denominazione.Tutto questo ha come conseguenza che un censimento, in sen-so proprio, non potrà che operare su realtà istituzionalmenteomogenee.
I problemi metodologici suggeriti dai tentativi di censimen-to fanno in realtà emergere questioni ancora più profonde. Inprimo luogo si evidenzia una spiccata fluidità delle norme cheregolano la vita di queste comunità monastiche, una fluiditàdella quale il “passaggio di regola” 102 pare costituire solamentel’aspetto più macroscopico. Le fonti sono avare di informazionesui contesti specifici di tali trasformazioni e d’altra parte nonè agevole, nella maggior parte dei casi, cogliere chi abbia potu-to influenzare, o perfino determinare, trasformazioni più o me-no radicali della forma di vita delle comunità monastiche fem-minili. Emerge però comunque una notevole “adattabilità” ditali comunità nei confronti di quadri istituzionali anche assaidifferenziati tra di loro. Questa capacità di adattamento fa sìche i monasteri femminili mostrino per così dire una “mobili-tà” diversa da quella che caratterizzava le comunità degli ordi-ni mendicanti maschili. Nel caso delle comunità femminili nonsi tratta di mobilità geografica, ma – almeno nella fase prece-dente agli anni Sessanta del XIII secolo – di una notevole ca-pacità di “spostamento” tra diverse forme istituzionali.
102 ALBERZONI, Sorores Minores cit., pp. 187-188.
FRANCESCA BARTOLACCI150
SUMMARY: The “female Franciscanism” of the beginnings can beincluded in the female religious movement – which we can also defineas the “complex world” of the mulieres religiosae - which concerns theEurope between 12th and 13th centuries. Delving into the origins ofthis complex world is no simple matter because it is difficult to fullycomprehend what these religious experiences were. The uncertaintysurrounding this issue depends not only on traditional historiographywhich traces all Franciscan foundations to saint Clare and saintFrancis, but also on the even more misleading tendency of historians toliken these religious movements a posteriori to the Clarisse order eventhough they are typologically quite different from one another and notnecessarily tied to Franciscanism in general. A local and regional lookat the issue could provide a solid basis for placing such religiousexperiences in their proper context, therefore in this paper I attempt ananalysis, through surviving documents, of six female monasteries in theMarches region: while all six fall within the same time period (between1227 and 1239, circa) and had been classified as Franciscan, they dostand out as exemplars of a deep diversity as regards their foundation,their history and their final outcome.
FRANCESCA BARTOLACCI
Università di Macerata