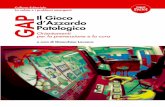Il Mare Invisibile
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Il Mare Invisibile
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ
CULTURA E RELIGIONEDELLE ACQUE
Atti del Convegno interdisciplinare«Qui fresca l’acqua mormora …» (S. Quasimodo, Sapph. fr. 2,5)
Messina 29-30 marzo 2011
a cura di
anna CalDerone
G I O R G I O b R E T S C H N E I D E R E D I T O R ER O M A • 2 0 1 2
COPYRIGHT © 2012 by GIORGIO BRETSCHNEIDER EDITOREVia Crescenzio, 43 - 00193 Roma - www.bretschneider.it
È vietata ogni forma di totale o parziale riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione, distribuzione o altro diverso utilizzo,
con qualsiasi modalità o strumento, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Editore.
Il mare InvIsIbIle. PaesaggIo e degrado nell’alto tIrreno cosentIno
Paola De SanctiS RicciaRDone
Un evento globale, una spettacolare sineddoche
roma 21 maggio 1972 ore 11 e 30, cappella della Pietà nella basili-ca di san Pietro: improvvisamente un uomo salta la balaustra e di fronte ad una attonita folla di fedeli e turisti comincia a colpire con un martello la meravigliosa Pietà di michelangelo gridando «Io sono gesù!». da allora lazlo toth, il folle australiano di origine ungherese che ha sfigurato la ver-gine, ha guadagnato una tetra ma perenne celebrità. ancora adesso, nelle enciclopedie, nei libri d’arte e anche nelle narrazioni orali delle guide tu-ristiche, il suo nome è costantemente associato a quello della famosa statua. della tragedia della Pietà parlarono i media di tutto il mondo e il fattaccio promosse un lungo dibattito sulla questione della tutela del patrimonio ar-tistico italiano (tav. XXXvI, a).
Pochi giorni dopo l’attacco, il settimanale americano Time pubblicò un saggio profetico dal titolo: «Può l’Italia essere salvata da se stessa?». secondo l’autore, il critico d’arte robert Hughes 1, la Pietà vandalizzata era in qual-che modo divenuta un campo di sineddoche dell’intero patrimonio cul-turale italiano. Hughes denunciava che già allora in Italia una significativa parte dell’architettura e dell’urbanistica storica, del patrimonio artistico, del paesaggio versava in uno stato di abbandono e deterioramento, soggetta a furti, cementificata e abbattuta «in nome del progresso». ricordava anche lo slogan di un manifesto turistico in circolazione a quel tempo che reci-tava: Visit Italy, before the Italians destroy it.
Hughes focalizzò perfettamente il cuore del problema, ovvero la mancanza di una sensibilità civica diffusa, l’estraneità sociale ed un comune sentire intor-no ai destini dell’immenso patrimonio storico-artistico e paesaggistico italiano: «come può essere salvato un patrimonio nazionale quando la stessa popola-zione non riesce a riconoscerlo come la propria insostituibile cultura?».
da allora una miriade di cloni di lazlo toth ha portato avanti il suo
1) HugHeS 1972.
Paola de sanctIs rIccIardone414
imperativo iconoclastico di sfigurare il bel Paese per eccellenza. I cloni si sono incarnati in amministratori locali e nazionali, politici, governi, impre-se di costruzioni, affiliati alle organizzazioni criminali. tuttavia, più spesso di quanto non si creda, anche semplici cittadini, comunità locali, e fram-menti consistenti della società civile assumono comportamenti che contri-buiscono al deterioramento del nostro patrimonio.
La Calabria, una sintesi dell’Italianismo
le costiere del mediterraneo spesso rappresentano una delle maggiori risorse economiche per le popolazioni locali. nell’Italia meridionale i pae-saggi marini consistono in una stupefacente combinazione di beni naturali, siti vernacolari e monumentali, depositi di patrimoni artistici, archeologi-ci e demo-antropologici. Propriamente amministrati essi potrebbero offri-re ineusaribili opportunità di lavoro, di impresa e di investimento in un quadro però di sviluppo realmente sostenibile. tuttavia invece di pianifica-re forti misure di tutela dei territori, molte zone costiere delle regioni me-diterranee, in Italia meridionale come altrove, hanno adottato una strategia di cosiddetto ‘sviluppo’ sostanzialmente basato su una rimozione collettiva dell’importanza dei loro patrimoni storici e naturali.
assieme alla liguria, la calabria ha il triste primato del consumo del suolo in Italia. nel gennaio 2010 un’ottimistica rilevazione del passato go-verno regionale 2, stimava il suo territorio martoriato da 800 milioni di me-tri cubi di edifici, ovvero 400 metri cubi per ciascun abitante: e ciò a fronte di un costante calo demografico nella regione. le più grosse responsabilità dell’ecocidio paesaggistico risiedono sicuramente nell’avidità del trasversa-le «partito del cemento» 3, la mancanza di una incisiva politica di pianifica-zione urbanistica e di controllo sull’abusivismo, forme locali e nazionali di corruzione, di lobbismo, di criminalità organizzata 4. tuttavia appare anche influente quella diffusa incapacità delle comunità locali di attribuire valo-re sociale e culturale ai propri patrimoni di cui parlava Hughes. la tutela e la difesa dei paesaggi non potrà mai essere esercitata dalle sole forze le-gislative, di polizia o giudiziarie, senza la collaborazione attiva dei cittadini e l’attribuzione ai luoghi di un significato condiviso.
La ricerca, il paesaggio e l’indifferenza
nella ricerca dipartimentale che gloria di rosa ed io stiamo condu-cendo, è stata posta sotto osservazione un’area ristretta dell’alto tirreno co-
2) Regione Calabria 2010, p. 223.3) SanSa 2010.4) SettiS 2010.
415Il mare InvIsIbIle. PaesaggIo e degrado nell’alto tIrreno cosentIno
sentino. e proprio questa area costiera mostra come il disastro paesaggisti-co sia anche il risultato di una disseminazione di piccoli e medi interventi di cosiddetta junkitecture posta in essere dalla popolazione e dalle ammini-strazioni locali, nell’illusoria speranza di raggiungere un qualche vantaggio economico a breve termine per le proprie famiglie e le comunità. l’area selezionata è quel tratto di costiera dal fiume noce fino alla cittadina di diamante e paesi limitrofi. Il fiume segna non solo in confine tra basili-cata e calabria, ma anche lo scarto visuale tra due differenti politiche del territorio. dal treno o dal mare il più virtuoso lato lucano appare sostan-zialmente tutelato, il verde dei monti e delle colline è prevalente, la costa quasi intatta, salvo poche e ben integrate costruzioni (tav. XXXvI, b). Im-mediatamente dopo il fiume, il paesaggio cambia repentinamente: lo sguar-do viene aggredito da fatiscenti edifici sulla spiaggia, antiche città compat-te circondate da un intenso sprawl urbano, il mare reso invisibile da cortine di edifici anonimi e informi, ovunque un forte inquinamento estetico pro-dotto anche dalla caotica disseminazione di insegne pubblicitarie ed infra-strutture ridondanti. lo stesso dissestato lungomare di tortora ad esempio sembra posto a difesa degli insediamenti edilizi dal mare piuttosto che per il godimento pubblico del mare (tav. XXXvI, c).
nel tratto costiero della nostra ricerca, la malavita organizzata, pur se presente, non è così invasiva come in altri luoghi della regione, come mo-strano ad esempio gli stessi rapporti della direzione Investigativa antimafia 5. Qui emerge con maggiore evidenza il ruolo degli abitanti e delle comuni-tà amministrative locali nella gestione (abbastanza autonoma) del paesaggio costiero, non essendo sottoposti ad un capillare mobbing territoriale da par-te delle ‘ndrine. abbiamo effettuato interviste e liberi colloqui con semplici cittadini, operatori turistici, commercianti, imprenditori immobiliari e po-litici locali, per sondare il grado di indifferenza socio-culturale rispetto al degrado urbanistico delle zone costiere. abbiamo inoltre raccolto del ma-teriale iconografico dello stato dei luoghi nel passato per confrontarlo con la situazione attuale (tav. XXXvII, a, b).
la prima fase della ricerca si è basata su un modello top-down di in-dagine: abbiamo estratto alcuni concetti convenzionali e ufficiali di paesag-gio così come sono stati elaborati ed utilizzati dall’Unesco, dal WWF e da altre associazioni non-profit per la tutela dei territori. Punto di partenza certamente è il concetto di ‘paesaggio culturale’ elaborato dall’Unesco nel 1972, inteso come «azione combinata della natura e dell’uomo» che poi diventò la piattaforma legale internazionale per l’identificazione e la difesa dei territori, con l’elaborazione di linee-guida per la loro eventuale inclu-sione nella ‘lista dei Patrimoni dell’Umanità’.
In Italia l’associazione legambiente, creata nel 1980 a seguito dei mo-
5) DIA 2008, pp. 90-171.
Paola de sanctIs rIccIardone416
vimenti antinucleari, produce dei dossier annuali sullo stato di salute, an-che estetica, dei nostri mari e delle nostre costiere, sui dissesti idrogeologi-ci, sul consumo del suolo, sull’abusivismo e quant’altro. molto interessanti sono stati, ai fini della nostra ricerca, le notazioni sulla calabria degli ulti-mi anni 6. l’immenso consumo del suolo ad opera dell’urban sprawl o città sdraiata 7, si affianca alla costruzione di numerosi cosiddetti ‘ecomostri’ che deturpano ed occultano irrimediabilmente le tradizionali visuali marine, ov-vero quei famosi panorami calabresi che affascinavano i viaggiatori dei secoli scorsi. la bulimia di cemento non ha specifiche ragioni in bisogni concre-ti, perché il mercato immobiliare nelle zone costiere è certamente sovradi-mensionato rispetto alla domanda, sia per l’acquisto sia per l’affitto. Infatti il trend demografico in calabria è in declino, i flussi turistici – sia interni che esterni – tendono ad oscillare verso la decrescita, mentre i dati più scon-fortanti riguardano la permanenza media e la qualità dei flussi stagionali 8. Inoltre diversi studi di economisti ed urbanistici dimostrano che nonostan-te i relativi guadagni a brevissimo termine, l’overbuilding produce in realtà una progressiva svalutazione dell’intero patrimonio immobiliare in calabria come altrove 9. Questi concetti e rilevazioni top-down, se messi in relazione con l’indagine bottom-up, sembrano arenarsi in una diffusa impermeabilità sociale. scarsamente conosciuti o apprezzati dalle popolazioni locali, spes-so suscitano negli interlocutori, soprattutto se impegnati in qualche settore imprenditoriale, un sentimento di diffidenza: come se le denunce e i mo-niti degli ambientalisti fossero un ulteriore ostacolo alla realizzazione di un non meglio specificato ‘sviluppo’ della regione. Un tratto culturale abba-stanza diffuso è la sostanziale indifferenza nei confronti dell’inquinamento estetico e visuale di cui soffrono le costiere. Persino nelle più sensibili per-sonalità intervistate, le maggiori preoccupazioni riguardano i rischi idrogeo-logici legati al consumo del suolo, l’inquinamento chimico e organico del mare, la qualità delle acque, le infiltrazioni del crimine organizzato nel set-tore edilizio e nelle amministrazioni locali, le conseguenze che una scarsa tutela dei territori possono rappresentare nei confronti della salute pubbli-ca, della biodiversità, dell’agricoltura locale.
Scheletri di cemento, arte, satira ed un’antinomia
le curiose istallazioni che l’artista slovena marjetica Potrc porta in giro per tutto il mondo raccontano con ironia e disincanto le nuove forme co-
6) Legambiente 2008, 2009, 2009a, 2011.7) gibelli, Salzano 2006.8) Regione Calabria 2010, p. 22.9) ciccone 2005; Scaglione 2006.
417Il mare InvIsIbIle. PaesaggIo e degrado nell’alto tIrreno cosentIno
struttive di quella architettura marginale e spontanea realizzata dal basso come pratica di sopravvivenza, anche tecnologica, delle comunità più po-vere, in slovenia come in america latina o in Florida. al maXXI (museo nazionale delle arti del XXI secolo, roma) nel 2010 ha installato un’em-blematica ‘casa permanentemente non finita’, con tanto di pali in attesa di future sopraelevazioni e un albero sintetico che però nasconde un’antenna per telefoni cellulari (tav. XXXvIII, a).
non siamo nelle periferie di caracas, ma in calabria la cementifica-zione si accompagna spesso ad una disseminazione di edifici in costruzione che imprimono ai territori costieri una ulteriore lesione estetica. la tem-poralità è spesso trasformata in condizione perenne, come nelle istallazioni di marjetica Potrc. gli abitanti convivono quasi ovunque e senza apparen-te disagio con scheletri di cemento dai pali in attesa che svettano verso il cielo con i loro tondini a testimonianza di future e forse improbabili so-praelevazioni. la coabitazione indifferente con la non finitezza, il caos ur-banistico e l’inquinamento estetico, sembra quasi l’effetto di una sorta di mitridatizzazione sociale, dopo decenni di continui abusi e sfregi urbanisti-ci: quasi una reificazione, in chiave paesaggistica, della fortunata teoria so-ciologica della ‘finestra rotta’ dal sasso di un teppista, che se non riparata immediatamente innesca fenomeni di emulazione e dà luogo ad una spira-le distruttiva dei territori 10.
la non finitezza dello sprawl in calabria è uno dei target della satira ci-vile di antonio albanese quando interpreta il losco ma vincente onorevo-le cetto la Qualunque. molte delle sue promesse elettorali vertono sul-la desertificazione dei territori («Un pilastro di cemento armato per ogni bambino che nasce»).
abbastanza sorprendentemente persino la mafia siciliana, che pure non è mai stata troppo rispettosa del paesaggio e dei territori, sembra sbef-feggiare in qualche caso l’eccessiva predilezione per il cemento dei ‘cugi-ni’ della ‘ndrangheta. In una recente intercettazione della polizia canadese che si occupa delle infiltrazioni oltreoceano delle cosche siciliane, due af-filiati del potente clan rizzuto parlano di un gangster calabrese: «Ho appe-na finito di parlare con quel ‘negro’ sì, hai capito, quello con la testa pie-na di cemento» 11.
comunque, al di là dei loschi affari dei clan, il disastro territoriale in calabria non sarebbe stato possibile senza una diffusa mancanza di apprezza-mento nei confronti dei paesaggi culturali che un tempo conferivano iden-tità ai luoghi. I filamenti continuativi dello sprawl urbano che asserragliano il mare e le costiere, si accompagnano a forme di disaffezione nei confronti delle antiche città compatte, dell’architettura vernacolare e dei tradizionali
10) WilSon, Kelling 1982.11) tonDo 2010, p. 37.
Paola de sanctIs rIccIardone418
modelli abitativi (che al contrario sono apprezzati dai non residenti). Que-sta disaffezione ha prodotto l’abbandono dei centri storici 12, spesso sfigu-rati da nuove anonime e intrusive insersioni edilizie prive di qualsiasi con-testuale armonia col tessuto urbano preesistente. la negligenza sociale nei confronti di alcuni aspetti della cultura materiale è di difficile interpretazio-ne. In qualche modo collide con l’immagine esterna di una calabria for-temente ancorata alle proprie tradizioni. In effetti ancora oggi, anche nei tratti costieri, si celebrano numerose feste patronali, pellegrinaggi con mi-gliaia di partecipanti locali e forestieri 13. le tradizioni culinarie e la musi-ca popolare sono sostanzialmente conservate, rivisitate e spesso utilizzate, a diamante e altrove, come nuove forme di branding territoriale per attrar-re turisti. Ugualmente il dialetto e le inflessioni tipiche della langue locale sono mantenuti con orgoglio.
La via calabrese alla pulizia spaziale
In un suo saggio dedicato allo spazio, al potere e alle politiche nazio-nali, michael Herzfeld 14 sostiene che «la fisicità dell’ambiente edificato ha una forte relazione diretta con le ideologie che lo circondano». Parlando a proposito della modernizzazione spaziale in grecia e in tailandia, lo stu-dioso rintraccia nell’arrivo di architetti e pianificatori un aspetto di cripto-colonialismo che in qualche modo ha inteso cancellare molte tracce visuali del vecchio ‘orientalismo’ urbanistico: città compatte, mercati pubblici, vi-coli stretti ed affollati, stradine tortuose ed altri spazi che possano rimanda-re ad un modello urbano di suq orientale. Questo processo ha generato un non sempre volontario spostamento territoriale delle popolazioni residen-ti, ovvero una sorta di evacuazione socio-culturale dagli antichi luoghi. In qualche modo l’‘occidentalismo’ urbanistico e l’adesione ad un facile mo-dello di modernizzazione, ha creato una «pulizia spaziale» nei paesaggi, che Herzfeld 15 mette in parallelo con la pulizia etnica.
In calabria la pulizia spaziale è un processo iniziato massivamente negli anni settanta del secolo scorso, posto in essere in forma anarchica da mol-teplici forze sociali, ma senza alcuna pianificazione urbanistica o interventi architettonici razionali e di qualità. Per le popolazioni e le amministrazio-ni locali il processo è stato inteso come una forma di ‘sviluppo’ per buttar-si alle spalle la povertà dei decenni e dei secoli passati. Infatti la calabria, secondo molti rilievi statistici ufficiali, ha il più basso reddito pro capite in
12) teti 2004.13) Faeta, Ricci 2007.14) HeRzFelD 2006, p. 128.15) HeRzFelD 2006, p. 132.
419Il mare InvIsIbIle. PaesaggIo e degrado nell’alto tIrreno cosentIno
Italia. Inoltre negli scorsi secoli la regione ha registrato imponenti fenome-ni di emigrazione. e ancora adesso il suo prodotto interno lordo si posi-ziona al fondo alla classifica regionale italiana 16, sebbene quest’ultimo dato sia particolarmente controverso a causa degli introiti occulti della malavita organizzata e della forte evasione fiscale.
diversamente da quanto osservato da Herzfeld ad esempio nell’antico rione monti di roma, l’evacuazione dei residenti dai centri storici in ca-labria è avvenuta volontariamente e non come conseguenza di un processo di gentrificazione. la rimozione collettiva del valore dei luoghi tradiziona-li sembra anche essere una conseguenza della necessità di allontanare ogni traccia materiale della passata povertà, di cui le piccole ed insalubri case dei centri storici costituivano il principale stigma sociale. Una chiave lontana di interpretazione della disaffezione sociale nei confronti dei tradizionali pae-saggi culturali può rintracciarsi ad esempio nel viaggio in calabria di cate-rina Pigorini beri 17, la quale mentre si impietosiva per l’angustia dei ‘tuguri’ insalubri in cui vedeva vivere i calabresi più poveri, rammentava saggiamen-te «l’emigrazione delle povere plebi, che in tanta copia di terreno ferace e libero non trovano un metro quadrato di terra neppure per esservi seppel-lite». l’occidentalismo spaziale, pur nella sua forma più degradata di subur-bio urbano intensivo, è stato comunque vissuto come una forma di riscat-to sociale accompagnato dal rifiuto delle tradizionali ‘figure’ paesaggistiche vernacolari in cui si consumava l’antico sfruttamento.
oggi si assiste in qualche modo ad una inversione di tendenza e nei programmi elettorali non c’è candidato a sindaco che non prometta riqua-lificazioni e ripopolamento dei centri storici, a diamante come a san ni-cola arcella o a tortora. ma sovente si tratta di richiami di maniera, artifici retorico-sentimentali per catturare il consenso, che difficilmente si accom-pagnano a incisive politiche di risanamento territoriale, mentre la corsa alla cementificazione delle coste continua senza sosta.
l’illusoria equazione che il cemento sia uguale a sviluppo sembra una forma di equivocazione o allodoxia culturale, nel senso di eterodossia vis-suta come ortodossia nella definizione di bourdieu 18. Infatti molti studi 19 su turismo e sviluppo mostrano che la conservazione del patrimonio cul-turale, del paesaggio, dei siti vernacolari e monumentali contribuiscono a rafforzare l’immagine della destinazione, ad aumentare i flussi turistici più qualificati e a richiamare investimenti. ad esempio il cosiddetto Chiantishire in toscana ha basato la sua opulenza finanziaria, immobiliare e di impresa nella creazione di un forte branding territoriale basato sulla caratterizzazio-
16) SVIMEZ 2010.17) PigoRini beRi 1892, p. 70.18) bouRDieu 1979/1983, pp. 326-328.19) cHHabRa, Healy, SillS 2003; HamPton 2004; PoRia, ReicHel, biRian 2006.
Paola de sanctIs rIccIardone420
ne dei luoghi e dei prodotti. accurate strategie di investimenti, sia nazionali che internazionali, hanno per lo più difeso il territorio e il paesaggio cul-turale, mantenendo lo stile delle antiche fattorie, dei piccoli centri urbani, delle case vinicole. Il Chiantishire è in qualche modo un ‘costrutto sociale’, se vogliamo una autenticità ‘messa in scena’ per usare l’espressione di mac-cannell 20, i cui pionieri sono stati gli investitori inglesi 21.
Postfamilismo e sacrificio del mare
nel luglio del 2010, ho avuto un colloquio con Franco (il nome è di fantasia), un imprenditore locale sulla quarantina. grandissimo lavoratore, non ha alcuna contiguità con la malavita, né con affari illegali (salvo for-se il ‘normale’ abusivismo edilizio). È infatti proprietario di un enorme ul-tradecennale scheletro di cemento che distrugge la vista panoramica del mare in un angolo di san nicola arcella, un delizioso paese costiero (tav. XXXvIII, b). non ha voluto che lo registrassi, né che lo riprendessi in vi-deo. tuttavia mi ha autorizzato ad usare per la ricerca i miei appunti scrit-ti. a proposito dello scheletro mi dichiara subito che è stato un errore, ma un errore finanziario, un cattivo investimento. aveva tanti progetti sulla sua destinazione, ma poi i soldi per completarlo sono finiti e quindi ha inten-zione di venderlo quanto prima. gli domando: «e che ne pensa di abbat-terlo?». mi risponde: «state scherzando? costerebbe troppo». Io ribatto ti-midamente che anche il paesaggio ha un valore, e la sua sfigurazione ha un suo costo sociale che si riversa su tutta la comunità. taglia corto sulle que-stioni ambientaliste sostenendo che la calabria non può permettersi il lus-so di fermarsi, e cioè che la conservazione dei luoghi non può essere un ostacolo allo sviluppo e alla lotta contro la povertà. e a quel punto inizia a parlarmi della sua famiglia: suo padre ha lasciato a lui e ai suoi fratelli del-le proprietà e loro debbono andare avanti, loro hanno il dovere di miglio-rare la situazione economica della famiglia rispetto a come l’aveva lasciata il padre. ciascun fratello conduce infatti con successo piccole imprese che riguardano il mare, stabilimenti, pesca, rimessaggio, barche, affitto di boe e custodia di natanti nel porticciolo.
Il riferimento alla famiglia come principale valore sociale in qualche modo sembra rimandare al famoso studio di edward banfield 22 sul ‘fami-lismo amorale’, concetto elaborato per un paesino della vicina basilicata. tuttavia molte cose sono cambiate da allora. anche il ‘familismo amora-le’, in passato confinato nell’ambito della subalternità contadina, è ora con-
20) maccannell 1973.21) King, WaRneS, WilliamS 2000, p. 154.22) banFielD 1958, 2006.
421Il mare InvIsIbIle. PaesaggIo e degrado nell’alto tIrreno cosentIno
testualizzato in cornici sociali del tutto differenti. Il nuovo post-familismo ha oggi una rilevanza mai vista prima in calabria come nel resto dell’Ita-lia. scavalcati i ghetti delle enclavi contadine come difensiva ‘base mora-le’ dell’arretratezza, a dirla con banfield, esso tende ad assumere una valen-za egemonica e influenza politiche nazionali e locali, media, mercato del lavoro, investimenti e – ahinoi – persino il sistema universitario. Il nostro imprenditore Franco ad esempio esprime con chiarezza il passaggio dalla subalternità all’egemonia: lui aveva già un fratello nella passata giunta comu-nale, tuttavia stava pianificando di entrare lui stesso in politica per le pros-sime elezioni. l’intento di questa «discesa in campo» mi è stato esplicitato con serenità: spingere il comune a realizzare un porticciolo turistico nel meraviglioso golfo naturale di san nicola arcella. Il progetto è fortemente avversato da WWF e legambiente, ma, secondo Franco, le preoccupazio-ni, a suo avviso infondate, degli ambientalisti sono quasi forme di oscuran-tismo che vogliono impedire lo sviluppo al paese: «Il porticciolo è nell’in-teresse della mia famiglia, certamente, ma tutta san nicola guadagnerà dal progetto». nelle elezioni ultime del maggio 2011 peraltro il candidato a sindaco cui si era legata la famiglia di Franco è stato sconfitto da barbara mele, la prima donna sindaco nella storia del comune. anche lei ha pro-messo riqualificazione del centro storico e tante altre belle cose (capitolo a parte e di futura indagine sono i dibattiti locali sull’istallazione di pale eo-liche). andando in giro da ficcanaso (il vero mestiere dell’antropologo) a registrare nei bar e nei capannelli i commenti degli avversari, si maligna di un’altra vittoria ‘familiare’, ma lei promette – come d’abitudine – di essere «il sindaco di tutti». anche san nicola arcella sta diventando un informe e filamentoso agglomerato di cemento con villettopoli a iosa. vedremo se la giovane prima cittadina riuscirà a fermare la diarrea urbana e a restitui-re decoro al suo paese.
l’invisibilità sociale della originaria bellezza del paesaggio costiero ca-labrese, sembra in qualche modo legata ad un diffuso analfabetismo este-tico, che è rilevante anche negli interni domestici, negli arredi urbani, nei negozi, bar, ristoranti e anche negli edifici pubblici di recente costruzio-ne. come se il cosiddetto sviluppo economico fosse stato realizzato in una condizione di cecità rispetto a quelle caratteristiche identitarie dei territo-ri che invece furono gli elementi di attrazione dei tour e dei flussi turisti-ci dei secoli addietro. molti degli investitori (anche campani) e operatori che costruirono infrastrutture per la ricezione turistica o per l’utenza loca-le, non furono capaci di identificare, come invece in qualche modo è acca-duto nella vicina costiera lucana, la grammatica visuale dei paesaggi e dei territori originari. ancora oggi si può dire che gli interventi di investimen-to non sono guidati da alcun modello qualificato che possa veramente va-lorizzare, anche finanziariamente, i territori.
In realtà l’architettura vernacolare in calabria ha una forte caratterizza-
Paola de sanctIs rIccIardone422
zione agro-pastorale 23. salvo per alcune eccezioni, nei paesi costieri, seppur puntati da elementi monumentali che riguardano il mare (torri, roccafor-ti, residenze storiche), si nota l’assenza di una tipicità vernacolare marina, come può essere osservata nelle Isole eolie o nella costiera amalfitana, dove la cementificazione, pur presente, ha tentato di conformarsi ad una qualche stilistica locale. l’assenza di bueprints, anche di importazione, ha consenti-to sia l’overbuilding, sia l’inquinamento estetico e visuale dei territori. Fuo-ri da qualsiasi parametro costruttivo di stile mediterraneo, anche puramen-te di maniera, i territori costieri calabresi sono stati vinti dal ‘colonialismo’ occidentalistico della più anonima degradazione urbana.
Gli oltraggi di Subtopia
Jan nairn 24 è stato un eroico ed inascoltato giornalista di architettu-ra che ha denunciato precocemente la tendenza all’urban sprawl in europa e nella sua Inghilterra in particolare. con il termine ‘subtopia’ (suburbio idea lizzato) ha identificato quei territori senza alcuna distinzione tra luoghi, tipi di ambiente, città e campagna. In qualche modo prefigurò il fortuna-to concetto di ‘non luoghi’ elaborato da marc augé 25 e comprese a fondo gli ‘oltraggi’ sul paesaggio prodotti dall’urban sprawl e dall’inquinamento vi-suale, anche negli arredi urbani e nella disseminazione della segnaletica via-ria e pubblicitaria. breheny 26 sostiene che nairn si preoccupava anche di un problema strettamente antropologico-culturale ovvero che «la subtopia avrebbe prodotto subtopiani: persone così assuefatte alle nuove configura-zioni da perdere ogni facoltà critica».
Il radicamento sociale dello sguardo critico e attento sul paesaggio è in-vece sostanziale per la tutela dei patrimoni e di una (più o meno ‘inventa-ta’) identità dei luoghi. secondo rachel de sousa vianna 27: «l’analfabetismo visuale impedisce alle persone di percepire la qualità estetica del loro am-biente» e in qualche modo influisce sulla stessa qualità della vita. In Italia, in grecia, come in spagna, gli strumenti per un recupero a medio e lungo ter-mine delle coste mediterranee sfigurate dal cemento, devono comprendere anche degli sforzi ‘pedagogici’, sin dalle scuole dell’obbligo, per innalzare il grado di consapevolezza delle comunità locali. molti studiosi di diverse di-scipline, come si evince proprio dal saggio di de sousa vianna 28, sostengo-no che l’educazione visuale di massa è un mezzo per migliorare la qualità
23) Faeta 1984.24) naiRn 1955.25) augé 1992.26) bReHeny 2002, pp. 18-19.27) Vianna 2002, p. 225.28) Vianna 2002, p. 256.
423Il mare InvIsIbIle. PaesaggIo e degrado nell’alto tIrreno cosentIno
estetica e sociale del paesaggio. d’altro canto, storici dell’arte, archeologi e antropologi hanno sottolineato che l’idea stessa di paesaggio (dai contorni molto sfumati) è tutt’altro che un dato spontaneo, ma un costrutto socio-culturale 29. In qualche modo questa idea ha le sue radici nella storia del-la modernizzazione in occidente ed ha molto a che fare con i percorsi del gusto pittorico 30 e la cultura materiale locale 31.
la calabria è popolata da molteplici subtopiani, portatori spesso incon-sapevoli della ‘sindrome di lazlo toth’. la loro azione devastante sulla re-gione andrebbe contrastata con mezzi legali e repressivi molto più severi di quelli in campo, tuttavia è anche importante sondare i percorsi storici e culturali che li hanno formati, sentire le loro voci e cercare di interpre-tarne le ragioni.
abbReViazioni bibliogRaFicHe
augé 1996 = m. augé, Nonluoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, mi-lano 1996 (19921).
banFielD 2006 = e. c. banFielD (con lauRa FaSano), Le basi morali di una società ar-retrata, bologna 2006 (19581).
bouRDieu = P. bouRDieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, bologna 1983 (19791).
bReHeny 2002 = m. bReHeny, Centrists, decentrists and compromisers: View on the future of urban form, in The compact city. A sustainable urban form?, a cura di m. Jens, e. bur-ton, K. Williams, london 2002, pp. 13-45.
mac cannel 1973 = D. mac cannel, Staged Authenticity: Arrangements of social spaces in tourist settings, «american Journal of sociology» lXXIX (3), 1973, pp. 589-603.
cHHabRa, Healy, SillS 2003 = D. R. cHHabRa, R. Healy, e. SillS, Staged authenticity and heritage tourism, «annals of tourism research» XXX (3), 2003, pp. 702-719.
ciccone 2005 = F. ciccone, Le diseconomie della seconda casa, 2005. http://eddyburg.it/articleview/3307/0/124
coSgRoVe 2006 = D. coSgRoVe, Modernity, community and the landscape idea, «Journal of material culture» XI (1/2), 2006, pp. 49-66.
De SuSa Vianna 2002 = R. De SuSa Vianna, Art education and urban aesthetics, «leonar-do» XXXv(3), 2002, pp. 255-261.
DIA = direzione Investigativa antimafia, Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia. 1° se-mestre 2008. http://www.interno.it/dip_ps/dia/pagine/semestrali.htm
29) coSgRoVe 2006, pp. 49-51.30) loWentHal, PRince 1965.31) gRotH, bReSSi 1997.
Paola de sanctIs rIccIardone424
Faeta 1984 = F. Faeta (a cura di), L’architettura popolare in Italia. Calabria, bari 1984.Faeta, Ricci 2007 = F. Faeta, a. Ricci, Le forme della festa. roma 2007.gibelli, Salzano 2006 = No Sprawl, a cura di m. c. gibelli, e. salzano, Firenze
2006.gRotH, bReSSi 1997 = Understanding Ordinary Landscapes, a cura di P. groth, t. W. bres-
si, new Haven and london 1997.HamPton 2004 = m. P. HamPton, Heritage, local communities and economic development,
«annals of tourism research» XXXII (8), 2004, pp. 735-759.HeRzFelD 2006 = m. HeRzFelD, Spatial cleansing monumental vacuity and the idea of the
west, «Journal of material culture» XI (1/2), 2006, pp. 127-149.HugHeS 1972 = R. HugHeS, Can Italy be saved from itself ?, «time», 5 giugno 1972.
http://www.time.com//time/magazine/articleISTAT = Istituto nazionale di statistica, XIV Censimento Generale della Popolazione e
delle Abitazioni, 2001. http://dawinci.istat.itLegambiente 2008 = Dossier Mare Monstrum. http://www.legambiente.eu/documenti/
2008/0625mareLegambiente 2009 = Tutti giù per terra. Viaggio nel Paese degli ecomostri e del cemento sel-
vaggio. http://www.legambiente/risorse.itLegambiente 2009° = Ecosistema Rischio Rapporto Frane. http://www.legambiente.eu/do-
cumenti/2009/1007Legambiente 2011 = Acque Nere. Dossier sulla mala depurazione in Calabria, catanza-
ro 2011.loWentHal, PRince 1965 = D. loWentHal, H. c. PRince, English landscape tastes, «geo-
graphical review» lv (2), 1965, pp. 186-222.naiRn 1955 = J. naiRn, Outrage, Westminster 1955.PoRia, ReicHel, biRan 2006 = y. PoRia, a. ReicHel, a. biRan, Heritage site manage-
ment: motivations and expectations, «annals of tourism research» XXXIII (1), 2006, pp. 162-178.
Regione Calabria = Decimo rapporto sul turismo. cosenza 2010.SanSa 2010 = La colata. Il partito del cemento che sta cancellando l’Italia e il suo futuro, a
cura di F. sansa, milano 2010.Scaglione 2006 = P. Scaglione, Nuovi territori. Verso l’innovazione in Calabria, roma
2006.SettiS 2010 = S. SettiS, Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l’ambiente con-
tro il degrado civile, milano 2010.SVIMEZ = Rapporto SVIMEZ 2010 sull’economia del Mezzogiorno, roma 2010.teti 2004 = V. teti, Il senso dei luoghi. Memoria e storia dei paesi abbandonati, roma
2004.tonDo 2010 = l. tonDo, Mafia vs ’Ndrangheta, «Il venerdì» di Repubblica, 19 marzo
2010, pp. 34-37.UNESCO = Cultural Landscape, 2010, http://whc.unesco.org/en/culturallandscape
TAV. XXXVI DE SANCTIS RICCIARDONE - IL MARE INVISIBILE
a)
b)
c)
a) Lazlo Toth sfigura la Pietà; b) Foce del fiume Noce: il versante lucanoc) Foce del fiume Noce: il versante calabrese
TAV. XXXVIIDE SANCTIS RICCIARDONE - IL MARE INVISIBILE
a-b) Sprawl costiero e degrado urbanistico
a)
b)