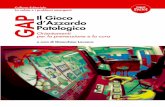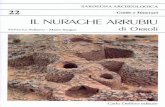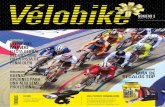Il ciclismo tra il gioco e lo sport
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Il ciclismo tra il gioco e lo sport
Mariano Fresta
IL CICLISMO FRA IL GIOCO E LO SPORT
«Il libro da leggere appartiene a quei miracoli di una tecnologia eterna di cui fan parte la ruota, il coltello, il cucchiaio, il martello, la pentola,
la bicicletta. Il coltello viene inventato prestissimo, la bicicletta assai tardi. Ma per tanto che i designer si diano da fare, modificando qualche particolare,
l’essenza del coltello rimane sempre quella…. Potete inventare un sistemadi cambi sofisticatissimo, ma la bicicletta rimane quel che è, due ruote,
una sella e i pedali. Altrimenti si chiama motorino ed è un’altra faccenda».
Da U. ECO, Libri da consultare e libri da leggere, in Libri e biblioteche, a cura di L. Canfora, Sellerio, Palermo 2002, pp. 110-111.
1.- Premessa1
Come testimoniano ampiamente i saggi di Hermann Bausinger, contenuti nel volume La cultura dello sport (2008), e la relativa Introduzione di Alessandro Simonicca, i giochi e gli sport sono stati spesso oggetto di studio e di riflessione da parte degli antropologi, sia per quanto riguarda le popolazioni etnologiche2, sia per quanto riguarda il mondo occidentale industrializzato. Più recentemente ad attirare l’attenzione di storici e antropologi sono stati i Giochi Olimpici e soprattutto il gioco del calcio3, la cui pratica richiama, in alcuni casi, aspetti di rituali bellici e, in altri, forme rituali religiose che, entrambi, «connettono il gioco-sport alla società nel suo complesso come interazione di sistemi di azione fra giocatori e pubblico, istituzioni e management sportivo, riti di gruppo e di passaggio di stadi della vita, condensazione di simboli e identificazione soggettiva» 4.
Il ciclismo, invece, sembra non sia stato capace di attirare l’attenzione degli antropologi europei, se non per rapidissimi cenni; qualche anno fa se ne è occupato lo storico Daniele Marchesini (1996), che ha tracciato una particolare storia d’Italia del Novecento attraverso la storia del Giro ciclistico. Probabilmente questa disattenzione nei confronti del ciclismo è dovuta al fatto che questo sport si manifesta essenzialmente come un’attività individualistica: le squadre che si affrontano nelle gare hanno comportamenti diversi rispetto a quelle di altri sport, e inoltre non c’è, almeno apparentemente, quella contrapposizione tra squadre avversarie che caratterizza i giochi che hanno una lontana origine rituale. Tra l’altro, il ciclismo non si pratica, a parte quello su pista, né negli stadi né in luoghi ben delimitati e chiusi, ma si disperde per campagne e città e non permette che una visione fuggevole non solo agli eventuali antropologi osservatori, ma anche agli stessi suoi tifosi e agli spettatori in genere. In compenso, almeno per quanto riguarda
1 Ringrazio qui Pietro Clemente, Paolo De Simonis , Alessandro Simonicca e Massimo Pirovano per la pazienza e la disponibilità con cui hanno seguito e letto questo mio lavoro e per i suggerimenti che mi hanno generosamente elargito.2 Una discreta sintesi di questi studi si trova nella “Garzantina” sullo Sport 2008, nelle schede Antropologia (p. 44 e sg.) ed Etnologia (p. 442 e sg.) entrambe di mano di M. Martini.3 Tralasciando la bibliografia, molto estesa, riguardante i Giochi Olimpici, si ricordano qui gli studi sul calcio pubblicati in Italia: quelli di A. Del Lago 1990, di Ch. Bromberger 1999 e di F. Dei, Il calcio: una prospettiva antropologica, in «Ossimori», 1992,1: 5 . 4 Simonicca, in Bausinger 2008:21.
1
l’Italia, il ciclismo ha interessato molti letterati (si vedano, per esempio: lo straordinario romanzo di Giovanni Testori, Il dio di Roserio, in Opere 1943-6, 19965, e il più recente, Roberto Piumini, Il ciclista illuminato, 1994), e poi molti scrittori che, a cominciare dalla fine dell’Ottocento, hanno seguito come inviati di alcuni quotidiani il Giro d’Italia (tra i più vicini a noi, Manlio Cancogni, Vasco Pratolini, Anna Maria Ortese, Dino Buzzati, Alfonso Gatto, Cesare Zavattini, Achille Campanile), nonché molti famosi giornalisti-scrittori, come Orio Vergani, Indro Montanelli, Gianni Brera, Enzo Biagi, Sergio Zavoli, ecc.6
In queste mie brevi riflessioni, che riguardano quasi esclusivamente la situazione italiana, affronterò solo sommariamente l’aspetto del ciclismo più noto e vistoso che è quello dell’attività professionistica, del ciclismo cioè di alto livello, e che è la costituente fondamentale delle grandi corse a tappe e delle corse in linea chiamate “classiche”; non mi riferirò affatto al ciclismo agonistico giovanile, degli “allievi” e dei “dilettanti”, (categoria quest’ultima ormai abbandonata e sostituita dalla “under 23”), che tendono al professionismo7; mi occuperò, invece, un po’ più a lungo, dell’attività di livello più basso, quella del ciclismo “amatoriale”, o, per evitare equivoci che questo aggettivo comporta per il suo significato nelle lingue inglese e francese, del cicloturismo8, su cui, per altro, fortemente si riverbera la pratica professionistica. E questo per almeno due ordini di motivi: primo, perché a questo livello è possibile cogliere meglio i modi e l’entità della diffusione di una “cultura” ciclistica; in questa attività, infatti, sono impegnati ragazzi, giovani e soprattutto adulti ed anziani che hanno la passione della bici e che cercano di acquisire e mantenere un certo benessere fisico. E’ pur vero che in questa categoria si trovano anche quelli che hanno tentato la carriera di allievi, di dilettanti e di professionisti senza però riuscire ad avere successo. Costoro, pur essendo i più forti atleticamente (vincono quasi tutte le gare riservate agli “amatori”), e pur riflettendo la mentalità del mondo professionistico, non sono ideologicamente egemonici: la maggioranza degli “amatori”, infatti, va in bicicletta soprattutto per motivi di benessere fisico e per divertimento e di essa solo una piccola minoranza partecipa alle gare proprie di questo settore.
Il secondo motivo per cui ho scelto di osservare questo particolare aspetto del ciclismo dipende dal fatto che da molti anni anch’io la pratico. E qui si pone una questione metodologica. Nella sua Introduzione al testo di Bausinger 2008, Simonicca (p. 17 e sgg.), ricordando che R. Sand e L. Wacquant passarono tre anni il primo come giocatore in una squadra di football e l’altro presso un club di boxe, per studiare meglio il gioco e capirne le valenze culturali per poterle descrivere, ricorda che in questo modo la prassi dell’osservazione partecipante teorizzata da Malinowski, veniva rovesciata in quella della partecipazione osservante9. Questo rovesciamento comporta rischi di errore nella valutazione antropologica di un fenomeno culturale? Secondo Malinowski un osservatore che non solidarizzi con la cultura delle persone che studia non può ritenere che gli esiti della sua ricerca siano corretti e sufficienti; ma un partecipante a tutti gli effetti di una pratica rituale o sportiva o, in senso ampio, culturale, può essere un osservatore tale da riuscire a dare di essa una descrizione senza che questa sia inficiata dalle passioni e dai pregiudizi di chi c’è dentro in maniera totale? Per mettere le mani avanti e per giustificare qualche mio eventuale giudizio partigiano, confesso che ho passato più di venti anni tra i cicloturisti, partecipando a molti raduni ed anche a qualche gara; ma quando ho iniziato questa attività era ben lontana da me l’idea di riflettere e scrivere su questo sport. Poiché ho 5 Nel romanzo si racconta di una gara ciclistica e del duello tra due corridori. La novità stilistica e narrativa di Testori sta nel fatto che chi narra è la stessa persona che sta gareggiando. Il lettore ha così la medesima visione della strada e della corsa che ha l’atleta che le affronta.6 Sul rapporto letteratura-ciclismo, si veda Brambilla 2007, che ne fa una storia breve ma esauriente e soprattutto di piacevole lettura. Nel suo volume si trovano molte altre indicazioni bibliografiche riguardanti il tema.7 Su dilettantismo e professionismo si veda di M. Martini la scheda relativa in Sport 2008: 384 e sgg.8 Anche il termine “cicloturismo” è improprio, perché di fatto esso indica quel turismo, promosso dal Touring Club Italiano più di un secolo fa, che usava come veicolo di spostamento non l’automobile ma la bicicletta. Qui, per semplificare il tutto, userò indifferentemente i termini “cicloturismo” e “ciclismo amatoriale” per indicare la stessa attività.9 Simonicca a questa metodologia di ricerca dà il nome di “etnografia esperienziale”.
2
cominciato a praticare questo tipo di ciclismo quando ero ormai piuttosto adulto, in un primo tempo la mia osservazione era principalmente diretta a capire come si sta in gruppo, a saper mantenere la distanza di pochi centimetri tra una bicicletta e l’altra per evitare di cadere e far cadere, come affrontare le curve e le salite, come e quando agire sul cambio, come vestirsi per ripararsi dal vento, come riuscire a fare la “pedalata rotonda”10. In sostanza si trattava di un’osservazione “tecnica”, finalizzata ad una corretta attività sportiva e a non fare magre figure; l’osservazione di carattere antropologico è venuta dopo, quando, ormai esperto dello stare in gruppo e capace di dosare le mie forze, potevo rivolgere l’attenzione ad altri comportamenti.
2.- Dal gioco allo sport, dal dilettantismo al professionismo
E’ ormai assodato che giocare è una delle attività che accomuna tutto il genere umano: un’attività che ai nostri occhi appare sui generis perché essa, al contrario di tutte le altre, è, per dirla in sintesi con l’aiuto di Huizinga (2002) e di Caillois (1981), totalmente libera perché nessuno è obbligato a parteciparvi; è improduttiva perché non crea né beni né ricchezze; non è affatto necessaria tranne che non si tratti di esercizi fisioterapici; non ha scopi pratici ed è, infine, del tutto fittizia, nel senso che, come dice Bateson (1996), durante il gioco ognuno assume ruoli e comportamenti diversi da quelli della vita quotidiana. Nonostante ciò, l’antropologia, la pedagogia e la psicologia la ritengono fondamentale nei processi di formazione; addirittura Huizinga ne parla come di un complesso sistema culturale, ma poi, per precisare meglio il suo pensiero, aggiunge: «[...] ciò non significa che il gioco muta o si converte in cultura, ma piuttosto che la cultura, nelle sue fasi originarie, porta il carattere di un gioco; viene rappresentata in forme e stati d'animo ludici: in tale "dualità-unità" di cultura e gioco, gioco è il fatto primario, oggettivo, percepibile, determinabile concretamente; mentre cultura non è che la qualifica applicata dal nostro giudizio storico dato al caso» (2002:55).
Il gioco può essere solitario o collettivo e si prefigge di raggiungere una finalità: quella di vincere. Se a giocare è un solo individuo (è il caso, per esempio, del “solitario” di carte), la vittoria gratifica il giocatore che è riuscito nel suo intento; se, invece, i partecipanti all’attività ludica sono due o più di due, il gioco allora si trasforma in gara, col che uno vince e l’altro rimane sconfitto. In questo caso subentrano due fattori: il primo riguarda l’introduzione di regole ben precise, che sono inconfutabili e che devono essere rispettate da tutti obbligatoriamente; il secondo fattore è l’agonismo, presente soprattutto nei giochi svolti durante cerimonie particolari come i riti di passaggio riguardanti il ciclo dell’anno, specie quelli del solstizio d’inverno e quelli primaverili. Spesso si tratta di corse a piedi, o di cavalli, in cui c’è in premio un palio, di giochi con la palla, ma anche di gare di tiro con l’arco, o di abilità varie. A volte l’agonismo, metaforicamente trasportato in una lotta tra Bene e Male, si trasforma in rappresentazione drammatica, perché il teatro è di per sé “gioco” (come ci spiegano meglio le lingue francese e inglese, per le quali “recitare” si dice “jouer” e “to play”). Queste gare e queste attività teatrali hanno un carattere ben augurale e sono presenti in genere nelle feste rituali contadine nelle quali svolgono la funzione di auspicare la fertilità della terra e l’abbondanza dei raccolti11. Scrive il Marchesini: «... si può dire che tali pratiche sono tutt’uno con le feste della comunità, del paese, della città. Il loro calendario è perciò quello del calendario religioso, il loro tempo è soprattutto
10 Pare che la “pedalata rotonda” sia stata una caratteristica di Fausto Coppi, attento curatore del proprio corpo che si studiava di far rendere al massimo. Si tratta di usare contemporaneamente la forza delle due gambe: mentre una spinge su un pedale, l’altra, nel portarsi in posizione di spinta, si trascina dietro l’altro; in questo modo si evita di avanzare a scatti e si dà alla bicicletta una propulsione continua e più efficace, ottenendo nello stesso tempo una maggiore fusione tra mezzo e atleta e quindi anche una postura più armonica ed elegante. Sulle modalità di servirsi del proprio corpo, si veda M. Mauss, Le tecniche del corpo, in Teoria generale della magia, Einaudi, Torino 2000. 11 Si veda Toschi 1976 ai capitoli X, XI, XII, XIII.
3
quello della chiesa, dei suoi santi, delle sue ricorrenze, delle sue celebrazioni (anche il carnevale, la più irriverente di tutte, è legato alla Pasqua» (1996:17). Ma è soprattutto il calendario dei cicli della natura, del lavoro dei campi, dei movimenti astronomici che si possono osservare nel cielo, quello sul quale lo stesso “calendario religioso” si è modellato.
Anche in certe occasioni cerimoniali famigliari, come nel passaggio da uno stato all’altro della vita, è presente l’elemento della gara: per esempio nei banchetti nuziali della Toscana mezzadrile i commensali, riprendendoli dalla tradizione o inventandoli lì per lì, si sfidavano scambiandosi stornelli e indovinelli in forma di stornello. Quest’uso doveva garantire prosperità economica e buona salute alla nuova famiglia.
Nel corso del secolo diciannovesimo i giochi tradizionali, in cui più forte era la presenza dell’agonismo e più organizzate erano le regole di svolgimento, si sono trasformati in “sport”. E’ stato allora necessario fondare associazioni che raggruppassero gli atleti, creare organismi dirigenti di livello nazionale (come le varie Federazioni del calcio, del tennis, del ciclismo e di tutti gli altri sport riconosciuti), che garantissero norme uguali per tutti e che organizzassero le gare in cui le attività sportive potessero trovare i modi e i luoghi della loro realizzazione12.
Tutto questo però non poteva avverarsi senza il presupposto che nella società capitalistica c’è il “tempo di lavoro” e c’è il “tempo libero”, cioè, per dirla banalmente, un tempo “per gli altri” e un tempo “per sé”, quest’ultimo spesso ottenuto dopo lunghe lotte sociali svolte in nome della rivendicazione ad avere una propria vita, scissa da quella legata ad un lavoro subordinato ed alienante. Così, scrive Simonicca (2008: 12), «… lo sport sembra conficcato all’interno del tempo libero e perciò anche inevitabilmente all’interno della dinamica oppositiva con il suo antagonista, il tempo del lavoro». E che questo sia vero è possibile verificarlo semplicemente partecipando a qualche cicloraduno: quando i cicloturisti passano accanto a campi od orti, sono, talvolta, apostrofati in modo poco cortese da chi sta svolgendo qualche lavoro agricolo: «Fannulloni, andate a lavorare!». La reazione verbale dei ciclisti è piuttosto violenta: frasi e parole ingiuriose ed offensive subissano l’imprudente che si è permesso di rimproverare ingiustamente chi ha già assolto il suo dovere di lavoratore e adesso, in bici, si sta godendo il suo meritato tempo libero.
Tra la fine dell’Ottocento, dunque, e i primi anni del secolo successivo avviene quel fenomeno che Elias chiama di civilizzazione dello sport: tutti quei giochi basati spesso sulla violenza, che avevano talora esiti cruenti (la boxe, innanzitutto), vengono regolamentati, con la conseguente diminuzione della dose di aggressività che li caratterizzava prima e il calo dei rischi per l’incolumità fisica degli atleti (Elias-Dumming 1989). Soprattutto gli sport di squadra acquisiscono codici e regolamenti riconosciuti a livello internazionale e condivisi anche dagli spettatori.
Norme e regolamenti, però, oltre che incivilire gli sport, fanno perdere loro l’aspetto di gioco, li fanno diventare, come dice Huizinga, sempre più seri. E’ facile a questo punto che molte discipline sportive, divenute così serie, così fortemente e severamente regolamentate, oltre che sulla carta anche sul campo da gioco con la presenza di arbitri e di giurie, finiscano con l’essere praticate da professionisti, che non le considerano più come gioco ma come lavoro o, per meglio dire, fonte di guadagno.
Davanti a queste nuove situazioni, grande è il rammarico di Huizinga (2002) il quale ritiene che con regole più severe e con una crescente sistemazione disciplinare del gioco «va perduto alla lunga qualche cosa della pura qualità ludica» (231). Egli non crede che lo sport moderno possa essere elevato «ad un’attività creatrice di stile e di cultura» e, pur riconoscendo che è «importantissimo per partecipanti e spettatori, esso rimane una funzione sterile in cui è morto in gran parte il tradizionale fattore ludico»(232); perché «per giocare veramente l’uomo, quando gioca, deve ritornare bambino» (233).
12 Su questa evoluzione dal gioco allo sport e sulla nascita delle associazioni sportive si soffermano Bausinger 2008: 71-85 e129 e sgg.; e Marchesini 1996: 17-23.
4
Possiamo accettare queste rimostranze di Huizinga oppure rifiutarle o metterle in discussione; certo è che in una società in cui lo scopo principale è il profitto, sia nel senso materiale del termine (guadagnare denaro o beni concreti), sia in quello astratto (acquisire il successo, la gloria, la notorietà), si può capire come il gioco possa diventare altro da quello che originariamente era. Che questa mutazione sia avvenuta nel corso dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento è comprensibile, perché quella età fu il periodo del progresso tecnico, delle specializzazioni, della ricerca delle prestazioni migliori in tutti i campi, compreso quello del lavoro, che venne suddiviso e talora parcellizzato allo scopo di una maggiore produttività e di una diminuzione dei costi di produzione. In questo senso, scrive Bausinger, «è possibile dimostrare che in entrambi gli ambiti [quello dello sport e quello dell’organizzazione tayloristica del lavoro] si realizzano processi di specializzazione e di meccanizzazione delle prestazioni… Lo sport rappresenterebbe perciò una diversa forma di lavoro alla catena di montaggio» (2008: 123).
In tempi più recenti abbiamo assistito però ad un cambiamento di scenario: se da un lato, infatti, c’è lo sport professionistico con tutta la sequela di conseguenze (il tifo, i gruppi di ultras, il giornalismo radiotelevisivo e quello della carta stampata, i piani urbanistici delle città con i vari stadi, i palazzetti dello sport, le palestre e così via), dall’altro lato un sempre maggior numero di persone si dà all’attività fisica, sia per questioni di benessere, sia perché è di moda13, sia per amore proprio dello sport praticato e non solamente vissuto come spettatore. Addirittura, a livello amatoriale si organizzano campionati ad imitazione di quelli delle categorie professionistiche. E’ il caso del gioco del calcio molto diffuso a livello di massa, sia nelle formazioni a undici giocatori, sia in quelle a cinque, detto “calcetto”. A proposito di tutta questa agitazione attorno alle attività sportive, Bausinger riporta le considerazioni di H. Haag il quale sottolineava il paradosso tipico della società contemporanea: «benché il progresso consista nella costante ricerca umana di far risparmiare gesti e movimenti, proprio da questo nasce nell’umanità un incontenibile desiderio di movimento» (2008: 70).
Si è verificata la stessa situazione anche nel ciclismo: oltre alle squadre dei professionisti (i quali, forse, saranno un qualche migliaio in tutto il mondo), finanziate da imprese multinazionali, oltre ai vari Giri nazionali e alle decine di classiche, per lo più disputate in Europa, esistono diverse decine di migliaia di persone che vanno in bicicletta non per lavoro ma “per sport”, molte delle quali sono organizzate in squadre, a loro volta affiliate a qualche federazione nazionale. Costoro sono i cosiddetti “amatori”.
3.- Brevi note sul ciclismo professionistico moderno
a) ciclismo e industria
Se si considerano gli aspetti ludici, la maggior parte degli sport odierni ha un’origine antica, come l’atletica, il pugilato, lo stesso calcio; il ciclismo, invece, essendo nato alla fine dell‘Ottocento, è uno sport del tutto moderno, come l’automobilismo, e per essere praticato ha bisogno di un mezzo tecnico che solo una società industriale sufficientemente avanzata può produrre, dotandolo, rispetto ai prototipi come la draisina settecentesca, di manubrio, di freni, di ruote gommate, di una catena e di una pedaliera che consentono il movimento.
13 La moda della bicicletta, come mezzo di diporto e non come mezzo di trasporto e di lavoro, è arrivata col periodo dell’austerity, nel 1974, quando, dopo un decennio di euforia automobilistica, si riscoprì la campagna, il passeggiare a piedi, l’andare a cavallo e in bicicletta, appunto. Da allora il numero dei cicloturisti, degli amanti della bici e in ultimo, ma non meno importante come fenomeno, degli appassionati della mountain-bike, è andato via via crescendo.
5
La bicicletta si è diffusa subito, specie nelle regioni pianeggianti, perché ha un costo relativamente basso e consente una facile mobilità su distanze non grandi. Ma, essendo un prodotto industriale, essa va commercializzata e per questo ha bisogno di essere propagandata quanto più diffusamente possibile. Fin dai primissimi tempi della sua apparizione sul mercato, uno degli strumenti pubblicitari più incisivi è stata certamente l’organizzazione di corse per dimostrare l’utilità, la robustezza e l’economicità del mezzo. Le prime corse si svolsero già negli ultimi venti anni dell’Ottocento e collocarono il ciclismo a metà strada tra lo sport e lo spettacolo, con gare prevalentemente disputate su pista. Più difficili da realizzare le gare su strada per la carenza di una viabilità adeguata; ciononostante, il Tour de France, il Giro d’Italia e le grandi “classiche”14 nacquero proprio a cavallo tra Ottocento e Novecento. In questo modo, scrive Marchesini, «le corse diventano il palcoscenico ideale e necessario su cui esibire le virtù degli articoli dei diversi fabbricanti (1996:24)». Ancora oggi, il giorno dopo una tappa del Giro di Francia o d’Italia o di una classica, come la Milano-Sanremo, sui giornali compare la pubblicità delle varie ditte che elogiano il telaio, i cerchioni delle ruote, i pneumatici, il cambio, il sistema frenante della bicicletta del vincitore, come se il merito della vittoria fosse del mezzo meccanico e non di colui che ci ha messo gambe e polmoni.
C’è dunque questo rapporto stretto tra industria e ciclismo. I corridori, come i braccianti, sono assunti per un anno o più, (secondo la loro bravura), e stipendiati a contratto. Le spese di gestione di una squadra sono enormi, perché oltre agli stipendi per i corridori e ai vari premi, simili a quelli “di produzione” in certi settori del lavoro, occorre retribuire anche i direttori sportivi, i massaggiatori, i meccanici, i piloti delle automobili che seguono la corsa; bisogna provvedere alle biciclette e agli indumenti di ricambio (maglie, pantaloncini, tute, giubbotti, calzini, guanti, ecc.) e al loro trasporto per circa 25 giorni di seguito nel caso del Tour o del Giro d’Italia o della Vuelta spagnola; occorre, infine, pagare la quota d’iscrizione alla corsa. Questo enorme esborso di denaro annuo costringe, dopo qualche tempo, le società finanziatrici del ciclismo a non impegnarsi più in imprese siffatte; ma in genere si trovano sempre i sostituti di chi si è tirato indietro. Così quasi ogni anno i corridori sono costretti a cambiare divisa e talvolta qualcuno rimane senza lavoro15.
14 Sono chiamate “classiche” tutte quelle gare di un giorno, nate sul finire dell’Ottocento e agli inizi del Novecento che conservano ancora oggi molte delle difficoltà di allora (fondo stradale a “pavé” o sterrato, la lunghezza del percorso, ecc.). Le più famose sono la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro delle Fiandre, la Milano-Sanremo, Il Giro di Lombardia.15 Negli anni 1930-50 in genere erano le fabbriche delle biciclette che finanziavano le squadre (Atala, Bianchi, Wilier, Legnano, Olmo); negli anni 1960-75, il periodo del boom economico in Italia, a finanziare il ciclismo furono le industrie delle cucine economiche e degli elettrodomestici (SCIC, Faema, Ignis) e poi i produttori di salumi (Molteni) e di gelati. Oggi sono grandi gruppi industriali e finanziari come Mapei, Liquigas, Telekom, USPostal; ed
6
La draisina
Guardando la condizione dei ciclisti professionisti, così fortemente vincolati ai finanziatori delle squadre e sottoposti alle grandi fatiche della corsa, Vasco Pratolini, seguendo come cronista di un giornale il Giro d’Italia del 1947, ebbe a scrivere che i ciclisti più che atleti impegnati in una libera competizione, in realtà sono «divisi in classi sociali, in sfruttati e sfruttatori, in domestici e padroni, una società dove gli schiavi persuasi e contenti di essere tali sono pochi, e i servi della gleba la grande massa» (Pratolini 1995:78).
b) L’epopea
Il ciclismo, dunque, oltre ad essere uno sport che deve molto all’industria meccanica, è moderno anche perché, a parte l’agonismo, sembra non avere quegli aspetti ludici, di origine antica, propri di altri sport e si identifica in qualche modo con quella mentalità otto/novecentesca che si basa sull’individualismo e sul conseguimento del successo. Ha, però, una sua mitologia, nata negli anni in cui i corridori dovevano affrontare fatiche immense dovute sia al chilometraggio del percorso16, sia alle pessime condizioni delle strade, sia al fatto che non c’era l’organizzazione di oggi che prevede che al seguito della corsa ci siano automobili con dirigenti, meccanici, medici, e veicoli che trasportano i ricambi per eventuali guasti del mezzo e le provviste per alimentarsi.
E a quel tempo non c’erano nemmeno i mezzi di comunicazione come la radio che può raccontare i fatti mentre accadono a chi si trova a centinaia di chilometri di distanza. Chi stava a casa poteva leggere solo qualche notizia sui giornali, il resto se lo doveva immaginare. E così, nell’immaginario collettivo, i corridori apparivano come agli uomini del Medio Evo i cavalieri erranti: eroi individualisti che, invece di combattere contro draghi ed orchi, affrontano e domano le asperità di passi alpini e pirenaici, l’afa e la sete delle lunghe tappe di pianura del Tour de France, le improvvise tempeste di neve sulle salite alpine e la fatica di estenuanti ore passate sul sellino.
Fino alla fine degli anni ’30 del Novecento l’epica ciclistica è stata narrata sui giornali; negli anni ‘40/50 subentra la radio con cronache in diretta delle tappe del Giro d’Italia e del Tour de France e di alcune classiche. Se nella fase della carta stampata gli eroi erano stati Guerra, Girardengo e Binda, nel mondo della radio assurgono a duelli epici, più grandiosi di quelli di Ettore contro Achille ed Enea contro Turno, le battaglie fra Bartali e Coppi, diventano conflitti fra giganti le sfide e le scaramucce ciclistiche tra italiani e francesi al Tour17, le lunghe tappe alpine si trasformano in “cavalcate” nel linguaggio dei radiocronisti. L’enfasi era di casa, non immune da un certo patriottismo e un certo nazionalismo ereditato dal Fascismo. E’ ormai fin troppo famosa l’apertura della radiocronaca di Mario Ferretti alla conclusione della tappa Cuneo-Pinerolo del Giro del 1949: «Un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi». Enfasi, certamente, forse anche retorica patriottarda, ma in quegli anni poveri di tutto, in una situazione culturale ancora contadina e ingenua, quelle frasi erano, unite alle reali imprese dei corridori, gli enzimi che facevano lievitare la fantasia e nascere i grandi miti.
Nei miei personali ricordi riaffiorano i pomeriggi afosi di un luglio di un cinquantennio fa quando, con altri coetanei, si stava attaccati alla radio dell’unico bar del paese ad ascoltare le radiocronache del Tour de France, continuamente disturbate dalle scariche e spesso interrotte per mancanza di collegamento internazionale. Ed ecco diffondersi nell’aria nomi di regioni, di montagne e di città sconosciute che diventavano fiabesche nella loro vaghezza, come i paesaggi
infine le banche ( come le francesi Crèdit agricole e Caisse d’erpagne).16 A volte i percorsi misuravano oltre 400 km che costringevano i corridori a stare in sella dalle 16 alle 20 ore.17 Nella canzone Bartali, del cantautore Paolo Conte, c’è l’eco di queste vicende: “e i francesi ci rispettano – che le
balle ancora gli girano”
7
lunari dell’Ariosto; altri fiumi, altri laghi, altre campagne: “le Midi”, l’Aubisque, il Mont Ventoux, Pau, Besançon, il Parco dei Principi di Parigi18.
I campioni allora sopravvivevano a lungo e si radicavano nella memoria collettiva. Oggi la televisione, per mezzo di telecamere poste su motociclette ed elicotteri, ci fa vedere le corse metro per metro, ci fa conoscere come funziona il sistema del cambio, come il meccanico, senza che il corridore si fermi e scenda dalla bicicletta, sporgendosi dal finestrino dell’auto in corsa riesca a mettere a posto il guasto dei freni, ci illustra con immagini doviziose i luoghi in cui la competizione si svolge; ma contemporaneamente essa in pochi minuti brucia le immagini, i campioni e le esperienze sportive ed umane. I personaggi durano per qualche stagione, non nasce nessun mito, né l'antagonismo tra due campioni diventa leggenda duratura, al massimo diventa un fatto tecnico o di età e si spegne nel giro di qualche anno: chi ricorda i duelli tra Merckx e Gimondi? Eppure non sono stati da meno di quelli di Bartali e Coppi.
c) Pantani, ciclismo e spettacolo.
Negli anni Novanta del secolo scorso apparve Marco Pantani, uno scalatore, e quasi subito sembrò che fosse tornato uno di quei campioni del passato capaci di entusiasmare le folle e di compiere imprese leggendarie da tramandare ai posteri. E così fu per alcuni anni. Era veramente emozionante vedere quel piccolo uomo lasciarsi alle spalle gli avversari con due o tre scatti brucianti nelle salite più impervie; scatti non improvvisi e di sorpresa, perché Pantani, prima di lanciarsi all’attacco, si toglieva il casco, la bandana e gli occhiali, quasi per annunciare la sua volontà di andarsene. Ed anche questo comportamento, così aperto nei confronti degli avversari, questa sfida così palese, rispetto alla tradizione ciclistica che vuole che l’attaccante parta da dietro le spalle degli avversari, lo faceva apparire, agli occhi della tifoseria e di tutto il pubblico che seguiva la corsa, come un eroe d’altri tempi.
18 Ho trovato, a proposito di ciclismo, una certa condivisione di memorie ed emozioni in P. De Simonis, Vive la différence. Diporti, comuni e stravaganti: visti e vissuti, in «Drammaturgia», 6, 1999. Questa comunanza di ricordi e sensazioni, non necessariamente legata al solo ciclismo, ha certamente un ambito molto più esteso di quello relativo a due sole persone e forse appartiene alle generazioni nate tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento.
8
Due grandi campioni:Charlie Gaul e Federico Bahamontessulle Alpi francesi
Ma il 5 giugno 1999, il giorno dopo una sua vittoria strepitosa che gli aveva fatto conquistare la maglia rosa, fu trovato positivo all’esame antidoping. Non più le quasi innocue anfetamine degli anni ’50 e ’60, ma eritropoietina che se favorisce una maggiore resistenza fisica, per converso aumenta il rischio di trombosi. Fu un trauma per tutti: lo stesso Gianni Mura, che per anni ne era stato il cantore, con articoli di denso lirismo19, dopo essersi chiesto perché Pantani «doveva forzare la mano quando gli avversari li aveva soggiogati» (2008: 271), ammetteva che poteva essersi sbagliato sull’uomo e sul campione. Quasi cinque anni dopo, alla notizia della morte di Pantani avvenuta per overdose di cocaina, Gianni Mura ribadisce la grandezza del corridore: «… il ciclismo senza Pantani era ed è una minestra assolutamente senza sapore. Un palcoscenico senza un primo attore, con volenterosi caratteristi che però non riescono a dare una scossa al cuore del pubblico» (p. 274).
E’ possibile, però, un ciclismo senza doping? La lotta contro l’uso di sostanze “dopanti” è sempre più severa, ciononostante periodicamente arrivano notizie di corridori sospesi dalle gare, licenziati dalle squadre, perché fanno uso di medicinali proibiti. A volte si ha l’impressione che tutte le misure prese per combattere questo pericoloso consumo siano soltanto frutto di ipocrisia, perché tutti sanno che è proprio lo sfruttamento esasperato del ciclismo e soprattutto dei ciclisti che ha portato a queste conseguenze drammatiche. Per sopportare la fatica di innumerevoli gare e di un calendario senza soluzioni di continuità, l’uso di sostanze corroboranti, già praticato anche in anni lontani, è aumentato smisuratamente nella quantità e soprattutto nella qualità, proporzionalmente all’aumento altrettanto smisurato della fatica dei ciclisti e, purtroppo, parallelamente allo sviluppo continuo della chimica.
Il ciclismo professionistico è ormai da tempo un fatto spettacolare; soprattutto negli ultimi venti anni il suo peso è cresciuto notevolmente; oltre ai Giri d’Italia e di Francia, si svolgono ormai quelli di Spagna, di Germania, del Lussemburgo e di alcuni Paesi slavi. Si sono moltiplicate le corse in linea, non c’è solo il Campionato del mondo (corsa di un solo giorno) ma anche la Coppa del Mondo (basata sui punti conquistati nelle classiche); il calendario europeo che prima iniziava il 19 marzo con la Milano-Sanremo e finiva grosso modo col campionato del mondo e con qualche altra classica verso la metà di ottobre (il Giro di Lombardia), oggi non ha più confini, perché durante il periodo autunno-invernale, una volta dedicato al riposo, si disputano altre gare nelle Americhe, in Malesia, in Australia. Le società che spendono fior di milioni per pagare tutta l’organizzazione di una squadra esigono un contraccambio in pubblicità e perciò costringono i loro ciclisti, (con i nomi dei finanziatori ben chiari su magliette pantaloncini calzini guanti e casco), a stare sempre sulla scena sportiva. Durante un’intervista
19 Talora la prosa lirica di Mura suona falsa, come di chi deve creare il mito a tutti i costi. Con ciò non gli si nega una sincera partecipazione sentimentale alle imprese di Pantani
9
Marco Pantanistacca GilbertoSimoni al Tour de France
televisiva di molti anni fa fu chiesto a Bartali quanti chilometri avesse fatto durante tutta la carriera. Fece un rapido calcolo: venti anni di attività per trentamila Km l’anno, cioè seicentomila Km tra allenamenti e gare. Oggi si sa che chi partecipa alla Milano-Sanremo, che resta sempre una delle prime gare del calendario in Europa, ha già percorso dai cinque ai quindicimila Km. Poi verranno le classiche belghe e francesi, il Giro d’Italia, quello di Spagna, il Tour de France, altre decine di classiche, i campionati del mondo, ecc. ecc. Ogni anno sono certamente molto più di trentamila i chilometri che i corridori professionisti devono mettere nelle gambe. Mentre una volta il corridore partecipava a tutte o quasi tutte le corse previste dal calendario, oggi sono pochissimi quelli capaci di esser sempre presenti, molto più spesso i corridori selezionano le gare cui partecipare: o si fa il Tour o il Giro d’Italia, ma corrono sempre troppo.
Di fronte alla lunghezza delle corse nessun ciclista ha mai protestato; a volte, invece, i corridori sono scesi in sciopero o per la pericolosità di certe strade all’origine di continue cadute o, come nel 1947, al Giro d’Italia, contro l’organizzazione che li costringeva a correre nelle ore più calde del giorno (Pratolini 1995: 53-60).
Era molto faticoso il ciclismo dei primi tempi, ma oggi non è da meno, tanto che anche nei modi di dire quotidiani si usano espressioni del gergo di questo sport. «Hai voluto la bicicletta? Adesso pedala!» si dice a chi inopinatamente ha voluto affrontare un’impresa difficile e fuori delle sue possibilità. Il verbo “pedalare” è diventato sinonimo di «impegnarsi senza risparmio e senza lamentarsi», perché «per primeggiare, per emergere da una situazione personale di inferiorità – giusta o ingiusta che sia – bisogna faticare, sudare, “pedalare” appunto» (Marchesini 1996: 26).
Così il ciclista è sempre più solo e più sfruttato, deve affidarsi alle sue gambe, ai suoi polmoni, al suo cuore; se qualcosa nel suo stato fisico non va, è destinato alla sconfitta e nessuno avrà pietà di lui. Oppure ricorre al doping20.
Oggi tutti sanno che il doping è generalizzato e tutti si affannano a condannare, a parole, il suo uso, ma nessuno propone, per esempio, che un corridore ogni anno non possa fare più di un certo numero di Km o non possa partecipare che ad un numero limitato di corse. Ma, come si dice per altre occasioni, the show must go on; e così tutti fanno finta di nulla, compreso il giornalismo radiotelevisivo e cartaceo che dovrebbe avere, oltre al compito della cronaca, anche quello della critica.
Capita, poi, che un atleta forte e generoso come Pantani caschi nella trappola e ci resti impaniato, per sempre.
d) individualismo e squadra
Le competizioni ciclistiche si svolgono all’insegna di un individualismo esasperato; ciò si vede soprattutto nelle gare degli allievi e dei dilettanti, dove dalla partenza all’arrivo è un continuo scattare, una lotta di uno contro tutti, mentre tra i professionisti si cerca di fare anche un gioco di squadra che permetta poi al capitano, riconosciuto come il più forte, di venir fuori negli ultimi chilometri e tentare di battere gli avversari.
Se tra Ottocento e Novecento è stato fatto lo sforzo di “incivilire” gli sport, togliendo ad essi tutti gli elementi di violenza e di crudeltà, il ciclismo ha conservato un suo carattere selvaggio, vivendo situazioni all’insegna dell’ “homo homini lupus” e della “mors tua vita mea”. Ognuno combatte contro tutti gli altri e sfrutta tutte le occasioni in cui gli avversari hanno qualche debolezza o si trovano in qualche difficoltà. Nel Tour de France del 1994, durante la telecronaca di una tappa nella quale il corridore Rominger accusava un momento di crisi, l’ex vincitore del Giro d’Italia e campione del mondo Vittorio Adorni così commentava l’episodio:
20 Sul doping nel ciclismo è intervenuto più volte l’ex sindaco di Pistoia e acceso tifoso di questo sport Renzo Bardelli: di lui si veda almeno Generazione Epo. Chi e come ha distrutto il ciclismo, EDIFIR, Firenze 2005
10
«Fa bene Indurain ad attaccare mentre Rominger è in crisi; non si può avere fair play con la bicicletta».
Ma non c’è nemmeno pietà per chi cade. In un gruppo composto di circa duecento corridori è facile che qualcuno perda l’equilibrio urtando con qualche altro o per una buca sulla strada: in questi casi c’è sempre una caduta che coinvolge dieci, venti corridori. Chi ha avuto la fortuna di trovarsi lontano dalla caduta, continua tuttavia ad andare avanti. Oggi si potrebbe trovare la giustificazione di questo comportamento nel fatto che, essendoci le autoambulanze e le auto dell’organizzazione al seguito, i gareggianti non sentono il dovere di fermarsi, ma non è così: rispetto, per esempio, al calcio o ad altri sport, nei quali se un atleta si fa male il gioco viene fermato, nel ciclismo si continua a pedalare, anche se qualcuno, cadendo, muore21.
Nonostante l‘individualismo sia la caratteristica del ciclismo agonistico, a poco a poco subentra l’idea che anche in questo sport, specie nelle corse a tappe, è possibile sfruttare un certo gioco di squadra. Occorre arrivare fino alla metà degli anni Cinquanta, tuttavia, perché una strategia e una tattica di squadra possano essere permesse dai regolamenti oltre che dalla tifoseria. Così quando Pantani, durante un Giro d’Italia, subisce una rovinosa caduta per colpa di un gatto che gli attraversa la strada, tutta la squadra lo aspetta, lo accompagna, lo sorregge e lo spinge fino al traguardo per non farlo arrivare fuori tempo massimo. Allo stesso modo, nessuno più si scandalizza se in prossimità di un arrivo in volata i velocisti utilizzano il cosiddetto “treno”, ovverosia tutta la squadra in fila indiana che, in testa al gruppo, trascina nella parte finale del percorso il proprio velocista ad oltre 50 km orari, per permettergli poi, negli ultimi duecento metri, di approfittare del suo scatto potente per vincere.
Scrive a proposito Marchesini: «Alla fine vince uno solo, e la sua vittoria è il risultato dell’impegno poco appariscente ma importante, dei compagni (i gregari). … La squadra si impegna, si sacrifica per portare al traguardo il suo uomo più forte. Le tensioni tra le ragioni della collettività (la squadra) e quelle del singolo (il leader), tra quelle della solidarietà e della competizione sono ben presenti, senza che ciò impedisca la loro compatibilità, in ultima analisi senza che sia compromesso il buon funzionamento delle regole della democrazia di massa con tutte le sue contraddizioni» (1996: 75 e sgg.).
Nel gioco di squadra grande importanza hanno i “gregari” che nel corso degli ultimi quaranta anni hanno cambiato ruolo. Mentre prima degli anni ’70 del secolo scorso, quando i regolamenti delle gare non permettevano la presenza di meccanici e di mezzi di trasporto di ricambi e di provviste alimentari al seguito delle corse, il gregario era colui che dava la propria bicicletta al capitano che aveva forato una gomma o rotto il cambio; era colui che gli portava la borraccia con l’acqua avendo fatto rifornimento presso le fontane pubbliche o presso le case private o facendo qualche piccola razzia nei bar che si incontravano lungo le strade. I gregari erano poi importanti quando il capitano perdeva contatto con il gruppo o per una foratura o per una crisi o per una caduta: in questi casi essi lo dovevano far rientrare senza farlo affaticare molto. Oggi i gregari non portano più l’acqua, visto che ci sono macchine e moto al seguito adibite a questo scopo, ma devono difendere il capitano dall’attacco delle altre squadre o portarlo all’attacco stancando gli avversari col mettersi in testa e tirando, anche per decine e decine di chilometri, a grande velocità22.
Rispetto al passato, però, nella squadra non c’è più il capitano che comanda e gli altri che ubbidiscono, anche perché nel ciclismo c’è stato un grande livellamento e dagli anni ’70 in poi non ci sono state più personalità emergenti come Bartali, Coppi, Anquetil, Hinault, Gimondi e Merckx. Ai tempi di costoro erano i campioni che si sceglievano i gregari, li facevano assumere dagli sponsor e li facevano licenziare. Anche quando personaggi come Indurain e Armstrong sembrano avere una squadra tutta al loro servizio, essi devono cedere qualcosa, devono lasciare una certa libertà di movimento e di autonomia ai loro cosiddetti “gregari”. E soprattutto devono
21 Come nel caso del giovane Casartelli caduto e morto in una discesa durante il Tour de France del 1995; si veda Mura 2008: 157-161.22 Su questa figura del gregario si sofferma Marchesini 1996: 139-144.
11
pagarli profumatamente. Il gregario protagonista di una poesia di Gianni Rodari e i servi della gleba di pratoliniana memoria sono ormai scomparsi23.
e) Agonismo e tifo
L’atletica leggera è considerata la regina degli sport ed ha il posto d’onore nelle Olimpiadi. Tutto ciò forse perché molte delle sue specialità derivano quasi direttamente dai giochi olimpici dell’antica Grecia e perché, tranne alcune eccezioni, rispecchiano la cultura classica nel fatto che, teoricamente, gli atleti gareggiano per se stessi e non per una nazione o un gruppo. In fondo questa era la visione utopica di De Coubertin quando coniò il motto dei Giochi olimpici: «L’importante è partecipare». Oggi anche nell’atletica le cose sono cambiate, ma le idee originarie erano quelle di vedere le Olimpiadi come competizioni in cui i vincitori e i vinti partecipano al rito mostrando il loro valore e spendendo tutto se stessi. Esattamente come avveniva nell’antichità classica e presso le popolazioni etnologiche24 e in qualche modo avviene anche nel rugby odierno, in cui la squadra che ha perso, nell’uscire dal campo di gioco, passa per un corridoio formato dai giocatori della squadra vittoriosa e da costoro è applaudita.
Nel ciclismo, però, le cose non funzionano così; nel ciclismo tutto si svolge come nel Palio di Siena. La contrada vincitrice è quella che arriva prima; è quella che viene registrata nell’albo dei vincitori. La contrada classificatasi seconda o terza non solo non conquista nessun premio, ma non sarà ricordata da nessuno. Per questo nelle gare ciclistiche l’agonismo è molto acceso, fino alla cattiveria, come si può vedere nel momento culminante di una corsa, che è la “volata”, durante la quale, nonostante i severi regolamenti e il rischio reale di gravi cadute, i corridori si scambiano spallate violente, si tagliano reciprocamente la strada, si urtano per impedire che gli altri li sorpassino.
Questa aggressività, questo individualismo esasperato, rappresentato negli anni ‘60/70 dal corridore belga Eddy Merckx, che non concedeva nessuno spazio ai suoi avversari25, probabilmente sta alla base del tifo ciclistico: nella performance del corridore la gente vede lo sforzo che occorre all’individuo per uscire da una condizione di anonimato ed affermarsi davanti alla società; forse vede anche una metafora della vita le cui difficoltà non si superano senza fatica e senza dolore e soprattutto senza la volontà di superarle.
Ma tra il ciclismo e gli altri sport c’è una grande differenza anche a proposito di tifo. Gli altri sport si svolgono in luoghi circoscritti e chiusi, dove può accorrere un pubblico numeroso che fa da spettatore, che si eccita nel seguire le fasi del gioco o della gara, che si divide in due gruppi contrapposti di “tifosi”. L’esempio classico è quello del calcio, ma le stesse situazioni, con un pubblico numericamente inferiore, si verificano anche per basket, pallavolo, tennis, ecc. Anche nel ciclismo gli spettatori parteggiano per l’uno o l’altro corridore, ma non possono aggregarsi e contrapporsi a gruppi opposti, (come nel calcio, per esempio, dove ci sono una “curva sud” e una “curva nord”; o nell’automobilismo dove ci sono i “ferraristi” e i “non ferraristi”) perché le gare ciclistiche si svolgono su un percorso lungo qualche centinaio di chilometri, attraversano campagne, villaggi, città. E soprattutto, il tifo è solo per un singolo corridore, non per una squadra. L’eccezione a questo stato di cose era il Tour de France fino agli anni ‘60 in cui i corridori non francesi erano raggruppati per squadre nazionali ed i francesi in squadre
23 Questi i versi di Rodari: Filastrocca del gregario / corridore proletario / che ai campioni di mestiere / deve far da cameriere / e sul piatto, senza gloria, / serve loro la vittoria. / Al traguardo, quando arriva, / non ha applausi, non evviva. / Col salario che si piglia / fa campare la famiglia / e da vecchio poi si acquista / un negozio da ciclista (da Filastrocche in cielo e in terra, Einaudi, Torino 1960).24 Notizie sintetiche su questi aspetti in Sport 2008: 44-47, s.v. Antropologia.25 Per questa sua avidità di vittorie, Merckx fu soprannominato “il cannibale”. E’ stato calcolato che le sue vittorie da professionista ammontano a 445, una su ogni tre gare fatte; si veda Sport (2008: s.v.). Negli anni più recenti, l’americano Lance Armstrong ha dimostrato una grande generosità concedendo a forti avversari la vittoria, nonostante potesse batterli facilmente (Mura 2008: 289-352).
12
subregionali (Midi, Ile de France, ecc.): in questo caso il tifo era rivolto alla squadra oltre che al singolo. In quegli anni qualche volta si arrivava, per colpa di un tifo intriso di nazionalismo, anche ad episodi gravi: durante il Tour del 1950, la squadra italiana, che palesemente dominava la corsa senza lasciare spazio ai padroni di casa, fu duramente osteggiata dalla tifoseria francese fino a che, in una tappa di montagna, Bartali che era in testa fu fatto cadere dalla bicicletta e picchiato da uno spettatore. Bartali quel giorno vinse lo stesso, ma l’indomani tutta la squadra abbandonò per protesta il Tour pur avendo Fiorenzo Magni in maglia gialla.
Negli altri sport, infine, sul campo a gareggiare sono sempre in pochi (al massimo in trenta come nel rugby), nel ciclismo la gara si svolge e si combatte tra 150-200 corridori, che sfilano davanti agli occhi degli spettatori alla velocità di 40 ed oltre Km l’ora. Non c’è nemmeno la possibilità di riconoscere il proprio beniamino26. Solo in salita il rapporto può essere più ravvicinato; ed infatti sulle strade delle montagne, dove passano il Giro o il Tour, si accalcano i tifosi, perché lì essi possono accompagnare i loro campioni, a passo di corsa, per qualche decina di metri, possono toccarli e spingerli. E qui succede che spesso il tifoso dimentica di sostenere il suo beniamino e comincia a tifare per tutti, cerca di spingere tutti, incita tutti: scatta la solidarietà con chi sta affrontando una grande fatica.
f) Da muratori a commentatori radiotelevisivi
Quando tra gli anni ’50 e ’60 i comici del varietà televisivo volevano prendere in giro i ciclisti, assumevano il ruolo di vincitore di una corsa e dicevano: «Ciao, mamma, sono contento di essere arrivato uno». Era una battuta crudele nei confronti di giovani uomini che nel ciclismo trovavano o cercavano un riscatto sociale, la possibilità di scappare da un’esistenza marcata da un’istruzione che a malapena arrivava alla quinta elementare e da condizioni di lavoro piuttosto disagiate. Una battuta crudele ma non lontana dalla realtà, perché quando si esprimevano ai microfoni della radio e della televisione, i vincitori di tappa e tutti i corridori in genere non sapevano far altro che ringraziare il patron della squadra e salutare gli amici del bar dello sport27.
Oggi molti corridori hanno diplomi di scuola superiore, altri frequentano l’università, qualcuno è addirittura laureato; quando si esprimono sanno usare discretamente la lingua italiana e spesso, per i loro continui impegni all’estero, sanno parlare anche il francese e lo spagnolo. I più disinvolti nell’eloquio, come Adorni, Saronni, Cassani e Martinello in Italia e Merckx in Belgio, “appesa la bicicletta al chiodo”, hanno trovato una collocazione presso radio e televisioni, pubbliche e private, dove fanno
i commentatori tecnici durante le riprese delle gare, discettando non solo di tattiche di gara e di storia ciclistica, ma illustrando e commentando anche la storia e i monumenti artistici delle località toccate dalla corsa. Per molto tempo il ciclismo è stato uno sport di poveri, in massima parte i corridori provenivano da mestieri umili, come quelli di garzoni da fornaio e di muratore, e quasi tutti erano figli di contadini o contadini essi stessi. Quando poi la loro carriera finiva intorno ai trenta anni, solo pochissimi potevano dirsi ricchi; altri, con i risparmi, potevano comprarsi qualche attività commerciale, molti tornavano ai mestieri di prima.
26 Di questa mancanza di “unità di luogo” propria delle gare ciclistiche e sul fatto che i tifosi vanno a “vedere “ una gara, di cui non riescono a “vedere” effettivamente nulla o quasi, scrivono Marchesini (1996: 227-236) e Brambilla (2007: 13-22).27 Paolo De Simonis mi ha fatto notare che l’imitazione si riferiva ad un ciclista che parlava un generico dialetto veneto, così come le servette di certi film della commedia all’italiana di quegli anni. In effetti, la maggior parte dei ciclisti professionisti era originaria di quelle zone, massimamente, e della Toscana, regione mezzadrile, desiderosa di riscatto sociale come le zone proletarie del Veneto. I corridori provenienti dalle regioni meridionali erano pochissimi, ma anche oggi costituiscono una bassa percentuale rispetto alla totalità. Il Meridione era, dice De Simonis, uno “stereotipo negativo” tanto che i ciclisti del Sud erano assenti perfino negli sketches radiotelevisivi.
13
Adesso anche i gregari guadagnano bene e i campioni italiani, i vincitori dei vari Giri o del campionato del mondo a volte, per sfuggire al fisco, vanno a prendersi la residenza nel Principato di Monaco. Il contrasto raccontato da Pratolini tra due gregari poveri come il friulano Conte e il siciliano Corrieri, al quale il primo rimproverava di fare incetta di traguardi volanti (in cui si vincevano premi in denaro e in natura, come polli, bottiglie di vino e perfino un maiale vivo) appartiene ad un mondo ormai scomparso (Pratolini 1995: 80-85).
g) Ciclismo: igiene e sesso
La fine di una certa censura nelle cronache televisive delle gare ciclistiche ci ha permesso a volte di vedere i corridori fermi ai margini della strada mentre espletano una necessaria funzione fisiologica, o addirittura li vediamo fare la stessa operazione sulla bicicletta in corsa. Si tratta di fatti che accadono abitualmente ma di cui non si parlava mai se non in occasioni eccezionali. E’ da chiedersi se l’immagine leggendaria dei campioni degli anni precedenti il 1960 non sia dovuta anche al fatto che questi uomini ci venivano presentati come superuomini, come eroi senza paura nell’affrontare le fatiche di una scalata sul Pordoi ed i pericoli di una discesa dal Gavia, e senza nessuna macchia dovuta ai bisogni fisiologici che tutte le persone comuni hanno. Certo, si sentiva parlare di “cotte per fame” quando al seguito della corsa non c’erano i rifornimenti ed ogni corridore doveva provvedere da sé, o con l’aiuto dei gregari, al mangiare e al bere, ma mai si parlava di altri bisogni, nonostante le molte ore passate sul sellino28: era come se i corridori fossero degli uomini straordinari, fuori di ogni quotidianità. Fino a quando non arrivò l’occasione eccezionale: al Giro d’Italia del 1957, la “maglia rosa” Charly Gaul, durante la tappa Como-Monte Bondone, si ferma sul ciglio della strada, pressato da un impellente bisogno. Se ne accorge il toscano Nencini, in quel momento secondo nella classifica generale, che attacca immediatamente e alla fine della tappa è lui ad indossare la maglia del primato. E da allora, commenta Marchesini, «anche quella generalmente solitaria operazione bisogna compierla in pieno gruppo, mentre i fidi gregari reggono e spingono il sellino, per mantenere alla bicicletta equilibrio e velocità» (1996: 142).
Ma c’è di più… Soprattutto nelle giornate calde ed afose, i corridori sono costretti a bere molto, anche quattordici borracce d’acqua al giorno, secondo il commento tecnico di 28 Si parlava al massimo di “foruncolosi”, una patologia tipica dei ciclisti causata dal contatto della pelle sudata con il tessuto dei pantaloncini e dallo sfregamento contro il sellino. Oggi di foruncolosi non si parla più perché i tessuti usati per gli indumenti sono di microfibre e asettici.
14
Due compagniaiutano il n. 71 ad espletare un bisogno in corsa
Cassani, pari cioè a una decina di litri. E così avviene che qualcuno abbia un attacco di dissenteria. Chi può si ferma, il campione che deve difendere la maglia del primato o la buona posizione in classifica non può farlo. Jan Ullrich, nella tappa dell’Alpe d’Huez, al Giro di Francia del 1997 che poi avrebbe vinto, dovette lottare anche contro questo inconveniente: «Si è liberato due volte, in corsa, aiutandosi col cappellino. Lo so che non sono dettagli gentili, neanche la corsa lo è stata», scrive Mura (2008: 209).
E poi c’è il sesso, anzi non c’è. Perché per un’antica e molto rispettata credenza si ritiene che l’attività sessuale sia controproducente per uno sportivo. In un’intervista a me rilasciata, I. B., corridore senese, gregario di Coppi prima e di Vito Taccone poi, mi raccontava che quando si sposò era in piena attività agonistica, così per non disperdere le sue energie passò la luna di miele «come un vero atleta», cioè senza consumare il matrimonio. Anche Binda pensò che fosse meglio rimandare il proprio matrimonio fino alla fine della sua brillante carriera, e quando nel 1994, durante il Giro, Gianni Bugno fu accusato dalla stampa di aver vissuto una notte brava, il suo direttore sportivo così lo difese: «Per correre così forte, quel poveretto fa l’amore due volte l’anno…» (Marchesini 1996: 50).
4.- Il ciclismo degli “amatori”.
a) ciclismo come gioco
Quelle persone che, durante la settimana, smessi gli abiti da lavoro e indossati i panni multicolori e un po’ ridicoli del ciclista, prendono la bici per allenarsi e la domenica partecipano ai cicloraduni, non sono, ovviamente, professionisti dello sport e non possono nemmeno essere considerati dilettanti, i quali, per i regolamenti ufficiali, sono quei giovani – allievi o juniores - che aspettano di raggiungere qualche successo per passare professionisti. Queste persone fanno parte dei cosiddetti “amatori”. Il loro quadro di riferimento è, tuttavia, il mondo del grande ciclismo, quello dei campioni, delle grandi prestazioni alpine e pirenaiche, ma poiché l’età e spesso il peso corporeo non consentono loro di ottenere risultati di qualche rilievo, si accontentano di dar sfogo alla loro passione percorrendo durante tutto l’anno da quattro a dieci mila chilometri. Eliminate le velleità di imitare i loro idoli, resta in loro qualcosa di quello spirito ludico di cui parla Huizinga, perché la bicicletta per loro è solo divertimento. A starci insieme, durante i cicloraduni, ci si accorge che in loro è rimasto un po’ di infantilismo29, più o meno latente, che viene alla luce nel piacere di stare in bici, nella felicità di scorazzare per le strade e in quel poco di aggressività che si manifesta quando la strada si fa più dura e i più forti provano gusto a lasciare indietro gli altri. Un po’ di infantilismo c’è nel modo in cui si apostrofano conoscenti e sconosciuti che s’incontrano nei paesi, davanti ai bar e per strada, e nelle conversazioni che avvengono mentre si pedala al centro del gruppo o nelle retrovie: si tratta di argomenti superficiali, di battute scherzose spesso trite e ritrite. Mentre si pedala, ci si sgombra la mente dai pensieri che rimandano al lavoro, ai problemi della famiglia, alla serietà della vita. Si è in piena atmosfera ludica. Anche l’indisciplina con cui si corre è propria di un certo infantilismo; malgrado sia prescritto che si deve rispettare il codice della strada, molti scavalcano la linea di mezzeria e continuano a pedalare contromano; altri affrontano brevi salite senza tenere le mani sul manubrio, c’è chi in discesa fa sorpassi azzardati. A ciò si aggiunge l’abbigliamento da corridore, multicolore e a volte stravagante, che mette sullo stesso piano queste persone, molto serie e compassate nella vita quotidiana, ed i giovani delle nuove generazioni con i loro vestiti casual e variopinti e stranamente acconciati. Per non parlare della bicicletta, anch’essa variamente colorata, perfino nei copertoni delle ruote, e che da mezzo di locomozione e di lavoro
29 In questo caso, col termine “infantilismo” indico non un atteggiamento giudicato negativo negli adulti, ma quella disposizione al gioco che, secondo Huizinga (2002:231-233), è propria del bambino.
15
diventa così “giocattolo”, strumento di puro divertimento. Edward Norbeck, citato da Paola De Sanctis (1994: 97-98), ritiene che Huizinga non si sarebbe rammaricato della perdita dell’attività ludica nel mondo moderno se fosse vissuto fino ad oggi.
b) l’associazionismo, i gruppi
Sia Bausinger che Marchesini, autori già citati, e Jacomuzzi (1973) si sono soffermati sulla nascita e l’evoluzione, nel tardo Ottocento e nei primi del Novecento, delle associazioni sportive che, per quanto riguarda l’Italia, accompagnavano la formazione della nazione. Si trattava spesso di associazioni le cui attività ginnico-sportive erano finalizzate alla diffusione di uno spirito patriottico e talora anche all’addestramento militare. Oggi tutte le associazioni sportive non hanno più queste funzioni, semmai servono agli sponsor a pubblicizzare le loro imprese e i loro prodotti e a qualche persona ambiziosa che vuole iniziare o continuare la carriera politica.
Nel ciclismo amatoriale i gruppi costituiti o, come si chiamano, le squadre, non sono più nemmeno delle associazioni con finalità culturali oltre che sportive, perché si limitano ad accettare le proposte del presidente che spesso è colui che si è fatto promotore del gruppo e che viene acclamato ogni anno come dirigente massimo in quanto si delegano a lui tutti i problemi e i grattacapi inerenti all’organizzazione. E difatti il presidente sceglie la federazione cui aderire (Uisp, Endas, Udace, ecc.), cerca gli sponsor per l’acquisto delle divise (ogni gruppo ha i suoi colori e un proprio nome), tiene i contatti con le altre squadre, attraverso un organismo zonale o provinciale, per organizzare il calendario delle poche gare e dei cicloraduni (circa una trentina l’anno), stimola gli iscritti a partecipare agli avvenimenti, organizza un paio di manifestazioni l’anno (con l’obbligo, dunque, di trovare altri sponsor, i premi – trofei, coppe, targhe, gadget vari, generi alimentari, ecc. – e di chiedere le autorizzazioni alle autorità competenti), programma e guida gli allenamenti di squadra nelle domeniche in cui non ci sono cicloraduni.
Alla fine di ogni anno sociale (ottobre/novembre), il presidente convoca presso un ristorante tutti i soci per l’assemblea annuale in cui non si discutono e approvano bilanci consuntivi e preventivi ma si rendicontano sommariamente spese e introiti; si rinnovano le iscrizioni e le cariche (per acclamazione), si discute del regolamento interno e di quello federale, si approva il calendario dell’anno successivo e si prenotano le visite mediche. Alla fine dell’assemblea si va a tavola e durante il pranzo avviene la premiazione degli atleti e dei dirigenti30.
Associazioni del genere non si possono definire “democratiche”, anzi, tutto somiglia ad una tribù il cui capo non viene eletto ma accettato perché a lui si riconoscono capacità organizzative e soprattutto un forte spirito di volontariato, necessario per il tempo da impiegare in questo incarico; come dire che il presidente di una squadra amatoriale è come il Principe machiavelliano diventato tale per “fortuna e per virtù”.
Eppure, nonostante questi aspetti negativi, si può confermare per il ciclismo quanto scritto da Bausinger per le altre attività sportive: «Lo sport ha promosso… una comunicazione interpersonale basata sul “tu” in maniera più efficace e continua che non l’ondata di proteste e di solidarietà politica durante il movimento del 1970» (2008: 75 e sgg.). E difatti tra i ciclisti il “tu” è d’obbligo. Con il che non vuol dire che l’egualitaria comunicazione interpersonale elimini i dislivelli sociali, culturali e ideologici, ma sulla bicicletta l’operaio, il professionista, il contadino, l’imprenditore, l’intellettuale, il disoccupato, l’elettore di sinistra e quello di destra sono semplicemente dei ciclisti. Rispetto agli altri sport il ciclismo accoglie tutti, da qualsiasi classe sociale provengano, mentre, per esempio, è difficile che il tennis o l’equitazione siano
30 Nella premiazione si distribuiscono tutti i premi guadagnati partecipando ai raduni: trofei, coppe, ma anche prosciutti, salumi, forme di cacio e gadget vari. I premi più ricchi si danno a chi ha partecipato a più raduni, ma anche colui che è stato poco attivo se ne torna a casa con un piccolo regalo.
16
praticati da persone che non appartengono allo stesso ceto. C’è, però, il rischio del qualunquismo o quanto meno del disinteresse per tutto ciò che non è ciclismo. In sostanza gli amatori, disinteressandosi, almeno durante il raduno, delle cose serie sono simili ai bambini che vogliono solo giocare.
c) la “cultura” del cicloturista
Durante il cicloraduno i corridori sono preceduti da staffette e da una macchina dell’organizzazione da cui spesso è lanciato, con l’altoparlante, il motto «Al servizio della salute e dello sport» che appartiene un po’ a tutte le organizzazioni nazionali dei cicloamatori. Slogan che è anche alla base della cultura di questa categoria di ciclisti. Essi hanno la consapevolezza di rappresentare l’alternativa all’automobile, allo smog, al frastuono dei motori, al colesterolo. Non hanno letto Ivan Illich31 ma sono pronti ad accogliere i suoi suggerimenti e a liberare le città dal caos automobilistico, dallo smog, a togliere i parcheggi alle auto e a restituire le piazze ai cittadini e ai ragazzi.
I cicloamatori sono decine di migliaia, presenti in tutte le regioni d’Italia, con pubblicazioni periodiche a loro dedicate, con manifestazioni cicloturistiche e sportive (cioè con gare) che negli ultimi anni sono diventate sempre più importanti, come il Campionato italiano e ad altri campionati regionali e interregionali.
Li accomuna una subcultura sportiva, fatta di allenamenti settimanali, di problemi tecnici, di appuntamenti cicloturistici, di condivisione di divertimento, che talora sfocia nell’ideologia, dietro la quale si nascondono esperienze sociali, di lavoro, di cultura molto diverse. In questa subcultura preponderante poi è l’elemento agonistico, ma non quello vissuto in proprio, bensì quello degli altri, dei professionisti, soprattutto dei grandi campioni, ai quali si delegano le grandi vittorie, le grandi performance sulle salite alpine e pirenaiche: i cicloturisti si limitano a scimmiottarli quando, scattando in prossimità di qualche cavalcavia, urlano: “ed ecco che Pantani con uno scatto fulminante stacca il gruppo”; oppure in vista dell’arrivo del raduno alcuni si producono in uno sprint del tutto inutile, visto che non ci sono premi per chi arriva primo, ad imitazione dei velocisti in quel momento più famosi. Oppure si affibbiano come soprannomi i cognomi di noti professionisti, come Carollo attribuito a colui che nelle piccole gare arriva sempre ultimo, come il vero Carollo degli anni ’50, famosa “maglia nera” del Giro d’Italia insieme con Malabrocca, e come Bugno e Berzin, corridore di origine russa, attribuiti a coloro che fisicamente ricordano i due campioni di qualche decennio fa.
Questa subcultura trova l’occasione maggiore per manifestarsi nelle discussioni che avvengono tra i corridori in gruppo, durante i cicloraduni. Oltre a lanciarsi reciprocamente frizzi e battute varie, agli amatori piace raccontare le loro imprese, dalle volate vinte ai distacchi inflitti ad altri in qualche salita famosa per la sua durezza. In genere si tratta di piccoli episodi gonfiati come se fossero imprese di Coppi, più spesso sono bugie spacciate come vicende vere: gli altri le accettano perché, prima o poi, anche per loro arriverà il turno di spacciare le proprie. Altri temi che costituiscono materia di conversazione sono le questioni tecniche: la lunghezza delle pedivelle, la funzionalità di un cambio, le differenze tra una ruota normale ed una lenticolare, se è meglio usare in salita una moltiplica da 39 o da 41 denti, e cose simili. Ma può capitare di scambiare qualche battuta sulla politica o di parlare di scuola se ci sono dei professori.
d) ciclismo e accessori
31 Si veda Illich 2006, in cui l’autore, facendo l’apologia della bicicletta, affronta problemi molto gravi come l’esauribilità delle fonti energetiche e l’inquinamento. La sua disamina, venata di sentimenti antimoderni, evidenzia le contraddizioni del nostro tempo.
17
I cicloturisti sfiorano la maniacalità. Non solo parlano sempre di biciclette, ma vogliono essere sempre à la page e per questo comprano tutto quanto il mercato presenta di nuovo per questo sport: magliette dai colori impossibili, pedali tipo “look”, scarpette e calzini estrosi, bandane per il capo, mantelline contro la pioggia, il cerotto per il naso per respirare meglio. Si fanno salti mortali per poter indossare la divisa della squadra in quel momento in auge, oppure la maglietta di Bugno o quella di Pantani. La «Gazzetta dello sport», giornale che ha inventato e patrocina l’annuale Giro d’Italia, il giorno precedente la partenza della grande corsa a tappe organizza un raduno al quale accorrono, da ogni parte del Paese, a volte più di dieci mila cicloturisti i quali, con una quota di iscrizione minima, possono acquistare una maglia rosa e un casco color rosa che indosseranno, orgogliosi, per parecchi mesi di fila. E’ ritenuto sommo onore, da smuovere l’invidia degli altri, poter indossare una tuta o meglio ancora la divisa con la quale la squadra italiana, gli “azzurri”, partecipa al Campionato del mondo o alle Olimpiadi.
Se poi qualcuno di loro partecipa a qualche piccola gara a cronometro, ecco che arriva al raduno con la bici corredata da ruote lenticolari o ad “alto profilo” e con un manubrio particolare, come quello dei grandi cronomen.
Negli ultimi anni, infine, tutti i cicloturisti dispongono di piccoli computer di bordo che oltre al contachilometri (parziale e totale) segnalano anche tempi di percorrenza, velocità istantanea e velocità media. Molti poi si sono dotati di cardiofrequenzimetro e di contapedalate, strumenti molto più necessari ai professionisti che ai pedalatori della domenica.
La rincorsa all’acquisto di biciclette costruite con materiali nuovi (carbonio, titanio), il maniacale desiderio di corredare di nuove tecnologie il mezzo, il voler possedere tutti gli accessori, anche quelli inutili, fanno correre il rischio, come scrive Simonicca (2008: 13), che «dalla alienazione da lavoro» si passi «alla “alienazione” da tempo libero… l’hobby … non è affatto una forma autonoma e consapevole di scelta esistenziale, ma una conseguenza della legge del profitto che integra l’individuo con imperativi di consumo che si trasformano in forme di dominio sulla coscienza stessa… Il tempo libero non è altro che una nuova forma di consumo mercantile».
e) le donne, il pubblico
Marchesini (1996: 47) fa notare come la bicicletta abbia dato grande impulso all’emancipazione femminile: quando la bicicletta fa la sua comparsa «le donne l’adottano subito intuendo la portata liberatrice ed egualitaria del nuovo mezzo, che insegna loro a vestirsi, muoversi, comportarsi e servirsi del proprio corpo diversamente dagli schemi imposti dalla morale sociale. Non più soltanto busti, giarrettiere, gonne e sottogonne, ombrellini, guanti, cappelli e velette, ma anche semplici pantaloni e maglioni di lana, possibilità di essere sporche, di sudare, di avere la pelle cotta dal sole». Per le donne, però, la bicicletta è rimasta solo un mezzo di mobilità breve: serve in campagna ma soprattutto in città, dove casalinghe, operaie, impiegate, signore della borghesia vanno al lavoro, al passeggio o a fare la spesa.
Negli ultimi decenni, tuttavia, a livello di ciclismo professionistico abbiamo assistito alla presenza sempre più numerosa delle donne, cui sono riservati un Giro d’Italia e un Tour de France, molte altre gare e i campionati del mondo e le Olimpiadi. Tra gli amatori le donne sono pochissime. Spesso nei raduni non ci sono affatto e, quando sono presenti, la loro percentuale è minima, perché su una media di centocinquanta corridori le donne sono quattro o cinque, quasi tutte ragazze e giovani, qualcuna anche sposata. Quelle pochissime che ci sono, però, sono molto allenate e danno del filo da torcere a molti uomini. Negli indumenti e negli accessori sono più sobrie dei loro colleghi maschi.
Il pubblico, trattandosi di manifestazioni cicloturistiche, è scarso ed è costituito da coloro la cui attenzione è attirata dallo speaker che si trova sulla macchina che precede il gruppo dei corridori. Esso dunque è quello che si incontra per caso per le strade dei paesi, nelle piazze
18
adiacenti al percorso, in sosta davanti ai bar. I giovani si mostrano indifferenti, gli uomini adulti guardano con curiosità o con aria di sufficienza, qualcuno che lavora, pur essendo giorno di festa, invita i ciclisti ad andare a lavorare. Le donne, invece, guardano con un certo interesse, sospendono per qualche minuto i lavori domestici, si affacciano ai balconi, guardano da dietro le tende delle finestre. Qualcuna, fra le più anziane, si lascia andare a qualche grido di incitamento e di approvazione.
f) Raduni: marce controllate e marce libere
Da marzo a settembre, quasi tutte le domeniche sono dedicate ai cicloraduni organizzati a turno dalle tante società o squadre. Spesso per raggiungere i luoghi dei raduni occorre percorrere qualche decina di chilometri, altre volte i Km da fare sono 70/100. Gli amatori dimostrano anche in queste occasioni di aver conservato una certa dose di infantilismo, perché sembrano piuttosto desiderosi e trepidanti di partire, tanto che la piazza di partenza è già piena di ciclisti variopinti quasi due ore prima del ”via”. Il responsabile della squadra si preoccupa di fare le iscrizioni, presentando i tesserini e le quote. Poi si parte per percorrere un giro che va dai quaranta ai sessanta km. Secondo i regolamenti delle Federazioni nazionali, i raduni possono essere “a marcia controllata” oppure “a marcia libera”; nel primo caso le staffette e la macchina che guida il gruppo dei corridori devono contenere la velocità media finale entro i venticinque km orari; così si marcia a volte a più di trenta in pianura e almeno a dodici in salita. Ogni tanto l’automobile che guida la corsa rallenta per dar modo ai più deboli di rientrare. Nel caso di raduni “a marcia libera”, che negli ultimi dieci anni sono diventati abbastanza numerosi, dopo i primi cinque o dieci Km percorsi dietro la macchina di testa, il giudice di gara dà il via. Da questo punto in poi ogni ciclista è libero di scegliersi il ritmo con cui andare verso il traguardo: i giovani, quelli che hanno più allenamento ed i più forti subito guadagnano terreno, gli altri procedono secondo le proprie forze.
Questi raduni “a marcia libera” sarebbero in contraddizione con gli statuti del ciclismo amatoriale che, prefiggendosi il mantenimento di un fisico sano, limitano il numero delle attività agonistiche; ma la presenza di ex dilettanti ed ex professionisti e la mentalità individualistica (anche quando non è sorretta da adeguata forza fisica) e l’eco delle imprese dei professionisti hanno fatto sì che questo tipo di raduno si pratichi quasi quanto l’altro. Non senza polemiche ed ostilità perché la “marcia libera” non è molto ben vista dai cicloturisti più anziani e più legati alla tradizione. In fondo per quest’ultimi il raduno è l’occasione per incontrarsi con gli amici di altri paesi, di passare piacevolmente una mattinata all’aria aperta e non quello di emulare, inutilmente, i campioni famosi.
Abbiamo visto che nell’attività professionistica c’è stato il passaggio dal ciclista poco istruito a quello poliglotta, dal gregario a caccia di premi in natura a corridori ben pagati. Anche presso i cicloamatori ci sono stati notevoli progressi, sia a livello di istruzione (molti i professionisti, gli impiegati, gli insegnanti), sia a livello di condizioni materiali di vita. Lo strato culturale più profondo, tuttavia, è rimasto quello di un’età povera e semianalfabeta; mentre da una parte, infatti, i cicloturisti spendono migliaia di Euro nell’acquisto della bicicletta (per un mezzo discreto se ne spendono almeno 2.500/3.000; per uno più sofisticato fino a 6.000) e non lesinano denari per gli accessori, anche i più futili, dall’altra, finito il raduno, esigono che l’organizzazione della gara offra loro quanto meno un panino col salame e un bicchiere di vino. Quando capita qualche volta che gli organizzatori di un raduno non siano riusciti a racimolare la somma necessaria per un buffet decoroso, i cicloamatori non si trattengono da critiche aspre e da dichiarazioni di non voler più tornare negli anni successivi in quel luogo. E così negli ultimi quindici anni circa, la squadra che organizza il raduno si prodiga per fare bella figura. A fine corsa, dunque, i ciclisti si lanciano all’assalto del buffet dove possono dissetarsi con acqua e bibite di ogni specie. Poi, dopo essersi rivestiti dentro le macchine con indumenti asciutti, senza nemmeno potersi lavare le mani, vanno direttamente ai cestini dove si trovano i panini imbottiti o
19
col salame, o col prosciutto o con la porchetta; in pochi minuti i cestini si vuotano, perché non ci si accontenta di un panino soltanto, ma qualcuno ne mangia anche tre o quattro, innaffiandoli col vino messo a disposizione. Talora sono serviti anche piatti caldi, come le “penne all’arrabbiata”.
Dopodiché si passa alla premiazione. I giudici hanno già approntato le classifiche: ad ogni corridore spettano dieci punti, così se una squadra ha presentato diciotto iscritti prende centottanta punti. Vince la squadra che ha totalizzato il punteggio più alto. Il criterio di assegnazione del punteggio rientra nei canoni del cicloturismo che premia non le capacità atletiche ma la presenza alle attività sportive. Alla squadra prima classificata va il trofeo e tante bottiglie di vino quanti sono i suoi corridori presenti. Il trofeo in genere è una specie di scultura che rappresenta un ciclista sulla bicicletta, di gusto piuttosto pacchiano ma che piace tanto ai cicloamatori, specie se è di grandi proporzioni; oppure è una coppa piuttosto grande, di metallo dorato. I premi successivi sono progressivamente di valore inferiore al trofeo, trattandosi per lo più di coppe più o meno grandi, targhe ed altri gadget. Ci sono premi speciali poi per le donne partecipanti, per il corridore più giovane e per quello più anziano ed anche per il corridore venuto da più lontano Si danno anche premi in cibarie (pacchetti di pasta e di biscotti, bibite, ecc.). La bottiglia di vino c’è per tutti.
5. Conclusioni
Per concludere, vorrei tornare all’inizio di questo lavoro, là dove si parla di gioco e di sport per cercare di sciogliere alcune perplessità che mi hanno seguito fino a qui. Per parlare del ciclismo “amatoriale” ho dovuto affrontare, pur se molto sommariamente, la questione del rapporto tra “gioco” e “sport”32 e poi mi sono dovuto riferire, anche qui molto semplicisticamente, al ciclismo professionistico, quello definito da tutti come “sport”. Le discussioni teoriche e la storia del gioco mi fanno ritenere il ciclismo come uno sport discendente, da un lato, da un’attività umana innata che dagli studiosi è chiamata “gioco”, e dall’altro come prodotto della società industriale, per il mezzo tecnico con cui si pratica, e della società moderna che lo colloca tra quelle manifestazioni spettacolari proprie della cultura di massa. Ma, pur essendone cosciente, ho eluso di discutere una questione che mi si pone ora con urgenza dopo aver illustrato l’attività del ciclismo amatoriale.
Sia il gioco che lo sport si presentano sotto due aspetti distinti, molto bene indicati nella lingua inglese (game e play) ma non in quella italiana. Quando parliamo di calcio ci riferiamo a quel gioco che si pratica su un campo rettangolare che ha precise misure, che vede, in 32 Su questo tema si veda De Sanctis 1994.
20
Un ciclo radunomolto affollato
contrapposizione tra loro due squadre di un numero limitato di giocatori (cinque, o sette o undici); che ha regole cui devono sottostare i giocatori e che sono condivise pure dai tifosi e dagli spettatori (altrimenti non capirebbero cosa avviene in campo), ecc. Tutto questo complesso di norme e di regole non è il calcio “giocato”, ma è la sua definizione, è ciò che può essere chiamato il game, o la competence, o, per dirla con De Saussure, la langue del gioco del calcio. Quando poi i giocatori giocano, siano essi professionisti o semplicemente dei ragazzini che in una piazza si divertono a tirare calci ad una palla, allora siamo davanti ad un play, ad una performance, alla parole.
E’ difficile, però, potere attribuire tutte queste cose al ciclismo, perché ci troviamo di fronte ad un’attività ludico-sportiva che non presenta molti degli aspetti contemplati dalle teorie. E’ esso, come il calcio o il basket, sia game che play? Se è anche un game, quali sono le sue regole grammaticali? E se invece è solamente una performance, quali sono i criteri cui i giocatori-ciclisti si rifanno? Nella bibliografia sul gioco e sullo sport da me utilizzata non si fa mai cenno al ciclismo. Sembra che esso sfugga agli studiosi (per colpa della velocità con cui i ciclisti passano davanti ai loro occhi?) e che non sopporti queste classificazioni. In effetti, quali regole presiedono a questo sport? Se ci riferiamo a quello professionistico possiamo dire che solo tre sono le regole da rispettare: 1) partire tutti insieme se è una gara in linea, o uno dopo l’altro, distanziati da qualche minuto, se è una gara a cronometro; 2) non danneggiare gli avversari facendoli cadere; o non mettersi a ruota di un altro se è una cronometro; 3) spingere sui pedali quanto più forte si può. Ma già in queste tre regole c’è una contraddizione, perché la terza appartiene più al momento della performance che della competence.
Se invece ci si riferisce al cicloturismo, possiamo dire che solo la terza regola è rispettata, perché le partenze sono del tutto informali e perché per civiltà, per educazione e per amicizia non si pensa mai di far cadere il compagno di raduno, perché lì non ci sono avversari e non c’è niente da vincere.
In sostanza non mi pare che il ciclismo professionistico e quello amatoriale, pur se praticati “a squadre”, possano essere paragonati ad altri sport in cui un gruppo di praticanti si contrappone ad un altro gruppo. Per questi sport sono necessari un terreno di gioco specifico, dalle misure ben definite; occorre che lo svolgimento del gioco si attui col rispetto di certe norme prestabilite, sono necessari alcuni momenti rituali (entrata in campo, saluto al pubblico, esecuzione di inni in caso di incontri internazionali, ecc.); nello stesso tempo, durante la performance, tutto ciò che avviene nel campo si riflette tra gli spettatori che partecipano emotivamente alle fasi del gioco, che commentano azioni, errori, falli, interventi dell’arbitro e che si contrappongono, come nel campo di gioco, tra tifosi di una squadra contro quelli dell’altra, e che vivono i loro momenti rituali (segni di identificazione come sciarpe, fasce, bandiere, colori sul viso e le mani; esposizione di striscioni, movimenti coreografici come l’ola, canti e inni, ecc.). Abbiamo visto, però, che il ciclismo non ha, a parte quello su pista, un luogo deputato in cui svolgersi, le sue regole sono pochissime e ridotte all’essenziale, non ha momenti di ritualità (a parte la premiazione del vincitore); da parte loro, i suoi tifosi si limitano a scrivere i loro incitamenti ai campioni sull’asfalto delle strade e su qualche cartello; se si tratta di gare internazionali, allora sventolano qualche bandiera del proprio Paese.
Semmai il ciclismo può essere paragonato alle gare di velocità (i 100 m., gli ostacoli) o di fondo (gli 800 m., i 1500 m., la maratona) in cui i singoli atleti corrono contro tutti gli altri. La differenza sta nel fatto che i podisti si affidano alle loro gambe, mentre i ciclisti usano, per correre, un mezzo meccanico dotato di ruote e di un meccanismo di propulsione. In questo modo il ciclismo esce dalla categoria della “competizione”, in cui pur essendoci un vincitore rimane importante il confronto, per entrare in quella dell’”agonismo” in cui il confronto è ridotto al minimo o addirittura annullato, mentre diventa essenziale la lotta individuale per il primato. Si torna, cioè, non tanto alle società arcaiche o a quelle etnologiche in cui il gioco risponde ad esigenze sociali e culturali, ma a quelle società, come quella della Grecia classica in cui il gioco, sostituendosi ogni quattro anni, con le Olimpiadi, alle attività belliche, era l’occasione in cui il
21
vincitore, mettendo in atto le sue virtù fisiche e morali, affermava, colla sua superiorità sugli altri atleti, quella della sua Polis sulle altre33.
Un’ultima questione: tutti gli antropologi che si sono occupati del gioco sono arrivati alla conclusione che esso, in un modo o nell’altro è metafora, se non dell’esistenza umana, della vita degli uomini che vivono in società; anzi, per dirla con Umberto Eco, nella maniera più sintetica, le regole del gioco «rendono possibile l’esistenza della società, e che momento agonale e momento funzionale (potere) si saldano nel fatto che il gioco non è ciò che la società gioca, ma il presupposto stesso del rapporto sociale» (1973: XXI). Ho l’impressione che il ciclismo non sia nemmeno questo e che quindi, se è un gioco, esso è del tutto particolare. Cosa spinge, infatti, una persona, che non pratica il ciclismo da professionista, come un lavoro, a sobbarcarsi (e molto spesso da solo) alla fatica di 150/200 Km. a settimana per l’allenamento? Perché, dopo aver superato una salita di diversi Km. con pendenze dal 5 al 15%, ci si sente soddisfatti e in pace con se stessi e con il mondo tutto? E che cos’è allora questa attività sportiva che, nonostante la sua poca “visibilità”, richiama decine di migliaia di tifosi e di spettatori? Cosa significa esaltarsi per un velocista che col suo sprint riesce a vincere sugli avversari solo per qualche centimetro? E incitare e rincorrere gli scalatori che affrontano salite ripide anche col 20% di pendenza a velocità forsennata?Se il ciclismo non può essere, come dice Eco, a fondamento dell’esistenza sociale degli uomini, può forse essere metafora della vita in altro senso, non per profonde e soggiacenti leggi, ma per come esso si manifesta ai nostri occhi: un’attività in cui oltre all’intelligenza si usa anche una certa dose di furbizia, oppure un po’ di cattiveria, od anche un po’ di solidarietà, secondo i casi; e in cui soprattutto si deve lavorare, “pedalare”, soffrire, patire il freddo, la sete e la fame ed, infine, arrivare al traguardo: esattamente come nella vita.
Oppure, più banalmente, è la metafora della società capitalistica e del profitto, in cui ogni tanto ai più deboli sono concesse solo le fughe solitarie con i premi dei traguardi volanti e qualche vittoria che non disturba i grandi? Oppure il vero ciclismo, eliminato lo spirito agonistico, è il gioco in cui tutti si danno del “tu” e corrono alla pari, giovani e anziani, donne e uomini, e che si conclude, alla fine della corsa, senza premi per i singoli, ma con trofei e coppe di scarso valore per tutte le squadre che hanno con la loro presenza “celebrato” il cicloraduno, e poi cibo e vino per tutti?
BIBLIOGRAFIA
Sul gioco e lo sport
BATESON Gregory1996 Questo è un gioco, Cortina Edizioni, Milano.
BAUSINGER, Hermann2008 La cultura dello sport. Introduzione di A. Simonicca, Roma, Armando
CALLOIS, Roger1981 (1958) I giochi e gli uomini, Bompiani, Milano, 1981
DE SANCTIS RICCIARDONE Paola
33 Spesso anche gli appassionati di ciclismo più imparziali, quando si tratta di pronosticare il vincitore di una gara importante, si lasciano scappare di bocca: “Speriamo che vinca un italiano.. mi piacerebbe vincesse un italiano”, pur sapendo che, in quel momento, i ciclisti non italiani sono i più forti.
22
1994 Antropologia e gioco, Liguori, Napoli.
DE SIMONIS Paolo, 1999 Vive la différence. Diporti, comuni e stravaganti: visti e vissuti, in
«Drammaturgia», 6. ECO Umberto,
2002 «Homo ludens» oggi, in Huizinga 2002:XXI (ed. orig. 1973)
ELIAS N. – DUMMING, H.1989 Sport e aggressività. La ricerca di eccitamento nel “loisir”, Il Mulino,
Bologna HUIZINGA Joan 2002 (1946) Homo ludens, Einaudi, Torino
JACOMUZZI Stefano 1973 Gli Sport in Storia d’Italia, Einaudi, Torino, vol. V, I Documenti
I, pp. 915- 938
MAUSS Marcel2000 Le tecniche del corpo, in Teoria generale della magia, Einaudi, Torino
PADIGLIONE V. – STAFFA F.2003
Enciclopedia dello sport, Istituto Enciclopedia Treccani, Roma, pp.3-52.
SIMONICCA Alessandro 2008 Introduzione a Bausinger, La cultura dello sport, pp..SPORT, 2008 Enciclopedia dello Sport, Garzanti, Milano
Altri sport
BROMBERGER Christian1999 La partita di calcio. Etnografia di una passione, Editori Riuniti, Roma
DEI Fabio1991 Il calcio: una prospettiva antropologica, in «Ossimori» n. 1:5 e sgg., Siena.DEL LAGO Alessandro1990 Descrizione di una battaglia, Il Mulino, Bologna
Sul ciclismo
BARTHES Roland1994 Il Tour de France come epopea, in Miti d’oggi, Einaudi, Torino
23
BRAMBILLA Alberto2007 La coda del drago, Ediciclo, Portogruaro (Ve)
ILLICH Ivan2006 (1973) Elogio della bicicletta, a cura di F. La Cecla, Bollati Boringhieri, Torino.
MARCHESINI Dario 1999 L’Italia del Giro d’Italia, Il Mulino, Bologna
MURA Gianni2008 La fiamma rossa, Storie e strade dei miei Tour, Minimumfax, Roma
ORMEZZANO G. Paolo1980 Storia del ciclismo, Longanesi, Milano
PICCHI Sandro1987.88 La storia illustrata del ciclismo, La casa dello sport, Firenze
PIROVANO Massimo2009 La montagna dei ciclisti, Seminario Permanente di Etnologia Alpina,
in SM/21, Annali di S. Michele. PORTINARI Folco2005 Il portiere caduto alla difesa. Il calcio e il ciclismo nella letteratura italiana del Novecento,
Manni Editore, Lecce.
PRATOLINI Vasco1995 Cronache dal Giro d’Italia (maggio-giugno 1947). Introd. di G. Fofi,
Edizioni La Vita Felice, Milano.
(Pubblicato su «Archivio di Etnografia», n.s., A. III, n. 1, 2008, pp. 47-77)
24