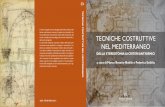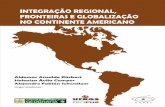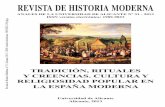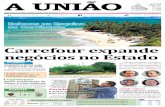‘Capitani coraggiosi’. Gli Eubei nel Mediterraneo, in Tra il mare e il continente: l’isola...
Transcript of ‘Capitani coraggiosi’. Gli Eubei nel Mediterraneo, in Tra il mare e il continente: l’isola...
Comitato scientifico: Cinzia Bearzot, Franca Landucci, Philip A. Stadter, Giuseppe Zecchini.
PP Bearzot-Landucci.qxd:_ 17/09/13 15:30 Page 2
a cura di CINZIA BEARZOTFRANCA LANDUCCI
Tra mare e continente:l’isola d’Eubea
STO
RIA
|R
ICE
RC
HE
VITA E PENSIERO
PP Bearzot-Landucci.qxd:_ 17/09/13 15:30 Page 3
La pubblicazione di questo volume ha ricevuto il contributofinanziario dell’Università Cattolica.
www.vitaepensiero.it
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limitidel 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previstodall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico ocommerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essereeffettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, CentroLicenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di PortaRomana 108, 20122 Milano, e-mail: [email protected] e sito webwww.clearedi.org
© 2013 Vita e Pensiero - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 MilanoISBN 978-88-343-2634-3
PP Bearzot-Landucci.qxd:_ 17/09/13 15:30 Page 4
INDICE
Presentazione VII
L’età arcaica
anna lucia d’agata
Il sito di Lefkandì e il suo significato al passaggio tra II e I millennio a.C. 3
luisa breglia
Titani, Cureti, Eracle. Mitopoiesi euboica e guerra lelantina 17
stefania de vido
‘Capitani coraggiosi’. Gli Eubei nel Mediterraneo 67
Il V e il IV secolo
cinzia bearzot
Da isolani a continentali. L’Eubea tra la fine del VI e la fine del V secolo a.C. 105
denis knoepfler
Un’amicizia decisamente ingannevole: Tucidide e la critica moderna di fronte al tradimento di Eretria nel 411 a.C. 137
VI INDICE
annabella oranges
La concessione dell’epigamia agli Eubei 173
marcello bertoli
L’Eubea nella prima metà del IV secolo a.C. tra aspirazione alla libertà e dipendenza da Atene 191
L’età ellenistico-romana
franca landucci
L’Eubea nella politica macedone 227
giuseppe zecchini
I Romani e l’Eubea 257
alessandro galimberti
L’Eubea in età imperiale e l’Euboico di Dione di Prusa 271
STEFANIA DE VIDO 1
‘Capitani coraggiosi’. Gli Eubei nel Mediterraneo
Coraggiosi e indomiti gli Eubei, che prima degli altri Greci hanno solcato il Mediterraneo da Oriente a Occidente, punteggiandone le coste di insediamenti e colonie e aprendo all’Hellenikon terre e prospettive. Tanto dinamismo merita che si esca da una prospettiva romanzesca, pur affascinante, per entrare nel più aspro terreno della ricostruzione storica a partire da alcune spinose questioni di metodo.
Parlare degli Eubei, infatti, significa dover affrontare di petto alcuni aspetti metodologici relativi alla colonizzazione di età arcaica, all’uso delle fonti, alla possibilità stessa di proporre una ricostruzione plausibile a partire da testimonianze letterarie ben strutturate ma evidentemente successive agli eventi e da evidenze archeologiche comunque frammentarie. Si tratta di un tema sempre sotteso allo studio dell’età arcaica, costante rumore di fondo in qualsivoglia indagine su fenomeni per cui si disponga di documentazione discontinua e disomogenea; tema che ciclica-mente torna alla ribalta della discussione quando qualcuno abbia voglia di ripensare presupposti apparentemente acquisiti, di nuo-vo scompaginando coordinate e orientamenti.
Questo l’effetto che ha sortito un ormai famoso intervento di Robin Osborne che con un’argomentazione serrata e per certi versi dissacrante ha rimesso in questione la possibilità stessa di scrivere una storia della colonizzazione, arrivando ad auspicare, immagino provocatoriamente, di eliminare del tutto il capitolo
* Ringrazio gli studenti del corso di Storia Greca sp. dell’a.a. 2012/2013 dell’U-niversità Ca’ Foscari di Venezia che mi hanno aiutato a riflettere e ad approfon-dire molti dei temi qui esposti.
68 STEFANIA DE VIDO
coloniale dai manuali di storia greca1. Lo studioso vuole esperire un approccio critico alle fonti arrivando a isolare con molta chia-rezza due elementi problematici, ma a suo parere imprescindibili: al fine di ricostruire la colonizzazione di VIII-VII sec. rischia di es-sere del tutto improprio leggere e utilizzare pagine di autori an-tichi che potrebbero aver proiettato su epoche ad essi precedenti lessico e modelli attivi invece nel momento in cui essi stessi scri-vevano; di qui l’effetto di patina inverosimilmente ‘modernista’ conferita a esperienze coloniali molto diverse da quelle sperimen-tate in epoca classica. Non solo, ed è questo il secondo aspetto al primo collegato: la tara anacronistica da cui sarebbero affette le ricostruzioni degli storici antichi dovrebbe indurre a rifiutare il tradizionale modello di natura ‘apecistica’ e a guardare al dinami-smo coloniale di età arcaica come a espressione non già di comu-nità politiche in divenire, quanto di iniziative individuali al di fuori di qualsivoglia progettualità politica e improntate piuttosto a una determinante caratterizzazione privata e in qualche modo casuale.
Non intendo qui riprendere le fila di una discussione teori-ca che conta già molti interventi2, ma – certo – il contributo di Osborne non può essere ignorato nel momento in cui si voglia delineare il filo euboico della colonizzazione, il più antico e dun-que il più esposto alle insidie del metodo. Merito indubbio di quella riflessione sta nell’aver indotto un ripensamento intorno a questioni che l’abitudine aveva ridotto a pregiudiziali irriflesse, esplicitando, anzi, qualche necessaria premessa. Perché parlare di Eubei nel Mediterraneo comporta disporsi a conferire o a ne-gare validità ad alcune fonti storiche antiche nonché a calibrare
1 Così R. OSbOrNE, Early Greek Colonization? The Nature of Greek Settlement in the West, in Archaic Greece. New Approaches and New Evidence, ed. by N. FIShEr - h. VAN WEES, London 1998, pp. 251-269, 269: «A proper understanding of archaic Greek history can only come when chapters on ‘Colonization’ are eradicated from books on early Greece»; ma Osborne enfatizza eccessivamente, mi pare, l’accezione moderna del termine ‘colonization’, lì dove da tempo la critica ha già ben messo a fuoco la differenza tra esperienze antiche e colonizzazione di età moderna. Su questo tema interessante e ricco di spunti il lungo lavoro di D. AShErI, Colonizzazione e decolonizzazione, in I Greci, I, a cura di S. SETTIS, Torino 1996, pp. 73-115.2 Basti qui rammentare il recente convegno tenutosi presso l’Academia Belgica di Roma (21-23 giugno 2012) su Contestualizzare la “prima colonizzazione”. Archeologia, fonti, cronologia e modelli interpretativi fra l’Italia e il Mediterraneo. In memoria di David Ridgway (1938-2012).
69‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
la possibilità di farle in qualche modo reagire con le evidenze di carattere archeologico.
Misurarsi, come qui facciamo, con una ‘narrazione’ continua sulla navigazione euboica in età arcaica significa dunque già di per sé aver deciso di poter attribuire statuto di verosimiglianza alle fon-ti antiche, il cui linguaggio, se ben interpretato, può comunque essere utile per ricostruire quell’esperienza; significa cioè accetta-re di scrivere un capitolo di una storia che, per quanto remota e frammentaria, costituisce un passaggio fondamentale già per gli antichi nel formarsi di un Hellenikon mediterraneo. Che esso ab-bia assunto per lo più le sembianze di fondazioni cittadine è forse l’elemento centrale di questa vicenda non solo nella percezione degli storici greci (come giustamente visto da Osborne), ma anche nella concretezza delle dinamiche politiche e sociali che proprio nella colonizzazione hanno trovato eccellente terreno di coltura. Sotto questo aspetto questa pagina di storia incrocia quella ancor più generale del formarsi di comunità strutturate in processi la cui lettura, come vedremo in chiusura, richiede probabilmente anche il superamento di un’ottica polarizzata tra ‘pubblico’ e ‘privato’.
Nel delineare il paesaggio naturale e umano in cui si colloca la storia dei nostri capitani coraggiosi non si può non ribadire la centralità del Mediterraneo come contesto di dinamiche di lungo periodo entro sistemi (naturali e antropici) assai specifici. È un mare dai confini mobili, da leggersi attraverso la griglia dei dati climatici, ambientali e, ad essi necessariamente connessi, cultura-li; un mare che ha nella densità delle relazioni la sua cifra caratte-rizzante, lente necessaria per interpretarne la storia3.
Ed è proprio nel contesto di questo mare che chiede di essere letta e seguita la storia degli Eubei, che l’hanno percorso in lungo e in largo nel segno delle interazioni produttive con altre terre e con altri popoli4. È la storia della circolazione mediterranea nei
3 Penso qui all’importante libro di P. hOrDEN - N. PurcEll, The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History, London 2000 (cui aggiungerei le considerazioni di N. PurcEll, The Boundless Sea of Unlikeness? On Defining on Mediterranean, «Medi-terranean Historical Review», 18.2 [2003], pp. 9-29) che mette al centro della riflessione termine e nozione di ‘connectivity’. 4 La mobilità mediterranea, da intendersi come insieme di dinamiche la cui energia seppe tenere insieme un mondo multietnico, è il fulcro su cui ruota il lavoro di M. GIANGIulIO, Avventurieri, mercanti, coloni, mercenari. Mobilità umana e circolazione di risorse nel Mediterraneo antico, in I Greci, II, 1, a cura di S. SETTIS,
70 STEFANIA DE VIDO
primi secoli del I millennio, un momento chiave nello strutturarsi di un mondo ‘nuovo’ dopo la fine dei regni micenei: sono i secoli in cui prende corpo e definizione quella straordinaria innovazio-ne di carattere sociale e politico cui diamo il nome di polis. Certo è che, in ogni caso, qualunque idea ci si voglia fare della cosiddetta nascita della città – processo molto lento di cui noi cogliamo sol-tanto l’esito finale comunque tardivo, oppure momento decisivo di svolta da collocare tra la fine del IX e la metà dell’VIII secolo –, resta che la colonizzazione euboica ha svolto un ruolo di primo piano sia nelle fasi cronologicamente anteriori alle prime fonda-zioni note alla tradizione storica (su cui peraltro – come corretta-mente osservato da Osborne – è possibile si proiettino in parte le storture ideologiche del pensiero storico classico), sia nello strut-turarsi di comunità politiche articolate.
Ma procediamo con ordine, muovendo dai primi secoli del I millennio, quando il Mediterraneo è mare percorso da navigan-ti non più, o non solo, greci. Basta leggere Omero, qualunque realtà si nasconda dietro questo nome, per capire che almeno di un’altra presenza bisogna tenere gran conto: ena de; oivnike nausiklutoi; luon andre, / tr'ktai, muriv agonte auvrmata ni melaivn5. Da tempo è stato chiaramente messo a fuoco il ruolo dei Fenici a partire almeno dall’XI secolo: un patrimonio di cono-scenze, rotte e contatti, prima condiviso con i Micenei, si trovava tutto nelle mani di questi navigatori abilissimi che percorrevano il Mediterraneo orientale e, abbastanza precocemente, anche quel-lo occidentale in un rapporto insieme alternativo e simbiotico proprio con gli Eubei. Si usa a volte chiamare la fase preceden-te alla colonizzazione greca, da intendersi come insediamento di apoikiai in luoghi lontani dalla Grecia propria, come pre-coloniz-zazione o proto-colonizzazione, facendo quasi presagire un mo-vimento teleologico che avrebbe avuto come esito ‘naturale’ la fondazione di città, punta emergente e compiuta di un processo orientato6. È preferibile, invece, isolare e descrivere quel periodo
Torino 1996, pp. 497-525, riferimento costante per molti aspetti di questo contributo. Per un inquadramento complessivo ancora affascinante il volume di J. bOArDmAN, I Greci sui mari. Traffici e colonie, trad. it., Firenze 1986 (1980).5 Od., 15, 415-416: «Arrivarono lì dei Fenici, navigatori famosi,/avidi, che porta-vano innumerevoli ninnoli con la nera nave» (trad. R. Calzecchi Onesti).6 Su questo ho di recente scritto in S. DE VIDO, Come rane in uno stagno: la diffusione
71‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
per quello che esso è stato senza ricorrere ad anticipazioni euristi-che in sé ben poco utili: più appropriato, se pur ancora a rischio di genericità, parlare di movimenti e frequentazioni, da intende-re come esperienze che, pur non conducendo necessariamente all’insediamento stabile di comunità fuori della patria, portarono comunque a scambio di uomini, risorse, prodotti, tecnologie e saperi. I quali, è chiaro, non hanno confini rigidi né di ordine geografico né di stampo etnico, soprattutto in presenza di società relativamente poco gerarchiche o comunque più dinamiche ri-spetto alle strutture verticistiche delle monarchie di II millennio. Potrebbe essere stata proprio l’omogeneità sociale, nel segno di un’aristocrazia ricca di risorse, il motore più efficace di tale con-divisione di spazi e finalità che vide per molti decenni Eubei e Fenici appaiati più che concorrenti prima nei mari orientali e poi, come vedremo, in Occidente7.
Proprio di un grande aristocratico parla il cosiddetto heroon di Lefkandi, clamorosa scoperta archeologica che a partire dagli anni Settanta del secolo scorso ha condotto a un ripensamento complessivo intorno alla stratificazione sociale delle comunità euboiche nonché al loro ruolo nelle esperienze di navigazione e commercio dell’inizio del I millennio. Lefkandi è sito euboico piuttosto vicino a Eretria, la cui fioritura si situa tra l’inizio del X e l’VIII secolo: di esso conosciamo sia l’abitato che la necropoli (la cui fine, piuttosto brusca e misteriosa, si colloca già nell’ultimo quarto del IX secolo), nonché le principali attività degli abitanti, dediti all’estrazione e alla lavorazione di minerali di ferro, e all’ar-tigianato (ceramisti, bronzisti ed orafi). Per cronologia e profilo questo sito, dunque, rappresenta al meglio proprio la fase di cui qui ora si discute8, ma esso deve la sua fama soprattutto al ritro-
del modello, in L’Antichità. Grecia, a cura di U. EcO, Milano 2012, pp. 148-171, cui mi permetto di rimandare.7 Su questo tema molto vasto, che dovrebbe anche tener conto del possibile ruolo dell’esperienza cipriota, mi limito a rimandare a A.J. DOmINGuEz, Mobilità umana, circolazione di risorse e contatti di culture nel Mediterraneo antico, in Storia d’Europa e del Mediterraneo. Il mondo antico, II. La Grecia, III. Grecia e Mediterraneo dall’VIII sec. a.C. all’età delle guerre persiane, a cura di M. GIANGIulIO, Roma 2007, pp. 131-175, in part. pp. 132-145.8 Tanto che A. mArINI, Circolazione e consumo dei beni orientali ed élite nell’Egeo della Prima Età del Ferro. Un caso “esemplare”: Lefkandi, RdA 32-33(2008-2009), pp. 25-91 parla per l’Egeo proprio di una ‘Età di Lefkandi’, introducendo un’analisi
72 STEFANIA DE VIDO
vamento del monumentale edificio absidato all’interno del quale sono state individuate due fosse, l’una con lo scheletro di quattro cavalli provvisti di morsi, l’altra con due sepolture umane. Come noto (ma vale la pena ricordarlo di nuovo), si tratta di un uomo e di una donna sepolti contestualmente, ma in maniera diversa (la coesistenza di riti diversi è peraltro ben testimoniata a Lefkandi): l’uomo in un cinerario bronzeo di fattura cipriota più antico di almeno un secolo rispetto alla sepoltura, la donna inumata con un pugnale di ferro con manico d’avorio all’altezza della gola9. Si tratta senza dubbio di due individui di status elevato: questo dicono la monumentalità dell’edificio, la sepoltura dei cavalli, la ricchezza del corredo che comprende oggetti di grande pregio di provenienza orientale (Cipro, Egitto, Vicino Oriente, Creta). L’impatto (un impatto anche visivo) di tale scoperta ha messo in moto una serie di riflessioni a più livelli, relative soprattutto alla lettura complessiva di un contesto che mantiene, a oggi, tratti di assoluta eccezionalità.
Il fronte interpretativo meno complesso riguarda ricchezza e varietà del corredo, tali da mettere ben in evidenza quanto fitti e proficui fossero i contatti tra l’Eubea e l’Oriente mediterraneo, sia che i vettori più vivaci e attivi in tutto il Mediterraneo orientale (toccando Egitto, Creta, Vicino Oriente e, soprattutto, Cipro) sia-no stati i Fenici, sia che si ritenga che gli Eubei fossero impegnati in prima persona a incrociare in questi stessi mari. Più problema-tica è invece l’interpretazione di un monumento così inconsueto: ci si chiede infatti se si tratti di una sorta di ‘palazzo’ (dalla vita invero assai breve) che alla morte del proprietario è stato appo-sitamente sotterrato in un tumulo, o se invece esso abbia avuto sin dalla sua concezione una specifica destinazione funeraria10.
molto completa, documentata e ricca di spunti in merito al significato storico e ideologico dell’importazione e dell’uso di orientalia nella prima Età del Ferro; rimando dunque a questo lavoro per un inquadramento complessivo del contesto di Lefkandi nonché di alcune questioni storiche ad esso connesse. 9 L’incinerato ha nel corredo una spada, un rasoio, una cote e pezzi di ferro; la donna una collana d’oro e due dischi di bronzo. Alcune ipotesi, non tutte condivisibili, in merito alla particolare posizione del pugnale nella sepoltura femminile in F. PESANDO, L’Eubea, in La città greca antica. Istituzioni, società e forme urbane, a cura di E. GrEcO, Roma 1999, pp. 99 ss., p. 102.10 In breve, con opportune indicazioni bibliografiche, si veda ancora PESANDO, L’Eubea, pp. 99-102.
73‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
In ogni caso, è proprio quest’ultima la funzione più evidente e duratura nel tempo, tanto più che esso divenne subito il centro to-pografico per sepolture di minore sfarzo, ma egualmente caratte-rizzate dalla concentrazione di beni provenienti dal Mediterraneo orientale. Si potrebbe allora riconoscere nell’edificio una sorta di heroon, da intendersi come luogo deputato non solo alla sepoltura, ma anche al culto di un individuo – o di una coppia – da parte del gruppo di appartenenza, che si impone come élite della società di Lefkandi anche perché capace di riconoscere e onorare un pro-prio ‘capostipite’11. Va detto che in questo caso l’interpretazione come heroon rischia di soffrire particolarmente della proiezione di esperienze squisitamente coloniali, dove lo statuto eroico vie-ne riconosciuto al fondatore; il caso di Lefkandi si distanzia da quelli meglio noti di età arcaica non solo per banali ragioni di cronologia, ma anche per il rapporto con lo spazio circostante. Le sepolture eroizzate degli ecisti delle apoikiai, infatti, trovano pro-pria collocazione nell’agora, luogo centrale della comunità dei vivi politicamente costituita; il cosiddetto heroon di Lefkandi, invece, è ‘solo’ il centro di una comunità di morti: il nesso tra la tomba maggiore e quelle che a grappolo le si assiepano intorno non è immediatamente intelleggibile se non in una lettura complessiva che riconosca proprio al culto dei morti una funzione essenziale nella solidificazione e nella visibilità di una memoria collettiva. Il signore di Lefkandi, dunque, è evidente riferimento per un grup-po di natura con ogni probabilità famigliare che in lui riconosce un personaggio eminente12, se non proprio il capostipite di una linea successoria: i vivi che gli assicurano simile sepoltura sono in-sieme suoi eredi e discendenti che in questo ruolo sembrano aver individuato un definitivo elemento identitario.
Il passo interpretativo successivo è il più delicato e riguarda la possibile pertinenza di questa sepoltura a una struttura comunita-ria più ampia, di cui il sepolto potrebbe essere stato il riferimento
11 A proposito dell’architettura e dei rituali attestati nel monumento di Lefkandi, O. murrAy, La Grecia degli ‘eroi’: mito, storia, archeologia, in I Greci, II, 1, pp. 173-188, 175, parla di «mentalità nella quale mito eroico ed eventi contemporanei sono profondamente compenetrati».12 murrAy, La Grecia degli ‘eroi’, p. 176 ipotizza trattarsi di un personaggio che avrebbe rivestito il ruolo di mediatore all’interno della comunità.
74 STEFANIA DE VIDO
‘politico’ da tutti riconosciuto13. Se egli fosse più simile al wanax miceneo, ai basileis omerici o ai grandi aristocratici di età arcai-ca non è possibile dire14: ogni ipotesi in uno o nell’altro senso riposa su un’idea generale dell’evoluzione delle strutture sociali all’inizio del I millennio e, più specificatamente, dello sviluppo dell’Eubea visto anche alla luce delle sue intense relazioni con il Mediterraneo orientale. Al di là di una definizione lessicale uni-voca e forse impropria, è comunque per noi possibile intravedere a Lefkandi una struttura sociale che riconosce un vertice e che si impone anche grazie a una capacità economica evidente nel pos-sesso e nell’esibizione di ricchezze. Che tra esse vadano annovera-ti anche i cavalli è una traccia che contribuisce a tendere un filo di continuità tra l’uomo di Lefkandi e le aristocrazie euboiche di età storica, il cui tratto distintivo, come vedremo, è costituito proprio dall’allevamento equino.
Il tumulo di Lefkandi si può infine interpretare come segnale di una mentalità in cui la coscienza dei gruppi sociali è ampia-mente imbevuta del mondo degli eroi – di gesti, rituali, parole che di esso risuonano – ovvero di echi omerici ravvisabili nel rito sepolcrale (si pensi ai funerali di Patroclo descritti nell’Iliade): l’incinerazione dell’individuo maschio adulto, l’elevazione del tumulo e la sepoltura dei cavalli. Monumento e versi omerici par-rebbero rimandare, cioè, a una medesima sensibilità, in cui il ri-conoscimento dell’eccellenza (militare e/o sociale) del singolo passa attraverso una ritualità da ricondurre a una comune ‘men-talità di tipo eroico’15 e ad atteggiamenti culturali conservativi e di lungo periodo; il che, naturalmente, non significa di per sé voler supporre aderenze necessarie e univoche tra mondo euboico e
13 Per quanto, come insegna l’Aristotele del I libro della Politica, il nucleo dei rapporti gerarchici di carattere regale si costruisca proprio su modello del ruolo che il capo dell’oikos ricopre rispetto alla comunità ‘famigliare’.14 In epoca storica nessuno conosce o attesta basileis in Eubea, né a Calcide né a Eretria (si veda in dettaglio P. cArlIEr, La royauté en Grèce avant Alexandre, Paris 1984, p. 429), il che fa ritenere che l’Eubea, forse proprio in virtù del suo percepibile dinamismo, abbia conosciuto una precoce strutturazione sociale non verticistica, ma articolata in gruppi aristocratici forti e concorrenti.15 Così si è interpretato, ad esempio, il ritrovamento ad Eretria di una punta di lancia in bronzo in una tomba maschile di inizio VII secolo: l’individuo lì sepolto avrebbe ‘recuperato’ un’arma antica (di bronzo e non di ferro) proprio per voluta imitazione di uno stile di vita, e di combattimento, ‘epici’.
75‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
poesia omerica. La precisazione risulterebbe forse superflua, se in questa direzione non si fosse diretta parte della critica anche su sollecitazione delle straordinarie scoperte euboiche. Eubea ed Euboici, è vero, sono ricordati solo sporadicamente nei poemi omerici, anche se in momenti di non scarsa rilevanza: nell’Iliade l’isola è ricordata nel Catalogo delle navi16, nell’Odissea (7, 317-322) nell’evocazione della rotta del ritorno per bocca di Alcinoo, che la dice ‘remotissima’17. L’importanza dei rinvenimenti euboici non-ché l’indubbio ruolo che gli Eubei hanno svolto nella mobilità me-diterranea dell’alto arcaismo hanno però incoraggiato ipotesi che al di là di natura e marginalità delle specifiche menzioni omeriche attribuiscono al mondo euboico un ruolo fondamentale sia nella composizione sia nella diffusione della poesia epica, in partico-lare dell’Odissea18, nonché nella ‘codificazione occidentale’ della geografia dei viaggi di Odisseo19. Nel percorrere rotte occidentali essi avrebbero disegnato una rotta retrospettivamente attribuita ad Odisseo attraverso una serie di felici coincidenze topografiche, paesaggistiche e lessicali, trovando proprio nella Itaca storica il
16 Il. 2, 534-545: t' d ama tessaravkonta mevlainai n'e eponto Lkr'n, oi naivousi pevrn ier' Euboiv. Oi d Euboian econ mevnea pneivonte Abante Calcivda t Eirevtriavn te polustavfulovn Istivaian; in un altro passaggio (4, 463-466) si fa menzione della morte di Elefenore comandante euboico.17 Si veda Od. 7, 317-322 nonché Od. 3, 173-175. Sull’Eubea come espressione di un ‘orizzonte’ di alterità e lontananza cfr. S.C. bAkhuIzEN, Le nom de Chalcis et la colonisation chalcidienne, in Nouvelle contribution à l’étude de la société et de la colonisation eubéennes, Naples 1981, pp. 163-174, 167.18 Lo studio di riferimento in tal senso è quello di M.L. WEST, The Rise of Greek Epic, JHS, CVIII(1988), pp. 151-172, che ritiene l’Odissea poema ‘euboico’ perché proprio in Eubea avrebbe assunto la sua facies linguistica definitiva; obiezioni di merito e diverso inquadramento della questione in A.c. cASSIO, Keinos, kallistephanos, e la circolazione dell’epica in area euboica, in Apoikia. Scritti in onore di Giorgio Buchner, a cura di B. D’AGOSTINO - D. rIDGWAy, AION(archeol), n.s., I(1994), pp. 55-67 e soprattutto ID., La cultura euboica e lo sviluppo dell’epica greca, in Euboica. L’Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente (Atti del Convegno di Napoli 1996), a cura di M. bATS - B. D’AGOSTINO, Napoli 1998, pp. 11-22 e ID., Epica greca e scrittura tra VIII e VII secolo a.C.; madrepatria e colonie d’Occidente, in Scritture mediterranee tra il IX e il VII secolo a.C. Atti del Seminario, a cura di G. bAGNAScO GIANNI - F. cOrDANO, Milano 1999, pp. 67-84, secondo il quale l’analisi linguistica non conforta, ma confuta l’ipotesi di un mondo euboico canale di trasmissione primo e privilegiato di un’eventuale epica ‘occidentale’.19 Questa l’ipotesi proposta in maniera articolata da L. brAccESI, Gli Eubei e la geografia dell’Odissea, in Hesperia, 3, a cura di L. brAccESI, Roma 1993, pp. 11-23.
76 STEFANIA DE VIDO
luogo ideale per impadronirsi e poi diffondere la chiave occiden-tale della saga odissiaca. In questo stesso senso è stato molto valo-rizzato un frammento esiodeo (Hes. fr. 150, 25-27 M-W)20 in cui la menzione di ‘Etna’, ‘Ortigia’ e ‘Lestrigoni’ deporrebbe a favore di una precoce codificazione scritta di questa geografia odissiaca.
Echi e assonanze occidentali dei percorsi di Ulisse sono fuor di dubbio; l’attribuzione certa a un ruolo diretto degli Eubei, da intendere come principale vettore delle tradizioni confluite nei poemi omerici, implica un certo numero di assunti in merito a na-tura e formazione della poesia epica e ancor più pesanti ricadute sulla ricostruzione complessiva delle interrelazioni tra movimenti precoloniali e coloniali da un lato e la tradizione squisitamente omerica dall’altro. Non di questo qui, soprattutto quando si noti che l’osservazione ravvicinata dei poemi ha potentemente inde-bolito gli argomenti linguistici di tali interpretazioni e le relative ipotesi di un ruolo decisivo dei parlanti euboico nella costituzione del testo omerico. Che, del resto, nei complessi mitici superstiti in qualche modo connessi a Eubea ed Eubei siano rintracciabili elementi che rimandano a tradizioni cosmogoniche legate alla la-vorazione dei metalli è dato che può ben prescindere da Omero e da una presunta unità etnica e culturale paneuboica21 e farsi piut-tosto interpretare all’interno del costituirsi di esperienze storiche molto specifiche e ben localizzate.
Proprio in questa direzione, e con risultati molto interessan-ti, vanno le osservazioni proposte da Alfonso Mele a proposito del mito di Calcodonte re di Beozia, padre di Elefenore signo-re dell’Eubea. Valorizzando i tratti caratterizzanti del nucleo tra-
20 Per l’interpretazione nella stessa direzione di un passo della Teogonia peraltro di discussa paternità (vv. 1011-1016) in cui si ricordano Agrios e Latinos figli di Ulisse e Circe si vedano di nuovo brAccESI, Gli Eubei, pp. 13-14, A.m. bIrASchI, Nostoi in Occidente ed esperienza ‘precoloniale’ nella tradizione e nella coscienza antica: aspetti e problemi, in La Magna Grecia e il mare. Studi di storia marittima, a cura di F. PrONTErA, Taranto 1986, pp. 75-106, in part. pp. 78-87 e I. mAlkIN, I ritorni di Odisseo. Colonizzazione e identità etnica nella Grecia antica, trad. it., Roma 2004, pp. 217-229. Una posizione cauta ed equilibrata è espressa da C. ANTONETTI, Verso l’Occidente sulle orme di Esiodo, in EPIEIKEIA. Studia Græca in memoriam J. Lens Tuero, ed. da M. AlGANzA rODáN - J.m. cAmAchO rOJO - P.P. FuENTES GONzálEz - m. VIllENA PONSODA, Granada 2000, pp. 19-25.21 Questa la linea interpretativa preferita invece da L. ANTONEllI, Sulle navi degli Eubei (immaginario mitico e traffici di età arcaica), in Hesperia, 5, a cura di L. brAccESI, Roma 1995, pp. 11-24.
77‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
dizionale relativo al mitico re beotico (a cominciare dal nome), lo studioso ha chiaramente messo a fuoco una speciale venatura dell’immagine degli Eubei veicolata dalla tradizione anche oltre i limiti isolani e legata alle loro speciali competenze in materia di metalli22: tecnologia del bronzo, tecnologia del ferro soprattutto ai fini della produzione di armi e oreficeria fine. Sin dall’inizio del millennio gli Eubei si dimostrarono particolarmente capaci di ac-quisire il materiale grezzo (di cui l’Eubea non è particolarmente ricca), di assicurarsi spazi e uomini adatti a produzioni importanti e prestigiose, di rendere operativa ed efficace una tecnologia di alto livello. Proprio di questo, del resto, parla l’insediamento di Oropo23 sulla costa beotica antistante l’isola, che nella sua fase più antica ospitò probabilmente un gruppo di origine euboica dedito appunto alla metallurgia24. La speciale posizione del sito nonché la sua precoce vocazione metallurgica consigliano di leggerne la storia all’interno di una più vasta ‘macro-area’ da identificare in un sistema beotico/euboico che almeno nell’alto arcaismo ebbe il suo cuore funzionale nell’Euripo25. Come altrove nel mondo de-gli Eubei (e non solo), la geografia chiede di essere guardata con occhio speciale, sensibile ai luoghi di passaggio da considerare
22 Si veda dunque, tutto importante, A. mElE, I Ciclopi, Calcodonte e la metallurgia calcidese, in Nouvelle contribution, pp. 9-33, nonché, con particolare riferimento all’VIII e al VII secolo, C. TAlAmO, Alcuni elementi euboici in Beozia in età arcaica, ibidem, pp. 35-43. Sulla tecnologia dei metalli e sui contesti etnici e geografici da essa definiti sono molto opportune le considerazioni generali di D. rIDGWAy, L’Eubea e l’Occidente: nuovi spunti sulle rotte dei metalli, in Euboica, pp. 311-322, in part. pp. 320-322.23 Tralascio qui volutamente, perché non strettamente necessario, il complesso problema dell’identificazione del sito con la Graia omerica, per cui rimando a R. cAlcE, Graikoi ed Hellenes: storia di due etnonimi (Diabaseis, 3.II), Pisa 2011, pp. 37-47.24 Si veda la amplissima presentazione con analisi dei materiali di scavo, discus-sione delle fonti e convincenti ipotesi di interpretazione storica di A. mAzArAkIS AINIAN, Oropos in the Early Iron Age, in Euboica, pp. 179-215.25 Del resto, specularmente, le testimonianze epigrafiche da Tebe fanno ritenere che il palazzo beotico di età micenea controllasse la parte centrale dell’Eubea e in particolare la piana di Calcide (cArlIEr, La royauté, p. 36); si aggiunga che nel Catalogo omerico la maggior parte dei centri nominati sono sulla costa occi-dentale dell’isola, a ribadire un legame speciale con la regione beotica, nonché una conoscenza unitaria dell’area in oggetto. Non concordo dunque con la lettura di bAkhuIzEN, Le nom de Chalcis, che ritiene che l’Eubea fosse un ‘mondo altro’ anche per i Beoti.
78 STEFANIA DE VIDO
più come punti di raccordo che come cesure. E così, con qualche azzardo, si può forse attribuire alla relazione speciale tra l’area eretriese ed Oropo una sorta di primogenitura in un modello in-sediativo che si vedrà ripetuto in altre terre e in altri Stretti.
Tecnica metallurgica e importazione di beni di lusso di origine orientale concorrono a suggerire la precoce presenza in Eubea di un’aristocrazia insieme molto strutturata e molto dinamica, capace di attivare processi culturali ed economici ad ampio rag-gio. Il modello sociale che essa incarna prevede una «interferenza tra attività mercantile esercitata in orizzonti sempre più larghi e aristocrazie terriere»26, se non, più probabilmente, l’emergere di una élite bifronte ma coerente che proprio a partire dalla solida proprietà di terra (da coltivare e su cui allevare cavalli) si può per-mettere l’esercizio di un commercio di alto livello, la prexis ome-rica27. Questo mondo aristocratico che in metafora possiamo im-maginare nutrito di Omero si inserisce e forse a sua volta innesca circuiti in cui il viaggio comporta lo scambio di metalli e di beni di prestigio, caratterizzanti un gruppo sociale mobile, innovatore, coraggioso28. Forte di una posizione geografica strategicamente centrale29, questa aristocrazia riconosce e promuove proficue re-lazioni con il Levante (Cipro, Vicino Oriente, Creta, Egitto) da cui importa vasi e oggetti pregiati, incrociando mercanti e navi di altre etnie, Fenici su tutti.
È verso Oriente, dunque, che guardano (o continuano a guar-dare) gli Eubei, attivi su rotte secolari tra terre e coste della mul-tiforme galassia del Mediterraneo orientale. In questa geografia di lungo periodo emerge una riconoscibile presenza di ceramica
26 Cfr. G. mADDOlI, L’Occidente, in I Greci, II, 1, pp. 995-1034, 1007.27 Necessario il riferimento al libro di A. mElE, Il commercio greco arcaico. Prexis ed emporie, Napoli 1979, cui si deve la riflessione a oggi più sistematica intorno a temi di carattere economico e sociale relativi al mondo omerico ed esiodeo con la fondamentale distinzione tra prexis ed emporìa che è assunta come riferimento teorico anche nel presente lavoro.28 Il nesso dinamico tra aristocrazia, navigazione e ricerca di beni di lusso e metalli è ben tratteggiato da O. murrAy, La Grecia delle origini, trad. it., Bologna 1983, in part. pp. 77-89 (Società e commercio in Eubea); si veda anche il quadro tracciato da J.P. crIElAArD, The Social Organization of Euboean Trade with the Eastern Mediterranean during the 10th to the 8th Centuries BC, «Pharos», I(1993), pp. 139-146.29 Così si esprime mADDOlI, L’Occidente, p. 1007: «… grande isola nell’Egeo, a cerniera tra etnie ioniche, eoliche e doriche».
79‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
di fattura euboico-cicladica in siti costieri della costa siriana e in particolare ad Al-Mina, alla foce dell’Oronte, a partire dalla fine del IX secolo. Al-Mina, le cui strutture non sono immediatamente riconducibili a un’univoca lettura funzionale, è presto diventata una sorta di palestra di metodo per verificare modelli interpre-tativi generali30. Che il sito abbia una palese vocazione e destina-zione ‘commerciale’ lo dicono strutture e ritrovamenti materiali (unanime da tal punto di vista la valutazione degli archeologi); più problematico, invece, è inquadrare queste evidenze in una lettura complessiva delle dinamiche relazionali attive nell’area. Si è spesso ricorsi, ed è questo un primo aspetto, alla nozione di ‘port-of-trade’ messa a punto come noto da Karl Polanyi31: un ‘port-of-trade’ si distingue per essere in una posizione di frontie-ra, di fondazione incerta e di popolazione mista; esso, soprattut-to, rappresenta il luogo di interazione tra commercio privato e commercio amministrato sotto il controllo dell’autorità regale. In linea generale, ovvero rimanendo sul piano dei ‘modelli’, Al-Mina potrebbe ottimamente adattarsi a questa definizione, ma rimane ancora poco chiaro – ed è questo il secondo aspetto – il ruolo degli Eubei in questo sistema apparentemente semplice. Oggetti di origine e fattura greca sono presenti nel Vicino Oriente già a partire dal X secolo, così come sin dall’inizio del I millennio (e Lefkandi ne è ottimo esempio)32 in Eubea circolano merci di produzione orientale; ma cosa questo significhi in termini di pre-senze straniere più o meno stabili nelle comunità sia levantine che greche e, soprattutto, in che misura e in che senso Al-Mina rap-presenti la sedimentazione definitiva di tali esperienze pregresse, difficile dire. Così difficile che nelle interpretazioni si percorre
30 Rimando ai lavori di J. bOArDmAN (The Excavated History of Al Mina, in Ancient Greeks. West and East, ed. by G.R. TSETSkhlADzE, Leiden-Boston 1999, pp. 135-161) e di R.A. kEArSlEy (Greeks Overseas in the 8th Century B.C.: Euboeans, Al Mina and Assyrian Imperialism, ibidem, pp. 109-134) per la presentazione critica delle strutture e dei livelli ritrovati nel sito; si leggano anche le osservazioni di J.Y. PErrEAulT, Les emporia grecs du Levant: mythe ou réalité?, in A. brESSON - P. rOuIllArD, L’emporion, Paris 1993, pp. 59-83, pp. 63-68 in un volume tutto importante per l’inquadramento complessivo dell’emporìa mediterranea.31 Basti leggere k. POlANyI, La sussistenza dell’uomo. Il ruolo dell’economia nelle società antiche, trad. it., Torino 1983 (1977), in part. pp. 130-134.32 Per il ruolo di Lefkandi in questo quadro rimando ancora a mArINI, Circolazione e consumo.
80 STEFANIA DE VIDO
l’intera banda delle possibilità, da quella che legge Al-Mina come ‘port-of-trade’ di iniziativa euboica a quella che invece preferisce individuarvi un terminale utile soprattutto alle attività commer-ciali condotte dai Fenici33. Pur rimanendo ancora irrisolta la do-manda sulla funzione ivi svolta dagli Eubei (residenti o visitatori; vettori in prima persona o fruitori di secondo livello), restano evi-denti due elementi: l’interazione profonda tra iniziative euboico-cicladiche e levantine, e la loro continuità nel tempo – almeno tra X e VIII secolo a.C. –; due elementi, questi, essenziali anche nella comprensione della colonizzazione euboica in Occidente, a chiu-dere (o ad aprire) un cerchio che guarda all’intero Mediterraneo.
Oggetti e vettori della circolazione di beni di lusso nel Medi-terraneo orientale consentono dunque di individuare il soggetto sociale di tali esperienze in un’aristocrazia che si va definendo anche attraverso uno specifico stile di vita, impasto formidabile tra usi guerrieri, pratiche sociali (la commensalità) e costumi fu-nerari, in cui il rapporto continuativo con il mondo orientale in-coraggia o accelera dinamiche di cambiamento e sviluppo. Il pro-gressivo definirsi di questa élite è strettamente contiguo (se non causa diretta) sia alla colonizzazione di età storica che alla nascita della polis, tanto più che la mancanza di testimonianze relative a basileis in Eubea (e nelle colonie calcidesi in Occidente) depone a favore di una precoce strutturazione in senso aristocratico che comportò anche una profonda ridefinizione dei rapporti interni alla comunità, sia in senso spaziale (centri urbani e campagna) che sociale (vertici e base sociale)34. Senza attivare alcun corto circuito logico né entrare in un dibattito molto complesso, si può comunque sottolineare il nesso tra emergere della forma polis e avvio della colonizzazione in Occidente, processi che – entrambi – hanno avuto motore evidente nell’aristocrazia della prima Età del Ferro.
Nella tradizione due sono le città euboiche più importanti di età arcaica, Calcide ed Eretria, ma solo di una possiamo conoscere la facies archeologica perché l’altra giace sotto l’abitato moderno ed è stata pochissimo indagata. Le ricerche archeologiche sul sito
33 GIANGIulIO, Avventurieri, mercanti, coloni, mercenari, pp. 499-500, ad esempio, ridimensiona con piglio la funzionalità di Al-Mina rispetto alle rotte euboiche.34 Su questo aspetto insiste molto GIANGIulIO, Avventurieri, mercanti, coloni, mercena-ri, p. 506 a proposito soprattutto della colonizzazione di età storica.
81‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
di Eretria indicano orientativamente l’inizio dell’VIII secolo come momento di fondazione, forse come risultato dell’improvvisa, e per certi versi ancora non spiegata, crisi della vicina Lefkandi. Il sito è ben scavato e riconoscibile nei suoi elementi significativi (strutture portuali, abitato, edifici monumentali, fortificazioni, tempio di Apollo Daphnephoros, necropoli), a dire di una polis ‘visibile’ e ben organizzata, di cui qui si vogliono evidenziare so-prattutto i rapporti con i vicini. Il primo versante cui guardare è senz’altro quello della vicina e concorrente Calcide, che dopo la guerra lelantina sarebbe divenuta la più importante delle città dell’isola35. La guerra per il controllo della piana di Lelanto36 ci è nota grazie a Tucidide che la segnala come unica occasione in cui nell’età più antica i conflitti uscirono da un orizzonte strettamen-te locale per avere un respiro ‘panellenico’, con una netta spac-catura del mondo greco schierato con uno dei due contendenti: kat allvlou de; ma'llon ekastoi oi astugeivtone epolevmoun. mavlista de; e to;n pavlai pote; genovmenon povlemon Calkidevn kai; Eretri'n kai; to; allo Ellniko;n e xummacivan ekatevrn dievst37. Al di là delle logiche che governano i due schieramenti (Samo, la Tessaglia, Corinto con Calcide e Mileto e Megara con Eretria), l’attenzione riservata a questo conflitto va inserita nello spartito generale dell’archeologia tucididea, tutta calibrata su dynamis, ta-lassocrazie, crescita economica, il che fa ritenere che anche da questo punto di vista la guerra rivestisse qualche interesse per lo storico. Del resto, proprio crescita e sviluppo consentono di me-glio spiegare la capacità dimostrata dall’Eubea di catalizzare l’ap-poggio di città e isole lontane e di ribadire anche così la propria centralità nei circuiti sociali ed economici del primo arcaismo.
Sconfitta sul piano internazionale, Eretria sembra stringere an-cor più i rapporti con l’antistante Oropo, che, pur anteriore alla
35 Strabo 10, 1, 8 Meta; de; to;n Geraisto;n Erevtria povli megivst t' Euboiva meta; Calkivda, epei Calki; mtrovpoli t' nvsou trovpon tinav, ep aut' t' Eurivp idrumevn. 36 La cronologia della guerra lelantina, pur non nota, è posta per lo più nella seconda metà dell’VIII secolo sulla base della valutazione del quadro storico ge-nerale, soprattutto alla luce sia delle dinamiche del movimento coloniale sia del quadro delle alleanze prospettato da Tucidide. 37 Thuc. 1, 15, 3; Strabone (10, 1, 2) riferisce dell’accordo tra le parti in guerra di non usare armi da lancio.
82 STEFANIA DE VIDO
fondazione della città euboica (questo dicono i materiali), entra presto nella sua diretta sfera di influenza. Pur non direttamente connesso a una più larga dimensione internazionale, il rapporto della città euboica con la Beozia tra la fine dell’VIII e la metà del VII secolo conserva alcuni aspetti interessanti38. Il primo, ancora una volta, rimanda alla connotazione specifica dell’aristocrazia isolana che, come già suggerito dal monumento di Lefkandi, ha nel cavallo un elemento di forza e di riconoscimento. L’allevamen-to dei cavalli è evidentemente legato a pratiche militari specifiche nonché alla disponibilità di territori morfologicamente adatti, il che poteva rendere particolarmente utile per gli Eretriesi il con-trollo delle piane costiere beotiche, soprattutto dopo che Calci-de si era assicurata la pianura di Lelanto. Che nella tradizione storica successiva l’aristocrazia euboica (e in particolare proprio eretriese) abbia il nome parlante di Hippobotai39 ribadisce questa connotazione legata alla terra e agli equini. L’altro aspetto è an-cora legato alla tecnologia dei metalli (bronzo e ferro, non neces-sariamente in alternativa) praticata nelle officine specializzate di Oropo anche dopo la guerra lelantina40.
Il quadro generale era però destinato a cambiare: i processi for-mativi della polis e il costituirsi di esperienze federative in Beozia, infatti, fecero prevalere nel tempo una logica strettamente regio-nale e sempre più concentrata su Tebe, rendendo progressiva-
38 Volutamente trascuro qui il tema che non si esita a definire immenso dell’assun-zione della scrittura alfabetica in Grecia, a partire dal famosissimo passo erodoteo (5, 57-59) che mette insieme Eubea e Beozia nel segno dei Gefirei discendenti di Cadmo e di quei Fenici che «avendo abitato questa regione [sc. la Beozia] introdussero fra i Greci molti e svariati insegnamenti, e fra questi le lettere dell’alfabeto, che, come mi sembra, non c’erano prima fra i Greci» (5, 58,1; trad. G. Nenci); per alcune osservazioni interessanti ai fini della nostra indagine cfr. comunque G. bOFFA, Erodoto (V 57-59) e i Gefirei, StAnt, 11(1998), pp. 9-23. 39 La lunga predominanza dell’aristocrazia eretriese parrebbe confermata anche da un evidente conservatorismo urbanistico ravvisabile nel quartiere abitativo (di età classica) detto dell’heroon, la cui struttura irregolare si potrebbe spiegare con l’intenzione di rispettare una necropoli di VIII secolo dal rituale funerario di tipo ‘eroico’, segnale di un’élite che voleva differenziarsi esplicitamente anche nella topografia funeraria: cfr. PESANDO, L’Eubea, pp. 104-107.40 Il quadro dei rapporti storici tra Eubea e Beozia è letto sullo sfondo delle nar-razioni mitologiche da TAlAmO, Alcuni elementi euboici, che ha individuato proprio nell’età arcaica lo sfondo necessario per comprendere narrazioni mitiche da cui sembra emergere un rapporto insieme necessario e conflittuale tra Eubea e Beozia.
83‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
mente marginale, fino a soffocarla, l’influenza euboica sulle coste continentali41. Se ancora Esiodo fa intuire un legame speciale tra Beozia ed Eubea nell’unica esperienza transmarina che lo vede attraversare l’Euripo per partecipare agli agoni in onore di Anfi-damante a Calcide42, nel tempo i due territori vedono sempre più separate le proprie vicende e l’isola torna a essere tale, periferica rispetto a dinamiche storiche destinate a risucchiarla inevitabil-mente nell’orizzonte ateniese. Il nome degli Eubei rimane più vivo e tenace nelle tradizioni coloniali, queste sì destinate a serba-re memoria concreta di un’esperienza per molti versi eccezionale.
Le parole della colonizzazione si fanno però particolarmente ardue e opache quando si tratti di definire le movenze iniziali, che per loro natura non possono essere descritte come mera sequenza di eventi. Certo, la tradizione antica sceglie per lo più la strada del racconto di ktiseis (si pensi all’archeologia siciliana di Tucidide), ma anche volendo attribuire il massimo grado di credibilità alle fonti antiche, è chiaro che qualsiasi fondazione è stata preceduta e accompagnata da esperienze di diverso segno che hanno garan-tito le conoscenze necessarie per poter navigare mari poco noti e approdare in terre nuove. Per alcuni anni tali esperienze sono state classificate sotto il nome di ‘pre-colonizzazione’, ma il me-todo sconsiglia di definire il ‘prima’ con il ‘poi’ e dunque oggi si preferisce parlare di ‘movimenti’ e di ‘frequentazioni’ da col-locare in quella fase lunga e per certi versi poco documentabile che ha visto passare dal «Mediterraneo dei ritorni a quello delle colonie»43. Tra i Greci sono stati proprio gli Eubei a guidare que-sta fase di trapasso, forti di quella capacità economica e di quella esperienza marittima che li rese protagonisti sia della modalità
41 TAlAmO, Alcuni elementi euboici, pp. 42-43 suggerisce di collegare il concludersi dell’esperienza euboica in Beozia sia con il primo formarsi della confederazione beotica, sia con un diverso strutturarsi delle comunità dell’isola anche in relazio-ne ai movimenti coloniali.42 Erga, 650-660. Facile la tentazione di pensare che Anfidamante fosse morto nella guerra lelantina, ma, pur plausibile, quest’ipotesi rischia di avvitare ulteriormente il circolo non sempre virtuoso su cui è costruita la cronologia di questa guerra. Anfidamante è indicato come il basileus giudice della contesa tra Omero ed Esio-do inscenata proprio in Eubea nell’operetta di età adrianea Certamen Homeri et Hesiodi. 43 Giustamente insiste su tali questioni di terminologia e metodo mAlkIN, I ritorni di Odisseo, pp. 29-34.
84 STEFANIA DE VIDO
più fluida ed evanescente di una ancora generica mobilità sia di quella più strutturata che condusse a insediamenti stabili44. Nel-la geografia euboica dell’alto arcaismo, così ampia da indurre a parlare di una koine euboica visibile almeno fino alla fine dell’VIII secolo e comprensiva di Beozia, Locride, Tessaglia, Cicladi, Cal-cidica45, si distingue subito una direttrice settentrionale protesa verso la penisola ‘calcidica’. Nome parlante.
Dice Strabone46: ai doun povlei autai diaferovnt auxei'sai kai; apoikiva esteilan axiolovgou ei Makedonivan Erevtria me;n ga;r sunvkise ta; peri; Pallvnn kai; to;n A povlei, de; Calki; ta; upo; Oluvn, a ivlippo dielumvnato. kai; t' Italiva de; kai;; Sikeliva polla; criva Calkidevn estivn. Due aspetti meritano qui attenzione: l’apparente parità nell’azione di Eretria e di Calcide che sembrano in qualche modo spartirsi le aree di competenza, e l’esplicito richiamo alle colonie occidentali dette ‘calcidesi’, per la fondazione di alcune delle quali, come vedremo, è proprio Strabo-ne a fornirci notizie essenziali: l’analogia tra penisola calcidica ed esperienze occidentali esplicitamente suggerita dalle fonti lettera-rie incoraggia una lettura d’insieme non già su base squisitamente etnica (come invece facevano gli antichi che parlavano, appunto, di Chalkidikon genos)47 ma, come vedremo, storica e funzionale.
Proprio il confronto con la tradizione relativa alle colonie oc-cidentali, nonché i risultati della ricerca archeologica nell’area (soprattutto a Mende e a Torone), hanno determinato due linee interpretative piuttosto diverse, condotte sul già ricordato discri-
44 Sugli Eubei come elemento ‘pilota’ di un’attività colonizzatrice che trova pieno compimento solo a partire dall’VIII secolo si vedano di nuovo GIANGIulIO, Avventurieri, mercanti, coloni, mercenari e mADDOlI, L’Occidente. Per completezza vanno almeno ricordate le tesi ‘negazioniste’ che invece pensano che quello euboico sia più una sorta di fantasma storiografico che realtà provata dalla do-cumentazione: si veda l’efficace sintesi di bAkhuIzEN, Le nom de Chalcis e, più di recente, J.K. PAPADOPOulOS, Phantom Euboians, «Journal of Mediterranean Archae-ology», 10.2 (1997), pp. 191-219.45 Così I.S. lEmOS, Euboea and its Aegean koine, in Euboica, pp. 45-58, 57: «If we really want to answer the question why Euboea was involved in early maritime enterprises, then we must fully understand the important role that the Euboeans and their koine took within the Aegean from the 11th to the mid 9th century BC».46 Strabo 10, 1, 8.47 Paiono presupporre la sostanziale unità culturale (se non politica) dei Calcidesi di Tracia sia Hdt. 7, 185, 2; 8, 127 che Thuc. 1, 57, 5.
85‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
mine tra frequentazione e fondazione: l’una, più fedele alla tradi-zione letteraria, ascrive la presenza euboica a una fase decisamen-te coloniale con fondazioni vere e proprie da collocare a partire dall’VIII sec., l’altra è incline a ipotizzare invece un processo di lunga durata, di cui la fondazione di poleis sarebbe solo l’esito fi-nale e finalmente visibile tra VIII e VII secolo, una sorta cioè di ‘solidificazione’ di esperienze precedenti48. Sono proprio i tratti specifici della tradizione, su questo punto visibilmente povera – mancano riferimenti precisi a metropoli, ecisti, oracoli, cronogra-fie e cause – e sensibilmente difforme rispetto ai più consueti rac-conti di fondazione, nonché i risultati delle indagini sul campo, a far ipotizzare una significativa presenza euboica nell’area già a partire dal X secolo: l’apparente contraddizione tra i due ordini di fonti si smorza ricollocando l’esperienza in Calcidica nel con-testo complessivo delle dinamiche nell’Egeo settentrionale, sulla scia del grande movimento migratorio che stava portando al po-polamento ellenico dell’Eolide e della Ionia settentrionale e alla luce del precoce interesse euboico per le risorse metallifere della Tracia. Così si potrebbero spiegare sia il carattere non distruttivo della presenza greca in Calcidica e, anzi, la cooperazione con le popolazioni locali49, sia la fitta densità dei siti che punteggiano le tre propaggini della penisola, dalla foce dello Strimone al Golfo Termaico50: a Metone gli Eretriesi (quelli scacciati da Corcira, se-condo Plutarco), i Calcidesi a Mende, Torone, Dikaia, di nuovo gli Eretriesi sulla Pallene e sull’Athos. Anche qui, almeno fino al VII secolo, gli Eubei assumono un ruolo centrale, fondano altre
48 Si vedano, rispettivamente, A. mElE, Calcidica e Calcidesi. Considerazioni sulla tradizione, in Euboica, pp. 217-228 (p. 228: «nella opinione dei Greci i Calkideis venivano da Calcide di Eubea e l’ellenizzazione della Calcidica era avvenuta per effetto di operazioni coloniali realizzatesi a partire dall’VIII secolo: prima non c’erano che barbari») e K. SOuErEF, Eubei lungo la costa della Grecia settentrionale. Nuovi elementi, ibidem, pp. 229-242, che sottolinea invece la specificità funzionale della prima presenza euboica in Calcidica e Macedonia, da collocare tra XII e VII sec.49 Su questo aspetto insiste molto SOuErEF, Eubei lungo la costa della Grecia setten-trionale.50 Sulla densità dei siti in Calcidica messa a confronto con la diversa distribuzione degli insediamenti occidentali, a dire un ‘cambio di passo’ nella dinamica colo-niale, insiste A.M. SNODGrASS, The Euboeans in Macedonia: a new precedent for west-ward expansion, in Apoikia, pp. 87-94.
86 STEFANIA DE VIDO
colonie e mantengono relazioni strette con la madrepatria e con altre colonie calcidesi. Anche qui l’equilibrio è destinato a rom-persi, con l’ingombrante presenza di Corinzi (che infatti fondano Potidea) e di Ateniesi: sembra quasi di antivedere dinamiche per-fettamente narrate nel I libro di Tucidide, con una storia che si fa sequenza di ‘grandi’ potenze del mare nel segno di una geografia dinamica e relazionale.
L’ordine canonico dell’esposizione (prima l’Oriente e poi l’Occidente) potrebbe trarre in inganno: l’insediamento stabile in Calcidica, infatti, va letto in sostanziale sincronia con l’inizio della colonizzazione in Occidente, in una sorta di movimento ‘a forbice’ sincrono e per molti aspetti omogeneo, almeno inizial-mente. A questa prima fase, ancora incerta nella documentazione e forse anche negli obiettivi, appartiene anche un episodio ogget-to di uno sguardo severamente critico da parte di alcuni studiosi: secondo Plutarco51 i Corinzi in viaggio verso Occidente avrebbe-ro scacciato dall’isola di Corcira un nucleo di Eretriesi che vi si era precedentemente insediato. Il sistema cronologico relativo alle colonie occidentali ci permette di collocare questo presunto insediamento a un’età precedente la colonizzazione di Siracusa (questa la destinazione finale del gruppo corinzio)52 e dunque in un orizzonte di pieno VIII secolo. La mancanza di inequivo-cabile evidenza archeologica di una presenza euboica a Corcira nonché la sporadicità della testimonianza letteraria hanno sovente indirizzato verso un’interpretazione negativa del passo plutarcheo ritenuto quale retroiezione propagandistica priva di alcuna plau-sibilità storica. Già si è discussa in apertura l’opportunità metodo-logica di posizioni duramente critiche verso la tradizione, tanto più che gli argomenti e silentio hanno un’intrinseca debolezza eu-ristica, soprattutto quando – come nel caso corcirese – le indagini archeologiche non hanno un carattere estensivo e sistematico53. È
51 Cfr. Plut. 293a-b.52 I sincronismi che regolano i racconti di fondazione di Corcira e le colonie più occidentali sono ora analizzati in maniera stringente da m. INTrIErI, Corcira fra Corinto e l’Occidente: rapporti e sincronismi di colonizzazione, in Sulla rotta per la Sicilia: l’Epiro, Corcira e l’Occidente, a cura di G. DE SENSI SESTITO - M. INTrIErI, («Diabaseis» 2), Pisa 2011, pp. 175-208, che consente di meglio inquadrare dal punto di vista sia storico che storiografico il ruolo di Corinto sulle rotte occidentali.53 Dopo la posizione molto critica (e invero ben meditata) di C. mOrGAN, Euboeans
87‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
più interessante, invece, provare a leggere la coerenza interna del complesso testimoniale intorno alla presenza euboica a Corcira e in Occidente, tanto più che vi si possono cogliere due dati, per così dire, strutturali. Il primo riguarda una sorta di duplice prota-gonismo di Eubei e Corinzi, recepito come tale già dalle tradizioni antiche, che pur riconoscendo unanimemente la primogenitura euboica nel processo coloniale non rinunciano ad affiancarle con scarto lievissimo una presenza corinzia che si annuncia sin da subi-to (a Corcira come in Sicilia) come più aggressiva. Il secondo dato, a questo strettamente connesso, sta nell’importanza dello spazio ionico-adriatico nel percorso che porta verso Occidente, un’im-portanza che si rintraccia integra proprio nelle tradizioni che ri-conoscono in Corcira (e nella sua perea) una precoce presenza euboica, offuscata dal successivo, ed esclusivo, predominio corin-zio. Questo spazio (lo spazio ionico, appunto) interessa gli uni e gli altri, a entrambi aprendo, o indicando, una strada occidentale. Che poi questa strada abbia avuto esiti diversi appartiene anche alle storie di partenza e di arrivo, con gli Eretriesi sconfitti nella guerra di Lelanto e confinati, come visto, in una prospettiva locale, e i Corinzi di Siracusa precocemente attivi in una politica sfaccia-tamente territoriale a tutto svantaggio degli insediamenti vicini.
E così arriviamo finalmente in Occidente54. La presenza euboi-ca nella penisola italica e in Sicilia è realtà fondante nella coscienza storiografica degli antichi come nelle ricerche storiche e archeo-logiche moderne che vi si sono lungamente applicate55: come già
and Corinthians in the Area of the Corinthian Gulf?, in Euboica, pp. 281-302 (p. 299: «I conclude that until Corinthian colonisation, Kerkyra was an island outside the main Ionian and Adriatic stream»), si legga mAlkIN, I ritorni di Odisseo, pp. 97-105, convincentemente favorevole a una lettura fiduciosa di Plutarco anche alla luce di un passo di Strabone (6, 2, 4) in cui si riferisce dell’espulsione da Corcira dei Viburni ad opera dei coloni corinzi, il che potrebbe far pensare a una presenza contemporanea dell’isola di Euboici e Illiri. Sulla evanescenza delle testimonianze archeologiche cfr. già I. mAlkIN, Ithaka, Odysseus and the Euboeans in the eight Century, in Euboica, pp. 1-10, 3-6 (secondo il quale la colo-nizzazione eretriese a Corcira sarebbe da intendere come «a short-term affair») che valorizza invece la tradizione su Orikos (su un’isola della baia di Valona), la cui fondazione nella metà dell’VIII secolo potrebbe essere ascritta proprio ad Eretriesi, ‘specializzatisi’ sulle rotte ionico-adriatiche.54 Per l’Occidente euboico non si può non iniziare da D. rIDGWAy, L’alba della Magna Grecia, Milano 1992.55 Un quadro sintetico e aggiornato dello stato delle conoscenze e dei problemi
88 STEFANIA DE VIDO
per le altre aree, si intende qui leggere questa esperienza storica solo nelle linee più generali, tentando di indicare alcuni temi che consentano almeno in parte di pensare a una sorta di fenomeno-logia della colonizzazione euboica56.
Si parta, di nuovo, dalla mera osservazione della carta geogra-fica che mette in evidenza con chiarezza le tre aree direttamente interessate dalla presenza euboica e più in particolare calcidese: il golfo di Napoli, l’area etnea, lo Stretto, in una partitura geo-grafica che, come qui detta, segue anche un ordine cronologico. La prima tappa di questo viaggio è per certi versi la più spinosa: Tou' me;n oun Misnou' provkeitai n'so Procuvt, Pikouss'n d estin apovspasma. Pikouvssa d Eretriei' kisan kai; Calkidei', eutucvsante de; di eukarpivan kai; dia; ta; crusei'a exevlipon t;n n'son kata; stavsin, usteron de; kai; upo; seism'n exelaevnte kai; anafusmavtn puro; kai; alavtt kai; erm'n udavtn ecei ga;r toiauvta apofora; n'so, uf n kai; oi pemfevnte para; Ievrno tou' turavnnou t'n Surakosivn exevlipon to; kataskeuase;n uf eaut'n tei'co kai; t;n n'son epelovnte de; Neapoli'tai katevscon57. Questa la testimonianza più articolata su quella che è considerata unanimemente come la più antica ‘fondazione’ ellenica in Oc-cidente, la cui fioritura si colloca tra il 770 e il primo quarto del VII secolo58. Pitecussa è da molto tempo palestra privilegiata nella
relativi agli insediamenti euboici occidentali si deve a G.F. lA TOrrE, Sicilia e Magna Grecia. Archeologia della colonizzazione greca d’Occidente, Bari-Roma 2011, pp. 28-44. 56 Utilissime da tal punto di vista le osservazioni generali di J.P. mOrEl, Problémati-ques de la colonisation grecque en Méditerranée Occidentale: l’exemple des réseaux, in Il dinamismo della colonizzazione greca, a cura di C. ANTONETTI, Napoli 1997, pp. 59-70, che utilizza efficacemente l’idea di rete (‘réseau’) per leggere in maniera dinamica la geografia della colonizzazione greca in Occidente, con particolare attenzione per Focei e, appunto, Eubei.57 Strabo 5, 4, 9. Per il complesso delle fonti antiche nonché per la storia della ricerca archeologica e bibliografia rimando per questo e tutti gli altri siti alle voci relative della Bibliografia della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, I-XXI, Pisa-Roma-Napoli, 1977-2012.58 Per la presenza euboica nel Golfo di Napoli con particolare attenzione proprio per la dialettica Pitecussa/Cuma è molto chiaro il quadro critico offerto in due riprese da B. D’AGOSTINO, Euboean Colonisation in the Gulf of Naples, in Ancient Greeks. West and East, pp. 207-227 e ID., La colonizzazione euboica nel golfo di Napoli, in Nel cuore del Mediterraneo antico. Reggio, Messina e le colonie calcidesi dell’area dello Stretto, a cura di M. GrAS - E. GrEcO - P.G. GuzzO, Corigliano Calabro 2000, pp. 99-113.
89‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
messa a punto dei modelli interpretativi più consoni alle prime fasi della colonizzazione, che sono continuamente rivisti e rimeditati sia sulla base di un affinamento dei concetti guida, sia per le ac-quisizioni per molti versi straordinarie (e assai ben studiate) della ricerca archeologica sul campo. Che poi proprio a Ischia sia stata trovata la cd. ‘coppa di Nestore’, tra le prime testimonianze della scrittura alfabetica nel mondo greco con le ben note e discusse risonanze di sapore epico, ha contribuito a fare della piccola isola del golfo di Napoli un osservatorio assolutamente privilegiato. Il cuore della questione sta tutto nella possibilità, o opportunità, di definire in maniera chiara la natura dell’insediamento pitecusano in relazione sia, in generale, alle dinamiche coloniali proprie delle genti euboiche, sia, più in particolare, nel rapporto con la terra-ferma e con il di poco successivo insediamento di Cuma.
La testimonianza di Strabone è molto chiara, anche se discus-sa, e fa esplicito riferimento a due risorse dell’isola, l’una ‘tecno-logica’, l’altra agricola. Le indagini precorritrici volute e condotte da Georg Buchner hanno già da tempo dimostrato come l’isola fosse un centro importante per technai altamente specializzate: la-vorazione di ferro, bronzo e oreficerie con produzioni di chiaro stile orientalizzante. La ricerca più recente ha non solo comple-tato e raffinato il quadro d’insieme, ma ha consentito una rilet-tura complessiva sulla base di un’intelligente interpretazione dei dati acquisiti sul terreno. L’organizzazione dell’insediamento ci si mostra oggi in tutta la sua complessità e ricchezza, con un’ar-ticolazione territoriale che aggiunge alle officine metallurgiche concentrate sull’acropoli e a quelle ceramiche nella zona portua-le la presenza di fattorie di carattere familiare site su pianori e collinette a quota relativamente alta rispetto al livello del mare e in prossimità di piccole sorgenti d’acqua59; la più nota tra queste è quella di Punta Chiarito, la cui cronologia abbraccia il periodo compreso tra la metà dell’VIII e la fine del VII secolo: un vero e proprio oikos destinato a produzione agricola specializzata e di pregio, in particolare di vino e olio60.
59 Sintetica ed efficace la descrizione di S. DE cArO, Appunti per la topografia della chora di Pithekoussai nella prima età coloniale, in Apoikia, pp. 37-46.60 Dopo C. GIAlANEllA, Pitecussa: gli insediamenti di Punta Chiarito. Relazione prelimi-nare, in Apoikia, pp. 169-204 e S. DE cArO - C. GIAlANEllA, Novità pitecusane. L’in-sediamento di Punta Chiarito a Forio d’Ischia, in Euboica, pp. 337-353, si veda la
90 STEFANIA DE VIDO
Proprio l’oikos sembra essere la struttura dominante dal punto di vista produttivo, topografico e sociale: in questa direzione va anche la lettura articolata della necropoli, utilizzata tra la metà dell’VIII e la metà del VI secolo e caratterizzata da ‘family plots’, ovvero aggregati sepolcrali in cui – cronologicamente e topografi-camente omogenei – ‘convivono’ tombe a tumulo, a cremazione e a fossa. Come ben dimostrato da B. D’Agostino, si tratta di sepol-ture ‘familiari’, in cui la diversificazione della modalità sepolcrale segnala le differenze di età, genere e livello sociale all’interno di una medesima unità familiare61. I corredi dicono trattarsi di grup-pi di buon livello sociale, che conoscevano pratiche connotate so-cialmente come il simposio e non disdegnavano l’utilizzo di merci pregiate, in una situazione complessiva più dinamica rispetto alla madrepatria e più visibilmente animata da momenti di competi-zione e affermazione identitaria.
È all’interno di tale contesto caratterizzato da insediamenti stanziali autonomi e dotati di disponibilità di risorse agricole e artigianali62 che va letta la presenza stabile delle altre componenti etniche, di Fenici63 e di Italici, anch’essi artigiani altamente spe-cializzati, capaci di allargare il tessuto di relazioni soprattutto con l’Occidente mediterraneo (Sardegna e Spagna). È in tal senso particolarmente significativo il ritrovamento nei più antichi livelli di Cartagine (prima metà dell’VIII) di ceramiche euboiche, forse importate direttamente dai Fenici insieme a ceramica italica, for-se prodotte in loco da artigiani euboici residenti64.
nuova sintesi in Dopo Giorgio Buchner. Studi e ricerche su Pithekoussai, a cura di C. GIAlANEllA - P.G. GuzzO, Salerno 2011.61 Estremamente interessante, e definitiva, l’analisi sociale proposta da D’AGOSTI-NO, La colonizzazione euboica nel golfo di Napoli; uno studio sistematico della fase più antica della necropoli ischitana, con interessanti considerazioni di ordine demo-grafico, si deve oggi a V. NIzzO, Ritorno ad Ischia, Napoli 2007, in part. pp. 25-36.62 B. D’AGOSTINO, Pitecusa - Una apoikia di tipo particolare, in Apoikia, pp. 19-27, 24-26 si sofferma proprio sugli aspetti economici, riprendendo un convincente modello interpretativo che individua in Pitecussa una comunità «dedita all’emporìa, alla produzione artigianale e alla messa a frutto della sapienza tecnica», nonché al commercio dell’olio e del vino.63 Sulla presenza fenicia e levantina a Ischia cfr. già J. bOArDmAN, Orientalia and Oriental on Ischia, in Apoikia, pp. 95-100.64 Cfr. DOmINGuEz, Mobilità umana, p. 148, che ipotizza l’esistenza di numerosi casi di stanziamento permanente o temporaneo (tra questi Oropo, Zagora ad Andros, Cicladi) di genti euboiche lontano dalla madrepatria; sulla stessa linea
91‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
Acquisita questa nuova immagine storica dell’isola, diventa pa-radossalmente più arduo capire il rapporto con la grande città (questa sì, senza dubbio, polis) sulla costa antistante, Cuma. Così Strabone65: tauvtai d efex' esti Kuvm Calkidevn kai; Kumaivn palaiovtaton ktivsma pas'n gavr esti presbutavt t'n te Sikelik'n kai; t'n Italitivdn. oi de; to;n stovlon agonte, Ippokl' o Kumai'o kai; Megasevn o Calkideuv, dimologvsanto pro; sfa' autouv, t'n me;n t;n apoikivan einai t'n de; t;n epnumivan oen nu'n me;n prosagoreuvetai Kuvm, ktivsai d aut;n Calkidei' dokou'si. Sull’o-rigine euboica di Cuma le fonti antiche non hanno alcun dubbio, come concordi sono sulla sua estrema antichità, che, nel dittico con Pitecussa, segnala il nucleo più antico dell’insediamento eu-boico (e greco) in Occidente. L’elemento disturbante in questa testimonianza è la menzione dell’altra Cuma, quella eponima, nella quale, dopo un generale consenso verso Cuma eolica, si è di recente riproposta la possibilità di individuare la Cuma euboi-ca, piccolo sito sulla costa orientale dell’isola66. Al di là di que-sta specifica lettura, in sé plausibile, non mi pare da escludere a priori che in un movimento coloniale così ambizioso possano essere stati coinvolti elementi non euboici, sia beotici, in sé più facili da identificare e collocare storicamente67, sia micrasiatici, in particolare dalla costa più settentrionale, solidale geografica-mente con i più antichi interessi calcidesi. Anche la tradizione sui due ecisti di Cuma68, in sé piuttosto tipica, si potrebbe spiegare
J. bOArDmAN, Early Euboean Settlements in the Carthage Area, OJA, 25(2006), pp. 195-200, che si sofferma sull’area cartaginese di cui valorizza gli indizi toponomastici. Propendono invece per un ruolo centrale dei Fenici anche nel trasporto e nella diffusione della ceramica euboica a Cartagine R.F. DOcTEr - H.G. NIEmEyEr, Pithe-koussai: the Carthaginian Connection, in Apoikia, pp. 101-115.65 Strabo 5, 4, 4; si vedano anche Liv. 8, 22, 5 Palaepolis fuit haud procul inde, ubi nunc Neapolis sita est; duabus urbibus populus idem habitabat. Cumis erant oriundi; Cumani Chalcide Euboica originem trahunt e Sol. 2, 16 Deinde constituta ab Ascanio Longa Alba, Fidenae, Aricia; Nola a Tyriis; ab Euboensibus Cumae. 66 Nel sito della presunta Cuma euboica è stato rinvenuto un edificio ovale con funzione di Kulthaus di inizio VIII e simile a quelli di Lefkandi ed Eretria: si veda l’analitico resoconto delle indagini offerto da E. SAPOuNA-SAkEllArAkI, Geometric Kyme. The excavation at Viglatouri, Kyme, on Euboea, in Euboica, pp. 59-104.67 Valorizzano gli elementi beotici (in particolare da Tanagra) nelle dinamiche della colonizzazione greca in Campania sia mElE, Il commercio greco arcaico, pp. 36-37 che, più di recente, bOFFA, Erodoto (V 57-59), p. 14.68 Dion. Hal. 7, 3, 1 riferisce invece che le due componenti erano entrambe
92 STEFANIA DE VIDO
proprio nell’ottica della convivenza di componenti egualmente forti o strutturate nell’orientare definitivamente finalità e destina-zione del nuovo insediamento69. La storia di Cuma, a differenza di Pitecussa compiuta polis hellenis, si sviluppa rapidamente come storia di una comunità politica autonoma a larga base territoriale, dotata di riconoscibili strutture civiche, e soprattutto capace, già a partire dagli inizi del VII sec., di organizzare intorno a sé una serie di centri da essa dipendenti (Partenope, Pozzuoli, Miseno) al fine di controllare il Golfo di Napoli. La città ha con il mare dal Golfo verso tutto il Tirreno meridionale un rapporto necessario: non a caso la tradizione tucididea tramanda una sua specifica attitudine alla pirateria, e non a caso proprio nelle acque di Cuma si combat-te la nota battaglia che nel 474 a.C. vede spartirsi definitivamente il Tirreno tra Etruschi e Siracusani.
La valorizzazione dell’elemento propriamente geografico con-sente di inquadrare diversamente anche il rapporto con Pitecus-sa70. Indebolita l’ipotesi di una sorta di opposizione strutturale tra i due insediamenti, superata la strettoia terminologica (antica e moderna) e concettuale tra emporion e polis, resta il nodo del rap-porto temporale e strutturale tra le due comunità71, da spiegar-si, credo, nell’ottica dell’integrazione più che dell’opposizione. Cuma, cioè, non si sostituisce a Pitecussa, ma con essa convive in un rapporto che ha la sua chiave più chiara nella logica topografi-ca e funzionale dello ‘stretto’. Per un breve periodo (breve, come
euboiche: … Kuvmn t;n en Opikoi' Ellnivda povlin, n Eretriei' te kai; Calkidei' ektisan…69 I materiali più antichi da Cuma sono databili al 750/725, dunque leggermente più recenti rispetto a quelli pitecusani, ma ad essi assai simili per tipologia: essi, però, provengono da tombe la cui ubicazione è già in relazione con un’area urbana ben definita.70 L’importanza dell’aspetto squisitamente geografico è stata messa in rilievo con la consueta lucidità da D. muSTI, Magna Grecia. Il quadro storico, Roma-Bari 2005, pp. 67-71 proprio a proposito degli insediamenti euboici e corinzi.71 La questione è posta con molta chiarezza da E. GrEcO, Pithekoussai: emporion o apoikia?, in Apoikia, pp. 11-18, in part. p. 15 che confrontandosi con l’ampia let-teratura, conclude: «Tutti gli elementi fino ad oggi recuperati non sembrano… contrastare molto con l’idea che essa fosse una polis, evidentemente nei limiti e con le specificità che rivestono questo concetto nel secolo VIII a.C.»; in questo senso è da rileg-gere la proposta di M. GIANGIulIO, Intervento, in Nouvelle contribution, pp. 152-155 di «classificare Pithekoussai come il punto più elevato di una comunità alla soglia del-la polis», che potrebbe essere allargata a molte comunità dell’alto arcaismo greco.
93‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
spiega Strabone, per ragioni naturali), le due comunità, diverse per attività produttive e articolazione sociale, si integrano a vicen-da, come declinazioni diverse e complementari di un’esperienza omogenea.
In Sicilia c’è un altro Stretto, assai più importante. Ma prima di arrivarci è bene leggere Tucidide, l’archeologia72: Ellvnn de; pr'toi Calkid' ex Euboiva pleuvsante meta; ouklevou oikistou' Navxon kisan, kai; Apovllno Arcgevtou bmo;n osti nu'n ex t' povlev estin idruvsanto, ef , otan ek Sikeliva eroi; plevsi, pr'ton uvousin. ... oukl' de; kai; oi Calkid' ek Navxou ormevnte etei pevmpt meta; Surakouvsa oikiseivsa Leontivnou te polevm tou; Sikelou; exelavsante oikivzousi, kai; met autou; Katavnn oikist;n de; autoi; Katanai'oi epoivsanto Euarcon.
In questo racconto di fondazione Nasso è indicata come la pri-ma delle colonie siceliote (734), seguita a pochi anni di distan-za da Leontini e Catane (729). Notiamo subito un elemento già annunciato dalle dinamiche proprie della madrepatria e dai rap-porti di forza instaurati sia nella penisola calcidica che a Corcira: come in Grecia propria anche in Sicilia la colonizzazione euboica deve fare i conti con Corinto che fondando Siracusa si incunea perfettamente – nel testo tucidideo almeno – nella scansione del-le fondazioni calcidesi. Una tessitura narrativa così perfetta di-spiega in pochi anni e in dinamiche apparentemente pacifiche movimenti che, come il caso corcirese dimostra, devono aver com-portato turbolenze e conflittualità più o meno latenti. La presa di possesso dell’ampia piana subetnea segnò un punto a favore dei Calcidesi che però assai presto e lungo tutta la loro storia furono letteralmente martoriati dai Siracusani. Quella di Nasso, Leontini e Catane è la storia di città il cui destino non fu segnato, come poi volle certa propaganda di alcuni secoli più tarda, dal profilo
72 Thuc. 6, 3, 1; 3 da leggere con l’insostituito commento di A.W. GOmmE - A. ANDrEWES - K.J. DOVEr, A Historical Commentary on Thucydides. IV, Oxford 1970; cfr. anche Strabo 6, 2, 3 kai; Katavn d esti; Naxivn t'n aut'n ktivsma e Diod. 12, 53, 1 epi; de; touvtn kata; t;n Sikelivan Leonti'noi, Calkidevn me;n onte apoikoi, suggenei' de; Anaivn, etucon upo; Surakosivn polemouvmenoi. A M. mOGGI, L’area etnea: le colonie di Thoukles, in Colonie di colonie: le fondazioni sub-coloniali greche tra colonizzazione e colonialismo (Atti del Convegno Internazionale, Lecce 2008), a cura di M. lOmbArDO - F. FrISONE, Galatina 2009, pp. 37-47 si deve una stringente analisi che partendo dal passo di Tucidide ricostruisce le dinamiche intervenute in Sicilia a ridosso della fondazione di Nasso.
94 STEFANIA DE VIDO
etnico (Ioni vs Dori), quanto dalla posizione geografica, in sé fe-licissima e per questo molto appetita da una Siracusa sempre più aggressiva. Non si spiegherebbe altrimenti il destino egualmente infelice di Megara, città dorica, ma anch’essa troppo prossima alla colonia corinzia.
In questa prospettiva squisitamente territoriale va inquadrato anche il ritmo tipicamente coloniale che vede la prima fondazione (Nasso) farsi a sua volta madrepatria di Leontini e Catane, vere ‘colonie di colonie’73: l’apoikia madre anche grazie all’aiuto della madrepatria segna il territorio con proprie sub-colonie, marcando confini geografici e culturali. Al di là dell’enfasi ideologica che si può forse attribuire alla pagina tucididea funzionale alle dinami-che della guerra del Peloponneso (in Ellanico, ad esempio, Teocle di Calcide avrebbe guidato una compagine di Calcidesi e Nassi di Nasso cicladica)74, è chiara la primogenitura di Nasso, che, pur ri-manendo di dimensioni limitate e nonostante una vita tutto som-mato breve, conserva comunque un ruolo centrale, almeno sul piano identitario: questo dicono sia il ruolo dell’ecista, il cui nome
73 Si leggano ancora Diod. 12, 53, 1 epi; de; touvtn kata; t;n Sikelivan Leonti'noi, Calkidevn me;n onte apoikoi, suggenei' de; Anaivn, etucon upo; Surakosivn polemouvmenoi e Strabo 6, 2, 3 kai; Katavn d esti; Naxivn t'n aut'n ktivsma.74 Hellanic. 4 F 82 ap. Steph. Byz. Calkiv povli Euboiva. Ekatai'o Eurvp (1 F 129) ... eklv de; apo; Kovmb t' Calkivdo kaloumevn, ugatro; Aspou'... kai; to; luko;n omvnumon t' povlei, kiv Lokriv, cvra kai; gunv Ellavniko Ierei'n Hra b “eokl' ek Calkivdo meta; Calkidevn kai; Naxivn en Sikeliv povlin ektise”. Anche qui, come nel caso di Cuma, la tradizione potrebbe conservare traccia di una partecipazione reale di elementi cicladici, tanto più che con le Cicladi l’Eubea intratteneva in età arcaica proficui rapporti testimoniati dai rinvenimenti ceramici: si vedano le riflessioni in merito di N. kOurOS, Euboea and Naxos in the Late Geometric Period: the Cesnola Style, in Euboica, pp. 167-177; sui crateri del tipo Cesnola Painter considerati come ‘compendio’ (per stile e iconografia) dell’attività ceramica di matrice euboica e dei gusti della sua classe aristocratica si veda J.N. cOlDSTrEAm, Pithekoussai, Cyprus and the Cesnola Painter, in Apoikia, pp. 77-86. Ancora più complessa la tradizione riportata da Eforo (Ephor. 70 F 137 ap. Strabo 6, 2, 2 fsi; de; tauvta [sc. Navxo kai; Mevgara] Eforo prvta ktis'nai povlei Ellnivde en Sikeliva, dekavt genea' meta; ta; Trikav tou; ga;r provteron dedievnai ta; listvria t'n Turrn'n kai; t;n movtta t'n tauvt barbavrn, ste mde; kat emporivan plei'n. eokleva d Anai'on parenecevnta anevmoi ei t;n Sikelivan katano'sai tvn te oudenvveian t'n anrvpn kai; t;n aret;n t' g', epanelovnta de; Anaivou me;n m; pei'sai, Calkideva de; tou; en Euboiva sucnou; paralabovnta kai; t'n Ivnn tinav, eti de; Drievn, <n> oi pleivou san Megarei', pleu'sai. tou; me;n oun Calkideva ktivsai Navxon, tou; de; Drieva Mevgara t;n blan provteron kaloumevnn).
95‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
viene tramandato da corposi segmenti di tradizione, sia l’impor-tanza dell’Apollo Archegetes (epiclesi evidente), il cui culto rima-ne a lungo attraverso la devozione dei theoroi come riferimento per l’identità siceliota nello specchio del proscenio panellenico.
La prima colonia sembra mantenere un legame stretto se non esclusivo con la madrepatria euboica (questo, almeno, dice la fa-cies ceramica)75, facendosi in certo modo garante e depositaria sia sul piano ideale che su quello materiale di rapporti privilegiati. La fondazione delle altre due poleis in Sicilia potrebbe essere il risultato di un progetto congiunto tra Nasso e gli Eubei per un migliore sfruttamento della pianura, a dire definitivamente, tra l’altro, l’insensatezza di una lettura che vorrebbe opporre le co-lonie euboiche di vocazione commerciale a quelle doriche di vo-cazione agricola. Le colonie, tutte le colonie, avevano bisogno di terra. Del tutto coerente con questa immagine è infine un altro passaggio straboniano che attribuisce a Nasso la fondazione di una Kallipolis e a Leontini quella di una Euboia: nomi parlanti di siti mai identificati che confermano però certo dinamismo anche sul piano territoriale76.
L’esperienza euboica in Sicilia ha il suo cuore più dinamico nell’altra area isolana, lo Stretto; attraverso lo Stretto si saldano le esperienze euboiche nel Tirreno e nell’Isola, e nello Stretto tro-viamo definitivamente evidenziate alcune caratteristiche già visibi-li nel Golfo campano: vocazione ‘istmica’, dinamismo marittimo, spregiudicatezza nelle misture etniche. Come osservato da Michel Gras, lo Stretto va letto alla luce della naturale contiguità e conti-nuità tra le due sponde: Zancle e Reggio e poi, a seguire, Mylae, Matauros ed Imera appartengono a un sistema coerente, a un ‘ter-ritorio’ cioè che integra mare e terraferma in una prospettiva con-divisa77. Rivelatrice di questa funzione di cerniera che si attiva pro-
75 Su questo aspetto mi limito a rimandare a m.c. lENTINI, Nuovi rinvenimenti di ceramica euboica a Naxos di Sicilia, in Euboica, pp. 377-386.76 Strabo 6, 2, 6 Kallivpolin de; Navxioi, Selinou'nta de; oi autovi Megarei', Euboian de; oi Leonti'noi.77 Si veda l’importante contributo di m. GrAS, Lo Stretto fra Calabria e Sicilia e i traffici arcaici, in Nel cuore del Mediterraneo antico, pp. 19-28, che apre una serie di lavori concentrati proprio sullo Stretto e su alcune città greche che su di esso gravitano: cfr. in particolare M.C. lENTINI, Naxos, 115-124; L. TOmAy, Métauros, 125-134; G. TIGANO, Milazzo, 135-160; ma sulla storia ‘parallela’ delle due sub-colonie Matauros e Mylai si veda già C. SAbbIONE, La colonizzazione greca: Matauros e
96 STEFANIA DE VIDO
prio attraverso una specifica caratterizzazione euboica è la storia della fondazione di Zancle (siamo verso il 730). Così è tramandata da Tucidide: avgkl de; t;n me;n arc;n apo; Kuvm t' en Opikiva Calkidik' povle lst'n afikomevnn kivs, usteron de; kai; apo; Calkivdo kai; t' all Euboiva pl'o elo;n xugkateneivmanto t;n g'n kai; oikistai; Perivr kai; Krataimevn egevnonto aut', o me;n apo; Kuvm, o de; apo; Calkivdo. onoma de; to; me;n pr'ton avgkl n upo; t'n Sikel'n klei'sa; a questa si aggiunge la testimonian-za di Strabone: ktivsma d esti; Messnivn t'n en Peloponnvs, parn tounoma metvllaxe kaloumevn avgkl provteron dia; t;n skoliovtta t'n tovpn (zavgklon ga;r ekalei'to to; skoliovn), Naxivn ousa provteron ktivsma t'n pro; Katavnn epvksan d usteron Mamerti'noi Kampan'n ti fu'lon78. La prima ambigua fase del nuovo insediamento sullo Stretto avrebbe visto come protagonisti pirati di Cuma in Opicia, cui sarebbero seguiti i veri e propri fondatori guidati dai due ecisti ‘canonici’ a inaugurare una storia non poco tormentata con le successive occupazioni di Sami, dei Messeni e, in una fine ormai drammatica, dai Mamertini. Più di altre, la po-lis di Zancle si presenta dunque come «lento e graduale farsi»79, gradualità da leggersi però non come segno di debolezza, quanto come segnale della polarizzazione di uomini e risorse determi-nata dallo Stretto e dalla particolare conformazione della costa (peraltro già sottolineata dal toponimo). L’incertezza delle crono-logie autorizza ricostruzioni che vedono la prima frequentazione di Zancle omogenea o all’insediamento di Pitecussa ovvero alla fondazione di Cuma80: comunque sia, è chiaro che a partire dalla
Mylai, in Lo Stretto crocevia di culture. Atti del XXVI Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 1986), Taranto 1987, pp. 221-236. Come ben suggerito anche dall’intervento di U. SPIGO in questo contesto (Lipari fra lo Stretto di Messina e il mondo italiota. Approccio ai dati archeologici, pp. 161-186) andrebbe meglio tenuto in conto il ruolo giocato dalle Eolie non solo alla fine del II millennio, ma anche in età pienamente coloniale. Per la ricostruzione d’insieme delle dinamiche in atto nello Stretto sul lungo periodo basti C. AmPOlO, La funzione dello Stretto nella vicenda politica fino al termine della Guerra del Peloponneso, in Lo Stretto, pp. 45-71.78 Thuc. 6, 4, 5 e Strabo 6, 2, 2-3.79 Questa la suggestiva espressione di A.m. PrESTIANNI, Zancle e le colonie zanclee, in Colonie di colonie, pp. 267-276, in un lavoro che coniuga ricostruzione storica e prospettiva storiografica, con particolare attenzione all’atteggiamento di Tucidi-de verso le città calcidesi di Sicilia.80 Le diverse ipotesi che spostano in alto o in basso le cronologie relative sono
97‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
metà dell’VIII secolo almeno la presenza euboica ha una concen-trazione evidente nel Basso Tirreno con un’iniziale fluidità che solo in una seconda fase, coerente con la fondazione delle colonie di area etnea, avrebbe portato a insediamenti stabili. Dal punto di vista sociale questa fluidità potrebbe rimandare alla specifica con-notazione dell’élite euboica su cui torneremo in chiusura.
Anche Zancle si fa protagonista di un rilancio coloniale che, di nuovo con l’aiuto di Calcide, porta nel 720 circa alla fondazione di Reggio, dall’altra parte dello Stretto. Testimone autorevolissimo, Antioco81: Ktivsma d esti; to; Rvgion Calkidevn, ou kata; crsmo;n dekateuevnta t' Apovllni di aforivan usteron ek Delf'n apoik'sai deu'rov fasi paralabovnta kai; allou t'n oikoen d Antivocov fsi, agklai'oi metepevmyanto tou; Calkideva kai; oikist;n Antivmnston sunevstsan ekeivnn. san de; t' apoikiva kai; oi Messnivn fugavde t'n en Peloponnvs katastasiasevnte. Anche Reggio è una colonia di colonia, anch’essa ha un pro-filo misto con la partecipazione sia della madrepatria che di un elemento esterno (i Messeni), anch’essa rappresenta la prima e più duratura iniziativa della primogenita Zancle che non si limita a ‘chiudere’ lo Stretto (sempre assai conteso), ma a promuovere altri insediamenti in modo da ‘circondare’ il Basso Tirreno con una corona di siti, dalla doppia valenza portuale e agricola82. L’in-teresse alle risorse della terra è evidente nell’occupazione tra la fine del VII e l’inizio del VI sec. del sito di Matauros83, l’odierna Gioia Tauro, una delle rare pianure coltivabili della Calabria, che però passa rapidamente sotto il controllo di Locri. Più duratu-ro invece il controllo sull’insediamento ad esso in qualche modo speculare sulla riva siceliota del Tirreno, Mylae (Milazzo), protesa verso le isole Eolie e inserita dallo Pseudo Scimno nel catalogo
riassunte e commentate da D’AGOSTINO, Pitecusa, pp. 20-21 che conclude, a mio parere saggiamente, che «... non mi sento né di correggere né di interpretare – adattandolo all’evidenza archeologica – il passo di Tucidide; mi interessa ciò che esso dice: la prima Zancle non era una polis».81 Antioch. 555 F 9 ap. Strabo 6, 1, 6.82 Dopo l’imprescindibile studio di G. VAllET, Rhégion et Zancle, Paris 1958, per molti versi davvero pionieristico, sulla presenza euboica in Calabria si veda ora L. mErcurI, Eubéens en Calabre à l’époque archaique. Formes de contacts et d’implantations, Rome 2004.83 Sol. 2, 11 A Zanclensibus Metaurum locatum, a Locrensibus Metapontum.
98 STEFANIA DE VIDO
delle città euboiche84: Meta; tau'ta d apo; Navxou Leonti'noi po'li, / t;n evsin t ecousa Rgivou pevran, / epi; tou' de; pormou' keimevn t' Sikeliva, / avgkl, Katavn, Kallivpoli esc apoikivan. / Pavlin d apo; touvtn duvo povlei, Euboia kaiv / Muvlai katkivssan epikalouvmenai, / ei Imevra kai; Tauromevnion ecomevn. Vi leggiamo i nomi di tutte le colonie euboiche di Sicilia: ci sono Kallipolis ed Euboia, ci sono anche Milazzo e Imera, ma la regia narrativa del testo le confonde tutte, leggendo come coerente e univoca una pluralità di insediamenti sgranati invece nel tempo e nello spazio. All’occhio del geografo di età imperiale le logiche locali ormai erano diventate sfuggenti e prevaleva quella distinzione ‘etnica’ che guardava al mondo coloniale attraverso il filtro dell’opposi-zione tra Ioni e Dori.
Imera, infine, fondata nella parte dell’isola più prossima ai Fenici (Solunto e Panormo lì vicine) nel 649 a.C. secondo la cronologia tradizionale. Così Tucidide85: kai; Imevra apo; avgkl kivs upo; Eukleivdou kai; Sivmou kai; Savkno, kai; Calkid' me;n oi plei'stoi lon e t;n apoikivan, xunvkisan de; autoi' kai; ek Surakous'n fugavde stavsei nikevnte, oi Multivdai kalouvmenoi kai; fn; me;n metaxu; t' te Calkidevn kai; Drivdo ekrav, novmima de; ta; Calkidika; ekravtsen. Abbiamo ormai imparato a ricono-scere gli ingredienti (il carattere sub-coloniale e misto della nuova città) cui qui si aggiunge la preziosa notazione che nel riferimen-to ai novmima ta; Calkidika; fa intuire la possibilità di una specificità politica delle colonie euboiche. Suggestivo potrebbe suonare il ri-chiamo alla figura di Caronda legislatore di Catania, il cui operato però ci è del tutto sconosciuto; plausibile, peraltro, che le colonie euboiche proprio perché fondate in una fase molto precoce del formarsi della polis abbiano conosciuto un’altrettanto precoce, e forse innovativa, prospettiva politica che al momento di strut-turare nuove poleis ha concepito particolari dispositivi legislativi ritenuti in seguito proprî di una politeia etnicamente connotata.
84 Ps. Scymn. 284-289.85 Thuc. 6, 5, 1; cfr. anche di nuovo Strabo 6, 2, 6 n t;n me;n Imevran oi en Mulai' ektisan agklai'oi, Gevlan de; Rovdioi, Kallivpolin de; Navxioi, Selinou'nta de; oi autovi Megarei', Euboian de; oi Leonti'noi. La cronologia della fondazione è ricostruita a ritroso a partire da un passo di Diodoro (13, 62, 4) secondo il quale la distruzione della città ad opera dei Punici (409 a.C.) sarebbe avvenuta 240 anni dopo la fondazione stessa.
99‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
Troppo poco, però, ci è noto e solo ritrovamenti epigrafici come quello della cosiddetta legge di Imera86 potranno dare qualche elemento aggiuntivo. Il mondo istituzionale delle città arcaiche di Sicilia (di tutte, non solo di quelle euboiche) ci è per ora pre-cluso, e provando a pensarle e a descriverle non possiamo che ricorrere a quanto sappiamo più in generale sugli aspetti politici dell’arcaismo greco.
Lasciando Imera al suo destino di città di frontiera, merita pro-porre in conclusione qualche breve riflessione d’insieme. La colo-nizzazione euboica in Occidente, come detto, può essere pensata ‘per circuiti’ che hanno come fuoco tre aree fondamentali per risorse e prospettive: il Golfo di Napoli, l’area etnea e lo Stretto. In tutte e tre, pur con modalità diverse e qualche sfasatura cro-nologica, noi vediamo una città primogenita che si fa carico di un movimento coloniale di seconda battuta volto a solidificare il controllo su un territorio più vasto: da Cuma a Neapolis; da Nasso a Leontini e Catane; da Zancle a Reggio e poi a Mylae, Matauros e Imera. La nozione di ‘territorio’, però, va qui intesa come siste-ma integrato di aree agricole, approdi e mare, il che porta a due ricadute immediatamente evidenti: la prima riguarda la centralità che qui come già in madrepatria hanno i passaggi, gli istmi, i brac-ci di mare che uniscono e non dividono; l’altra, più in grande, obbliga a leggere questi tre circuiti come necessariamente inter-dipendenti, il che è suggerito, del resto, proprio dalla complessità cronologica e relazionale delle tradizioni sulle fondazioni mede-sime. Questi circuiti, soprattutto una volta che Siracusa ha chiuso definitivamente ogni prospettiva verso la Sicilia orientale, hanno come denominatore comune il Basso Tirreno87, su cui in misura diversa si apre la maggioranza delle colonie euboiche e che sin dai primi movimenti coloniali si conferma ‘luogo’ privilegiato, vuoi per le risorse oggettive, vuoi per l’incrociarsi in esso di popola-
86 Il riferimento è alla laminetta bronzea rinvenuta a Imera, che si data alla fine del VI secolo e riporta la normativa relativa alla redistribuzione della terra necessaria in un’occasione non meglio precisabile: si veda nel dettaglio A. bruGNONE, La legge di Himera sulla redistribuzione della terra, PP, LII(1997), pp. 262-305.87 Come rilevato da lA TOrrE, Sicilia e Magna Grecia, p. 40 rimane ancora da chiarire l’assetto insediativo dell’area compresa tra lo Stretto e il Golfo di Napoli, dove è possibile che i navigatori euboici potessero far «affidamento… su tutta una sere di scali naturali intermedi».
100 STEFANIA DE VIDO
zioni diverse (con un occhio particolare per Fenici e Cartaginesi da un lato ed Etruschi e Italici dall’altro). Vista così, pur nella sua incompiutezza, Pitecussa è una sorta di paradigma intrinseco dell’importanza di quest’area e, in essa, dell’azione euboica.
Azione, e questo è un secondo aspetto, che vede in più occasio-ni l’intervento diretto della madrepatria, soprattutto nella perso-na di Calcide se, come plausibile, Eretria dopo la guerra di Lelan-to arretra verso una prospettiva più localistica. I soggetti trainan-ti di questa azione coloniale di così grande respiro e ambizione sono probabilmente i grandi aristocratici, quelli che sin dall’alto arcaismo avevano assecondato, e potenziato, i contatti con uomini e terre lontane. Un nesso che, del resto, è esplicitamente sottoli-neato già da Aristotele88: kai; t' Italiva de; kai; Sikeliva polla; criva Calkidevn estivn estavlsan de; ai apoikivai autai, kaavper eirken Aristotevl, nivka t'n Ippobot'n kaloumevn epekravtei politeiva proevstsan ga;r aut' apo; timmavtn andre aristokratik' arconte. Sono gli aristocratici della prexis, nell’accezione messa a punto da Alfonso Mele, un’attività che tiene insieme, inte-grandole reciprocamente, produzione, navigazione e commercio, che ancora si fonda su valori che noi riconosciamo come ‘omerici’ (primi tra tutti ospitalità e doni), che esporta vino, olio e grano surplus del prodotto delle proprietà fondiarie per acquisire me-talli da lavorare poi in officine specializzate. Un’aristocrazia forte, ricca, molto motivata e molto dinamica, che si fa riconoscere pre-cocemente (ovvero sin dal X sec.) per accumulazione ed esibizio-ne di ricchezza, come dimostrato dai grandi vasi figurati con fun-zione prima simposiale e poi funeraria, e per allevamento di un animale di lusso come il cavallo. Un’aristocrazia che non disdegna nemmeno la pratica della pirateria, forma alternativa di commer-cio non regolamentato e strumento di controllo navale di aree strategiche89. Come è stato giustamente osservato, così, non v’è
88 Aristot. fr. 603 Rose ap. Strabo 10, 1, 8 ai doun povlei autai diaferovnt auxei'sai kai; apoikiva esteilan axiolovgou ei Makedonivan Erevtria me;n ga;r sunvkise ta; peri; Pallvnn kai; to;n A povlei, de; Calki; ta; upo; Oluvn, a ivlippo dielumvnato. kai; t' Italiva de; kai; Sikeliva polla; criva Calkidevn estivn estavlsan de; ai apoikivai autai, kaavper eirken Aristotevl, nivka t'n Ippobot'n kaloumevn epekravtei politeiva proevstsan ga;r aut' apo; timmavtn andre aristokratik' arconte.89 Dopo mElE, Il commercio greco arcaico, si vedano le considerazioni di A. mElE, Il Tirreno tra commercio eroico ed emporia classica, in Navies and Commerce of the Greeks,
101‘CAPITANI CORAGGIOSI’. GLI EUBEI NEL MEDITERRANEO
opposizione tra gli emporoi di Pitecussa e i lestai di Zancle90, omoge-nea espressione di una élite che anche attraverso l’esperienza colo-niale metteva a punto dispositivi adatti sia al controllo territoriale sia a quello del mare, tanto più che proprio in quelle acque essa doveva fare i conti con la concorrenza dei suoi omologhi etru-schi. Che tutto questo sia espressione di una dimensione privata, come vorrebbe Osborne91, o ‘statale’ è a mio parere questione mal posta, lì dove è lo stesso soggetto sociale, l’aristocrazia euboica appunto, a sperimentare strade nuove sia sul terreno politico sia su quello squisitamente sociale ed economico. L’esito supera le premesse portando in Occidente come altrove nel mondo greco le nuove dinamiche di città fondate, da pensarsi come organismi dall’articolazione complessa in cui la logica ‘primitiva’ per gene deve fare i conti con una strutturazione più dinamica, in cui an-che le risorse sono diversamente distribuite92.
Una storia, questa, che travalica la specificità euboica, di lì a poco non più riconoscibile come tale, se non nelle memorie iden-titarie (il genos Chalkidikon rammentato dagli storici del V secolo) di chi cerca di ricordare se stesso.
the Carthaginians and the Etruscans in the Tyrrhenian Sea, Strasbourg-Ravello 1988, pp. 57-68, in part. 66-67 proprio sui caratteri del commercio euboico di VIII secolo anche nelle sue tangenze con la pirateria; limpidissima anche la sintesi di metodo proposta da A. SchNAPP, Le vie del commercio Greco in Occidente, in Nel cuore del Mediterraneo antico, pp. 43-48.90 Il tentativo di lettura organica della presenza degli Eubei a Pitecussa e sullo Stretto è già stato convincentemente esperito da G. VAllET, Les cités chalcidiennes du Détroit et de Sicile, in Gli Eubei in Occidente. Atti del XVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 1978), Taranto 1979, pp. 83-143, in un convegno programmaticamente orientato a valorizzare tale prospettiva.91 Richiamo ancora le considerazioni di OSbOrNE, Early Greek Colonization?, che comunque sollecitano verso una migliore messa a fuoco della questione termino-logica anche nella riflessione moderna in merito alla possibile distinzione tra ‘state’ e ‘private’.92 Sulla strutturazione sociale di Pitecussa, già meno rigidamente gerarchizzata rispetto a quella della madrepatria euboica, sono convincenti le osservazioni di D’AGOSTINO, Pitecusa, pp. 26-27 che vede in questa esperienza ‘coloniale’ un segno di dinamismo e cambiamento precocemente innestato sul modello aristo-cratico dell’alto arcaismo.
102 STEFANIA DE VIDO
ABSTRACT
In this paper we intend to present a critical overview of Euboea’s role in the Mediterranean Sea after the Dark Ages and during the historical colonization. The topic is based on historical and archaeological sources and follows a route from 1st-millennium BC Eastern Mediterranean to the 8th-century BC Western Colonies.
The first part of this paper focuses on two places that are really im-portant in the research on the Euboeans: Al-Mina, at the mouth of the Orontes river, an emporion for which the model of the polanyian ‘port-of-trade’ has been evoked, and Lefkandi, where the famous funerary building was discovered. Both of them make evident the importance of interferences with the Phoenician routes and the movement of luxury goods, ceramic, and metal products; furthermore, the funeral rite has urged interesting considerations about the heroic (Homeric?) culture of that very aristocracy, as well as the political function of the buried couple.
As elsewhere in the Greek world, even Euboea knows the formation of poleis: Chalcis and Eretria, which share the first colonial experiences towards the Chalkidike area and the West (via Corcyra). After the Le-lantine War (VIII cent. BC) Eretria declines in a local dimension with strong and particular relationship with Boeotian Oropus; Chalcis, how-ever, has long been very active on the Western routes and in particular in three areas: the Gulf of Naples, the region of Aetna in Sicily, the Strait of Messina. We can try to identify some recurring issues that might suggest sort of an ‘Euboic model’ in the Colonization of the West: the frequency of colonies’ colonies, the importance of the straits, the mixed charac-ter of the foundations (up to the limit-case of Himera with Ionians and Dorians together). In any case, it is clear the centrality of the Lower Tyrrhenian Sea, starting from the first settlement of Pithecusae and the maritime activity of Etruscans and pirates.
The presence of pirates has suggested the final considerations about the peculiarities of the social subject of this experience, to be identified in an aristocracy linked to the land (and the breeding of horses), but capable of expressing great dynamism both politically and in social as well as economic development.