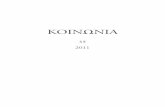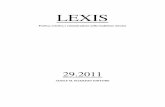Il lessico mentale
Transcript of Il lessico mentale
Corso di Laurea Magistrale in Italianistica e Scienze Linguistiche
SCIENZE COGNITIVEAnno Accademico 2013-2014
Il lessico mentale
Studente: Beatrice CocliteMatricola: 0000709099
Anno: I
Il lessico mentale
1. Cos'è il lessico mentale?...................................................................................... 3
1.1 Criteri di organizzazione......................................................................................... 3
1.2 I deficit categoria-specifici...................................................................................... 5
2. Modelli di rappresentazione.................................................................................7
2.1 Il modello a ricerca attiva di Forster.......................................................................8
2.2 Fodor e la modularità della mente.......................................................................... 9
2.3 Il secondo modello logogen di Morton ................................................................. 10
2.4 L'approccio connessionista: McLelland e Rumelhart............................................ 12
2.5 Simple Recurrent Network..................................................................................... 13
Bibliografia.............................................................................................................17
Il lessico mentale
1. Cos'è il lessico mentale?
Il lessico mentale consiste nel database di parole, conservate nella memoria a lungo
termine, che utilizziamo per comprendere il linguaggio e per produrre a nostra volta enunciati
di senso compiuto. Esso contiene informazioni di tipo ortografico e fonetico, sintattico e
semantico. Paragonarlo a un comune dizionario, tuttavia, sarebbe riduttivo: il lessico mentale
si attiva in maniera non-cosciente in pochi millisecondi; esso cambia notevolmente,
arricchendosi di contenuti1, nel corso della nostra vita ed è in grado di auto-organizzarsi di
volta in volta in base ai nuovi stimoli cui il cervello è sottoposto, mantenendo integre per anni
le informazioni raccolte; inoltre esso non è organizzato secondo un criterio di tipo alfabetico,
ma in base a relazioni più complesse e differenziate.
1.1 Criteri di organizzazione
Postulare l'esistenza di una serie di criteri di organizzazione dell'informazione lessicale è
un passo fondamentale: per poter funzionare in maniera economica ed efficace il lessico
necessita di una struttura; tuttavia il problema della sistemazione delle rappresentazioni
mentali è ancora largamente dibattuto nell'ambito delle neuroscienze.
Alcuni dati sperimentali possono venirci in aiuto: sappiamo innanzitutto che, nei compiti di
decisione lessicale, le parole di uso più comune, le più frequenti, vengono riconosciute più
velocemente di altre. Inoltre stimoli acustici e stimoli visivi attivano zone diverse del cervello,
in particolare sembra che la distinzione tra suoni verbali e suoni non-verbali avvenga nel
settore mediano del solco temporale superiore, mentre l'elaborazione fonologica e semantico-
lessicale si realizzi nel giro temporale medio e nel giro temporale inferiore. Per quanto
riguarda gli input visivi, invece, l'elaborazione delle unità ortografiche ha molto
probabilmente sede nelle regioni occipito-temporali dell'emisfero sinistro. Questo ci porta ad
ipotizzare l'esistenza di due diversi lessici: un lessico fonologico e un lessico ortografico, a
1 È bene ricordare a questo proposito che in ogni lingua sono presenti classi aperte di parole, le quali sono in continuo rinnovamento, come nomi, verbi, aggettivi, e classi chiuse di parole, pressoché immutabili nel tempo, come pronomi, articoli, preposizioni e congiunzioni.
3
loro volta distinguibili in lessici di input e lessici di output, posto che la comprensione e la
produzione di parole e frasi comporta l'innesco di operazioni di tipo differente.
A tal proposito, alcune ricerche, utilizzando il priming, hanno dimostrato che, mentre il
riconoscimento visivo di una parola è facilitato da una sua precedente presentazione nella
stessa forma, tale fenomeno non si verifica nel momento in cui viene usato uno stimolo
uditivo.
Il priming
Il priming è un metodo di indagine largamente utilizzato nella neuropsicologia e consiste
nel presentare a un soggetto due stimoli in successione, il prime e il target, che possono
intrattenere o meno una relazione; il soggetto è chiamato ad effettuare un compito (ad
esempio di denominazione o di decisione lessicale) sul secondo elemento e il suo tempo di
risposta viene misurato. Il priming si basa sul concetto di cronometria mentale, cioè sulla
rilevazione dei tempi necessari ad effettuare un determinato compito, e sull'assunto
dell'esistenza di un rapporto pressoché proporzionale tra tempo di reazione del soggetto e
complessità delle operazioni cognitive da svolgere.
Un ruolo importante nell'organizzazione del lessico sembra essere svolto dal criterio di
vicinanza acustica, cioè la relazione che si instaura tra due parole che differiscono per un
singolo fonema, le cosiddette coppie minime (es. bende – tende). Le parole che fanno parte di
più coppie minime tendono ad essere identificate in maggior tempo perché sono soggette a
fenomeni di competizione.
Sempre attraverso il priming è stato dimostrato che i tempi di risposta si accorciano
notevolmente quando tra prime e target sussiste una relazione di tipo semantico (come quelle
di meronimia, olonimia, iponimia, iperonimia, sinonimia e antinomia; ad es. cucchiaio -
posata): questa facilitazione della velocità di reazione ci porta a ipotizzare che l'attivazione
del primo stimolo non si realizzi solamente a livello fonetico o ortografico, ma anche a livello
concettuale; questo significa che, quando ascoltiamo o leggiamo una parola che conosciamo,
non ci serviamo esclusivamente del lessico di input, ma anche della rappresentazione mentale
della parola e quindi della nostra memoria semantica.
4
È stato formulato a tal proposito un modello da Collins e Loftus (1975)2 secondo il quale i
significati sono organizzati in una rete e i nodi di questa rete sono costituiti dalle parole, le cui
connessioni si basano su relazioni semantiche di diversa intensità: quando la somiglianza
semantica è forte, la parola-stimolo propaga la propria attivazione (diffusone automatica
dell'attivazione o automatic spread of activation - ASA) ai nodi adiacenti, in funzione anche
dell'accessibilità dei concetti. L'energia di attivazione rilasciata è inversamente proporzionale
alla distanza dei nodi. Questo modello, dunque, oltre ad essere supportato dai test sul priming
semantico, spiegherebbe anche il fenomeno del priming indotto dall'aspettativa che si verifica
quando prime e target sono presentati a distanza di un intervallo di tempo superiore ai 500 ms
e quando nell'esperimento le coppie di stimoli correlati sono presenti in numero elevato.
Oltre ad associarsi per campi semantici, le parole sembrano anche organizzarsi in coppie
oppositive, sia cioè in antonimi contrari (che ammettono fasi intermedie), come caldo e
freddo, sia in antonimi contraddittori, come vivo e morto.
1.2 I deficit categoria-specifici
Uno studio di Elisabeth Warrington3 su pazienti affetti da demenza semantica, pazienti cioè
che non erano in grado di assegnare alcune parole ad una determinata categoria semantica,
non solo ha suffragato l'ipotesi di un'organizzazione per classi del lessico mentale, ma ha
anche aperto la strada a successive ricerche di corrispondenze tra categorie semantiche e zone
del cervello. I pazienti di Warrington, ad esempio, avevano difficoltà a individuare immagini
che rappresentavano cibi ed esseri viventi, ma non manufatti e utensili.
In particolare, nel 1996, Hanna Damasio4 e i suoi collaboratori hanno dimostrato l'esistenza
di deficit particolarmente selettivi e localizzati rispetto a compiti di denominazione di nomi
propri, animali e utensili: al primo deficit categoria-specifico corrisponderebbe una lesione
nel lobo temporale sinistro, al secondo nella porzione anteriore del lobo temporale inferiore
sinistro e al terzo nella regione postero-laterale del lobo temporale inferiore sinistro e nella
giunzione laterale temporo-occipito-parietale.
Tuttavia i pazienti erano ancora in grado di attivare particolari contenuti semantici relativi
2 Cfr. MICHAEL S. GAZZANIGA, RICHARD B. IVRY, GEORGE R. MANGUN, Neuroscienze cognitive, Zanichelli, Bologna 2005, p. 346 e ss.
3 Cfr. ibidem, pp. 348 – 349.4 Cfr. ibidem, pp. 349 – 350.
5
agli oggetti che non riuscivano a denominare. Questo ha portato a ipotizzare che il deficit si
trovasse a livello lessicale, ma che non intaccasse le altre strutture di elaborazione del
linguaggio; Antonio e Hanna Damasio (1992) ne individuano tre: un primo sistema che
categorizza le rappresentazioni semantiche, un secondo che riguarda le combinazioni
fonematiche e sintattiche e un terzo che media fra i due a livello lessicale. Le lesioni
categoria-specifiche studiate si troverebbero proprio in quest'ultimo livello, mentre, ad
esempio, problemi generalizzati come le distorsioni o le difficoltà a produrre parole
morfologicamente corrette riguarderebbero il secondo livello e, infine, patologie come
l'acromatopsia o la prosopagnosia percettiva avrebbero a che fare con il primo livello
(incapacità di percepire o anche solo immaginare determinati oggetti).
Figura 1: Localizzazione delle lesioni cerebrali correlate con deficit categoria-specifici
Fonte: M. S. GAZZANIGA, R. B. IVRY, G. R. MANGUN, Neuroscienze cognitive, p. 350. Adattata da Damasio et al.
(1996).
6
Figura 2: I tre livelli interpretazionali che si attivano nella produzione del linguaggio
2. Modelli di rappresentazione
Gli studiosi non sono concordi su alcune questioni riguardanti il lessico mentale,
soprattutto per quanto riguarda l'accesso lessicale, ossia il procedimento con cui input acustici
e fonetici vengono messi in relazione con i contenuti e le rappresentazioni delle parole
immagazzinate.
Quando riceviamo un impulso esterno dobbiamo in qualche modo confrontarlo con il
nostro database mentale per scoprire se è una parola che conosciamo. Vi sono teorie che
sostengono che la selezione delle entrate lessicali avvenga in maniera seriale e teorie che
sostengono invece un’attivazione in parallelo: il modello di Forster, ad esempio, è di tipo
seriale; il modello logogen di Morton prevede sì un'attivazione seriale, ma di più unità che
operano in parallelo.
Entrambi hanno in comune l’idea che i processi di elaborazione linguistica siano
scomponibili in processi più elementari e specifici, i moduli, strutture verticali specializzate. Il
paradigma modularista, infatti, è fondamentale nelle scienze cognitive, insieme al pardigma
connessionista: grande impulso è stato dato al primo dagli studi di Jerry Fodor. Nel
modularismo le strutture mentali del linguaggio sono viste come degli insieme di regole, dei
meccanismi specifici.
7
Il modello di McClelland e Rumelhart è invece un modello connessionista, che non
prevede moduli, né lessici, ma reti e che, soprattutto, mette in discussione le architetture
computazionali di tipo sequenziale. La rappresentazione semantica, nel connessionismo, non
corrisponde a un’unità semantica precisa, ma a un pattern di attivazione tra diverse unità.
L’elaborazione avviene attraverso l’azione di varie unità interconnesse, attivate in parallelo. I
processi mentali superiori emergono dall’interazione e dalla cooperazione di tante piccole
unità semplici.
Il Simple Recurrent Network, infine, si distacca da entrambi i paradigmi e propone
un'ipotesi ancora più estrema: supera il concetto di lessico mentale in sé e per sé e introduce il
concetto di stato mentale e quello di stimolo mentale.
2.1 Il modello a ricerca attiva di Forster
In questo modello5, formulato nel 1976, il lessico è considerato come un grande archivio
centrale che contiene le informazioni verbali essenziali sui tratti semantici delle parole, in un
formato indipendente dallo stimolo, che sia esso acustico o visivo; accediamo all’archivio
principale tramite tre archivi periferici: uno ortografico, uno fonologico e uno sintattico-
semantico. Esiste inoltre un magazzino della conoscenza generale in cui sarebbero contenute
le conoscenze possedute dal soggetto.
È un modello di tipo seriale in cui l’elaborazione attraversa una serie di stadi sempre nello
stesso ordine.
Utilizziamo l’archivio ortografico quando leggiamo, l’archivio fonologico quando
ascoltiamo e l’archivio sintattico-semantico quando produciamo un discorso.
Ogni entrata di ciascun archivio periferico è associata ad un’entrata nell’archivio centrale
ed è organizzata in “bin”, raggruppamenti di parole basati su relazioni di somiglianza e di
frequenza.
Ad esempio, quando leggiamo una parola, si attiva l’archivio ortografico e il “bin” di
appartenenza più probabile; si avvia poi una ricerca all’interno del “bin”, come in uno
schedario, in cui le parole più frequenti sono più accessibili. Una volta individuata l’entrata si
accede all’archivio centrale.
5 Cfr. Pier L. Baldi, pp. 19-20
8
Questo modello spiega l’effetto di priming semantico affermando che, quando si raggiunge
l’entrata nell’archivio centrale, le rappresentazioni ad essa associate si raggruppano con essa
in un bin.
Figura 3: Autonomous search model
2.2 Fodor e la modularità della mente
Nel modello di Fodor possiamo distinguere tre strutture: i trasduttori, i sistemi di input e i
processi centrali.
I primi registrano informazioni sul mondo esterno e creano rappresentazioni
successivamente elaborabili, trasformando il fisico in simbolico. I sistemi di input utilizzano
le informazioni dei trasduttori e le trasformano in dati linguistici riconoscibili (si tratta di
sistemi sia linguistici che percettivi). Essi si attivano in maniera non-cosciente in base agli
9
stimoli che ricevono, non possono cioè essere messi volontariamente in stato di riposo una
volta ricevuto un input (non si può evitare consciamente di ascoltare una frase) e funzionano
in maniera seriale (processano prima l'aspetto fonetico/ortografico, poi quello lessicale e
infine quello sintattico). Solo una volta che i sistemi di input hanno completato l’elaborazione
dei trasduttori il risultato può essere trasmesso ai processi centrali. I processi centrali
collegano e integrano tra loro gli output dei diversi sistemi di input e servono a esprimere
giudizi e a produrre informazioni.
Due sono le proprietà fondamentali di questo modello, l'impermeabilità cognitiva e
l'incapsulamento informazionale: in base alla prima caratteristica, un individuo non può
accedere coscientemente ai livelli intermedi dei trasduttori e dei sistemi di input, così come i
sistemi di input e i trasduttori non possono servirsi del patrimonio contenuto nei processi
centrali. L’elaborazione, dunque, è unidirezionale, dal basso verso l’alto, dal semplice al
complesso (bottom-up). L'incapsulamento, invece, è la proprietà che impedisce ai moduli
stessi di comunicare tra loro e che li rende veloci e funzionali.
Figura 4: modello Modulare.
10
2.3 Il secondo modello logogen di Morton
È un modello ad attivazione in parallelo: i logogen sono meccanismi che accumulano
informazioni sugli stimoli verbali da elaborare, ogni logogen corrisponde ad uno stimolo. Essi
operano in parallelo e sono sensibili al contesto sintattico e semantico.
Quando un logogen supera un determinato livello di soglia, costituito da variabili come
frequenza, concretezza, lunghezza, ecc., la parola viene riconosciuta. Il logogen che ha più
caratteristiche in comune con lo stimolo, cioè, si attiva in misura maggiore. Ad esempio una
parola molto frequente ha un livello di soglia più basso rispetto a una parola inusuale. Quando
dunque ascoltiamo la sillaba /ka/ dovrebbero attivarsi i logogen di “cane”, “casa”, “carro” e
così via, ma, col procedere dell'elaborazione, alcuni decadranno e altri si attiveranno in misura
maggiore, fino a che uno di essi raggiungerà la soglia di attivazione.
Nella prima versione del modello si ha un unico sistema di logogen, nella seconda, invece,
Morton ha ipotizzato l’esistenza di meccanismi separati per il riconoscimento di parole udite e
di parole scritte.
Il flusso di informazioni e bi-direzionale, cioè sia bottom-up che top-down, poiché il
contesto semantico e sintattico sono in grado di abbassare la soglia di attivazione di
determinati logogeni.
Figura 5: modello Logogen.
11
2.4 L'approccio connessionista: McLelland e Rumelhart
È uno tra i primi modelli connessionisti. Lo scopo principale del modello è mostrare
l’influenza, durante la lettura, del contesto di una parola sull’identificazione delle lettere che
la compongono.
Troviamo tre livelli: un livello responsabile dei tratti, un livello in cui ogni unità
corrisponde a una lettera e un livello in cui ogni unità corrisponde a una parola.
Ogni unità è collegata a quelle dei livelli immediatamente precedenti e successivi: le
connessioni possono essere eccitatorie, se il collegamento è appropriato, o inibitorie, se è
inappropriato. Ad esempio, la lettera T faciliterà l’accesso alla parola “TORTA” ma lo inibirà
alla parola “CORTA”. Quando un’unità viene attivata, propaga la propria attivazione lungo le
connessioni di tutte le altre unità cui è legata, aumentandone l'attivazione qualora la
connessione sia di tipo eccitatorio, diminuendola se è di tipo inibitorio.
Le lettere hanno connessioni facilitatorie più forti con parole ad alta frequenza
Ogni livello può essere considerato come una rete i cui nodi si inibiscono reciprocamente,
mettendo in atto una strategia competitiva.
Figura 6: esempio di modello connessionista: le frecce indicano le connessioni eccitatorie, le linee le
connessioni inibitorie. Fonte: M. S. GAZZANIGA, R. B. IVRY, G. R. MANGUN, Neuroscienze cognitive, p. 359.
Adattato da McClelland e Rumelhart (1981).
12
2.5 Simple Recurrent Network
Dati sperimentali dimostrano che specifici aspetti di un termine, che fanno parte di strati
profondi del lessico mentale, vengono attivati dal soggetto in fasi precoci del processo di
comprensione.
Questo fenomeno può verificarsi in alcuni casi di risoluzione di ambiguità, ad esempio
quando si hanno dei sintagmi nominali in posizione post-verbale, come nella frase “the boy
heard the story was interesting”: in questo contesto “the story” potrebbe essere sia il
complemento oggetto di “heard”, sia il soggetto di una frase subordinata (come nel nostro
caso). Il fatto che l’interpretazione del sintagma “the story”, nei test effettuati, sia inizialmente
quella di complemento oggetto, è spiegabile, secondo i modularisti, dal procedere sequenziale
dell’interpretazione, processando prima informazioni sintattiche basilari (il verbo “to hear” è
transitivo) e solo successivamente informazioni complesse (il verbo può reggere una
subordinata).
Secondo Jeffrey Elman6, invece, sono altri fattori ad entrare in gioco già in una prima fase
dell'interpretazione: 1) la frequenza con cui il verbo occorre con un complemento oggetto
piuttosto che con una subordinata; 2) la frequenza con cui il verbo regge una subordinata
senza la congiunzione “that”, che disambiguerebbe il periodo; 3) la plausibilità del sintagma
nominale come complemento oggetto di quel particolare verbo. Studi recenti, infatti,
sembrano dimostrare che la “propensione” del verbo influenza l’interpretazione di frasi
ambigue.
Un’altra dimostrazione di come il significato possa essere utilizzato per predire una
struttura si ha nelle frasi in cui sono presenti dei verbi che possono avere sia una costruzione
transitiva sia una costruzione intransitiva. Nel momento in cui la frase è sintatticamente
ambigua, quando cioè non si è ancora letto/ascoltato né un complemento oggetto né un
complemento indiretto, il soggetto tende ad aspettarsi una costruzione che sia appropriata al
significato del verbo; esso è suggerito dagli argomenti, che possono essere dei buoni agenti
causali o dei buoni temi7 (le informazioni vengono inferite dal contesto).
6 JEFFREY L. ELMAN, “Lexical knowledge without a lexicon?”, Ment. Lex. 2011 ; 6(1), p. 4.7 Si tratta di ruoli tematici: ogni verbo ha una precisa griglia tematica che consiste nell'insieme degli argomenti
che deve necessariamente possedere; se la griglia è incompleta la frase risulta a-grammaticale. L' agente è l'entità che compie intenzionalmente l'azione, il paziente o tema è l'entità che subisce l'azione.
13
Es.1 Gianni cede il patrimonio a Maria
(Gianni = agente causale; cede = verbo transitivo);
es.2 Il tetto cede sotto i colpi della grandine
(tetto = tema; cede = verbo intransitivo)
Altri studi hanno poi dimostrato come il tempo verbale potesse influenzare la risoluzione
di ambiguità nei casi di pronomi riferibili a più soggetti.
Es.3 Paolo ha raccontato a Luigi una storia. (Egli) ________
Quando il verbo esprime uno stato perfettivo, come nel passato prossimo in italiano, tende
a indicare un’azione conclusa; quando invece esprime uno stato imperfettivo, come
nell’imperfetto, l’azione si dà come in svolgimento. I dati rilevano che, i partecipanti agli
esperimenti, trovandosi davanti a un verbo imperfettivo, tendono a indicare che il soggetto
della prima frase e il soggetto della seconda sono uguali in percentuale molto maggiore
rispetto a quando viene usato un verbo perfettivo.
Es.4 Paolo raccontava una storia a Luigi. (Egli) ________
Questi studi ci dicono dunque che una forma verbale può creare delle aspettative riguardo a
molteplici aspetti di una frase: sulla sua struttura sintattica, sui suoi argomenti e, in ultima
analisi, anche sulla salienza dei partecipanti dell'evento che descrive (nell'es.4 il verbo
all'imperfetto dà maggiore salienza a Paolo rispetto a Luigi perché il soggetto si aspetta che la
sua azione continui).
Questi risultati non possono essere spiegati con la teoria della diffusione dell’attivazione
del prime, perché le connessioni da essa innescate non sono né dinamiche, né sensibili al
contesto. In particolare l’aspettualità non è una proprietà intrinseca dei verbi, ma altamente
variabile e quindi difficilmente potrebbe essere contenuta in un lessico mentale.
Una soluzione consiste nel considerare il linguaggio come una rappresentazione di eventi
in cui i verbi, così come altre parti del discorso, come i sostantivi, svolgono il ruolo di indizi,
nel senso che creano delle aspettative nei soggetti che delimitano la gamma degli eventi
possibili.
Se dunque le parti del discorso contengono una così ampia quantità di informazioni sul
14
contesto dell'evento, sull'aspettualità del verbo e sui suoi argomenti, su agenti e pazienti, ecc.,
tentare di sistematizzarle all'interno del lessico mentale inteso come un dizionario o un
database sarebbe un'impresa pressoché impossibile o quanto meno difficilmente
circoscrivibile.
Se le parole non sono oggetti passivi che risiedono nel lessico per essere semplicemente
analizzati, ma operatori che alterano lo stato della mente, allora il lessico mentale va
considerato come un sistema dinamico in cui le parole sono degli input che perturbano lo
stato interno del sistema man mano che vengono processati. Un modello che spiega questa
visione è quello del Simple Recurrent Network (SRN) formulato da Jeffrey Elman nel 1990.
Nel SNR abbiamo una rete neurale a 3 livelli con un livello nascosto di memoria (hidden
layer, lo stato mentale, interno) che è in grado di apprendere sequenze nel tempo e di predire il
completamento di una sequenza basandosi sulla struttura latente del flusso studiato; essa, cioè,
sa riconoscere strutture complesse in un flusso di elementi indistinti.
La conoscenza nel SNR è rappresentata dalle connessioni tra le diverse unità e dalla forza
di queste stesse connessioni. L'apprendimento avviene tramite esempi: si forniscono al
sistema degli esempi di stimoli ben formati, invece di istruirlo con regole pre-determinate.
In questo modello il tempo non è visto come un semplice ordinatore di unità di input e di
output: la rete, infatti, tiene conto non solo degli input in entrata, ma anche dello stato
precedente della rete stessa (unità di contesto: nello stato t la porzione di rete che conserva
traccia degli apprendimenti dello stato t-1). Il livello mentale (unità nascoste), dunque, varia
sia in base al suo stato precedente, sia in base agli stimoli esterni. Elman ha introdotto nel
lessico mentale (anche se forse definirlo ancora tale sarebbe improprio) il fattore
dell'esperienza.
Il SNR è stato in grado di apprendere, ad esempio, la nozione intuitiva di parola con un
semplice training test, senza cioè conoscere i criteri di delimitazione di parola o il concetto
stesso di parola. È stata inoltre in grado, dato un certo numero di frasi a struttura semplice
(nome-verbo o nome-verbo-oggetto) di suddividerne i termini in categorie lessicali in base a
proprietà distributive e informazioni di co-occorrenza.
15
Bibliografia
AA. VV., Manuale di psicologia, Edizioni Simone, Napoli 2010.
BALDI PIER LUIGI, Le parole della mente: lessico mentale e processi linguistici, Franco
Angeli, Milano 2003.
DENES GIANFRANCO, “Neuropsicologia del linguaggio nel XXI Secolo”, Treccani.it,
consultabile presso: http://www.treccani.it/enciclopedia/neuropsicologia-del-
linguaggio_(XXI-Secolo)/ (ultima consultazione 7 marzo 2014).
ELMAN JEFFREY L., “Lexical knowledge without a lexicon?”, Ment. Lex. 2011 ; 6(1), 1-33.
-, “An alternative view of the mental lexicon”, TRENDS in Cognitive Science 2004 ; 8 (7),
301-306.
GAZZANIGA MICHAEL S., IVRY RICHARD B., MANGUN GEORGE R., Neuroscienze cognitive,
Zanichelli, Bologna 2005.
LIBBEN GARY, JAMENA GONIA, “Mental Lexicon Research in the New Millennium”, Brain
and Language 2002 ; 81, 2–11 .
17