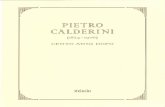detrazione fino al 19 per cento, ma pochi lo sanno - Il Mensile
"I Cento Passi": la mafia come modello mentale ed il ruolo dello stereotipo nell'apprendimento ...
Transcript of "I Cento Passi": la mafia come modello mentale ed il ruolo dello stereotipo nell'apprendimento ...
„I CENTO PASSI“: LA MAFIA COME MODELLO MENTALE ED IL RUOLO DELLO
STEREOTIPO NELL’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO
Fabio Catanese
Matrikelnummer: 4812121
Italienische Philologie (Kernfach) / Geschichte (Module)
Tel. 015785370949
[email protected] 18. Oktober 2014
Indice.
Introduzione……………………………………………………….………………pag. 3
1. Pregiudizio e lingua straniera………………... ………………………………..pag. 4
1.1 Può lo stereotipo avere una funzione positiva? ………………………………pag. 4
1.2 Sistemi di superamento dello stereotipo………………………………………pag. 5
2. La mafia come modello mentale ed immaginario mediatico …………….……pag. 6
3. „I Cento Passi“………………………..…….……………………………….…pag. 7
3.1 Piano delle lezioni…………………...………………………………………..pag. 7
3.2 Obiettivi………………………………………………………………...……..pag. 11
Conclusioni………………………………………………………………..………pag. 11
3
Introduzione
Sebbene “stereotipo” e “pregiudizio” siano due termini apparentemente simili tra di loro, è bene
circoscriverne il significato per meglio affrontare la loro incidenza nel processo di
apprendimento di una lingua. Stando alle definizioni1, lo stereotipo rappresenterebbe una
“espressione, motto, detto proverbiale o singola parola nella quale si riflettono pregiudizi e
opinioni negative con riferimento a gruppi sociali, etnici o professionali”. Per pregiudizio
intendiamo invece un “atteggiamento sfavorevole od ostile, in particolare quando esso presenti,
oltre che caratteri di superficialità e indebita generalizzazione, anche caratteristiche di rigidità,
cioè quando implichi il rifiuto di metterne in dubbio la fondatezza e la resistenza a verificarne
la pertinenza e la coerenza”. Nella seconda definizione, vediamo come siano presenti termini
come “generalizzazione”, “rigidità” e “superficialità”. Cosa accade quando tali aggettivi
riguardo l’atteggiamento di uno studente tedesco nei confronti della lingua italiana? Innanzi
tutto si genererà una visione irreale e stereotipata della cultura italiana e, sul piano meramente
didattico, verrà a mancare quell’autentico processo di comprensione autentica di una realtà
diversa che gioca un ruolo irrinunciabile nell’apprendimento di una lingua straniera. Cosa
ancora peggiore, qualora il pregiudizio non venisse sfatato, rischierebbe di “fossilizzarsi” nello
studente senza possibilità di rielaborazioni future.
Nei limiti della sua analisi, questo lavoro si propone di studiare un caso particolare: gli
stereotipo di “mafia” e “mafioso” all’interno dei processi di apprendimento dell’italiano come
lingua straniera. Dopo un’iniziale descrizione di cosa sia effettivamente il pregiudizio
nell’ambito dello studio di una lingua, passeremo ad analizzare alcuni sistemi di superamento
dello stereotipo. Il secondo capitolo di questo lavoro entrerà nello specifico, analizzando la
mafia come stereotipo e proponendo un piano di lezioni legato all’opera di Marco Tullio
Giordana sulla vita di Giuseppe Impastato.
1 Fonte: www.treccani.it, voci “stereotipo” e “pregiudizio”
4
1. Pregiudizio e lingua straniera
Già Carlo V diceva: “parlo in spagnolo a Dio, in italiano alle donne, in francese agli uomini e
in tedesco al mio cavallo”. Stereotipi e pregiudizi legati alle lingue straniere fanno parte della
vita quotidiana, sia che si declinino come aspetti positivi (la presunta eleganza del francese, la
musicalità dell’Italiano) o negativi (la durezza del russo o del tedesco). I bambini ed i ragazzi a
scuola, non sono tabulae rasae innanzi al processo di apprendimento di una lingua straniera, ma
latori di stereotipi foraggiati dai media, dai genitori, dagli amici. Persino gli insegnanti possono,
inconsapevolmente, favorire il processo di “stereotipizzazione” di una cultura: James Lynch ha
sottolineato come insegnare voglia dire a volte anche schematizzare e dunque semplificare;
l’effetto più rischioso di tale semplificazione è appunto un apprendimento per categorie che
trasforma realtà concrete in stereotipi2.
1.1 Può lo stereotipo avere una funzione positiva?
Se da un lato gli stereotipi donano un immagine falsificata di una cultura, dall’altro va
sottolineato come rappresentino per lo studente un immaginario conosciuto, un ambiente
“familiare”. Immaginiamo il caso in cui uno studente debba confrontarsi con una lingua antica
come il sanscrito: non avrebbe probabilmente delle dirette corrispondenze cui far riferimento ed
il processo di apprendimento sarebbe forse limitato da questa distanza. Nel caso delle lingue
romanze invece, il bombardamento mediatico e familiare e quella che potremmo chiamare
socializzazione stereotipale creano un background utile per catturare l’attenzione dello studente.
Va comunque sottolineato come la funzione positiva dello stereotipo nell’apprendimento di una
lingua straniera vada necessariamente limitata a questa funzione: attirare l’attenzione degli
studenti verso la lingua e la cultura straniera, darle una dimensione familiare. Se si va oltre, lo
stereotipo piò addirittura finir per rappresentare l’inizio di una vera e propria “educazione
discriminazione”: la linguista Isabella Chiari ha sottolineato come l’alterità linguistica divenga
facilmente alterità etnica ed il giudizio su di una lingua possa diventare il giudizio sul gruppo
etnico che la parla3.
2 Lynch, James: Educazione multiculturale in una società globale. Armando Editore 1993. Pag. 30
3 “[…]molti stereotipi sulle lingue non possono essere identificati e interpretati in modo distinto dalla stereotipizzazione di aspetti contigui, soprattutto legati alle caratteristiche del parlante…(continua)
5
1.2 Sistemi di superamento dello stereotipo
Seguendo un approccio metodologico costruttivista, Hugh Gash e Vincent Kenny affermano
come gli strumenti migliori per mettere in crisi un pregiudizio/stereotipo siano la formulazione
di domande che costringano a riflettere sul proprio pregiudizio e la proposizione di contro-
esempi che contraddicano il pregiudizio stesso.4 Nessun campo si presta forse meglio dello
studio di una lingua straniera per comprovare tale metodo. Molto spesso infatti gli studenti non
hanno un contatto concreto con l’oggetto di studio che, ricordiamo, non è un entità linguistica
asettica ma il sistema comunicativo di contesti sociali ben precisi.
Gigliola Zanetti ha sottolineato inoltre come oggetto di pregiudizio non siano mai i singoli
individui ma delle categorie5. La categorizzazione, è un processo psicologico utile a risparmiare
complessi calcoli al nostro cervello: in un paese straniero categorizziamo immediatamente il
poliziotto, il taxista, l’infermiere, poiché essi appartengono tutti ad un immaginario a noi
conosciuto6. Cosa accade però, quando oggetto di tale processo è un gruppo sociale o un’intera
cultura? Si genera inevitabilmente una distanza che non solo può falsare l’immagine di una
cultura ma, nel nostro contesto, può rendere più difficoltoso il processo di apprendimento
linguistico. Se a questo aggiungiamo il fatto che il pregiudizio riguarda sempre e solo un
outgroup, un gruppo esterno, comprendiamo come tale distanza possa farsi incolmabile.
Focalizzare sull’individuo e dargli un’identità ed una storia permette di contrastare apertamente
la sedimentazione di un pregiudizio: se da un lato infatti la concretezza di una singola storia
eviterà processi di riduzione e categorizzazione, dall’altro concentrarsi su uomo/donna in carne
ed ossa permetterà forse un processo di immedesimazione, di com-passione che avvicinerà allo
studente quello che prima era uno stereotipo. Tuttavia, nell’avviarsi verso la realizzazione di
tale proposito, bisogna evitare di cadere nel pericolo opposto: quello di appianare le differenze
…Molto spesso lo stereotipo linguistico non è autonomo, ma si configura come una specificazione o una appendice diuno stereotipo etnico.” Da Chiari, Isabella: Parlo spagnolo a Dio, italiano alle donne, francese agli uomini e tedesco al mio cavallo: Stereotipi sulle lingue nel tempo. Pag. 42. In: Thornton, Maria; Voghera, Miriam (a cura di) Per Tullio De Mauro. Roma 2012 4 “[…] So if we consider the general case of the prejudice "members of the outgroup are unreliable" -
questions may be of the form "is this always true in your experience? […]" Gash, Hugh; Kenny, Vincent: The Implementation of a Constructivist Approach to the Resolution of Prejudice in Methodologia, issue 16. 1996. 5 Zanetti, Gigliola: Le barriere del pregiudizio. Come conoscerle e superarle. Pag. 76 6 Zanetti. Pag. 77
6
con la cultura “altra” sino al punto da renderla “senza colore”7, ovvero sino al punto di privarla
delle sue peculiarità.
2. La mafia come modello mentale ed immaginario mediatico
Non vi è praticamente campo mediatico che non abbia contribuito alla formazione
dell’immaginario mafioso: dal cinema, con la trilogia de Il Padrino di Coppola, passando per la
televisione, col tono canzonatorio de I Soprano sino a giungere addirittura a rielaborazioni
videoludiche del fenomeno8. Non è mai mancata una localizzazione ben precisa del fenomeno
mafioso: la Sicilia ed in alcuni casi la Campania o la Calabria. Per forza di cose, concentrandosi
sugli aspetti “folkloristici”, se non “romantici” del fenomeno, i media non hanno mai tentato di
approfondire il problema, o di dargli una rappresentazione intellegibile. Quali sono state le
conseguenze? Stando alla definizione di Johnson-Laird9, si potrebbe dire che la Mafia è
divenuta un modello mentale affermato, un contesto che, richiamato pur da una singola frase,
attiva un immaginario pregresso, già ben consolidato grazie al bombardamento mediatico. Cosa
accade associando tale modello mentale al linguaggio? Dal punto di vista linguistico,
nuovamente Isabella Chiari ha sottolineato come lo stereotipo associato ad un idioma straniero
tenda raramente a configurarsi in maniera “drammatica”, apparendo invece comico, parodistico
ridicolo10. La percezione della mafia non sfugge a tale regole, come è facilmente osservabile
nelle numerose vignette, barzellette, satire condotte al di fuori dell’Italia su tale delicato tema.
Riassumendo: se da un lato la Mafia è ben presente nell’immaginario di uno studente tedesco,
dall’altro non vi è presente in maniera complessa ma sotto forma di immaginario mediatico o
realtà parodiata.
7 Zanetti. Pag. 191 8 Mafia: The City of Lost Heaven, un videogioco del 2002 campione di incassi
9 Johnson-Laird, Philip N. : Mental Model. Harvard University Press. 1986 10 Chiari 2012. Pag. 43.
7
3. I „Cento passi“
Cento sono i passi che separavano la casa di Peppino Impastato da quella del boss Gaetano
Badalamenti. Una breve distanza che raccoglie due ideologie diametralmente opposte ma anche
la soffocante realtà di una convivenza quotidiana ed inevitabile con l’ideologia mafiosa. Tale è
il tema centrale dell’opera di Marco Tullio Giordana11: la vicinanza del proprio nemico ma
soprattutto la vicinanza di ciò che più si odia. Tralasciando la storia concreta di Radio Aut12, la
trasposizione cinematografica delle vicende di Giuseppe Impastato, attivista comunista contro la
mafia, permette di vivere per la prima volta non una storia romanzata, idealizzata, stereotipata
ma una quotidianità terribile attraverso il punto di vista di un ragazzo. Oltre all’innovativo POV,
il film fornisce anche un ritratto di ciò che è un ambiente omertoso, aspetto trascurato dalla
comunicazione mediatica perché decisamente meno attraente. Inoltre, l’appartenenza dello
stesso Peppino ad una famiglia mafiosa, ne fa un protagonista realistico, assediato da dubbi e
debolezze e ben lontano dagli stereotipati ed incorruttibili poliziotti di Brian De Palma13.
3.1 Piano delle lezioni
Dato il tema delicato e considerando soprattutto il pericolo/opportunità di immedesimazione
fornito dalla pellicola, con essa si potrà lavorare in una classe di ragazzi già maturi (sedici anni)
ed in contatto con la cronaca quotidiana. I temi che verranno trattati nel piano delle lezioni
saranno:
-Individuum und Gesellschaft (Q1).
Poiché si avrà modo di affrontare le difficili scelte personali del protagonista in una società
omertosa da un lato ed il contrasto fra attivismo politico del singolo ed assoluta immobilità della
società dall’altro.
11
Oltre alla visione del film, è vivamente consigliata la lettura del libro I cento passi (Feltrinelli 2001), scritto da Giordana e Zapelli che spiega con accuratezza la ragione di alcune scelte stilistiche e che è un’introduzione irrinunciabile per l’utilizzo didattico della pellicola. 12
Per la quale si rinvia agli studi del “Centro siciliano di documentazione Peppino Impastato”: http://www.centroimpastato.it/ 13 Si prenda come esempio lo statuario Eliot Ness de „Gli Intoccabili“
8
-Herausforderungen der Gegenwart (Q4).
Poiché verrà trattato il tema della lotta alla mafia nella particolare accezione della cosiddetta
“antimafia sociale” o “antimafia dal basso”.
Le lezioni saranno dedicate allo sviluppo delle competenze interculturali degli studenti, in
particolare:
-“Capacità di distinguere fra motivazioni culturali ed individuali.”
-„Capacità di riconoscere le varie e differenti cause di un fenomeno, quindi di comprendere la
complessità di società diverse.”
-“Capacità di pensiero globale.”14
Le lezioni copriranno dieci ore in totale. Durante le prime due ore si terrà una discussione
introduttiva sugli stereotipi riguardanti la mafia ne sulla conoscenza che i ragazzi hanno del
fenomeno. Nelle seguenti sei ore la classe vedrà interamente il film “I Cento Passi”, svolgendo
dopo ogni spezzone degli esercizi e lavorando contemporaneamente a delle ricerca fatte a casa
sui vari aspetti emersi in classe. Le ultime due ore saranno dedicate ad una Podiumdiskussion
che coinvolgerà l’intera classe e che, assieme alle ricerche fatte in piccoli gruppi, concorrerà nel
determinare la valutazione finale.
Discussione introduttiva.
In questa fase gli studenti saranno chiamati a raccogliere le loro conoscenze pregresse riguardo
alla parola “mafia”, ovvero –secondo quanto detto prima- a palesare il loro modello
mentale/immaginario mediatico: “Cosa sapete sulla mafia?” , “Quali aggettivi assocereste alla
parola Mafia?” sono alcune delle possibili domande da rivolgere in classe per stimolare la
discussione. Inoltre, verranno mostrate vignette umoristiche riguardanti la mafia, chiedendo agli
studenti di commentarle: se da un lato si avrà così modo di comprendere a che livello è radicato
14
Dal Lehrplan: Schwerpunkte: Interkulturelle Kompetenz , ins besonders: -Unterschieden zwischen kulturellen und individuellen Motivationen. -Erkennung der vielfältigen und unterschiedlichen Bausteine eines Phänomens -Denken in globalen Zusammenhäng.
9
nella coscienza dei ragazzi lo stereotipo, dall’altro si potrà dare inizio a quel processo di
demistificazione dello stereotipo stesso passando da ritratti ridicoli del fenomeno mafioso alla
dura realtà di esso. Infine, in tale fase introduttiva saranno presentate una definizione tedesca ed
una italiana della parola “mafia”, chiedendo agli studenti di evidenziarne le differenze.
Analisi del film.
In tale fase, si procederà alternando la proiezione per spezzoni dell’intero film con discussioni
ed esercizi riguardanti le parti visualizzate. Nelle scene iniziali, riguardanti l’allontanamento di
Peppino dal Partito Comunista, sarà possibile introdurre il concetto di “antimafia sociale” in
contrapposizione all’ “antimafia istituzionale”. Molto spazio verrà dedicato anche
all’evoluzione dei rapporti familiari della famiglia Impastato, invitando i ragazzi a descrivere il
clima delle scene domestiche ed a riflettere sulla variazione dei rapporti fra il protagonista ed il
padre, la madre ed il fratello.
Alla scena che da il nome al film –il dialogo fra Peppino ed il fratello- andrà dedicata
particolare attenzione: si potrà chiedere ai ragazzi di esprimere i loro sentimenti nei confronti
del protagonista o addirittura, qualora da loro stessi emergesse tale stimolo, di cercare di
comprendere cosa loro farebbero al posto di Peppino.
Nel corso della proiezione del film, sarà dedicato spazio all’analisi di singole frasi pronunciate
dal protagonista – “Io la invidio questa normalità”, “Bisognerebbe ricordare alla gente cosa è la
bellezza” - che offriranno ai ragazzi la capacità di spaziare, di riflettere profondamente anche
sul senso “estetico” della lotta alla mafia.
Un peso sarà dato anche alle variazioni linguistiche presenti nel film: un confronto fra il dialetto
usato da Peppino in tono canzonatorio, dal Boss in tono minaccioso e dalla madre del
protagonista con un’accezione dolce. L’analisi linguistica riguarderà anche l’italiano e l’italiano
regionale presenti nel film, con un’analisi dell’idioma incerto del padre del protagonista o di
quello complesso del vecchio Comunista. Le scene con i cugini americani, permetteranno di
aprire una parentesi sulla peculiarità linguistica dell’italo-americano.
10
Uno spazio particolare sarà riservato alle presenze “letterarie” all’interno del film. Si potrà sia
accennare alla Commedia dantesca (usata come parodia nella pellicola), sia esaminare insieme
ai ragazzi la “Supplica alla madre” di Pierpaolo Pasolini.
Le scene che riguardano l’arrivo dei “compagni fricchettoni”, ovvero della Comune di “Figli dei
fiori”, serviranno ad illustrare ai ragazzi il contesto storico delle opposizioni politiche nell’Italia
di quegli anni: da un lato la liberazione morale importata dall’estero, dall’altro l’obbedienza ai
diktat del Partito Comunista e, in funzione minoritaria, la piccola “disobbedienza” dei gruppi
provinciali auto-organizzati, come Radio Aut.
Lungo tutto il film verrà evidenziato il ruolo peculiare della musica: con i ragazzi si cercherà di
comprendere in quali contesti sia presente la musica tradizionale italiana (Modugno e Patti
Pravo su tutti) ed in quale la musica americana degli anni 70.
Sulla scena finale del film bisognerà concentrarsi con molta attenzione: se infatti da un lato il
carico emotivo rischia di esser troppo, dall’altro il “caso” umano potrebbe far passare in
secondo piano il particolare messaggio lanciato dal film. Per questo motivo, ci si concentrerà
soprattutto sul discorso finale alla radio di Salvo Vitale – “la mafia ci da sicurezza, ci identifica”
– per poter ricostruire con i ragazzi il suo particolare significato.
Infine, in un elaborato scritto, i ragazzi potranno immaginare una fine alternativa per il film e
riflettere sull’idea di un progetto nato da dei semplici ragazzi, alcuni persino loro coetanei, per
combattere una realtà mostruosa come quella mafiosa. Tale elaborato sarà anche un ottimo
spunto per riflettere sul ruolo dell’informazione nella lotta alla(e) mafia(e). In tale elaborato, i
ragazzi potranno anche descrivere se e come sia cambiata la loro idea di “mafia” dopo la visione
del film.
Ricerche in piccoli gruppi
Saranno da affiancare alla proiezione e permetteranno ai ragazzi di formare un bagaglio
personale di conoscenze riguardo al fenomeno, servendosi di quotidiani forniti dall’insegnante
stesso o attraverso ricerche online. Possibili temi saranno:
-La Mafia in Italia
11
-La criminalità organizzata in Germania.
-L’antimafia sociale: Radio Aut, Libera, ecc.
-Mafia e politica in Italia.
Nella Podiumsdiskussion finale, i ragazzi potranno condividere, confrontare ed “intrecciare” i
risultati delle loro ricerche.
3.2 Obiettivi
Alla fine del piano delle lezioni, i ragazzi saranno in grado di avere una visione più complessa
del fenomeno mafioso, dei suoi effetti sull’individuo e nelle sue realizzazioni internazionali.
Accanto a tale obiettivo, ci sarà forse una visione diversa dello stereotipo, una modifica
auspicabile del “modello mentale mafioso” che escluderà – o anche soltanto limiterà - gli aspetti
parodistici. Infine, i ragazzi potranno comprendere le origini di un contesto sociale del tutto
alieno per loro: quello omertoso.
Conclusioni
Probabilmente una serie di lezioni sulla mafia non potrà eliminare del tutto il pregiudizio o lo
stereotipo associato all’apprendimento dell’italiano, né potrà imporsi del tutto su un
immaginario mediatico che avrà influenzato e continuerà ad influenzare i ragazzi: quel che però
sarà possibile sarà appunto dire che tale immaginario esiste e che è una costruzione artificiosa,
esterna e non fedele alla realtà. In questo modo, si potranno spingere i ragazzi un po’ più avanti
nel processo di socializzazione alla differenza che, secondo chi scrive, sta alla base della reale
comprensione di una cultura straniera.
12
Bibliografia
Chiari, Isabella: Parlo spagnolo a Dio, italiano alle donne, francese agli uomini e tedesco al
mio cavallo: Stereotipi sulle lingue nel tempo. In: Thornton, Maria; Voghera, Miriam (a cura di)
Per Tullio De Mauro. Roma 2012
Fava Claudio; Giordana, Marco Tullio; Zapelli, Monica: I cento passi. Feltrinelli, 2001
Johnson-Laird, Philip N. : Mental Model. Harvard University Press. 1986
Lynch, James: Educazione multiculturale in una società globale. Armando Editore 1993
Sitografia
Gash, Hugh; Kenny, Vincent: The Implementation of a Constructivist Approach to the
Resolution of Prejudice in Methodologia, issue 16. 1996.
http://www.methodologia.it/l1602/pse/meth162e.pdf
Zanetti, Gigliola: Le barriere del pregiudizio. Come conoscerle e superarle
http://www.gigliolazanetti.eu/files/download/7bd733e2b96e36a46c8b03ae645f7a51.pdf
Sulla defizione di “stereotipo” e “pregiudizio”
www.treccani.it
Per informazioni su Radio Aut, l’antimafia “dal basso” e la storia dei movimenti antimafia:
“Centro Siciliano di Documentazione Peppino Impastato”
http://www.centroimpastato.it/