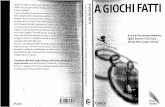La Cassazione torna sui suoi passi (ma fino ad un certo punto): l’ammissibilità della domanda...
Transcript of La Cassazione torna sui suoi passi (ma fino ad un certo punto): l’ammissibilità della domanda...
52014
AN
NO
XX
XLA
NU
OVA
GIU
RIS
PRU
DEN
ZA C
IVIL
E C
OM
MEN
TATA
ISSN 1593-7305N. 11 NOVEMBRE 2014 • Anno XXX RIVISTA MENSILEde Le Nuove Leggi Civili Commentate
LA NUOVAGIURISPRUDENZA
CIVILECOMMENTATA
a cura di Guido Alpa e Paolo Zatti
Tarif
fa R
.O.C
.: Po
ste
Italia
ne S
.p.a
. - S
ped.
in a
bb. p
ost.
- D.L
. 353
/200
3 (c
onv.
in L
. 27/
02/2
004
n. 4
6) a
rt. 1
, com
ma
1, D
CB
Mila
no
La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca giusprivatistica nell’Università di Padova
9!BMMCF>:RSQ
WTQ!IS
BN
978
-88-
13-3
4285
-2
5!;EE;;F:SXV
RUP!00
1497
36
D 29,00
DANIELA M. FRENDA
La Cassazione torna sui suoi passi (ma fino ad un certo punto): l’ammissibilità della domanda risarcitoria
e il limite dei fatti sopravvenuti
CASS. CIV., sez. un., 11.4.2014, n. 8510Conferma App. Trieste, 24.1.2012
Contratto in genere - Scioglimento
del contratto - Risoluzione del con-
tratto per inadempimento - Rapporti
tra domanda di risoluzione e di
adempimento - Facoltà di mutamento
della domanda di adempimento in
quella di risoluzione - Estensione
alla domanda di risarcimento del
danno da risoluzione formulata ex
novo - Ammissibilità (cod. civ., art. 1453,comma 2o)
La parte che, ai sensi dell’art. 1453, com-ma 2o, cod. civ., chieda la risoluzione delcontratto per inadempimento nel corsodel giudizio dalla stessa promosso per ot-tenere l’adempimento, può domandare,contestualmente all’esercizio dello «iusvariandi», oltre alla restituzione della pre-stazione eseguita, anche il risarcimentodei danni derivanti dalla cessazione deglieffetti del regolamento negoziale.
dal testo:
Il fatto. 1. - Il 2 gennaio 1992 veniva stipula-to, tra la s.r.l. Cave Ponte della Regina (d’ora inpoi Cave Ponte) e C.P., un contratto denomi-nato “Promessa di appalto di escavazione”, inforza del quale la prima, titolare di un’autoriz-zazione alla coltivazione di cava di inerti rila-sciata nel 1983 e rinnovata nel 1986, si impe-gnava – sul presupposto dell’adozione, in data8 aprile 1991, di un nuovo piano regolatore ge-nerale del Comune di San Vito al Tagliamento,che prevedeva l’attuazione di attività estrattivadi materiali di cava di inerti interessanteun’area nel cui ambito erano ricompresi alcuniterreni già di proprietà di Cave Ponte – ad ac-quistare i restanti terreni rientranti nell’area an-zidetta, con conseguente cessione dei diritti diescavazione al C. Costui, a propria volta, accet-tava – per sé o per persona da nominare (identi-ficata successivamente nella s.r.l. Calcestruzzi eConglomerati Bituminosi Padova, di seguitoCGB, successivamente trasformatasi nella
s.p.a. Beton Candeo) – la cessione del diritto diescavazione su tutti i terreni, nonché il trasferi-mento della proprietà dell’intera cubatura del-l’inerte da estrarre, dietro pagamento del prez-zo della cessione, determinato – ai sensi degliartt. 3 e 5 dell’accordo contrattuale – sulla basedell’intero quantitativo da estrarre dalla cava.
La società CGB, assumendo di aver acquisi-to la proprietà dell’intero giacimento di cava diinerti, con atto di citazione notificato il 26 feb-braio 2000 convenne in giudizio Cave Ponte,chiedendone la condanna al rilascio di tutti iterreni (anche di quelli trasferiti ex art. 1478c.c.), come individuati nel contratto.
Per contro, la convenuta, nel costituirsi ingiudizio, contestò la domanda di parte avversa,rilevando che il contratto suddetto – da inten-dersi come preliminare di vendita mobiliare edi appalto – aveva avuto concreta attuazione, acausa della mancata approvazione del piano re-golatore generale, solo nei limiti di quanto giàassentito in favore di essa Cave Ponte, in forzadell’autorizzazione del 1986.
Propose, inoltre, domanda riconvenzionalevolta a conseguire la dichiarazione di cessazio-ne del rapporto contrattuale di appalto, per ef-fetto del compimento dell’opera di escavazio-ne, nonché l’accertamento della responsabilitàdi CGB per vizi e difformità dell’esecuzionedello scavo rispetto a quanto autorizzato (re-sponsabilità dalla quale chiese di essere tenutaindenne), instando, altresì, per la riduzione delcompenso dovuto all’appaltatore e la condan-na dello stesso al risarcimento dei danni, da li-quidarsi in separato giudizio, oltre alla risolu-zione del contratto per inadempimento, in re-lazione ai predetti vizi e difformità e al manca-to rispetto del quantitativo minimo pattuito dimateriale inerte da scavare, pari a 100.000 me-tri cubi; in ogni caso, domandò di essere im-messa nel possesso e nella libera disponibilitàdell’area di cantiere e la condanna della con-troparte al risarcimento dei danni da ritardatariconsegna della stessa.
A fronte di tale linea difensiva della conve-nuta, parte attrice, all’udienza di trattazionedella causa, formulò, ai sensi dell’art. 183c.p.c., una reconventio reconventionis, aventead oggetto l’accertamento della permanente ef-ficacia e validità del contratto, nonché la con-danna di Cave Ponte al suo adempimento.
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 Contratto in genere
NGCC 2014 - Parte prima 991
c
Con sentenza n. 4 del 26 febbraio 2004, pas-sata in giudicato (stante l’estinzione del relati-vo giudizio di appello per rinuncia al gravame),il Tribunale di Pordenone, sezione distaccatadi San Vito al Tagliamento, rigettò la domandaprincipale, dichiarò inammissibili le altre do-mande proposte dall’attrice, dichiarò cessato ilrapporto contrattuale in relazione alla aree de-tenute da CGB, delle quali ordinò il rilascio infavore di Cave Ponte, la cui domanda risarcito-ria venne respinta.
2. - Con successivo atto di citazione notifica-to il 23 novembre 2005, la s.p.a. Beton Candeo(già s.r.l. CGB) conveniva Cave Ponte innanzial medesimo Tribunale, chiedendone la con-danna all’esecuzione del contratto del 2 gen-naio 1992, come integrato dalle pattuizioni del9 settembre 1993 (in forza delle quali era statastabilita una modificazione del prezzo del ma-teriale inerte estratto dall’appaltatrice) e del 17novembre 1994 (con cui le parti, invece, si era-no date atto dell’intervenuta emanazione delprovvedimento amministrativo regionale cheimpediva la realizzazione degli specchi d’acquamediante l’attività di scavo oggetto dell’appal-to, nonché dell’impugnativa dello stesso, con-fermando – per l’ipotesi dell’accoglimento del-l’impugnativa – le condizioni contrattuali cosìcome originariamente stabilite il 2 gennaio1992 e successivamente modificate il 9 settem-bre 1993).
La convenuta Cave Ponte, nel contestare ilfondamento delle domande attoree, chiedeva ilrigetto delle stesse.
3. - Con sentenza n. 15 del 30 marzo 2010,l’adito Tribunale, nel rilevare che Beton Can-deo – in sede di precisazione delle conclusioni– aveva chiesto, a modifica dell’originaria do-manda di adempimento, la declaratoria di riso-luzione del contratto per inadempimento dellaconvenuta e la condanna della stessa al risarci-mento dei danni per equivalente, rigettava ladomanda, accogliendo l’eccezione di giudicatoesterno sollevata dalla convenuta. Non vi puòessere – rilevava il Tribunale – “alcuno spaziogiurisdizionale ulteriore”, giacché “con la sen-tenza n. 4 del 2004 di questo Tribunale è statosancito che il contratto de quo è cessato”.
4. - In accoglimento del gravame propostoda Beton Candeo, questa decisione è stata ri-formata, con sentenza resa pubblica mediante
deposito in cancelleria il 24 gennaio 2012, dallaCorte d’appello di Trieste, la quale ha dichiara-to la risoluzione del contratto, condannandoCave Ponte al risarcimento del danno, quanti-ficato in Euro 16.577.120, oltre interessi e riva-lutazione dalla domanda al saldo.
4.1. - La Corte d’appello ha in primo luogoescluso che tra le parti si sia formato un giudi-cato preclusivo per effetto della sentenza delTribunale di Pordenone, sezione distaccata diSan Vito al Tagliamento, n. 4 del 2004. Il giu-dicato – si osserva – inerisce alle sole aree dete-nute da Cave Ponte e la cessazione del rappor-to di appalto tra le parti è limitata a tali areesulle quali l’attività estrattiva era esaurita, nontoccando le altre aree facenti parte di un com-prensorio più ampio che avrebbe dovuto for-mare oggetto dell’estrazione di inerti da partedi Beton Candeo. Non essendo intervenuta al-cuna decisione di merito con riferimento allealtre aree del comprensorio suddetto, ma unamera dichiarazione di inammissibilità della do-manda per genericità della stessa e quindi pervizio della sua introduzione, la Corte territoria-le ha giudicato ammissibile, con riferimento aqueste, l’esame nel merito della pretesa dedot-ta in giudizio relativa all’accertamento dellaperdurante efficacia dell’appalto.
La Corte di Trieste ha quindi rilevato, allaluce dell’istruttoria espletata in primo grado ein particolare della consulenza tecnica d’uffi-cio, che l’escavazione sulle altre aree era ancoraeseguibile sulla base del nuovo piano regolato-re comunale di San Vito al Tagliamento appro-vato il 3 dicembre 2001 ed entrato in vigore il 3novembre 2002 (in quanto l’impugnazioneproposta avverso il provvedimento ammini-strativo che aveva determinato la temporaneaimpossibilità di esecuzione dell’appalto fu ac-colta dal TAR e il Comune deliberò di adottareun nuovo PRGC, approvato dalla Regione nel2002, in sostituzione di quello del 1991, in at-tuazione del quale era stato concluso l’appaltodel 1992), e che l’estrazione di inerti restava so-stanzialmente conforme a quella contrattual-mente prevista.
Disattendendo il contrario assunto della par-te appellata, il giudice d’appello ha ritenutoammissibile anche la domanda risarcitoria in-trodotta unitamente a quella di risoluzione,sebbene quest’ultima fosse stata proposta in
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 Contratto in genere
992 NGCC 2014 - Parte prima
corso di causa (avendo Beton Candeo agito, aborigine, per l’adempimento), interpretando,così, in modo “coordinato” l’art. 1453 c.c.,commi 1 e 2, nel senso, cioè, che se l’una di-sposizione rimette al contraente non inadem-piente la scelta tra l’adempimento e la risolu-zione, facendo però salvo “in ogni caso” il ri-sarcimento del danno, l’altra, nel consentire ilmutamento in corso di causa della domanda diadempimento in domanda di risoluzione, per-mette di affiancare quest’ultima anche con ladomanda risarcitoria.
La Corte territoriale ha quindi ritenuto checostituisce grave inadempimento, tale da giu-stificate la risoluzione del contratto de quo, lacircostanza che Cave Ponti non abbia consen-tito, appena divenuta nuovamente eseguibilesulla base del nuovo PRGC, la prosecuzionedel contratto stipulato nel 1992.
5. - Per la cassazione della sentenza dellaCorte d’appello Cave Ponti ha proposto ricor-so, con atto notificato il 18 luglio 2012, artico-lato in cinque motivi e illustrato con successivamemoria, cui Beton Candeo ha resistito concontroricorso.
All’esito dell’udienza pubblica svoltasi il 4luglio 2013, la Seconda Sezione civile, con or-dinanza interlocutoria 9 agosto 2013, n. 19148,ha trasmesso gli atti al Primo Presidente perl’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezio-ni Unite ai fini della risoluzione del contrastosulla questione, veicolata dal secondo motivodi ricorso, se, convertita in corso di causa ladomanda di adempimento in quella di risolu-zione del contratto per inadempimento ai sensidell’art. 1453 c.c., comma 2, sia consentita an-che la proposizione, contestuale, della doman-da di risarcimento dei danni.
Il Primo Presidente ha disposto l’assegnazio-ne del ricorso alle Sezioni Unite.
Acquisita la relazione dell’Ufficio del massi-mario, e depositata, da parte della ricorrente,una nuova memoria illustrativa, il ricorso è sta-to discusso all’udienza pubblica del 25 marzo2015.
I motivi. 1. - Il ricorso viene all’esame delleSezione Unite per comporre il contrasto sullaquestione se, convertita in corso di causa la do-manda di adempimento del contratto in quelladi risoluzione del contratto inadempiuto ai
sensi dell’art. 1453 c.c., comma 2, sia consenti-ta, contestualmente alla variatio, la proposizio-ne della domanda di risarcimento dei danni.
La questione è posta con il secondo motivodi ricorso. (Omissis)
Con la proposta censura Cave Ponte lamentaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1453c.c., nonché insufficiente e contraddittoria mo-tivazione su punti decisivi della controversia,sul presupposto che erroneamente il giudiced’appello avrebbe rigettato l’eccezione da essaformulata, volta a far dichiarare l’inammissibi-lità del mutamento della domanda, da condan-na all’esecuzione del contratto a risoluzioneper inadempimento e risarcimento del danno:e ciò in quanto la domanda di condanna al ri-sarcimento del danno costituisce domandaeventuale e distinta rispetto a quella di risolu-zione, avendo per oggetto un bene diverso daquello che, nell’ipotesi di inadempimento del-l’altro contraente, può essere alternativamenterichiesto, in base alla richiamata disposizionecodicistica, sub specie di domanda di adempi-mento e di risoluzione.
5.1. - Il motivo interroga queste Sezioni Uni-te sul se il contraente fedele possa introdurrenel corso del giudizio la domanda di risarci-mento del danno, ex novo e contestualmente almutamento, consentito dall’art. 1453 c.c., com-ma 2, della originaria domanda di adempimen-to del contratto in quella di risoluzione delcontratto inadempiuto.
5.2. - Come ricordato dalla Seconda Sezionenell’ordinanza interlocutoria, sul punto si con-frontano due orientamenti, uno che nega, l’al-tro che ammette la possibilità di affiancare ladomanda di risarcimento del danno a quella,nascente dalla conversione della originaria do-manda di adempimento, di risoluzione delcontratto per inadempimento.
5.2.1. - Il primo, restrittivo, è scolpito nelprincipio di diritto enunciato da Sez. 2^ 23gennaio 2012, n. 870, in base al quale l’art.1453 c.c., comma 2, deroga alle norme proces-suali che vietano la mutatio libelli nel corso delprocesso, nel senso di permettere la sostituzio-ne della domanda di adempimento del contrat-to con quella di risoluzione per inadempimen-to, ma tale deroga non si estende alla domandaulteriore di risarcimento del danno consequen-ziale a quella di risoluzione, trattandosi di do-
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 Contratto in genere
NGCC 2014 - Parte prima 993
manda del tutto diversa per petitum e causa pe-tendi rispetto a quella originaria. Il principio èstato enunciato in un caso nel quale l’attore –un promissario acquirente di un appartamentoin condominio, detentore del bene oggetto dicausa per averne ricevuto la consegna anticipa-ta – aveva agito per ottenere l’esecuzione speci-fica dell’obbligo di concludere il contratto de-finitivo ex art. 2932 c.c., per poi proporre, nelcorso del giudizio, la domanda di risoluzionedel contratto preliminare per inadempimento,in luogo di quella originaria di adempimento,e, contestualmente, quella di risarcimento deldanno, pari agli oneri straordinari corrispostial condominio nel periodo in cui aveva abitatol’appartamento. La Corte ha cassato senza rin-vio il capo della sentenza con cui il giudice delmerito aveva accordato anche la chiesta tutelarisarcitoria, trattandosi di “causa” che non po-teva essere proposta in quel giudizio.
Alla base di questo indirizzo vi è la presad’atto che la facoltà concessa dall’art. 1453 c.c.,comma 2, al contraente non inadempiente dimutare l’originaria domanda di adempimentoin quella di risoluzione, apporta una vistosa ec-cezione – come tale di stretta applicazione – al-la regola del divieto assoluto di modifica delladomanda, che cala all’esito dell’udienza di trat-tazione della causa o della sua propaggine rap-presentata dalla memoria ex art. 183 c.p.c. Epoiché l’introduzione, nel corso del giudizio,ancorché contemporaneamente all’eserciziodello ius variandi di cui all’art. 1453 c.c., com-ma 2, della domanda risarcitoria affiancata alla(consentita) domanda di risoluzione, comportal’introduzione di un ulteriore tema d’indaginee di un nuovo petitum, sono destinate a trovareapplicazione le preclusioni di cui agli artt. 183e 345 c.p.c. La deroga al divieto di mutatio li-belli non opera, quindi, per la domanda di ri-sarcimento dei danni, fatta salva in ogni casodal primo comma dell’art. 1453 cod. civ., inte-grando questa un’azione del tutto diversa, percausa petendi e per petitum, dalle altre due, siada quella con cui è stato attivato il rimedio ma-nutentivo, sia da quella con cui è stato chiestolo scioglimento del contratto per inadempi-mento.
Espressione del medesimo orientamento chevede nello ius variandi di cui all’art. 1453 c.c.,comma 2, una previsione eccezionale, è la re-
gola che ammette la proponibilità della do-manda di risoluzione solo se anteriormente èstato chiesto l’adempimento: il mutamento, in-vece, non può avvenire quando in un primotempo l’attore si è limitato a chiedere il risarci-mento del danno (Sez. 3^ 30 marzo 1984, n.2119, seguita da Sez. 3^ 9 aprile 1998, n. 3680,da Sez. 3^ 26 aprile 1999, n. 4164, e da Sez. 3^27 luglio 2006, n. 17144).
Simmetricamente, se in un primo tempo èstato domandato l’adempimento, non è possi-bile chiedere in corso di causa il risarcimento:tornano ad applicarsi le norme processuali cheprecludono la proposizione di domande nuove(Sez. lav. 27 marzo 2004, n. 6161, e Sez. lav. 16giugno 2009, n. 13953). In questo stesso “am-biente” si colloca Sez. 3^ 14 marzo 2013, n.6545: la quale, richiamandosi alla citata senten-za n. 870 del 2012, ha negato l’ingresso, duran-te il corso del giudizio, ad una domanda dicondanna generica al risarcimento dei danniper l’accertato inadempimento definitivo del-l’obbligo di trasferire un immobile, quando,originariamente, la tutela risarcitoria era stataavanzata per il ritardo nell’adempimento (inmisura corrispondente al valore locativo del-l’immobile).
5.2.2. - Al secondo indirizzo, che invece am-mette la possibilità di affiancare la domanda ri-sarcitoria contestualmente al passaggio al rime-dio ablativo, è riconducibile Sez. 2^ 31 maggio2008, n. 26325.
Vi si afferma che “la facoltà prevista dall’art.1453 c.c., comma 2, di mutamento della do-manda di adempimento in quella di risoluzionecontrattuale in deroga al divieto di mutatio li-belli si estende anche alla conseguente doman-da di risarcimento danni (nonché per le stesseragioni a quella di restituzione del prezzo (...)),essendo quest’ultima domanda sempre propo-nibile quale domanda accessoria sia di quelladi adempimento sia di quella di risoluzione,come espressamente previsto dall’art. 1453c.c., comma 1”.
Sulla stessa linea estensiva si muove, in fatti-specie particolare, Sez. 3^ 19 novembre 1963,n. 2995, la quale, in un caso nel quale il con-traente deluso aveva già esplicitamente intro-dotto la pretesa risarcitoria accanto a quella dimanutenzione del contratto, ha riconosciuto lapossibilità di domandare, in occasione della
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 Contratto in genere
994 NGCC 2014 - Parte prima
mutatio libelli ex art. 1453 c.c., comma 2, idanni da risoluzione in luogo di quelli da ritar-do nell’adempimento o da inesatto adempi-mento: ciò sul rilievo che “quando la legge am-mette, in deroga alle generali norme processua-li, la sostituzione della domanda di risoluzionea quella di adempimento, non può, correlativa-mente, non ammettere l’introduzione della ri-chiesta dei danni da risoluzione, anche se effet-tivamente diversi, per essenza e quantità, daquelli che siano stati richiesti insieme con l’ori-ginaria domanda di adempimento (arg. ex art.1453 c.c., commi 1 e 2)”. Il principio è stato in-cidentalmente richiamato e confermato daqueste Sezioni Unite con la sentenza 18 feb-braio 1989, n. 962, precisandosi che esso è de-stinato a valere “nel caso... in cui la domandadi risoluzione sia, come deve essere, fondatasullo stesso fatto costitutivo della domandad’adempimento (ovvero, senza che ad esso sia-no sostituiti altri elementi materiali, tali da in-tegrare una nuova causa petendi) e la connessadomanda di risarcimento dei danni, malgradociò, sia diretta a conseguire un ristoro patrimo-niale essenzialmente diverso, per qualità equantità, da quello perseguito con la prima do-manda di danni, restando peraltro inalterata lacausa petendi della domanda principale”.
La giurisprudenza ammette altresì che, inoccasione della mutatio, possa essere avanzataex novo, accanto alla domanda di risoluzione,quella di restituzione del praestatum Sez. 2^ 27novembre 1996, n. 10506, e Sez. 2^ 27 maggio2010, n. 13003, declamano che la facoltà di po-ter mutare nel corso del giudizio di primo gra-do, nonché in appello e persino in sede di rin-vio la domanda di adempimento in quella di ri-soluzione in deroga al divieto di mutatio libellisancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., sem-preché si resti nell’ambito dei fatti posti a basedella inadempienza originariamente dedotta,senza introdurre un nuovo tema d’indagine,comporta che, in tema di contratto preliminaredi compravendita, qualora sia sostituita la do-manda di adempimento con quella di risolu-zione, il contraente deluso possa chiedere la re-stituzione della somma versata a tiolo di prez-zo, quale domanda consequenziale a quella dirisoluzione, implicando l’accoglimento di que-sta, per l’effetto retroattivo espressamente pre-visto dall’art. 1458 cod. civ., l’obbligo di resti-
tuzione della prestazione ricevuta, onde di taledomanda – si afferma – il giudice può decidereanche se su di essa non vi sia stata accettazionedel contraddittorio.
6. - Il contrasto va composto aderendo all’in-dirizzo espresso dall’orientamento estensivo,dovendo riconoscersi che lo ius variandi possaesercitarsi in modo completo affiancando alladomanda di risoluzione, non solo quella di re-stituzione, ma anche quella di risarcimento deidanni.
7. - L’art. 1453 c.c., nell’attribuire al con-traente deluso la facoltà di chiedere “a sua scel-ta” l’adempimento o la risoluzione del contrat-to, offre alla parte che, con la domanda diadempimento, abbia inizialmente puntato al-l’attuazione del contratto sul presupposto delsuo mantenimento, anche la possibilità – afronte di un inadempimento che, nel prolun-garsi del giudizio, perdura o si aggrava – di ri-vedere la propria scelta, e, perduti la speranzao l’interesse rispetto alla prestazione, di reagireall’inattuazione dello scambio contrattuale pas-sando alla domanda di risoluzione per inadem-pimento, onde veder cancellato e rimosso l’as-setto di interessi disposto con il negozio.
Il codice civile, nell’accordare la facoltà discegliere tra la condanna del debitore all’adem-pimento e la risoluzione del contratto, in con-siderazione dell’interesse al conseguimento tar-divo della prestazione, se ed in quanto ancorarealizzabile, al contempo non vincola il con-traente non inadempiente ad una scelta irrevo-cabile, quale risulterebbe dall’avere “optatoper l’adempimento senza la possibilità di chie-dere successivamente la risoluzione all’esito in-fruttuoso della domanda di adempimento”(Sez. Un. 18 febbraio 1989, n. 962, cit.).
Lo ius variandi si giustifica con il fatto che ledue azioni, quella di adempimento e quella dirisoluzione, pur avendo un diverso oggetto,mirano a risultati coordinati e convergenti dalpunto di vista dello scopo. Nei contratti a pre-stazioni corrispettive, l’azione di adempimentoe quella di risoluzione costituiscono due diver-si rimedi giuridici a tutela del diritto che dalrapporto sostanziale deriva al contraente in re-gola: pur presentando diversità di petitum, en-trambe mirano a soddisfare lo stesso interessedel creditore insoddisfatto, consistente nel-l’evitare il pregiudizio derivante dall’inadempi-
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 Contratto in genere
NGCC 2014 - Parte prima 995
mento della controparte (Sez. 2^ 29 novembre2011, n. 15171). E lo testimonia il fatto che laproposizione della domanda di adempimentoha effetto interruttivo della prescrizione anchecon riferimento al diritto di chiedere la risolu-zione del contratto, il quale potrà essere eserci-tato fino a quando il termine prescrizionalenon sarà nuovamente decorso per intero (Sez.Un. 10 aprile 1995, n. 4126).
Lo ius variandi della vittima dell’inadempi-mento non può cogliere di sorpresa il debitore.Questi, infatti, è rimasto inadempiente nono-stante sia stato sollecitato ad eseguire (o ad ese-guire esattamente) la prestazione richiesta, lad-dove la sua esecuzione successiva alla domandadi adempimento avrebbe rimosso il presuppo-sto della risoluzione. D’altra parte, la domandadi adempimento non può significare rinunciaall’efficacia risolutiva dell’inadempimento nelperdurare dello stato di violazione del contrat-to. Come è stato efficacemente osservato indottrina, l’inerzia del debitore, per ogni mo-mento che passa, viene ad aggravare lo iato trail momento della scadenza ed il momento del-l’esecuzione, sicché la scelta iniziale per il rime-dio manutentivo in presenza di un inadempi-mento precorso non distrugge la facoltà di ri-correre alla tutela ablativa per un inadempi-mento che si rinnova, che cresce o che si aggra-va nella pendenza del processo.
Prevedendo la reversibilità della scelta ini-zialmente espressa per la manutenzione delcontratto ed offrendo al creditore che ha chie-sto l’adempimento la possibilità di cambiareidea e di chiedere la risoluzione, il codice detta,anzitutto, una norma di diritto sostanziale chedisciplina l’esercizio di un’opzione tra i diversimezzi di reazione all’altrui inadempimento: undiritto che non può essere ostacolato dall’ante-riore scelta per il rimedio manutentivo.
Lo dimostra il fatto che la giurisprudenzaammette che il contraente deluso, anche se sisia formato un giudicato di condanna all’esecu-zione in forma specifica, conserva pur semprela possibilità di domandare la risoluzione delcontratto dopo il processo, qualora l’adempi-mento non si verifichi (Sez. 2^ 18 maggio1994, n. 4830; Sez. 2^ 4 ottobre 2004, n.19826; Sez. 2^ 12 luglio 2011, n. 15290).
Lo ius variandi, pur non dovendo necessaria-mente esercitarsi nel processo rivolto ad otte-
nere l’adempimento, ha tuttavia una valenza si-curamente processuale, come dimostra la stessaformulazione letterale dell’art. 1453 c.c., com-ma 2, che, guardando alla dimensione giudizia-le dell’istituto, discorre di risoluzione che “puòessere domandata” e di “giudizio... promossoper ottenere l’adempimento”. L’esercizio delpotere del contraente non inadempiente diprovocare lo scioglimento del contratto nonpuò essere pregiudicato dalla pendenza del giu-dizio promosso per ottenere l’adempimento.
Quando in luogo dell’adempimento chiedela risoluzione, l’attore non si limita a precisareo a modificare la domanda già proposta. Egline muta l’oggetto. L’azione di risoluzione ènuova rispetto a quella di adempimento: la tra-sformazione della domanda di adempimento aquella di risoluzione rappresenta un’autenticamutatio libelli.
Sotto questo profilo, il passaggio, consentitodall’art. 1453 c.c., comma 2, dalla domanda diadempimento a quella di risoluzione costitui-sce una deroga alle norme processuali che pre-cludono il mutamento della domanda nel cor-so del giudizio e la proposizione di domandenuove in appello. La disposizione dell’art.1453 c.c., comma 2, infatti, abilita la parte cheha invocato la condanna dell’altra ad adempie-re, a sostituire a tale pretesa quella di risoluzio-ne, in deroga agli artt. 183 e 345 c.p.c., nelle fa-si più avanzate dell’iter processuale, oltrel’udienza di trattazione: non solo per tutto ilgiudizio di primo grado, ma anche nel giudiziodi appello (Sez. 2^ 5 maggio 1998, n. 4521; equesto indirizzo è stato ribadito – da Sez. 2^ 6aprile 2009, n. 8234, e da Sez. 2^ 12 febbraio2014, n. 3207, entrambe riferite a vicende pro-cessuali iniziate dopo il 30 aprile 1995 – in se-guito alla riforma del regime delle preclusioniprocessuali realizzata dalla L. 26 novembre1990, n. 353).
Tutto ciò – come queste Sezioni Unite hannogià precisato (con la citata sentenza 18 febbraio1989, n. 962) – vale a condizione che i fatti de-dotti a fondamento della domanda di risoluzio-ne coincidano con quelli posti a base della do-manda di adempimento originariamente pro-posta. Se l’attore allega alla domanda di risolu-zione un inadempimento diverso, ossia unanuova causa petendi, con l’introduzione di unnuovo tema d’indagine, tornano ad applicarsi
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 Contratto in genere
996 NGCC 2014 - Parte prima
le preclusioni di cui agli artt. 183 e 345 c.p.c.,giacché la deroga alle disposizioni del codice dirito è limitata all’introduzione di un nuovo e so-stitutivo petitum immediato. L’immutazionedei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giu-dizio, introducendo nel processo un nuovo te-ma d’indagine e di decisione, altererebbe “l’og-getto sostanziale dell’azione ed i termini dellacontroversia”, e si risolverebbe, in definitiva,nel far valere in giudizio “una pretesa... diversa,per la sua intrinseca natura, da quella fatta vale-re in precedenza”. “Inderogabili esigenze delcontraddittorio e della difesa – hanno precisatole Sezioni Unite – sono d’ostacolo a che possaporsi a base della nuova domanda di risoluzio-ne un fatto costitutivo, materialmente diversoda quello su cui sia stata fondata la domandaoriginaria d’adempimento, non essendo, cioè,permesso di dedurre, quale causa petendi delladomanda di risoluzione, inadempimenti nuovie diversi da quelli in base ai quali sia stata primarichiesta la prestazione pattuita”.
8. - Ritengono le Sezioni Unite che l’inter-pretazione estensiva, oltre a non essere incom-patibile con il dato letterale dell’art. 1453 c.c.,comma 2, ne coglie le ragioni e l’intima ratio eal tempo stesso assicura la finalità di concen-trazione e pienezza della tutela che la disposi-zione del codice ha inteso perseguire: tale let-tura, infatti, offrendo al contraente non ina-dempiente la possibilità di spingere la pretesaalle naturali conseguenze sul piano restitutorioe risarcitorio, consente di realizzare, nell’ambi-to dello stesso processo, il completamento sulpiano giuridico ed economico degli effetti chesi ricollegano allo scioglimento del contratto.
8.1. - Dal punto di vista letterale, l’art. 1453c.c., comma 2, disciplina l’ipotesi tipica, delpassaggio dall’azione di esecuzione del contrat-to a quella di risoluzione dello stesso per il per-sistere dell’inadempimento della controparte.Si tratta di una disciplina dettata senza pretesadi completezza, la quale, lasciando all’interpre-te il compito di completare il dettaglio dellatrama normativa per le fattispecie non espres-samente regolate, non esclude che, in occasio-ne dell’esercizio dello ius variandi, vi si affian-chino quelle pretese che hanno una funzionecomplementare rispetto al rimedio base.
Del resto, il primo comma dello stesso arti-colo, nel fare “salvo, in ogni caso, il risarcimen-
to del danno”, configura come possibile il cu-mulo tra la domanda rivolta ad ottenere loscioglimento del contratto e l’azione risarcito-ria per la riparazione del pregiudizio economi-co del creditore insoddisfatto, delineando unmodello di tutela unitario risultante dall’opera-re combinato dei due rimedi, con l’azione didanno che può accompagnarsi tanto all’azionedi adempimento quanto alla domanda di riso-luzione.
Mentre l’azione di adempimento e quella dirisoluzione danno luogo ad un concorso alter-nativo di rimedi, in parte tra loro surrogabili,con il solo limite della seconda parte del secon-do comma (posto che “non può più chiedersil’adempimento quando è stata domandata la ri-soluzione”), la domanda di risarcimento può, ascelta dell’interessato, essere proposta insiemecon quella di adempimento o di risoluzione.
La lettera della norma del codice non impe-disce, pertanto, di considerare che l’accoppia-mento dei due rimedi (risoluzione del contrat-to e risarcimento del danno) possa aversi, nonsolo quando il contraente in regola abbia pun-tato, sin dall’inizio, alla cancellazione degli ef-fetti del contratto, ma anche quando questi,dopo una citazione con domanda di condannaad adempiere, abbia abbandonato il rimedioattuativo del contratto e sia passato ad una do-manda rivolta ad eliminarne gli effetti.
8.2. - A questa soluzione conduce un’inter-pretazione sistematica, orientata dalla ratio del-lo ius variandi.
L’interesse del contraente deluso che do-manda la risoluzione non è soltanto quello diottenere lo scioglimento del vincolo contrat-tuale per un difetto funzionale sopravvenuto,di eliminare cioè il regolamento contrattuale inquanto fonte di prestazioni corrispettive e diessere in tal guisa liberato dalla prestazione sudi lui gravante. Di fronte alla violazione del-l’obbligazione contrattuale, pattuita in corri-spettivo di una prestazione ancora da eseguire,al contraente non inadempiente basta opporrel’eccezione al fine di non dovere prestare a chisi sia reso inadempiente, secondo quanto di-sposto dall’art. 1460 c.c., (inadimplenti non estadimplendum).
All’iniziativa risolutoria il contraente in rego-la è stimolato a rivolgersi anche per un interes-se che va al di là della mera cancellazione del
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 Contratto in genere
NGCC 2014 - Parte prima 997
sinallagma: per conseguire la restituzione dellapropria prestazione, ove già eseguita, e per ot-tenere la riparazione del pregiudizio che abbiaeventualmente sofferto a causa dello sciogli-mento del rapporto.
Precludere a chi in prima battuta abbia chie-sto in giudizio la condanna della controparteall’adempimento e si sia poi rivolto alla tutelarisolutoria, di azionare, nell’ambito dello stessogiudizio in cui ha esercitato la facoltà di muta-mento, la tutela complementare restitutoria erisarcitoria, vanificherebbe la finalità di con-centrazione che il codice civile ha inteso perse-guire accordando al contraente in regola lo iusvariandi nel corso di uno stesso ed unico giudi-zio. La vittima dell’inadempimento, infatti, perprocurarsi il risultato ripristinatorio della riso-luzione, con la restituzione della prestazioneeseguita e dei suoi accessori, e per rimuovere ledifferenze tra la situazione in cui si sarebbetrovato in caso di integrale attuazione del con-tratto e la situazione conseguente allo sciogli-mento del vincolo, sarebbe costretta ad intra-prendere un nuovo e separato processo, con laframmentazione delle istanze giurisdizionali el’allungamento dei tempi complessivi necessariad ottenere l’integrale soddisfazione delle pro-prie ragioni. E ciò nonostante, da un lato, le re-stituzioni rappresentino il logico corollario del-lo scioglimento ex tunc del contratto (la risolu-zione provocando il venir meno della giustifi-cazione causale delle prestazioni eseguite), edall’altra il risarcimento del danno scaturentedalla rimozione del contratto rinvenga la pro-pria origine proprio nell’inadempimento dellacontroparte agli obblighi contrattuali assunti emiri a far ottenere al risolvente un assetto eco-nomico equivalente a quello che gli avrebbe as-sicurato lo scambio fallito.
La ratio dello ius variandi – offrire giustaprotezione all’interesse dell’attore vittima del-l’inadempimento, specie di fronte al comporta-mento del debitore convenuto in giudizio, chepermane inattivo nonostante sia stato sollecita-to a eseguire la prestazione – richiede che, inoccasione del (e contestualmente al) mutamen-to della domanda di adempimento in quella dirisoluzione del contratto, sia ammessa l’intro-duzione della domanda restitutoria e della ri-chiesta di danni da risoluzione, data la funzio-ne complementare che l’una e l’altra svolgono
rispetto al rimedio diretto ad ottenere la rimo-zione degli effetti del sinallagma.
9. - A questa soluzione non sono di ostacoloné la circostanza che la norma dell’art. 1453, se-condo comma, cod. civ., in quanto recante unadisciplina di deroga rispetto a quella sancita dalcodice di rito in tema di preclusioni processua-li, dovrebbe formare oggetto di stretta interpre-tazione, stante il principio generale di divieto dinova, che non consente l’ampliamento succes-sivo del thema decidendi; né il rilievo che la pre-tesa risarcitoria è non solo nuova per petitum ecausa petendi rispetto alla domanda iniziale diadempimento o a quella, risultante dalla muta-tio, di risoluzione, ma anche – a differenza delladomanda restitutoria – non consequenziale aquella di risoluzione del contratto.
9.1. - Innanzitutto occorre rilevare che giànel passaggio, espressamente regolato dal codi-ce civile, dall’adempimento alla risoluzione,l’indagine si allarga, dovendo questa essere di-retta all’acquisizione di dati ulteriori che po-trebbero mancare in quel processo, non essen-do di per sé necessari ai fini nel giudizio pro-mosso per ottenere l’adempimento.
Per chiedere la condanna all’esecuzione, èsufficiente che il contratto risulti inadempiuto,senza bisogno di una particolare qualificazionedell’inadempimento. Invece, la risoluzione delcontratto ha presupposti più rigidi, occorren-do un certo livello di gravità: presupposto ba-silare per conseguire la risoluzione giudizialedel contratto è che “l’inadempimento di unadelle parti sia di non scarsa importanza, avutoriguardo all’interesse dell’altra” (art. 1455 c.c.).
D’altra parte, se l’attore non può allegare afondamento della successiva domanda di riso-luzione un distinto fatto costitutivo, cioè uninadempimento diverso da quello posto a basedella pretesa originaria e già verificatosi all’attodella introduzione di quest’ultima (Sez. Un. 18febbraio 1989, n. 962, cit.), è ben possibile ladeduzione, da parte sua, dei fatti sopravvenutiche, rendendo irreversibile l’inattuazione delsinallagma negoziale, orientano e inducono laparte, di fronte agli sviluppi successivi alla pro-posizione della domanda iniziale, ad avvalersidello ius variandi.
9.2. - È poi senz’altro esatto che soltanto ladomanda di restituzione, e non anche la do-manda di risarcimento del danno, è propria-
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 Contratto in genere
998 NGCC 2014 - Parte prima
mente accessoria alla domanda di risoluzione.Soltanto la prima, infatti, pur essendo autono-ma nell’oggetto (petitum), costituisce un effet-to legale dello scioglimento del sinallagma con-trattuale, avendo il proprio titolo immediatonell’effetto giuridico (recuperatorio ex tuncdelle prestazioni eseguite) che forma oggettodella domanda principale di risoluzione.
Questo rapporto di consequenzialità logico-giuridica manca con riguardo all’azione risarci-toria, la quale non solo non presuppone il ne-cessario esperimento dell’azione di risoluzionedel contratto, ma neppure, a maggior ragione,il suo accoglimento (Sez. 3^ 10 giugno 1998, n.5774; Sez. 3^ 23 luglio 2002, n. 10741; Sez. 1^27 ottobre 2006, n. 23273).
E tuttavia, la qualificazione concettuale nonè dirimente nel caso in esame.
In primo luogo perché anche la tutela resti-tutoria (per la quale occorre una autonoma do-manda, nonostante l’obbligo di restituzionedella prestazione ricevuta costituisca un effettonaturale della risoluzione del contratto: Sez. 2^2 febbraio 2009, n. 2562; Sez. 3^ 29 gennaio2013, n. 2075) può, talvolta, esigere l’acquisi-zione di dati che non sono disponibili nel giu-dizio che sia stato promosso per ottenere lacondanna all’esecuzione: basti pensare allaeventualità della conversione della restituzionein natura in restituzione (in tutto o in parte)per equivalente, che si ha quando il venir menodella causa solvendi riguardi una cosa perita odeteriorata, giacché in tal caso occorrerà accer-tarne il valore o la diminuzione di valore (cfr.art. 2037 c.c.).
In secondo luogo perché la tutela risarcitoria,quantunque non legata da un rapporto di con-sequenzialità logico-giuridica alla domanda dirisoluzione, concorre nondimeno ad integrare ea completare le difese del contraente in regola,costituendo un coelemento, un tassello di un si-stema complessivo di tutela, affidato – proprionell’impianto della stessa disposizione che con-templa lo ius variandi – all’azione combinata dipiù domande: sistema nel quale, con l’affianca-mento alla risoluzione della pretesa risarcitoria,si offre alla parte non inadempiente la soddisfa-zione del suo interesse a guardare al negozio, icui effetti vengono eliminati grazie alla risolu-zione, come fonte anche di un determinato as-setto quantitativo del suo patrimonio.
L’art. 1453 c.c., comma 2, infatti, proprio nelsuo carattere processuale, ha la funzione di re-care non solo la disciplina generale dell’azionedi risoluzione, ma anche dei suoi rapporti conle altre azioni poste comunque a tutela del con-traente non inadempiente, mirando ad attuare,nello specifico contesto del rapporto contrat-tuale con prestazioni corrispettive litigioso, ilprincipio di economia del e nel processo, con-sentendo alla vittima dell’inadempimento dievitare il promovimento di un’ulteriore contro-versia attraverso lo sfruttamento più razionaleed intensivo delle risorse del giudizio già pro-mosso, che è e diventa la sede idonea ancheper dispiegarvi la richiesta di tutela comple-mentare.
9.3. - In questa prospettiva, neppure apparelogico circoscrivere la possibilità per il con-traente fedele di introdurre la pretesa risarcito-ria in occasione della mutatio libelli al solo casoin cui questi avesse già proposto sin dall’origi-ne la domanda di danni, affiancandola a quelladi adempimento. Una tale soluzione non tieneconto del fatto che anche in tale evenienza, puressendo la domanda risarcitoria presente sindall’inizio nel processo, il tema d’indagine èdestinato comunque a variare con il passaggioal rimedio ablativo: posto che quando la richie-sta di risarcimento si accoppia alla domanda diadempimento, il danno da risarcire è equiva-lente alla differenza tra un’esatta o tempestivaesecuzione del contratto e un’esecuzione ine-satta o tardiva ma fermo restando il contratto,mentre il danno scaturente dalla rimozione de-gli effetti del contratto è pari alla differenza trala situazione scaturita dal fallimento della vi-cenda contrattuale ed il vantaggio che il con-tratto autorizzava a ritrarre (cfr. Sez. 2^ 24maggio 1978, n. 2599; Sez. 3^ 7 maggio 1982,n. 2850; Sez. Un. 25 luglio 1994, n. 6938; Sez.2^ 7 febbraio 1998, n. 1298; Sez. 2^ 30 agosto2012, n. 14714).
10. - La proposizione nel corso del giudiziodi merito, anche quando siano calate le ordina-rie preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c., delladomanda risarcitoria affiancata al rimedio riso-lutorio, comporta certamente un ampliamentodell’oggetto del giudizio (che dall’inadempi-mento grave si allarga al pregiudizio sofferto eall’entità dei danni) e, conseguentemente, delthema probandum: di qui la necessità che al
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 Contratto in genere
NGCC 2014 - Parte prima 999
contraente in regola sia accordata la possibilitàdi dimostrare i fatti costitutivi della pretesa ri-sarcitoria, e, parimenti e corrispondentemente,che all’altra parte sia consentito di difendersi,replicando alla domanda nuova, proponendole eccezioni che sono conseguenza della stessae provando eventuali fatti impeditivi, estintivio modificativi del diritto al risarcimento fattovalere.
Si è tuttavia al di fuori dell’operatività del re-gime delle preclusioni. Queste tendono ad im-pedire il comportamento dilatorio delle parti,imponendo loro di allegare all’inizio del pro-cesso tutto ciò di cui sono già in possesso perfar valere le loro ragioni. Ma poiché qui è il co-dice civile che consente, per ragioni di effettivi-tà e concentrazione della tutela, di far valere,contestualmente al mutamento della domandadi adempimento in quella di risoluzione delcontratto inadempiuto, la pretesa risarcitoria, ilregime di preclusioni non è di ostacolo né allapossibilità dell’introduzione del nuovo tema diindagine, né al pieno dispiegarsi, su di esso, deldiritto di difesa e del diritto al contraddittorioin condizioni di parità.
Non si pone neppure un problema di ri-messione in termini, venendo piuttosto in gio-co il doveroso esercizio dei poteri di direzio-ne del processo da parte del giudice per ren-dere possibile l’esercizio del diritto in sedegiurisdizionale nel rispetto dei principi delgiusto processo. È la domanda nuova che po-ne l’esigenza di allegazioni, controallegazioni,eccezioni, deduzioni e controdeduzioni istrut-torie: sicché queste attività processuali debbo-no essere consentite, non già per provvedi-mento discrezionale del giudice, ma per ga-ranzia del diritto di azione e di difesa e delgiusto processo.
11. - L’ordinamento, del resto, conosce altreipotesi nelle quali il divieto di nova è derogatoal fine di evitare la moltiplicazione dei giudiziin relazione alla medesima fattispecie.
11.1. - Nel settore tradizionale delle azioni adifesa della proprietà, la rivendicazione può es-sere proseguita anche contro chi, dopo la do-manda, dolo desiit possidere, e, in caso di im-possibilità di attuare la tutela restitutoria in na-tura, è possibile “trasformare” la domanda inuna “diversa” causa, eventualmente miranteanche al risarcimento del danno, su specifica
richiesta del proprietario (art. 948, primo com-ma, cod. civ.).
11.2. - Nel campo del diritto delle societàper azioni, l’art. 2378 c.c., comma 2, nel testoconseguente alla riforma operata dal D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6, preclude l’annullamentodella delibera societaria impugnata se nel corsodel processo venga meno nel socio o nei sociopponenti la quota azionaria minima per pote-re essere legittimati all’impugnazione, ma faespressamente salvo in tal caso il diritto a pre-tendere il risarcimento del danno, per ciò stes-so evidentemente consentendo che siffatta do-manda possa essere introdotta durante il giudi-zio.
11.3. - Sebbene nel giudizio d’appello nonpossano proporsi domande nuove, l’art. 345c.p.c., non si limita a porre tale divieto, ma ac-corda la possibilità di domandare, tra l’altro, ilrisarcimento dei danni sofferti dopo la senten-za impugnata. Possono così trovare ingressonuovi temi d’indagine: dandosi alla vittima dilesioni personali la possibilità di domandarenel giudizio di appello, senza violare il divietodi ius novorum, sia il risarcimento dei danniderivanti dalle lesioni, ma manifestatisi dopo lasentenza di primo grado, sia il risarcimento deidanni la cui esistenza, pur precedente alla sen-tenza impugnata, non poteva essere rilevatacon l’uso dell’ordinaria diligenza (Sez. 3^ 31marzo 2008, n. 8292); consentendosi – “attesoche la ratio della norma è quella di evitare ilfrazionamento dei giudizi” – di chiedere “nelcorso del giudizio di appello, e sino alla preci-sazione delle conclusioni” “i danni riconduci-bili alla causa già dedotta in primo grado”, ma“manifestatisi successivamente all’inizio dellacontroversia” (Sez. 3^ 15 marzo 2006, n.5678); affermandosi in generale che “nel giudi-zio di risarcimento del danno è consentito al-l’attore chiedere per la prima volta in appello ilrisarcimento degli ulteriori danni, provocatidal medesimo illecito, manifestatisi solo in cor-so di causa” (Sez. 3^ 18 aprile 2013, n. 9453).Al fondo di questo orientamento vi è, ancorauna volta, la consapevolezza che “sarebbe irra-zionale costringere l’attore a promuove succes-sivi giudizi per far valere il progressivo am-pliarsi del danno, in presenza di un comporta-mento dannoso in atto al momento della do-manda o di un evento dannoso che non ha an-
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 Contratto in genere
1000 NGCC 2014 - Parte prima
cora esaurito i suoi effetti” (Sez. 3^ 10 novem-bre 2003, n. 16819).
12. - A composizione del contrasto di giuri-sprudenza, va pertanto enunciato il seguenteprincipio di diritto: “La parte che, ai sensi del-l’art. 1453 c.c., comma 2, chieda la risoluzionedel contratto per inadempimento nel corso delgiudizio dalla stessa promosso per ottenerel’adempimento, può domandare, contestual-mente all’esercizio dello ius variandi, oltre allarestituzione della prestazione eseguita, anche ilrisarcimento dei danni derivanti dalla cessazio-ne degli effetti del regolamento negoziale”.
13. - Il ricorso contiene altri due motivi.Con il quarto mezzo, infatti, la ricorrente
censura violazione e falsa applicazione degliartt. 2935 e 2946 c.c., sul rilievo che la sentenzaimpugnata avrebbe dovuto accogliere l’ecce-zione di prescrizione, giacché il diritto al risar-cimento del danno poteva essere esercitato sindal 1994.
Il quinto motivo, a sua volta, denuncia con-traddittorietà delle diverse statuizioni dell’im-pugnata sentenza, illogicità della motivazionerelativa all’ammontare del danno e violazionedegli artt. 1218 e 1223 c.c. Sarebbe in primoluogo contraddittoria la statuizione di risolverei contratti di cui è causa, risalenti agli anni1992, 1993 e 1995, e poi fare riferimento ai va-lori dell’anno 2008 per determinare il quantumdel risarcimento. Avrebbe poi errato la senten-za impugnata a ritenere l’ammontare del dan-no equivalente ai valori di mercato del materia-le scavato, dovendosi calcolare anche i costi ef-fettivi che Beton Candeo o la sua dante causaavrebbero sopportato nel 1994 con riferimentosia agli oneri per l’escavazione che a quelli rela-tivi alle spese generali. Il profitto, infine, nonpoteva essere tout court pari ai prezzi di mer-cato, giacché Beton Candeo avrebbe dovutodimostrare il prezzo di vendita a quella datapraticato nei confronti degli altri clienti.
Ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c., la causava rimessa alla Seconda Sezione per la decisio-ne, con separata sentenza, di questi ulteriorimotivi. (Omissis)
[Rovelli Presidente – Giusti Estensore – Cenic-
cola P.M. (concl. conf.). – Cave Ponte (avv.ti Sarto-ri e Verino) – Beton Candeo (avv.ti Nuzzo, Gabriellie D’Amico)]
Nota di commento: «La Cassazione torna suisuoi passi (ma fino ad un certo punto): l’ammis-sibilità della domanda risarcitoria e il limite deifatti sopravvenuti» [,]
I. Il caso
All’esito di una complessa vicenda avente ad og-getto un contratto preliminare di appalto, l’appalta-tore conviene in giudizio il committente dapprimaper sentire pronunciare la condanna di quest’ultimoall’adempimento del contratto, e in seguito, mutan-do avviso in corso di causa sulla scorta della facoltàconcessagli dal disposto del comma 2o dell’art. 1453cod. civ., per ottenerne la risoluzione, nonché – in-troducendo per la prima volta la domanda in giudi-zio – il risarcimento dei danni subiti a seguito delloscioglimento del contratto.
La questione delle condizioni per la proponibilitàdell’azione di risoluzione, da un lato, e della propo-nibilità ex novo, d’altro lato, dell’azione di risarci-mento, nel procedimento iniziato per ottenerel’adempimento, divide ad oggi la giurisprudenza. Se-condo un primo orientamento, la proposizione delladomanda di risoluzione nel processo iniziato per ot-tenere l’adempimento costituisce una vistosa ecce-zione alla regola processuale del divieto di mutatio li-belli e, pertanto, è ammessa in casi di stretta applica-zione; conseguentemente, è esclusa la possibilità diintrodurre, accanto all’azione di risoluzione, una ri-chiesta di risarcimento dei danni, per essere que-st’ultima una domanda diversa rispetto a quella dellarisoluzione (e, dunque, non autorizzata dalla normadi cui all’art. 1453, comma 2o, cod. civ.). Un secondoe più estensivo orientamento, invece, reputa ammis-sibile l’azione di risarcimento, insieme alla domandadi restituzione di quanto già prestato, poiché volta alraggiungimento di una tutela che, sul piano giuridicoed economico, integra e completa, rendendola effet-tiva, quella derivante dalla risoluzione.
Chiamate a dirimere il contrasto in atto, le sez. un.della Cassazione hanno da ultimo preso posizioneper un orientamento estensivo della regola di-sposta dal comma 2o dell ’art. 1453 cod. civ.,interpretandola come comprensiva della fa-coltà , da parte del contraente non inadem-piente, di proporre anche istanze risarcitorie,in quanto attuative della medesima ratio diconcentrazione e pienezza di tutela che con-sente il mutamento della domanda da adem-pimento a risoluzione, in modo da garantireun ’adeguata realizzazione del diritto nel ri-spetto di un principio di economia processuale.
[,] Contributo pubblicato in base a referee.
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 - Commento Contratto in genere
NGCC 2014 - Parte prima 1001
Il favor novorum così manifestato non sembra,tuttavia, essere l’esito di un ragionamento del tuttocoerente e consapevole: nel passaggio dalla doman-da di adempimento a quella di risoluzione, infatti,l’esigenza di tutela effettiva del contraente in regolaviene dalle sezioni unite subordinata alla condizioneche non abbiano a dedursi, a fondamento della do-manda successiva di risoluzione, fatti diversi daquelli posti alla base dell’azione originaria di adem-pimento, fatta eccezione per quelli sopraggiunti intempi successivi alla proposizione di quest’ultima.
In questo senso, perciò, il percorso seguito dellapronuncia delle sez. un. in commento non sembra li-neare, poiché esse lasciano sopravvivere, dietro ilmanifesto di una nuova interpretazione orientata allaratio dello ius variandi, ancora l’idea di una subordi-nazione piuttosto rigida del diritto sostanziale aquello processuale, che l’apertura verso l’ammissibili-tà del risarcimento voleva vedere finalmente superate.
II. Le questioni
1. La tesi della natura processuale del-
l’art. 1453 cod. civ. e l’immutabilità dei fatti
giuridici costitutivi della pretesa. Tanto il di-ritto civile processuale quanto il diritto civile sostan-ziale rivendicano l’appartenenza a sé della norma dicui all’art. 1453, comma 2o, cod. civ.
In particolare, quanti vi leggono una deroga al di-vieto di mutatio libelli – codificato agli artt. 183, 184e 345 cod. proc. civ. – attribuiscono a detta disposi-zione natura processuale a dispetto della sua collo-cazione tra le norme di diritto sostanziale, facendo-ne conseguire un obbligato carattere di eccezionali-tà, da cui, a sua volta, deriverebbe l’inammissibilitàdi una sua applicazione oltre il caso considerato. Inbase a tale orientamento, pertanto, lo ius variandiammesso dal comma 2o dell’art. 1453 cod. civ. nonpotrebbe concedere al contraente non inadempientenulla più di quanto previsto espressamente dallanorma, ovverosia unicamente la possibilità di sosti-tuire, nel corso del processo avviato per l’adempi-mento del contratto, la domanda originaria di adem-pimento con quella di risoluzione.
Seguendo tale orientamento, tuttavia, il comma 2o
dell’art. 1453 cod. civ. finisce per consentire al con-traente in regola addirittura meno di quanto lasciaintendere la lettera della stessa norma: non soltanto,infatti, la tutela della parte sarebbe limitata rigorosa-mente alla sostituzione della domanda di adempi-mento con quella di risoluzione, ma, vieppiù, la de-roga al divieto di mutatio libelli nel corso del proces-so sarebbe ammessa soltanto limitatamente al peti-tum, mentre si richiede che «la causa petendi restiinalterata in quello che costituisce l’elemento materia-le del fatto giuridico costitutivo della pretesa» origi-
nariamente dedotta in giudizio (Cass., sez. un.,18.2.1989, n. 962; Cass., 18.1.2008, n. 1003, en-trambe infra, sez. III).
Ora, sul significato di tale assunto, che si è tra-mandato di sentenza in sentenza alla stregua di unamassima tralatizia, e sulle ragioni di un suo inseri-mento come limite all’esercizio della facoltà di mu-tamento della domanda in corso di causa, molto c’èda osservare.
L’attenzione cade, preliminarmente, sulla defini-zione e sull’estensione del concetto di «causa peten-di» e, conseguentemente, sul senso da attribuirsi allalocuzione «fatto giuridico costitutivo».
Comune è l’insegnamento secondo cui la nozionedi causa petendi si traduce negli elementi di fatto enelle ragioni giuridiche dedotti a sostegno della do-manda volta a far valere un diritto in giudizio.Quando, però, si voglia riportare detta formula adun significato più concreto, l’unanimità di intesecessa e la disputa si gioca sul peso da attribuire, ri-spettivamente, al substrato fattuale ovvero alla vestegiuridica data ai fatti materiali.
Senza pretesa di svelare nel dettaglio le questioniche investono il problema della causa petendi nellasua complessità, in questa sede ci limitiamo a rileva-re che il conflitto tra elementi di fatto ed elementi didiritto all’interno della domanda si riflette nel con-fronto – giunto a noi dalle riflessioni nate in seno al-la dottrina tedesca – tra teoria della sostanziazione eteoria dell’individuazione.
Mentre la prima circoscrive la portata individua-trice della causa petendi alla sola allegazione dei fatticostituivi, sicché un suo mutamento potrebbe regi-strarsi soltanto al variare dei fatti posti a fondamen-to dell’azione, a fronte del ruolo del tutto marginalecui è relegata la veste di giuridicità del fatto (Gian-
nozzi, 35 ss., infra, sez. IV), la teoria dell’individua-zione pone invece al centro della pretesa fatta valerel’indicazione del diritto soggettivo cui il fatto avreb-be dato origine e di cui si chiede la tutela; stando aquesto secondo orientamento, cioè, la mutazionedei fatti soltanto, nell’identità del rapporto giuridicocui essi danno vita, non fa mutare la causa petendi enon sposta, perciò, l’oggetto della controversia(Heinitz, 146 ss., infra, sez. IV).
Dal quadro sia pur così sinteticamente tratteggia-to sembra potersi apprendere che la giurisprudenzapressoché unanime, allorché predica il divieto di de-duzione di fatti ulteriori, abbia basato il proprio dik-tat su una nozione sostanzialistica della causa peten-di, che si potrebbe così conservare identica nel pas-saggio da azione di adempimento ad azione di risolu-zione. Adottando, invece, gli insegnamenti propridella dottrina individuazionista, anche i fatti dedottiex novo a sostegno della domanda di risoluzionerientrerebbero nella medesima causa petendi del-
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 - Commento Contratto in genere
1002 NGCC 2014 - Parte prima
l’originaria domanda di adempimento, poiché la cau-sa petendi dell’azione di risoluzione continuerebbeciononostante ad essere designata, sotto il profilo giu-ridico, dall’inadempimento, al pari della domandastessa di adempimento (Rota, 897 s., infra, sez. IV).
Non pare, tuttavia, che siano questioni di princi-pio a legare la Cassazione alle conseguenze propriedella teoria della sostanziazione, poiché in fattispe-cie diverse da quella in esame essa ha accolto tesiproprie della teoria opposta; e del resto, come un’at-tenta dottrina processualcivilista non ha mancato diosservare, anche muovendo da una concezione so-stanzialista sarebbe possibile comunque giungere alrisultato di far rientrare nella medesima causa peten-di l’allegazione di fatti di inadempimento diversi daquelli allegati con la domanda iniziale (Rota, 897).Secondo un’autorevole ricostruzione aderente alloschema sostanzialista, infatti, individuato il contenu-to della causa petendi nella sintesi tra il fatto costitu-tivo di un diritto (la c.d. causa petendi attiva che, nelnostro caso, è il contratto), la qualificazione giuridi-ca di esso, ovverosia il suo nomen juris (nel nostrocaso, il contratto preliminare di appalto di escava-zione di cave) e, infine, il fatto costitutivo dell’inte-resse ad agire – cioè il fatto che ha recato offesa aldiritto (quest’ultima detta causa petendi passiva che,nel nostro caso, è l’inadempimento) – il mutamentodel solo fatto costitutivo dell’interesse ad agire nondeterminerebbe alcun cambiamento nella causa pe-tendi, poiché esso, «dedotto in giudizio, non è ele-mento indispensabile alla identificazione dell’ogget-to del processo e quindi (...) può variare senza che sidetermini novità della domanda» (Giannozzi, 79).
A questa stregua, però, l’immutabilità della causapetendi non è allora altro che un pretesto che, caval-cando la confusione esistente intorno al concettostesso di fatto costitutivo (Gamba, 113 ss., infra, sez.IV), mira proprio ad impedire l’ingresso di nuovifatti in giudizio.
Il divieto all’ingresso in giudizio di nuovi temi diindagine nasce, invero, dalla preoccupazione di ga-rantire un ordinato e razionale svolgimento del pro-cesso, nella convinzione che, se esso rimanesse fon-dato sui medesimi fatti e sulle medesime prove alle-gate fin dall’inizio, non vi sarebbe alcuna «mossa asorpresa» a danno del debitore inadempiente e,dunque, non si minerebbe il corretto svolgersi delcontraddittorio in condizioni di parità tra le parti(Cass., 18.1.2008, n. 1003, cit.).
Ma una tale preoccupazione non può che trovareappiglio in un malinteso sul significato stesso delprincipio del contraddittorio, in quanto è il divietodi introdurre domande nuove in giudizio ad esserefinalizzato ad evitare che le parti vengano esposte al-l’aggiunta o al mutamento senza limiti, per tutta ladurata del processo, delle pretese addotte, con l’evi-
dente pregiudizio del diritto di difesa che loro con-seguirebbe; non ha senso, invece, vietare la prova difatti ulteriori a supporto della domanda quando, co-me nella fattispecie in esame, la facoltà di introdurreuna nuova domanda è consentita dalla stessa legge:in questa situazione, pertanto, correttamente si è af-fermato che «allorché il criterio del nuovo tema diindagine è diretto (...) ad impedire l’ingresso (...) dinuovi fatti, e non di nuove domande, il suo impiegosi traduce in una palese violazione, non solo del di-ritto di difesa della parte, ma direttamente del prin-cipio del contraddittorio e della garanzia di ugua-glianza delle parti che questo implica» (Rota, 914).
A causa di un tale malinteso, a lungo la giurispru-denza – e buona parte della dottrina – ha tramanda-to una rigida chiusura verso la possibilità di introdu-zione di nuove prove in giudizio, vestendo per l’oc-casione detta chiusura con il pretesto dell’osservan-za della regola – che però non trova appiglio norma-tivo alcuno – secondo cui la deroga al divieto di mu-tatio libelli sarebbe ammessa a patto di non mutare,insieme al petitum, anche la causa petendi.
La contraddizione che ne deriva è palese: la dero-ga al divieto di mutamento della domanda sarebbein quest’ottica assoggettata, in una sua parte decisi-va, allo stesso divieto di mutamento della domandache, secondo le premesse, essa doveva avere la forzadi derogare (Rota, 906).
Né a questa osservazione si può obiettare che nonvi è una contraddizione, bensì una mera limitazionealla facoltà di ius variandi, necessitata da inderogabi-li principi di garanzia della difesa e del contradditto-rio: e ciò in primo luogo perché, come si è detto, ildivieto di introdurre nuovi fatti costitutivi quando èpermessa l’introduzione della domanda nuova, nongarantisce il rispetto di detti principi – che trovano illoro ossequio invece nella simmetria dialettica tra leparti, poiché al convenuto è comunque sempre pos-sibile difendersi sui temi introdotti dall’attore – maanzi li viola; e, in secondo luogo, per la decisivitàche un tale limite verrebbe ad assumere nella mate-ria in esame, in quanto negare alla parte il diritto didedurre e offrire tutti i mezzi di prova per l’accogli-mento del rimedio richiesto significherebbe privaredi attuazione la tutela contenuta nel comma 2o del-l’art. 1453 cod. civ.
Del resto, la stortura cui conduce il divieto di al-legazione di fatti ulteriori è evidente solo che sipensi che i fatti probanti l’inadempimento, posti afondamento della domanda di esecuzione del con-tratto, potrebbero non essere sufficienti, perchénon ancora gravi ex art. 1455 cod. civ., a legittima-re al contempo anche un’azione di risoluzione; ov-vero, quando si pensi che la parte potrebbe averetralasciato alcuni fatti che erano irrilevanti ai finidell’azione di manutenzione, ma che poi si sono ri-
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 - Commento Contratto in genere
NGCC 2014 - Parte prima 1003
velati decisivi a fondare la successiva domanda dirisoluzione.
Sicché, entro gli angusti limiti intesi dalla giuri-sprudenza tradizionale, o i fatti dedotti a sostegnodella domanda di adempimento sono già sufficienti,fin dall’inizio, a giustificare anche la risoluzione (e ilcontraente in regola li ha dedotti tutti fin dall’inizio,rilevanti o superflui che siano), oppure egli non haalcuna possibilità di ottenere, nella realtà, la tutelache, sulla carta, il comma 2o dell’art. 1453 gli offre:in questi termini, cioè, norma attributiva dello iusvariandi è svuotata di significato.
Corollario di una lettura in chiave restrittiva didetta norma è il divieto, come si è detto, per il con-traente fedele di agire altresì, ex novo, per il risarci-mento dei danni che conseguono alla risoluzione:l’azione di risarcimento infatti, integrando una do-manda del tutto diversa e autonoma rispetto a quelladi risoluzione, non sarebbe compresa nella derogaalle norme processuali che vietano la mutatio libelli,e dunque non sarebbe proponibile accanto ad essa(Cass., sez. un., 18.2.1989, n. 962;Cass., 16.9.2009, n.13953; Cass., 23.1.2012, n. 870, tutte infra, sez. III).
2. L’esercizio dello ius variandi alla luce
dei principi di economia processuale e l’am-
missibilità della domanda risarcitoria. In net-to contrasto con il pensiero tradizionale, le sez. un.della Corte di Cassazione si sono ora pronunciate nelsenso di ammettere che lo ius variandi possa eserci-tarsi in modo completo: nel giudizio iniziato per ot-tenere l’adempimento, pertanto, il contraente fedelepuò ben proporre, unitamente all’azione di risolu-zione, non soltanto l’azione di restituzione ma anche,ex novo, la domanda di risarcimento del danno con-seguente alla cessazione degli effetti del contratto.
In particolare, facendo proprio l’orientamentogiurisprudenziale minoritario, riconducibile ad unarecente quanto isolata pronuncia resa dalla Corte diCassazione nel 2008 (Cass., 31.5.2008, n. 26325, in-fra, sez. III) – la quale, a sua volta, si allinea ad un’al-tra pronuncia rimasta isolata, risalente quest’ultimaagli anni Sessanta (Cass., 19.11.1963, n. 2995, infra,sez. III) – la Supr. Corte accoglie l’interpretazioneestensiva dell’art. 1453, comma 2o, cod. civ., secon-do cui «il potere di provocare la risoluzione devequalificarsi come diritto sostanziale, avente per og-getto l’esercizio di un’opzione fra i possibili mezzi direazione all’altrui inadempimento» (Gabrielli, 601s., infra, sez. IV).
In quest’ottica, il comma 2o dell’art. 1453 cessa diessere una norma avente carattere di eccezionalità e,consentendo una visione che va al di là della formu-lazione letterale, rende possibile che le venga attri-buita «una portata adeguata al significato che vi èsotteso» (Gabrielli, 603).
Invero, in linea con la sua natura di norma di di-ritto sostanziale, essa – come la stessa Supr. Corte incommento afferma – detta una disciplina «senza pre-tesa di completezza», e perciò, «lasciando all’interpre-te il compito di completare il dettaglio della tramanormativa per le fattispecie non espressamente regola-te, non esclude che, in occasione dell’esercizio delloius variandi, vi si affianchino quelle pretese che han-no una funzione complementare» a quella allo scio-glimento del contratto: sicché lo scenario delle com-binazioni possibili tra le azioni si apre a schemi di-versi da quello, tipico, del passaggio da adempimen-to a risoluzione e pure, in realtà, da quello «adempi-mento/risoluzione-risarcimento», per comprendereanche altri modelli analoghi rispetto all’ipotesi base,e finora per lo più negati dalla giurisprudenza, qualiil passaggio da adempimento a risarcimento, o da ri-sarcimento a risoluzione.
In questi termini, si deve intendere che il comma2o dell’art. 1453 cod. civ., nel nominare le sole dueazioni di adempimento e di risoluzione, abbia dise-gnato soltanto a grandi linee la tutela offerta al con-traente fedele avverso l’altrui inadempimento, masenza con ciò volere escludere la sua estensione adaltri rimedi che, come lo scioglimento del contratto,contribuiscono a riportare la situazione della parte fe-dele allo status quo ante alla stipulazione dello stesso.
Nel giudizio delle sez. un. in commento, pertanto,«l’interpretazione estensiva, oltre a non essere incom-patibile con il dato letterale dell’art. 1453, comma 2o,cod. civ., ne coglie le ragioni e l’intima ratio e al tempostesso assicura la finalità di concentrazione e pienezzadella tutela che la disposizione del codice ha intesoperseguire: tale lettura infatti» – continua la Supr.Corte – «offrendo al contraente non inadempiente lapossibilità di spingere la pretesa alle naturali conse-guenze sul piano restitutorio e risarcitorio, consente direalizzare, nell’ambito dello stesso processo, il comple-tamento sul piano giuridico ed economico degli effettiche si ricollegano allo scioglimento del contratto».
Un’interpretazione estensiva della norma di cuiall’art. 1453 cod. civ. è suggerita, pertanto, da rifles-sioni di sistema: affinché lo ius variandi possa eserci-tarsi in modo completo, e la tutela possa essere ef-fettiva, non deve essere impedito al contraente in re-gola di introdurre nello stesso processo anche lepretese restitutorie, nonché quelle risarcitorie per idanni che gli derivano dalla cessazione degli effettidel contratto; la Cassazione sembra finalmente avve-dersi che con l’azione di risoluzione il contraente inregola mira ad interessi ulteriori alla cancellazionedel sinallagma, in quanto se avesse mirato unica-mente ad essere liberato dalla prestazione corrispet-tiva su di lui gravante, avrebbe potuto opporre effi-cacemente l’eccezione di inadempimento ex art.1460 cod. civ. senza necessità di intraprendere la via
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 - Commento Contratto in genere
1004 NGCC 2014 - Parte prima
dell’azione risolutoria, che può sempre opporre, invia riconvenzionale, nel momento in cui il contraen-te inadempiente si decida finalmente ad eseguire laprestazione dovuta, e pretenda a propria volta lacontroprestazione.
Per questo motivo, correttamente la Supr. Corteosserva che «precludere (...) la tutela complementarerestitutoria e risarcitoria vanificherebbe la finalità diconcentrazione che il codice civile ha inteso perseguireaccordando al contraente in regola lo ius variandi nelcorso di uno stesso ed unico giudizio».
È bene osservare, a questo proposito, che la sen-tenza in commento prende le distanze da quelle pro-nunce che – pur in seno all’orientamento estensivo –per legittimare in questo contesto l’istanza risarcito-ria hanno sentito l’esigenza di qualificarla (al paridella domanda di restituzione) come «accessoria»alla domanda di risoluzione, deducendo tale assuntodal comma 1o dell’art. 1453 cod. civ., che fa «salvo,in ogni caso, il risarcimento del danno» (Cass.,31.5.2008, n. 26325, cit.).
Tale qualifica, se superficialmente coglie il rap-porto di dipendenza tra la risoluzione e il risarci-mento dei danni che conseguono alla cessazione delvincolo, risulta tuttavia piuttosto imprecisa: una pre-tesa può dirsi accessoria ad un’altra – secondo la no-zione che ne dà la dottrina processualista – quandoessa abbia titolo immediatamente nell’effetto giuri-dico prodotto dall’altra, sua «principale» (Coma-stri, 443, infra, sez. IV); il che definisce esattamenteil rapporto tra l’istanza di risoluzione e l’istanza direstituzione, ma non tra quella di risoluzione e quel-la di risarcimento. Quest’ultima infatti può dirsi latosensu dipendente dalla rimozione del vincolo quan-do proposta per ottenere il ristoro dei danni che nesono conseguiti, ma mai tecnicamente accessoria adessa, poiché, in sé, è una domanda autonoma dallesorti del contratto, come dimostrato peraltro – argo-mentando in maniera più ragionevole proprio ex art.1453, comma 1o, cod. civ. – dal fatto che può esserechiesta «in ogni caso».
In realtà, come si avvede ora giustamente la Supr.Corte – muovendo un passo ulteriore verso un’in-terpretazione estensiva dello ius variandi – la qualifi-ca di domanda accessoria non è decisiva per legitti-mare la proposizione dell’azione di risarcimento;non è, invero, l’accessorietà alla domanda di risolu-zione a legittimare l’ingresso in giudizio anche al-l’istanza risarcitoria, bensì la sua funzione comple-mentare rispetto al rimedio ablativo, poiché l’azionedi risarcimento, insieme a quella di restituzione,concorre ad integrare e completare le difese chemuovono il contraente in regola verso la risoluzione,consentendo così piena attuazione alla tutela conte-nuta nel comma 2o dell’art. 1453 cod. civ.
Questa prospettiva fa salvi i principi di concentra-
zione ed economia processuale, poiché ammette laparte a ripristinare l’assetto economico e giuridicoesistente prima della conclusione del contratto,
senza che essa debba a tal fine introdurre un nuo-vo e successivo processo avente ad oggetto il risarci-mento del pregiudizio subito, e quindi evitando uninutile frazionamento delle istanze giurisdizionali eun inevitabile allungamento dei tempi e dei costi digiustizia.
Tale approccio inverte così i termini degli studiprocessualistici tradizionali, in quanto si concentra –secondo i canoni propri di una concezione strumen-tale del diritto – sulla qualità della decisione giudi-ziale, mirando non già ad un rimedio che rigidamen-te reintegri il diritto leso, bensì alla soluzione piùcorretta in termini di effettività (Gamba, 145 e 196).
3. La possibilità di allegare i soli fatti so-
pravvenuti: superamento di un limite o con-
traddizione? L’evoluzione segnata dalla pronun-cia in commento, tuttavia, non è completa. Invero,al di là delle declamazioni di principio, le concessio-ni fatte al contraente fedele sono in realtà inferiorialle aspettative ingenerate: pur dopo avere delineatocosì nitidamente le ragioni alla base della disposizio-ne dell’art. 1453 cod. civ. e le esigenze che essa vor-rebbe soddisfare, infatti, effettività della tutela e fi-nalità di concentrazione del giudizio si trovano co-munque ancora, nelle motivazioni della Corte, a ce-dere il passo ad «inderogabili esigenze del contraddit-torio e della difesa».
Innanzitutto, pur affermando la natura di dirittosostanziale del comma 2o dell’art. 1453 cod. civ., laSupr. Corte non rinnega però neppure del tutto l’as-sunto tradizionale secondo cui detta norma costitui-rebbe una regola processuale eccezionalmente dero-gante alle disposizioni che precludono il mutamentodi domanda nel corso del giudizio; conseguente-mente, in questo richiamando la nota sentenza pro-nunciata dalla Cassazione a sez. un. nel 1989 (Cass.,sez. un., 18.2.1989, n. 962, cit.) – manifesto, que-st’ultima, dell’orientamento restrittivo opposto – laCassazione oggi in commento subordina anch’essal’esercizio dello ius variandi alla condizione che l’at-tore non ampli il tema di indagine tramite l’allega-zione di fatti diversi da quelli posti a fondamentodell’originaria azione di adempimento ché, diversa-mente, tornerebbero in vigore le preclusioni proces-suali, e la nuova domanda non sarebbe ammissibile.
Dietro tale apparente sintonia, in realtà, la pro-nuncia dell’89 e quella in commento tradiscono spi-riti opposti: mentre la prima ammetteva unicamenteil passaggio da adempimento a risoluzione e soltantoa patto che le due azioni fossero basate sui medesimifatti, e negava la possibilità di introdurre ex novoun’azione di risarcimento per i danni derivanti dallo
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 - Commento Contratto in genere
NGCC 2014 - Parte prima 1005
scioglimento del contratto, la seconda è tutta proiet-tata verso un modello che sappia assicurare al con-traente fedele un esercizio pieno dello ius variandi eperciò non esclude che la facoltà di mutamento diazione in corso di causa comprenda anche domandecomplementari a quella di risoluzione.
È forse rincorrendo tale modello senza al contem-po volere rinnegare in pieno la tradizione – e forsenel conforto, altresì, di quella dottrina che ipotizzache la domanda di adempimento possa valere «ri-nuncia agli effetti risolventi dell’inadempimentoprecorso, ma non (...) agli effetti risolventi dell’ina-dempimento futuro» (Sacco, 617, infra, sez. IV) –che la pronuncia in commento introduce al divietodei nova, che pur conferma, un’importante eccezio-ne: essa statuisce, infatti, che l’interdizione all’in-gresso di nuove prove resti ferma per i fatti già esi-stenti diversi da quelli allegati in origine, ma che siainvece consentita l’allegazione dei fatti sopravvenutiche, aggravando il quadro iniziale, inducano il con-traente fedele ad avvalersi dello ius variandi.
La novità – probabilmente anche suggerita dallepreoccupazioni di una certa dottrina, secondo cuisarebbe irragionevolmente lesivo del diritto di dife-sa dell’attore vietargli anche la prova di fatti soprag-giunti o conoscibili soltanto dopo l’instaurazione delgiudizio volto ad ottenere l’adempimento (Della-casa, 219 ss., infra, sez. IV) – non è di poco conto,perché consente di assicurare al contraente fedeleuna tutela effettiva in quei casi – che sono forse i piùfrequenti – di inadempimento che diventa definiti-vo, o di ritardo che si aggrava sensibilmente, soltan-to in seguito alla proposizione della domanda diadempimento. Nulla la sentenza dice invece di queifatti esistenti già al tempo dell’azione di manuten-zione, ma che il creditore ignorava, con o senza col-pa: nel silenzio della motivazione, sembra più coe-rente ritenere che almeno i fatti ignorati senza colpapossano essere considerati al pari dei fatti sopravve-nuti e, quindi, ancora deducibili dalla parte in corsodi causa.
Osserviamo, tuttavia, che l’introduzione del cor-rettivo secondo cui il contraente fedele sarebbe am-messo a provare i soli fatti sopravvenuti – al di là deidubbi che questo suscita sul piano dei principi –non solleva comunque in modo del tutto soddisfa-cente le sorti dell’effettività della tutela di cui all’art.1453, comma 2o, cod. civ.: tale regola imporrebbeinnanzitutto – per quanto i casi possano non esseredei più ordinari – di escludere tutti quei fatti che ilcreditore avrebbe potuto conoscere con una diligen-za maggiore, ma di cui – per la complessità della vi-cenda, o per altre varie circostanze, quali ad esem-pio la mancanza di testimonianze decisive o l’esitonegativo di alcune indagini – egli è rimasto all’oscu-ro fino a dopo l’introduzione del giudizio di manu-
tenzione; inoltre, tale regola costringerebbe il con-traente che agisce per l’adempimento del contratto asobbarcarsi l’onere di allegare e provare tutte quellecircostanze, anche le più ininfluenti o ardue in quelcontesto (e magari anche inopportune perché forie-re di ulteriori liti tra le parti in una fase in cui l’atto-re ha interesse a mantenere intatto l’accordo con-trattuale), per non perdere la possibilità di avvaler-sene in seguito, se mai si vedrà costretto a mutarel’azione di manutenzione in quella di risoluzione.
Una simile impostazione non soltanto accetta uningiustificato aggravio nella difesa di parte attrice,bensì rischia di comportare un appesantimento del-l’istruttoria per il giudice, che si troverà a quel pun-to a dover scremare le circostanze utili da una seriedi dati superflui, oltre che nell’imbarazzo di decide-re se assumere anche quelle prove che pure gli paio-no irrilevanti – con aggravio di spese e dispendio ditempo – nel dubbio che esse diventino decisive inseguito (e, magari, non tutte lo saranno comunque),se il contraente in regola deciderà di esercitare lo iusvariandi. Invero non è chiaro, dalle motivazioni del-la Corte di Cassazione, se alla parte sia permessoprovare, in sede di risoluzione e risarcimento, anchequei fatti allegati già da principio con la domanda diadempimento, ma in quella sede poi non assunti aprova dal giudice perché da quest’ultimo ritenutisuperflui e irrilevanti rispetto al fine perseguito o se,invece, dette prove saranno andate ormai irrimedia-bilmente perse, perché non classificabili come relati-ve a fatti sopravvenuti.
Ma, ancor più – e al di là di un’analisi volta casoper caso a riscontrare se e come la possibilità di pro-vare i fatti sopravvenuti attui la tutela accordata alcontraente in regola dalla norma in questione, equanto frequenti siano i casi in cui questi possa re-stare ugualmente sfornito di tutela – una soluzionesiffatta, motivata dalla salvaguardia di inderogabiliesigenze del contraddittorio e della difesa, stridecon l’enunciazione dell’esercizio «in modo comple-to» del favor novorum, poiché, con la scelta di miti-gare soltanto, anziché escludere del tutto, la preclu-sione all’ingresso di nuove prove, le sez. un. mostra-no di non aver accolto del tutto l’insegnamento –l’acquisizione del quale avrebbe permesso un realecambiamento di rotta rispetto al passato – secondocui il diritto processuale è preordinato all’attuazionedel diritto sostanziale, e non deve, viceversa, esserestrumento per limitarlo (Satta, 140 s.; Gabrielli,605; Patti, 1 ss., tutti infra, sez. IV).
Infatti, se l’impedimento ad ampliare il tema diindagine non era giustificato, come abbiamo visto,neppure in seno all’interpretazione tradizionale ri-duttiva – che limitava la tutela ex art. 1453, comma2o, cod. civ. esclusivamente al passaggio dalla do-manda di manutenzione alla domanda di risoluzio-
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 - Commento Contratto in genere
1006 NGCC 2014 - Parte prima
ne, senza possibilità di ottenere ulteriori rimedi afronte dell’inadempimento altrui – tanto meno essoha senso quando è mantenuto, seppure solo in par-te, con riguardo ad un indirizzo estensivo, che auto-rizza la proposizione di tutte le istanze complemen-tari rispetto a quella risolutoria, compresa l’azionedi risarcimento del danno da risoluzione.
Proprio con riguardo all’azione di risarcimentodei danni sofferti dal contraente in regola a cagionedella risoluzione, peraltro, la sentenza trascura ogniriferimento esplicito al limite dell’allegazione deifatti ai soli fatti sopravvenuti: ciò con apparentescarsa consapevolezza, poiché non vi si riporta alcu-na ragione né a sostegno dell’esclusione di detto li-mite, né a giustificazione della differenza di tratta-mento della domanda risarcitoria rispetto alla do-manda di risoluzione.
Siffatta assenza di riferimenti potrebbe leggersinel senso che tale limite non riguarda l’azione risar-citoria (al punto 10, la sentenza parla invero di «ne-cessità che al contraente in regola sia accordata la pos-sibilità di dimostrare i fatti costituivi a sostegno dellapretesa risarcitoria», senz’altra precisazione riguardoa quali fatti possano essere dimostrati, e quali sianoinvece da escludere); a questa stregua, pertanto, perl’azione risarcitoria non varrebbe la rinuncia alleconseguenze degli effetti risolventi dell’inadempi-mento precorso, sicché essa potrebbe essere fondatasu qualsiasi prova, anche anteriore alla proposizionedella domanda di risoluzione.
Se questa fosse l’interpretazione corretta delle in-tenzioni del S.C., il quadro così delineato – mentremira ad un contemperamento tra l’esigenza di man-tenere un ordinato e razionale svolgimento del pro-cesso e gli interessi del contraente in regola di otte-nere un integrale risarcimento del danno sofferto acagione della rimozione degli effetti del contratto –denoterebbe tuttavia un profilo di incoerenza nellemotivazioni della sentenza, perché non terrebbeconto di quelle «inderogabili esigenze del contraddit-torio e della difesa» che, considerate a fini preclusivicon riguardo alla risoluzione, paradossalmente nonlo sarebbero più con riguardo ai danni che ne deri-vano.
Potrebbe essere, per contro, che la limitazione aifatti sopravvenuti si debba applicare – a mente dellesezioni unite – anche all’azione risarcitoria, comepotrebbero far pensare sia la struttura unitaria deltesto della sentenza, sia un’esigenza di coerenza nel-la motivazione, sia il richiamo, in più punti, alla sen-tenza n. 962/1989 (5.2.2, 7 e, soprattutto, 9 e 9.1) –che poneva i medesimi limiti all’ingresso di fatti co-stitutivi a supporto della domanda di risoluzione edella domanda di risarcimento – sia gli esempi, ad-dotti dal S.C., in cui il divieto dei nova è derogato alfine di consentire (anche) la proposizione ex novo di
un’azione risarcitoria, tutti riguardanti fatti soprav-venuti all’azione originariamente promossa («nelleazioni a difesa della proprietà, la rivendicazione puòessere proseguita anche contro chi, dopo la domanda,dolo desiit possidere (...)»: 11.1; «nel campo del di-ritto della società per azioni, l’art. 2378 c.c., comma2o (...) preclude l’annullamento della delibera societa-ria impugnata se nel corso del processo venga menonel socio o nei soci opponenti la quota azionaria mini-ma per essere legittimati all’impugnazione, ma faespressamente salvo in tal caso il diritto a pretendereil risarcimento del danno (...)»: 11,2; «sebbene nelgiudizio d’appello non possano proporsi domandenuove, l’art. 345 c.p.c. (...) accorda la possibilità di do-mandare (...) i danni sofferti dopo la sentenza impu-gnata»: 11.3).
Ora, in questa seconda ipotesi, una limitazione al-l’ingresso in giudizio di fatti precedenti alla risolu-zione sarebbe tuttavia irragionevole e vanificante laportata dell’innovazione data dalla stessa Supr. Cor-te in commento con l’interpretazione estensiva delcomma 2o dell’art. 1453 cod. civ.: essa avrebbe inve-ro l’effetto di escludere la possibilità di ottenere il ri-storo di quei danni che, pur conseguenti al fallimen-to della vicenda negoziale, sarebbero dimostrabilisolo deducendo accadimenti precedenti alla propo-sizione della domanda; il risarcimento di detti pre-giudizi sarebbe infatti perduto a meno che il con-traente non abbia allegato e provato tali fatti sin dal-l’inizio a corredo della domanda di adempimento(pensando ad un’istanza risarcitoria pur senza poi,sorprendentemente, proporla). Altrimenti, semprein quest’ottica, per ottenere il ristoro integrale deldanno egli avrebbe dovuto proporre sin dall’iniziol’azione di risarcimento (per poi ampliarne il peti-tum in seguito alla risoluzione), ma ciò dimostra chel’integrale risarcimento del danno non sarebbe neifatti possibile, a queste condizioni, per il tramite diuna istanza formulata ex novo. Non a caso le pro-nunce, richiamate dal S.C., che in passato – lontano(Cass., 19.11.1963, n. 2995, cit.) o recente (Cass.,31.5.2008, n. 26325, cit.) – hanno accolto una visio-ne estensiva della tutela contenuta nel comma 2o
dell’art. 1453 cod. civ., ammettendo il risarcimentodel danno unitamente alla proposizione della do-manda di risoluzione, non hanno subordinato l’eser-cizio delle azioni nuove ad improbabili restrizioniprobatorie.
Non rinunciando in modo netto all’impostazionerestrittiva precedente e lasciando piuttosto indefinitii contorni delle novità introdotte, invece, la pronun-cia in commento ha perso un’occasione per superarerealmente i limiti di tale impostazione e segnare unadecisiva svolta rispetto ad essa; dopo avere predica-to l’opportunità di un’interpretazione sistematicaimprontata all’effettività dello ius variandi, le sezioni
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 - Commento Contratto in genere
NGCC 2014 - Parte prima 1007
unite si sono accontentate infatti di una soluzione dicompromesso tra i due orientamenti tradizional-mente contrapposti; detta soluzione, però, non sol-tanto non riesce a considerare tutti casi in cui la pro-va di fatti ulteriori renderebbe effettiva la tutela ac-cordata al creditore sulla carta, ma – il che è più gra-ve – evidenzia un certo contrasto tra le premesse in-dicate e gli obiettivi annunciati, poiché dopo avereaffermato la natura sostanziale della norma attribu-tiva dello ius variandi al fine di legittimare la partefedele a proporre anche domande complementari aquella di risoluzione, si ritrova contraddittoriamentea sostenerne la natura processuale così da continua-re a giustificare, seppure in forma ridotta, il divietodei nova.
Forse, allora, un ulteriore passo sarebbe necessa-rio per consentire un reale affrancamento da queimalintesi che a lungo hanno impedito al favor novo-rum di realizzarsi compiutamente.
III. I precedenti
1. La tesi della natura processuale del-
l’art. 1453 cod. civ. e l’immutabilità dei fatti
giuridici costitutivi della pretesa. Sostengonoil carattere processuale della norma di cui al comma2o dell’art. 1453 cod. civ. e la necessità di mantenereimmutati i fatti giuridici costitutivi del diritto al-l’adempimento: Trib. Busto Arsizio, 23.7.1948, inGiur. it., 1949, I, 130 ss.; Trib. Bari, 13.1.1950, ivi,1950, I, 2, 662 ss.; Cass., 30.3.1984, n. 2119, inMass. Giur. it., 1984; Cass., sez. un., 18.2.1989, n.962, in Riv. dir. proc., 1990, 876 ss.; Cass.,22.7.1993, n. 8192, in Mass. Giur. it., 1993; Cass.,2.3.1996, n. 1636, in Giust. civ., 1996, I, 1963 ss.;Trib. Alessandria, 25.3.1998, in Dir. proc. civ.,1998, 1865 ss.; Cass., 9.4.1998, n. 3680, in Corr.giur., 1998, 640 ss.; Cass., 5.5.1998, n. 4521, inMass. Giur. it., 1998; Cass., 26.4.1999, n. 4164, ivi,1999; Cass., 19.8.2003, n. 12133, ivi, 2003; Cass.,27.3.2004, n. 6161, in Gius, 2004, 343 ss.; Cass.,18.1.2008, n. 1003, in Mass. Giur. it., 2008; Cass.,16.6.2009, n. 13953, ivi, 2009; Cass., 23.1.2012, n.870, reperibile on line su Leggi d’Italia De Agostini;Cass., 14.3.2013, n. 6545, ivi; Cass., 12.2.2014, n.3207, ivi. Esclude, in particolare, che l’art. 1453,comma 2o, cod. civ. consenta il mutamento della do-manda di adempimento con quella (sola) di risarci-mento: Cass., 16.6.2009, n. 13953, cit.; escludono,invece, che la norma consenta di mutare la domandada risarcimento a risoluzione: Cass., 9.4.1998, n.3680, cit.; Cass., 26.4.1999, n. 4164, cit.; Cass.,27.3.2004, n. 6161, cit.
Espressamente si pronuncia sulla inammissibilitàdella domanda risarcitoria accanto a quella di risolu-zione: Cass., 17.2.1982, n. 1012, in Mass. Giur. it.,
1982; Cass., 27.7.2006, n. 17144, in Mass. Giust.civ., 2006; Cass., 18.1.2008, n. 1003, cit.; Cass.,16.6.2009, n. 13953, cit.; Cass., 23.1.2012, n. 870,cit.; Cass., 14.3.2013, n. 6545, in Guida al diritto,2013, fasc. 22, 58. In seno al medesimo orientamen-to, esplicita l’ammissibilità della domanda di restitu-zione, accessoria a quella di risoluzione: Cass.,27.11.1996, n. 10506, in Contratti, 1997, 139 ss.;Cass., 6.4.2009, n. 8234, ivi, 825 ss.
2. L’esercizio dello ius variandi alla luce
dei principi di economia processuale e l’am-
missibilità della domanda risarcitoria. Am-mettono la proposizione delle domande di restitu-zione e di risarcimento dei danni, ritenendole en-trambe accessorie all’azione di risoluzione: Cass.,sez. un., 10.4.1995, n. 4126, in Contratti, 1995, 570ss.; Cass., 31.5.2008, n. 26325, in Mass. Giur. it.,2008; Cass., 27.5.2010, n. 13003, in Mass. Giust.civ., 2010. Ammette l’istanza risarcitoria, senza peròparlare di accessorietà, bensì solo di consequenziali-tà tra l’azione di risarcimento e quella di risoluzione,Cass., 19.11.1963, n. 2995, in Giur. it., 1964, I, I,758 ss.
3. La possibilità di allegare i soli fatti so-
pravvenuti: superamento di un limite o con-
traddizione? Ammette espressamente il rimediorisarcitorio, ma continuando a riportare l’assuntodel carattere processuale dell’art. 1453, comma 2o,cod. civ. e dell’immutabilità dei fatti costitutivi dellapretesa, Cass., 27.5.2010, n. 13003, cit. Così pure,benché con sfumature dubitative su alcuni profilidel problema Cass., ord. 9.8.2013, n. 19148, in Con-tratti, 2014, 125 ss., che ha rimesso la questione allesez. un. in commento.
IV. La dottrina
1. La tesi della natura processuale del-
l’art. 1453 cod. civ. e l’immutabilità dei fatti
giuridici costitutivi della pretesa. Affermanoil diritto di mutatio libelli per il contraente fedeleDalmartello, voce «Risoluzione del contratto»,nel Noviss. Digesto it., XVI, Utet, 1969, 140, Sacco,in Sacco-De Nova, Il contratto, II, Utet, 1993, 620,e, in particolare, anche dopo il passaggio in giudica-to della sentenza di adempimento, Auletta, Ancorasul mutamento della domanda di esecuzione in do-manda di risoluzione, in Giur. it., 1950, I, 2, 661 ss.;Id., Sentenza di condanna all’esecuzione e azione dirisoluzione per inadempimento, ivi, 1953, I, 1, 53 ss.;Mosco, Azione di adempimento e azione di risolu-zione per inadempimento, in Foro it., 1951, 1280 ss.Sostengono il carattere processuale della norma dicui al comma 2o dell’art. 1453 cod. civ. e la necessitàmantenere immutati i fatti giuridici costitutivi del
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 - Commento Contratto in genere
1008 NGCC 2014 - Parte prima
diritto fatto valere in giudizio, affinché la causa pe-tendi non muti: Carnevali, Della risoluzione perinadempimento, nel Commentario Scialoja-Branca,Zanichelli-Foro it., 1990, sub artt. 1453-1454, 82;Gili, Rapporti tra diritto di mutare la domanda diadempimento in domanda di risoluzione, ex art.1453, 2o co., c.c. e nuovo regime delle preclusioni nelprocesso civile di primo grado, in Dir. proc. civ., 1998,1865 ss.; Pagni, Il processo nelle impugnative nego-ziali, nel Trattato del contratto, VI, a cura di Roppo,Giuffrè, 2006, 870 s.; Borrione, La risoluzione perinadempimento, Cedam, 2004, 240, il quale espres-samente nega poi il diritto a proporre contestual-mente l’azione di risarcimento. Riporta tale opinio-ne dominante in giurisprudenza, ma senza prendereposizione, Iudica, Risoluzione per inadempimento,in Riv. dir. civ., 1983, 189.
In relazione alla causa petendi della domanda giu-diziale, sostiene la teoria della sostanziazione Gian-
nozzi, La modificazione della domanda nel processocivile, Giuffrè, 1958, 35 ss.; sostiene, al contrario, lateoria dell’individuazione Heinitz, I limiti oggettividella cosa giudicata, Cedam, 1937, 146 ss.; si occupadel concetto e delle teorie sulla causa petendi, non-ché della nozione di fatto costituivo, Mandrioli,Riflessioni in tema di «petitum» e di «causa petendi»,in Riv. dir. proc. 1984, 465 ss. Sulle varie accezionidella nozione di fatto costitutivo e sulle incertezzeriflesse in giurisprudenza nel delineare la causa pe-tendi v. Gamba, Domande senza risposta. Studi sullamodificazione della domanda nel processo civile, Ce-dam, 2008, 113 ss.
Rileva le contraddizioni insite nel vietare la provadi nuovi fatti a fronte della proponibilità di nuovedomande, Rota, Dalla domanda di adempimento alladomanda di risoluzione, in Dir. proc. civ., 1990, 876 ss.
Ravvisa nell’art. 1453, comma 2o, cod. civ. unanorma tanto di diritto sostanziale, quanto di dirittoprocessuale, Luiso, voce «Appello nel diritto pro-cessuale civile», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez.civ., I, Utet, 1987, 371.
2. L’esercizio dello ius variandi alla luce
dei principi di economia processuale e l’am-
missibilità della domanda risarcitoria. Affer-ma che l’art. 1453, comma 2o, cod. civ., deroga agliartt. 183 e 184 cod. proc. civ., al punto da ammettereil mutamento della domanda anche dopo la primaudienza di trattazione e, altresì, l’allegazione di nuo-vi documenti e la richiesta di nuovi mezzi di prova,Bigiavi, Mutamento della domanda in corso di giudi-zio, in Giur. it., 1946, IV, 12 s. Sottolinea il contenu-to di diritto sostanziale della norma attributiva delloius variandi, che identifica un diritto potestativo,Sicchiero, La risoluzione per inadempimento, in Ilcodice civile. Commentario, diretto da Busnelli,
Giuffrè, 2007, 269 ss.; di questo avviso, parla di op-zione tra i rimedi all’altrui inadempimento, critica ildivieto di allegazione di nuovi fatti e ammette la pro-ponibilità dell’istanza risarcitoria, Gabrielli, Propo-nibilità delle domande risarcitoria e restitutoria in cor-so di giudizio purché congiuntamente con quella di ri-soluzione del contratto inadempiuto, in Riv. dir. civ.,2012, 597 ss.; per l’ammissibilità dell’azione risarci-toria, in ossequio a finalità di concentrazione delprocesso, propende anche De Menech, Mutamentodella domanda di adempimento in quella di risoluzio-ne del contratto e pretesa risarcitoria avanzata in occa-sione della mutatio libelli, in Contratti, 2014, 125 ss.Sulla ratio alla base della norma attributiva dello iusvariandi v. anche Mosco, La risoluzione del contrat-to per inadempimento, Jovene, 1950, 248 ss.
Sostiene il carattere di diritto sostanziale dell’art.1453, comma 2o, cod. civ., affermando che «l’eserci-zio di un diritto (...) non può essere pregiudicatodalla pendenza del giudizio», Satta, Commentarioal codice di procedura civile, II, Vallardi, 1962, 134s.; sostiene la natura di diritto sostanziale della nor-ma, pur vietandone l’attuazione dopo la primaudienza di trattazione, Travi, «Jus variandi» previ-sto dall’art. 1453 cod. civ., 2o comma, e suoi limiti inrapporto alla risoluzione del patto di preferenza, inGiur. it., 1949, I, 130 ss., e con rifermento alla rifor-ma operata dalla l. 353/90, Consolo, Il processonella risoluzione del contratto per inadempimento, inRiv. dir. civ., 1995, 321.
Sulla nozione di accessorietà, Comastri, nelCommentario al codice di procedura civile, a cura diComoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella, Utet,2012, sub art. 31, 443.
3. La possibilità di allegare i soli fatti so-
pravvenuti: superamento di un limite o con-
traddizione? Condivide parzialmente il divietodei nova formulato dalla giurisprudenza dominate,ma sostiene che al creditore in regola non possa es-sere impedito di provare almeno i fatti sopravvenutie quelli divenuti conoscibili dopo l’introduzione delgiudizio: Dellacasa, Il giudizio di risoluzione. Inat-tuazione e risoluzione: i rimedi, nel Trattato del con-tratto, a cura di Roppo, V-2, Giuffrè, 2006, 213.Ipotizza che la domanda di adempimento possa va-lere rinuncia agli effetti risolventi dell’inadempi-mento precorso, ma non già a quelli dell’inadempi-mento futuro, Sacco, op. cit., 617.
Affermano la strumentalità delle norme proces-suali rispetto a quelle sostanziali, Patti, Diritto civi-le e diritto processuale civile: frammenti di un percor-so, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, 1 ss.; Satta,op. cit., 140 s.; Gabrielli, op. cit., 605.
Daniela M. Frenda
Cass., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 - Commento Contratto in genere
NGCC 2014 - Parte prima 1009