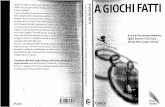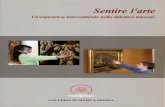Sofocle a Colono: i fatti del 411 e l'esperienza politica ateniese tra le righe dell'ultimo Edipo
Transcript of Sofocle a Colono: i fatti del 411 e l'esperienza politica ateniese tra le righe dell'ultimo Edipo
Siamo nel 4071. Venuto a conoscenza del fatto che Alcibiade avevaimpegnato le migliori truppe ateniesi tra Nozio e Samo, il re spartanoAgide II mette a punto un piano che – se fosse riuscito – avrebbe potutorisolvere prima del tempo l’annoso conflitto che divideva la Grecia. Èmolto dettagliata e colorita la prosa di cui si serve Diodoro Siculo2 perraccontare l’accaduto: da Decelea 28.000 soldati e 1.200 cavalieri tra re-parti tebani e peloponnesiaci si muovono in una notte nera, cogliendo disprovvista le sentinelle. Atene si sveglia bruscamente per fronteggiarel’emergenza: gli anziani più esperti e i giovani più robusti si armano, la
* Ringrazio sentitamente Giorgio Camassa, Davide Susanetti e Fabio Ven-druscolo per l’aiuto fornitomi nel corso della ricerca.
1 Le datazioni, se non diversamente indicato, sottintendono l’indicazioneavanti Cristo.
2 XIII, 72, 3-73, 1.
SOFOCLE A COLONO: I FATTI DEL 411 E L’ESPERIENZA POLITICA ATENIESE
TRA LE RIGHE DELL’ULTIMO EDIPO
ABSTRACT. In 411 BC the Athenian Assembly, unusually gathered in the deme of Co-lonus Hippios, voted for the suppression of the democratic government: it was thebeginning of a short – though intense – period of violence and instability, whichbrought the city on the brink of a dreadful civil war. Among the actors in that dra-matic overthrow there was Sophocles, the celebrated tragedian. Few years later, So-phocles chose to set the action of his last work in Colonus, where Oedipus died onlyto become guardian of the city. This paper examines the connections between theplay and the facts of 411 through the figure of Sophocles, focusing on the pro-blems of guilt, duty, responsibility and salvation in the very last years of the Athe-nian democracy.
KEYWORDS. 411 BC, Oligarchy, Athenian Democracy, Sophocles’ Oedipus at Colonus.
città riesce a resistere fino al mattino. Il sorgere del sole svela ai generalila reale entità del pericolo: le mura sono circondate dai nemici per circatre quarti del loro perimetro. Ciò nonostante gli assediati non si perdonod’animo e, alla fine, la cavalleria ateniese riesce a respingere le forze pe-loponnesiache e tebane – queste ultime particolarmente tenaci.
Agide ripiega allo scopo di prendere tempo; in attesa di un’altra oc-casione propizia, si accampa – dice Diodoro – !" #$%&'µ(), vicino aldemo di Colono Hippios. La perseveranza del re non basta, però, a pie-gare la testarda resistenza ateniese: anche il secondo tentativo di attaccosi risolve in un nulla di fatto. A Spartani e alleati non rimane che accon-tentarsi di razziare il resto dell’Attica e ritornare nel Peloponneso.
A questo episodio solo raramente si accenna nelle principali sintesimoderne dedicate alla fase finale della guerra tra Sparta e Atene. Se sivaluta il contesto più ampio all’interno del quale esso si verificò, la cosanon sorprende: protagonisti di quegli ultimi anni sono personaggi cari-smatici come Alcibiade e Lisandro (nessuno dei quali minimamentecoinvolto nel colpo di mano di Agide), gli scenari davvero cruciali sonoda cercarsi altrove. Tuttavia queste sono valutazioni a posteriori che è fintroppo facile compiere: il fatto che nella produzione teatrale di queglistessi anni comincino a farsi frequenti gli accenni a Colono dimostraquanto, in realtà, l’episodio di quella vittoria avesse segnato le coscienzedel pubblico – cioè dei cittadini. A teatro diventano protagoniste le ossadi Edipo, la leggenda per la quale Atene, avendo accolto le sue spoglie,sarebbe stata benedetta dagli dèi: ne aveva già accennato Euripide nelleFenicie3, ma è Sofocle a dedicare al mito un’intera tragedia, l’ultima dellasua carriera, l’Edipo a Colono4. Il collegamento tra l’opera sofoclea el’episodio narrato da Diodoro è facilmente riconoscibile nel secondo sta-simo5, quando gli anziani Ateniesi del Coro, immaginandosi lo scontrotra Teseo e i Tebani di Creonte, alludono piuttosto chiaramente alla re-cente battaglia contro Agide e i suoi alleati.
A Colono, però, appena pochi anni addietro era accaduto un altroepisodio che nessun Ateniese allora in vita avrebbe mai dimenticato. Si
3 Vv. 1703-1707. In difesa dell’autenticità dei versi si è schierato in modomolto convincente MASTRONARDE (1994), p. 626.
4 L’edizione di riferimento è quella curata da Guido Avezzù e Giulio Guido-rizzi (Milano 2008).
5 Vv. 1044-1095.
MARMAI166
può ben credere che la semplice menzione del demo potesse essere suf-ficiente a evocare negli spettatori ricordi più che dolorosi, non diversa-mente da quanto può causare in Italia il nome di Caporetto: proprio aColono, infatti, si tenne la seduta assembleare della primavera del 411,durante la quale Atene cedette alle illusioni propugnate – legalmente enon – dagli oligarchi e votò per la soppressione della democrazia6.
Ma, si potrebbe obiettare: se il collegamento ipotizzato fosse mera-mente accidentale? Colono è considerato il demo di nascita di Sofocle7:non avrebbe potuto egli, vecchio e conscio di essere prossimo alla fine,sceglierlo simbolicamente per un dramma fortemente introspettivo,come a chiudere un cerchio attorno a sé?
Nulla nell’opera rimanda esplicitamente ai fatti del 411. Edipo vivein un ‘non-tempo’, quasi una dimensione a parte rispetto agli altri per-sonaggi, sfugge testardamente, astiosamente a chiunque tenti di coinvol-gerlo nei conflitti del potere; e se da morto – da eroe – egli recupera difatto un ruolo politico facendosi protettore terribile8 di Atene, i nemicicui allude sono senza volto9. Ancora, che dire della descrizione di Co-lono «biancheggiante, dove più assiduo l’usignolo effonde il lamentomelodioso nelle valli verdeggianti, sull’edera color di vino, sul fogliameinaccessibile del dio, ricco di grappoli, ombroso, immune dai venti diogni tempesta»10? L’orgoglio commosso per la sua bellezza contrasta net-
6 Cfr. LANZA (1986), p. 43: «tra il 411 e il 406 Colono era un nome che ri-correva molto spesso in Atene, e non soltanto a teatro, ma anche nell’assemblea,per il colpo di stato costituzionale di Colono, in conseguenza del quale Colono fuconsiderato presidio della salvezza dell’Attica». Si ricorda che, benché rappre-sentato postumo solo nel 402/1, l’Edipo a Colono fu scritto tra il 409 (anno dirappresentazione del Filottete) e il 406/5 (anno della morte di Sofocle).
7 Si veda infra. 8 Terribile perché ancora non placato, perché ancora in grado di provare un
odio che esplode sinistro in questi versi (621-622): «A questo punto il mio corpo,assopito nella tomba, gelido berrà da loro il sangue caldo» (trad. di G. Cerri).
9 Questo almeno stando al senso ultimo della sua riflessione (vv. 607-623): èvero che, nello specifico, Edipo si sta riferendo ai Tebani, ma solo accidental-mente, perché Teseo li ha chiamati in causa. La risposta cinica e disillusa del vec-chio cieco travalica la sua esperienza personale e si proietta in una dimensione digenerica instabilità tra le parti. Niente rimane uguale, gli amici di oggi saranno inemici di domani: la sete di sangue del morto colpirà chiunque ostacolerà Atene,senza differenze e, soprattutto, senza significative specificazioni.
10 Vv. 670-677.
167SOFOCLE A COLONO: I FATTI DEL 411
tamente con gli scenari cupi di quei giorni di angoscia e prevaricazione.Parrebbe lecito, a questo punto, pensare che il dramma debba intendersicome l’ultima, intima riflessione di un Sofocle che si accomiata dal suopubblico e dalla sua patria.
In un certo senso, questo corrisponde a verità: molto spesso dietro lamaschera di Edipo si riconosce il volto del poeta. La domanda, però, èun’altra: Sofocle, affidando a quest’ultimo dramma il peso dei suoi pen-sieri, può davvero aver ignorato qualsiasi dimensione pubblica, ritiran-dosi nel mero !"#$%? È difficile crederlo, a meno che non si ammetta che,nel redigere l’opera, egli abbia dimenticato di essere – oltre che un uomoanziano – un cittadino, figlio di una polis che aveva servito ai massimi li-velli e con la quale aveva condiviso momenti di irripetibili gloria e cu-pezza. Ed ecco, quindi, che il discorso ci riporta di nuovo al 411 e a Co-lono, dove il poeta approvò assieme agli altri syngrapheis il piano elabo-rato dagli oligarchi per delegittimare il popolo e la Boule11.
La scelta dell’ambientazione della tragedia non è casuale, lo abbiamovisto. L’episodio della vittoria su Agide poteva costituire un barlume disperanza per un’Atene che aveva bisogno di credere di non essere an-cora vittima del conflitto che, di lì a poco, l’avrebbe invece messa in gi-nocchio. La possibilità che Sofocle vi fosse nato rende plausibile l’idea diun simbolico, nostalgico ritorno alle origini prima dell’addio definitivoalla vita; ma se davvero a Colono il poeta è stato tra coloro che hanno ro-vesciato la democrazia, allora è impensabile che anche quella gravosa de-cisione e le conseguenze che ne erano scaturite non abbia lasciato, in-trappolata tra i versi, un’eco sinistra.
Non c’è tuttavia unanime consenso relativamente alla questione dellaproboulia di Sofocle, come – più in generale – riguardo alla fondatezzadelle informazioni concernenti la sua carriera politica. Il primo passo in-dispensabile diventa, quindi, quello di inquadrare il problema e stabilire(fonti permettendo) un profilo biografico politico per il poeta.
L’anonimo autore della Vita Sophoclis12 ne riferisce solo in manierapiuttosto vaga e confusa, accennando ad incarichi politici ed ambasce-
11 Si veda infra.12 TrGF 4, T1. Si tratta della versione ridotta di un testo risalente approssimati-
vamente al I secolo: tra le fonti citate dal suo autore, infatti, la più recente è Caristiodi Pergamo (ultimo terzo del II secolo), il che ci permette di stimare questo periodocome terminus post quem, cfr. G. LIPPOLD, s.v. Sophokles, in RE!, 5 B, col. 1040.
MARMAI168
rie13 e ad una strategia, ricoperta assieme a Pericle e Tucidide14 all’età di65 anni, sette anni prima dello scoppio della Guerra del Peloponneso15.Questa notizia trova parziale riscontro nelle parole di Androzione16, ci-tate da uno scoliasta di Elio Aristide, che registrano la lista degli strate-ghi impegnati nella soppressione della rivolta a Samo nel 441/0:
!"# $%&' (!)'!*+"# !"# ,# -.µ/ !0 1#2µ'!' &'!0 3#$)4!56#'· -6&).!*73#'+8).(947, -4:4&;<7 ,& =4;6#4> ? @49*!A7, 3#$4&5$*7 =8$'B*#'9CD7, =)%6#-&'µE6#5$*7, FC)9&;<7 G4;')+CD7, H;'D&6# ,& =C)'µ%6#, =';;5(!)'!473I')#CD7, JC#4:"# KC;C!CD7, L'µ@)5$*7 FC9)'9CD7, H;'8&%!*7 † 3B*#'M47 †,=;C9!4:"# N4)'9CD717.
Parziale, si diceva, perché in realtà i dati cronologici non collimano.Secondo la versione dell’anonimo, Sofocle sarebbe stato nominato stra-tego all’età di sessantacinque anni: benché sia difficile stabilire una dataprecisa per la nascita del poeta18, anche accettando la più alta tra quelle
13 § 1 = TrGF 4 T1, r. 11 = […] &'O ,# @4;9!C5P &'O ,# @)C(EC5'97 ,Q*!.RC!4,«egli si cimentò sia nell’esercizio della propria cittadinanza, sia partecipando adambascerie».
14 § 1 = TrGF 4, T1, rr. 4-5: […] 4S +0) CT&U7 !U# ,& !4> !494>!48 +C#2µC#4#(!)'!*+5'7 VQ96B<#'9 (W# FC)9&;CM &'O N48&8$5$X, !4M7 @)Y!497 !<7 @2;C67,«Non pare ragionevole, infatti, che un uomo di tali origini possa essere stato ri-tenuto degno della strategia assieme a Pericle o Tucidide, i leader della città». Vadetto che in questo passo probabilmente l’autore non intendeva suggerire cheessi avessero servito tutti nello stesso anno come (8(!).!*+49, bensì che Sofocleera stato onorato di tale incarico prestigioso proprio come Pericle e Tucidide, cfr.EHRENBERG (1958), pp. 163-164.
15 § 9 = TrGF 4, T1, rr. 35-36: &'O 3B*#'M49 $Z 'S!U# QC´ ,!"# [#!' (!)'-!*+U# C\;4#!4 @)U !"# FC;4@4##*(9'&"# ]!C(9# R´, ,# !^ @)U7 3#'5487 @4;%µ/,«Gli Ateniesi lo elessero generale a sessantacinque anni, sette anni prima dellaguerra del Peloponneso, durante il conflitto contro gli Anei».
16 Su Androzione si vedano HARDING (1993); BEARZOT, LANDUCCI GATTI-NONI (2010).
17 TrGF 4 T19 = FGH 324 F 38. Cfr. inoltre FORNARA (1971), pp. 40-71.18 Considerando che egli risulta già defunto alle Lenee 405 (anno di rappre-
sentazione delle Rane e delle Muse di Frinico) e che le fonti concordano nell’at-tribuirgli una vita lunga all’incirca novant’anni (cfr. lessico Suda, s.v. -4:4&;<7;Marmor Parium FGH 239 A 64), è lecito supporre che la sua nascita risalga altrienno tra il 498 e il 495.
169SOFOCLE A COLONO: I FATTI DEL 411
plausibili (cioè il 498), il suo sessantacinquesimo compleanno sarebbecaduto solo nel 433, vale a dire otto anni dopo i fatti di Samo di cui ri-ferisce Androzione – e comunque, sia accettando il 441/0 sia il 433 comedata della strategia, in nessun caso avremmo un Sofocle generale setteanni prima dell’inizio del conflitto tra Sparta e Atene19.
Indubbiamente il peso della testimonianza di Androzione meritamaggiore considerazione del florilegio di biografie cucito insieme dal-l’anonimo della Vita; non a caso perfino i più irriducibili scettici cedonosu questo punto e ammettono che sì, il poeta dev’essere stato membrodel collegio degli strateghi almeno nel 441/020. Dunque l’autore dellaVita s’è semplicemente ingannato, magari rifacendosi via via a cronolo-gie diverse o poco affidabili?
Non necessariamente. C’è infatti la possibilità che all’origine di que-sta confusione temporale vi sia il riferimento ad una seconda strategiacui il Nostro sarebbe stato chiamato. Su quest’ultimo punto forti sonotutt’oggi le resistenze, ma esistono almeno due ottimi motivi per riflet-terci seriamente: l’uno ha nome Plutarco, l’altro Aristofane.
Nella Vita di Nicia21, Plutarco racconta di quando, invitato a parlareper primo in qualità di membro più anziano tra gli strateghi, Sofocleavrebbe graziosamente declinato, cedendo il privilegio al !"#$%&'(')*Nicia. L’aneddoto non è corredato di riferimenti cronologici, ma il fattoche a Nicia spetti tale appellativo rende plausibile una datazione tra il
19 La questione di Anaia è a sua volta un problema alquanto intricato, dalmomento che le fonti non offrono riscontri in merito. In estrema sintesi, delledue l’una: o dobbiamo immaginare che questa guerra contro Anaia (perea diSamo) sia stata una misura presa da Atene successivamente alla missione samiadel 441/0, oppure (e questa mi pare l’ipotesi preferibile) alla base di tutto vi èsemplicemente un errore di trascrizione che ha trasformato l’originariaespressione !"+* ,-µ).* nella lezione !"+* /0(1).* – termine di per sé inesi-stente, dal momento che la forma corretta dovrebbe essere /0(21'(*, cfr. Thuc.,III, 19, 2. Si vedano comunque FANTASIA (1986), pp. 113-143; CARUSI (2003), pp.137-139.
20 Cfr. AVERY (1974), p. 511, per il quale la notizia sarebbe «our one securepoint of reference for his political career».
21 15, 2. Non si vedono reali ragioni per negare credibilità storica all’aned-doto plutarcheo come invece suggerisce WOODBURY (1970), pp. 212-213.
MARMAI170
423 e il 415 – e, all’interno di tale delimitazione di massima, l’anno del-l’armistizio (423/2) e quello della cosiddetta Pace di Nicia (421) appa-iono i più soddisfacenti22.
Teniamo in mente questo dato mentre passiamo a considerare unadelle (rarissime) frecciate che Aristofane ha architettato ai danni delpoeta nella Pace: la Pace chiede a Trigeo nuove su alcuni «vecchi arnesi»(!"#$%$) che aveva a suo tempo lasciato ad Atene, e il primo della lista èproprio Sofocle. Tutto bene, riferisce Trigeo, nonostante si stia trasfor-mando in Simonide – tant’è che il vegliardo, pur decrepito, per il gua-dagno sarebbe pronto ad affrontare i flutti su una stuoia23. Certo non sipuò dire che Sofocle fosse uno dei bersagli prediletti di Aristofane, chelo chiama in causa rarissimamente e che si mostra nel complesso più chebenevolo nei suoi confronti24: dunque come spiegare questa burla? Unoscoliasta ha provato a motivare la pointe della battuta ricordando il com-portamento tenuto da Sofocle nel corso della sua strategia, avendo egliapprofittato della campagna di Samo per arricchirsi. Tuttavia la Pacevenne rappresentata solo nel 421, vale a dire ben vent’anni più tardi:l’avidità di Sofocle in quel frangente non poteva certo essere ancora unsucculento argomento di attualità e dunque la sua chiamata in causaresta ugualmente immotivata. Ma ammettiamo che, come si è suggerito,Sofocle sia stato eletto alla strategia una seconda volta attorno al 423/2 oproprio nel 421: in questo caso sì che l’interesse aristofaneo per la cupi-digia del poeta troverebbe una più che logica giustificazione.
171SOFOCLE A COLONO: I FATTI DEL 411
22 In una fase segnata dal profilarsi di importanti accordi diplomatici con gliSpartani, non era affatto impensabile eleggere tra i generali anche personalità piùabili a persuadere che a combattere, come poteva essere Sofocle. Poco importa cheal tempo egli fosse già molto vecchio: le magistrature ad Atene prevedevano un’etàminima, non un’età massima – purché chiaramente il candidato fosse in grado di as-sumersene il carico (e il poeta sembra aver goduto fino all’ultimo di un’invidiabile lu-cidità mentale). Peraltro, operando un calcolo con criterio esclusivo, il 421 precede-rebbe proprio di sette anni la ripresa delle ostilità tra Atene e Sparta, dunque non sipuò escludere che l’anonimo della Vita, nella sua imprecisa sintesi, abbia in questocaso confuso l’inizio vero e proprio del conflitto (431) con la sua ripresa (413).
23 Vv. 695-699.24 Si considerino ad esempio le Rane, dove il poeta appare come un vero gen-
tiluomo, nobile di nascita e di spirito, nonché come uno dei più grandi poeti, se-condo solo ad Eschilo.
Maggiori dovrebbero essere i dubbi relativi, invece, alla carica di hel-lenotamias, attribuitagli a cuor fin troppo leggero: la rilevanza dell’iscri-zione del lapis primus è in realtà molto meno probante di quanto si vo-glia credere. Nel frammento incriminato – IG I! 269 (443/2)25 – al rigo36 si legge infatti:
!"#$%&' ()$*&+&),' -.$+&/%0µ[µ"#)$), !]&1&*23'26 4&2&[+56)+ h)22)+�µ7]08' 9+.
Un tesoriere di nome Sofocle e originario di Colono: la tentazione distabilire un’identità tra costui e il poeta è forte. Peccato che l’informa-zione sia resa irrimediabilmente ambigua dalla perdita di quelle pochema fondamentali lettere che completavano il demotico del tamias.
Ad Atene esistevano almeno tre Colono – Kolonos Hippios, scenariodella tragedia sofoclea e assegnato alla tribù Egeide, e due Kolonai, ap-partenenti rispettivamente alla Leontide e all’Antiochide27. Tre demiomonimi implicano tre possibili integrazioni: 4&2&[+56)+, 4&2&[+36)+,4&2&[+:$'. La scelta dell’editore, nel caso specifico, è caduta sullaprima, la quale è però epigraficamente altrimenti del tutto inattestata28;l’unico parallelo a tutt’oggi noto si trova in un manoscritto bizantino(Parisinus 2712) databile solo al XIII secolo d.C.29 Se invece conside-riamo i documenti coevi, la formula prediletta per indicare la prove-nienza da Colono Hippios risulta essere piuttosto ;* 4&2<+&=30. Questaformula si dimostra tuttavia incompatibile con il testo superstite del-l’epigrafe, che parrebbe adattarsi meglio a una delle restanti soluzioni, equesto implicherebbe che il tesoriere fosse originario di un demo diverso
25 Cfr. MERITT, WADE-GERY, MCGREGOR (1949), tav. 12. 26 Ai dubbi sollevati da LEWIS (1955), p. 15, circa la lettura corretta delle let-
tere componenti il nome del tesoriere, ha risposto con molta sicurezza MERITT
(1959), p. 189.27 Cfr. TRAILL (1975); TRAILL (1986).28 Sebbene si debba precisare che il numero di testimonianze superstiti pre-
cedenti al IV secolo e contenenti il demotico «da Colono» siano oggi davveromolto poche (quattro, senza contare l’epigrafe in questione), il che rende talecampione molto meno indicativo di quanto sarebbe auspicabile.
29 Cfr. LEWIS (1955), p. 12. Il manoscritto contiene sei tragedie di Euripide,sette di Sofocle e sette commedie di Aristofane.
30 Vd. infatti la testimonianza di Androzione riportata sopra.
MARMAI172
rispetto a quello del poeta31, invalidando l’identificazione tra i due.Certo, di per sé il demotico (o l’ipotetico demotico) !"#"$%&'$ è for-malmente corretto e plausibile; tuttavia basarsi su di esso per concludereche Sofocle è stato certamente tesoriere della Lega ci imprigionerebbe inun labirinto logico – il demotico del tamias dev’essere integrato in -$%&'$perché il poeta veniva da Colono Hippios, ed è ovvio che il poeta fosseanche il tamias: non appartenevano forse al medesimo demo? In questocircolo vizioso la tesi da dimostrare si fa premessa e fondamento dellasua stessa dimostrazione: l’unico modo per uscirne è ammettere l’insuf-ficienza dei dati a nostra disposizione. Del resto, anche espungendo dalcursus honorum sofocleo la carica di tesoriere, quello che resta è un cur-riculum politico di tutto rispetto, con all’attivo due strategie (o comun-que almeno una) e incarichi diplomatici. Per di più non solo Sofocleaveva servito la polis ai massimi livelli possibili, ma l’aveva anche fatto la-vorando fianco a fianco con quel Pericle che, nell’Atene del post-413,era assurto a figura quasi eroica, cui si attribuivano (a torto o a ragione)tutte le doti che mancavano ai leader del presente, quelli che avevanotrascinato nel fango la città.
Consideriamo un po’ più da vicino la situazione di quegli anni, cioèdi quelli successivi al 413 – una «matassa ingarbugliata»32, ripetendo unabrillante metafora aristofanea. Dalla sconfitta in Sicilia la potenza diAtene era uscita umiliata, la sua autorità ridimensionata e la sua econo-mia disastrata sia per le perdite ingenti, sia per la sostanziale mancanzadi tempo per assorbirle. Il demos, in ambasce, si risolve a ripiegare suuna misura di emergenza: la nomina di dieci commissari scelti tra i citta-dini più saggi ed avveduti, affinché a loro fosse affidata la salvezza dellapatria33.
31 La famiglia di Sofocle apparteneva sicuramente alla tribù Egeide. Nei do-cumenti ufficiali, dove i magistrati erano elencati per tribù, sia il suo nome siaquello di suo nipote Sofocle compaiono regolarmente al secondo posto. Questosignifica che, tra i tre demi omonimi, quello di cui era originario il poeta era Co-lono Hippios.
32 Lys., v. 567.33 Di questi commissari parlano sia Tucidide sia Aristotele, anche se in ter-
mini diversi e fondamentalmente inconciliabili. La questione richiederebbemolto più spazio di una semplice nota, ma basti in questa sede precisare che, trai due resoconti, quello di Aristotele appare preferibile: da un lato, la sua versione
173SOFOCLE A COLONO: I FATTI DEL 411
Dieci, dunque, erano i probouloi, ma solamente di due di costoro co-nosciamo il nome: il primo è Agnone34, l’altro è Sofocle – e a riferirceloè l’attendibilissimo Aristotele35:
!"# $%µ&'(")*+µ,*+%, -.* -(/01µ" &+)2 03 $%µ&,("$µ", 04* "506"* '5&'7*, +8+*9+:+!;<=, -(>0/µ'*+= ?&3 @')$A*B(+% '5 CB+D'* "E0F, G$&'( !"# 0+7= H;;+)=&(+I+J;+)=, !"0"$0<$") 0+K= 0'0("!+$6+%=, C:1 “06 B,L +E &+*1(A $+) 0"M0"-BN!') 'O*")L” C:1. “+E!+M* $K 0"M0" C&("D"= 0. &+*1(AL” “*"#” C:1 “+E P.( Q*H;;" I';06>”.
«Se una conclusione è posta in forma interrogativa, bisogna specificare la ragionedella risposta, come fece Sofocle; interrogato da Pisandro se anch’egli, come glialtri probuli, avesse approvato l’instaurazione dei Quattrocento, lo confermò. “Edunque? Non ti era sembrata una cosa spregevole?” aggiunse l’altro, e Sofocleconfermò di nuovo. “Quindi hai fatto questa cosa spregevole?” domandò ancoraPisandro, e quello rispose: “Sì, perché non c’era un’alternativa migliore”».
Identificare nel proboulos il poeta è una via possibile – non l’unica,però. Ci sono almeno altri due omonimi che potrebbero essere stati pro-tagonisti dell’aneddoto citato: Sofocle figlio di Sostratides, che fu stra-tego dal 426 al 424 e poi esiliato in seguito ad una condanna per corru-zione (per comodità, d’ora in poi Sofocle il Generale) e Sofocle il mem-bro della commissione dei Trenta citato da Senofonte36 (Sofocle l’Oli-garca). Non mancano gli studiosi convinti che il racconto aristotelico siriferisca appunto a uno di loro37; ma fino a che punto sono soddisfacentiqueste identificazioni?
Che il probulo fosse il Generale è tecnicamente sostenibile: a di-spetto dell’esilio, egli può essere tornato in patria in occasione dell’am-nistia del 413 e sicuramente aveva un’età e un’esperienza sufficienti a
viene confermata da Arpocrazione con riferimento ad Androzione e Filocoro(SUD., s.v. $%PP(":'7=); dall’altro, essa è l’unica capace di adattarsi al confrontocon Lisia che – nel Contro Eratostene – accusa Agnone (padre di Teramene e pro-boulos) di aver favorito gli interessi dei Quattrocento proprio approfittando diquest’ultimo incarico (12, 65). Si veda comunque infra.
34 Cfr. nota precedente.35 Rhet., III, 18, 6.36 Hell., II, 3, 2.37 Cfr. BEARZOT (1997), pp. 178-180; KRENTZ (1982), p. 54.
MARMAI174
giustificare la sua nomina tra i commissari. Il suo, però, non era affattoun curriculum politico immacolato, con quella condanna per corruzione:è davvero difficile credere che, a un passo dal baratro, gli Ateniesi ab-biano potuto pensare di mettere le sorti della patria nelle mani di unuomo che – amnistia o meno – era stato riconosciuto degno di esserecacciato dai suoi confini38.
Anche l’identificazione con l’Oligarca è di per sé credibile: visto ilsuo coinvolgimento successivo nella commissione dei Trenta Tiranni, èben possibile che già nel 413 egli abbia nutrito simpatie antidemocrati-che – e che alcuni probuli fossero complici dei Quattrocento è un’even-tualità facilmente accettabile, anche se non necessaria. Poco importache, nel passo della Retorica, il nostro Sofocle si ingegni a dissociarsidalle malefatte dei cospiratori, anziché appoggiarle: in seguito all’assassi-nio di Frinico e al tracollo dei piani di pace con Sparta, quella della de-monizzazione dei più reazionari tra i Quattrocento era diventata un’atti-vità praticata da molti dei loro (ex)complici e simpatizzanti, si pensi aTeramene o al futuro Tiranno Crizia. Ciò che lascia davvero perplessi,nel caso specifico, è piuttosto l’assoluta inconsistenza della figura di que-sto Oligarca, il cui spessore è tanto sottile da non potersi escludere unacorrispondenza tra quest’ultimo e il Generale39. Se questo fosse il caso,la sua identificazione con il proboulos risulterebbe insoddisfacente pergli stessi motivi esposti sopra. Se invece fosse vero il contrario, alloraavremmo a che fare con un personaggio sfuggente, privo di reale fama alivello storico e nella letteratura contemporanea e posteriore40. Ed è pro-prio questo il punto: Aristotele non si cura di presentare né Pisandro néil Sofocle che gli ribatte in modo così esemplare. È evidente che per luiquesto fosse uno sforzo superfluo, dunque entrambi i personaggi dove-
38 BEARZOT (1997), p. 179, aggira l’ostacolo suggerendo che il Generaleavrebbe potuto ricostruirsi una ’verginità’ politica in seno all’ambiente antide-mocratico; ma se, come riferito da Aristotele, i probuli sono stati nominati nel413 – cioè esattamente nell’anno dell’amnistia –, quanto in fretta si può immagi-nare sia avvenuta questa catarsi?
39 Così, ad esempio, TRAILL (2006), p. 340. Cfr. anche JAMESON (1971), p.545 e KIRCHNER (1903), p. 262, nr. 12827.
40 Lo stesso Senofonte si limita ad elencarlo nel catalogo, senza spendere perlui una sola parola in più.
175SOFOCLE A COLONO: I FATTI DEL 411
vano essere riconoscibili ancora a distanza di quasi un secolo dagli eventinarrati. Ma si può credere davvero che uno di questi magistrali interlo-cutori fosse l’Oligarca, così costantemente ignorato dalle principali fontidell’epoca? Non sarebbe stato meglio, in tal caso, aggiungere qualchechiarificazione onde evitare di confonderlo con il Poeta – di gran lungail Sofocle più noto?41
Abbiamo detto che identificare il probulo con il poeta è una via pos-sibile: a fronte di ciò che si è appena rilevato, si può concludere che èanche la via più probabile. Sofocle vantava i requisiti di anzianità previ-sti, aveva maturato un’esperienza politica di primo livello, era istintiva-mente associato alla politica dell’età periclea42 e godeva di un indiscussorispetto in città: ciò bastava e avanzava per garantirgli la più piena fidu-cia dei suoi concittadini in difficoltà.
Ma – e siamo infine giunti al tasto dolente – questa fiducia è stata de-gnamente ripagata? Sofocle ha corrisposto le aspettative che il demos nu-triva nei suoi confronti? E, ancor più intimamente, Sofocle sentiva diaver compiuto il suo dovere senza rimorsi e senza rimpianti?
Può darsi che tali domande siano eccessive rispetto alle possibilità diuna onesta ricerca sulle fonti cui di consueto lo storico fa ricorso – e tut-tavia vale la pena di tentare la strada, non tanto per spremere l’impossi-bile dai resoconti aristotelici e tucididei, quanto per considerare una di-mensione spesso ingiustamente esclusa: quella del teatro tragico43.
Per prima cosa, però, occorre sfatare un mito: ad Atene l’istituzionedei probuli non ha avuto direttamente a che vedere con la successiva de-riva oligarchica. La riflessione politica di Aristotele44 e il resoconto pro-babilmente impreciso di Tucidide45 hanno contribuito a condizionare
41 Cfr. JAMESON (1971), pp. 543-546.42 Non nel senso che egli condivideva in tutto e per tutto la linea e i piani di
Pericle o che ne era un accorato sostenitore, bensì nel senso che veniva percepitocome un ‘politico dell’età dell’oro’, degli anni in cui i retori non erano demagoghi.
43 Sull’annosa questione della liceità dell’uso delle tragedie per la ricostru-zione storica (pur con la debita accortezza), si vedano soprattutto (con le relativebibliografie) WINKLER, ZEITLIN (1990); VERNANT, VIDAL-NAQUET (1991); BEL-TRAMETTI (2011).
44 Cfr. Pol. IV, 1299 b, 30-39; IV, 1298 b, 26-34; VI, 1323 a, 6-9.45 VIII, 67, 1-2. Dell’incompatibilità tra le informazioni fornite da quest’ul-
timo e quelle – più attendibili – registrate da Aristotele si è già accennato sopra.
MARMAI176
non poco le prospettive degli studiosi, almeno quanto la circostanza percui pochi anni dopo la nomina dei commissari ci sia stato un colpo dimano oligarchico: cucendo insieme i due avvenimenti col filo logico delpost hoc ergo propter hoc, molti si sono convinti che l’istituzione dei pro-buli sia stata la prima vera e propria mossa dei futuri capi dei Quattro-cento. Questo è falso, per più ragioni. Innanzitutto, si trattava di una mi-sura eccezionale sì, ma comunque prevista dalla politeia di Atene, e nel-l’ambito della polis attica i probuli avevano del resto poteri limitati alsolo oggetto del proprio mandato46, cioè la salvezza della città. Questo ècomprovato dal fatto che esistono prove documentarie di come la Bouleabbia continuato a riunirsi normalmente fino al 411, quando fu violen-temente estromessa proprio dai Quattrocento47. Accanto a questo, Tuci-dide è molto chiaro nel riferire di come l’idea della metabole sia balenatain mente ai congiurati solo dopo che Alcibiade si fu recato da loro aSamo nel tentativo di guadagnarsi un facile rientro in patria – cioè nonprima del 41248. Questo è un primo argomento utile per ‘scagionare’ icommissari dall’accusa di essere stati complici del regime.
Un’obiezione possibile è che Lisia rinfaccia esplicitamente adAgnone di aver favorito le trame dei cospiratori in qualità di probulo.Certamente non si può non mettere in conto l’intento persuasivo del di-scorso di un oratore, e dunque il rischio che le sue valutazioni sui singolisiano state opportunamente forzate; tuttavia, la possibilità che ci fosseun accordo sotterraneo tra alcuni commissari e Pisandro e compagni è,di per sé, tutt’altro che campata in aria. Alcuni commissari, però: giacchéfare del collegio dei probuli in toto un’appendice connivente (o addirit-tura corresponsabile) dei sovvertitori di Samo è un passo non necessario.Ritorniamo per un attimo alle parole di Aristotele49. Il filosofo scinde indue atti il complotto: in un primo tempo, dice, si tenne la seduta assem-bleare durante la quale Pitodoro di Anaflisto propose di aggiungere aidieci commissari già in carica (µ!"# "$% &'()&*'+,%"-% ./0*
46 Sulla questione si veda soprattutto ALESSANDRÌ (1990).47 Cfr. Thuc., VIII, 69. Pur non essendo molto numerosi, si possono citare
anche alcuni decreti, come ad es. IG I! 96 (412/11) che recano la formula intro-duttiva consueta per le delibere emanate dall’azione congiunta di Consiglio e As-semblea.
48 Cfr. Thuc., VIII, 47, 2. Si veda anche HEFTNER (2001).49 Ath. Pol., 29.
177SOFOCLE A COLONO: I FATTI DEL 411
!"#$#%&'() altri venti syngrapheis affinché si impegnassero tutti insiemea redigere delle proposte di legge utili alla città; queste proposte venneropoi presentate a Colono dalla suddetta commissione allargata, e in talesede si decise per l’abrogazione della democrazia. È fuor di dubbio chea questo collegio di trenta sia da imputare il favoreggiamento dei sov-versivi; ma, all’interno del nuovo gruppo, gli ex-probuli si trovavano innetta minoranza. Se davvero essi fossero stati sin da principio in com-butta con Pisandro e i suoi, che senso avrebbe avuto dilazionare contanta prudenza i tempi? Se i generali di Samo avessero potuto contaresull’appoggio incondizionato dei commissari, a che pro riassorbirli in uncorpo deliberante ampliato con nuovi elementi – questi sì di certo d’ac-cordo con i loro piani? O forse (e questa pare in effetti la soluzione piùconvincente) i congiurati temevano di non riuscire a trarre dalla propriaparte l’intero collegio dei probouli, e per questo preferirono ’diluirne’l’incontrollabilità grazie alla predominanza numerica di syngrapheis ap-positamente scelti?
Questi dieci saggi, cui Atene aveva affidato la propria salvezza, noncostituirono dunque un complesso omogeneo. Ma, all’interno di questavarietà di posizioni, dove è più opportuno collocare Sofocle?
Il succitato passo della Retorica, pur nella sua brevità, è molto elo-quente nel presentare il poeta in evidente contrasto con la linea di Pi-sandro50, però al contempo riferisce di come egli, a suo tempo, avessecomunque votato a favore delle proposte di quest’ultimo. Un ripensa-mento, dunque, un passo indietro quello riferito da Aristotele; ma do-vuto a cosa, ad una sincera contrizione o ad un opportunismo non di-verso da quello dei molti che, durante la rotta dei Quattrocento, si af-frettarono a dissociarsi prima che fosse troppo tardi?
Le parole di Sofocle, quel suo laconico «Non c’era un’alternativa mi-gliore», nella loro evidente autoindulgenza non illuminano in merito.Tutto il contrario, invece, per quanto riguarda la scelta di rappresentareuna tragedia come l’Edipo a Colono – un dramma ossessionato dal pro-blema della colpa. Naturalmente occorre trattare la materia con estrema
50 Non è chiaro, purtroppo, quale fosse il contesto nel quale lo scambio tra idue è avvenuto. Per le teorie più accreditate, si vedano soprattutto JAMESON
(1971), pp. 547-564; SHEAR (2011), pp. 60-61; UGOLINI (1998), p. 38; CANFORA
(2011), pp. 327-329.
MARMAI178
cautela, onde evitare di forzare il significato dei versi, ma è evidente cheil ‘motore immobile’ del processo di selezione e costruzione dell’estremaopera sofoclea sia stato il soffertissimo anelito ad una riflessione pro-fonda e misurata sulle responsabilità maturate nel corso di quegli ultimi,fatali anni dell’Atene democratica – responsabilità generali e individuali.Il poeta non si nega, né si pone come realtà trascendente rispetto allapolis, ma si cala pienamente in essa51.
Colono è la chiave di volta. Nella rosa delle varie tradizioni relativealla fine di Edipo52, il racconto del suo arrivo in Attica e della sua sepol-tura è stato sicuramente una variante regionale e secondaria, almeno finoalla consacrazione del teatro sofocleo53. Nonostante la sostanziale margi-nalità dell’episodio mitologico, il poeta sceglie di farne il nucleo di un in-tero dramma – e non solo, nel corso dell’azione egli vira con estremaforza verso il demo a discapito dell’Atene vera e propria, di cui solo letorri si vedono, di lontano54. Dunque cosa c’è alla base di un simile ma-
51 E ciò è naturale, considerando che il teatro greco era una forma d’arte co-munitaria, non personale. Il tragediografo aveva la possibilità di scegliere cosasottoporre al giudizio del demos, ma le tematiche presentate, i contrasti mostratiriguardavano il demos stesso, non l’intimità del poeta. Tuttavia il riconoscimentodi questa dimensione socio-politica del teatro antico a dispetto di quella – percosì dire – più intimistica non significa strappare le opere dalle mani di chi le hacomposte. Gli aspetti comunitari della tragedia non sono incoerenti con unaqualsiasi connessione biografica tra autore e dramma, e questo perché appunto iltragediografo stesso era in primo luogo un polites, un membro della comunità cuisi rivolgeva. La sua vita era condizionata dagli stessi fenomeni e risentiva dellestesse difficoltà che interessavano il suo pubblico.
52 Per le quali si veda EDMUNDS (1981), pp. 221-238; (1985), pp. 47-57;(1996), pp. 87-100. Cfr. inoltre MARKANTONATOS (2007), pp. 43-60.
53 L’unica altra menzione nota, se si eccettua il riferimento presente nelle Fe-nicie ai vv. 1703-1707, è quella riassunta da Androzione (FGH 324 F 62), cfr. ED-MUNDS (1996), p. 96.
54 La polis, è vero, viene spesso richiamata, ma resta in un perenne altrove.Per contro, il recinto sacro delle Eumenidi sembra essere stato trasferito dal-l’Areopago (Paus., I, 28, 6-7) al boschetto sacro coloniate; oltre a questo, al v. 58Colono è definita !"#$%µ’ &'()*), «baluardo di Atene» sulla falsariga della lodepindarica alla stessa Atene, +,,-./0 !"#$%µ1, «baluardo della Grecia» (Ditir.,framm. 76 [46]). Lo stesso Teseo, rappresentante dell’asty, è costretto a spostarsidi continuo, perché il fulcro dell’azione è lontano dalla reggia – né Edipo, di
179SOFOCLE A COLONO: I FATTI DEL 411
gnetismo, perché Colono? Perché nei suoi pressi la cavalleria atenieseera riuscita ad avere la meglio sui Tebani nel 407? Forse. Perché quelloera il demo natale di Sofocle? È plausibile. Perché è stato lì che, nel 411,alla presenza del poeta stesso, si era originata quella frattura nel corpocivico che era andata poi divaricandosi spaventosamente, facendo scivo-lare inesorabilmente Atene sempre più nel baratro? Analizziamo più davicino quest’ultima possibilità.
La parentesi dei Quattrocento non si è chiusa in modo indolore. Aldi là dei morti sacrificati ‘alla causa’, ci sono stati i processi, che – standoalle parole di Tucidide55 – coinvolsero molte persone, non solo i piùesposti rappresentanti del movimento oligarchico. Di questa «ondata»56
persecutoria oggi siamo in grado purtroppo di ricostruire molto poco,ma di una cosa si può essere certi: che il suo non fu un rapido deflusso57.
Il punto è che la caduta del regime non significò subito il ripristinodella democrazia precedente. La forma di governo assunta, la cosiddettafase intermedia dei Cinquemila, costituiva un compromesso che, nono-stante le lodi di Tucidide58, comportava l’esclusione politica di molti59, esoprattutto di molti tra coloro che servivano nella flotta. Il fatto che inpoco più di un anno la situazione si sbilanci di nuovo in favore dei radi-cali la dice lunga sulle pressioni che gli esclusi riuscirono ad esercitare:in fondo, nessuno poteva negare che le principali vittorie ateniesi conti-nuassero a dipendere dalle braccia dei rematori60. Quella restaurata è
fronte alla possibilità di trasferirvisi, si risolve ad abbandonare il luogo dov’ègiunto (vv. 638-646).
55 VIII, 68, 2.56 CANFORA (2011), p. 329.57 Ancora nel 405 – anno di rappresentazione delle Rane – Aristofane ac-
cenna al problema dei processi politici (vv. 687-702). Cfr. anche SHEAR (2011),pp. 60-67.
58 VIII, 97, 69-70.59 Concordo con RHODES (1972), pp. 115-127, e PESELY (1983), p. 98, nel
considerare tale esclusione assoluta. Contra DE STE. CROIX (1956), pp. 1-23, ilquale ritiene che a coloro che non rientravano nei Cinquemila fossero preclusesolo le magistrature e la partecipazione alla Boule.
60 A Cinossema, presso Sesto e poi presso Abido nell’estate del 411; l’annosuccessivo a Cizico – battaglia durante la quale si riuscì ad uccidere Mindaro, ilnavarco spartano, e a catturare l’intera flotta nemica.
MARMAI180
però una democrazia inquieta, che si sente minacciata dall’interno e chesi difende in modo estremamente aggressivo, a colpi di condanne illegit-time, esili, confische e perdita dei diritti civili61. Tale situazione vieneparzialmente risolta solo nell’autunno del 405, con l’approvazione del-l’amnistia proposta da Patroclide – e tuttavia il contrasto interno alla cit-tadinanza continua a macinare sospetto su sospetto, alimentando la dif-fidenza nei confronti di coloro che (realmente o anche solo ipotetica-mente) appaiono compromessi con i nemici pubblici. Questa forma didivisione ‘passiva’, più subdola e sotterranea, non sfocia necessariamentein attacchi espliciti e nondimeno pesa fin troppo sugli equilibri interni diuna comunità in crisi: di fatto, non esiste difesa possibile contro la cen-sura sociale. Il contrasto originatosi può solo aggravarsi, mai risolversi.
Questa era la condizione interna della già provata polis di Atenequando Sofocle compose l’Edipo a Colono. Ecco perché, per un’analisisocio-politica, il problema della reintegrazione dell’escluso si pone comequestione centrale all’interno del dramma; e tuttavia, come già spiegato,tale questione è indissolubilmente legata al problema della definizionedella colpa. La polis doveva ricomporsi: questo non doveva significareriaccogliere anche gli elementi irrimediabilmente corrotti, ma nemmenoeccedere in intransigenza, mutilandosi e privandosi di cittadini la cui re-sponsabilità non poteva essere paragonata a quella dei veri colpevoli,perché determinata da un’inconsapevole buona fede62, da forze mag-giori, perché per loro «non c’era un’alternativa migliore».
A tale scopo, nessun personaggio poteva rispondere all’appello me-glio di Edipo. Egli è imputato di crimini gravissimi, che non può negaredi aver compiuto; eppure, a dispetto delle sue colpe raccapriccianti,l’eroe cerca – e trova – piena grazia, sia tra gli uomini sia tra gli dèi.
Non stupisce, quindi, che Sofocle prepari per il suo protagonista bentre accorate apologie. Esse variano d’intensità, perché sono sempre in-dotte dall’incalzare di terzi, ma rimangono costanti nel contenuto: Ediposostiene e ribadisce di non essere degno di biasimo, perché nessuno deisuoi crimini è stato compiuto con dolo.
È interessante che la questione dell’omicidio e dell’incesto non siapresentata da un punto di vista meramente morale e filosofico, ma attra-
61 Si consideri ad esempio il decreto di Demofanto, di cui riferisce Andocide(1, 96-98).
62 Cfr. Lys., 20, 1.
181SOFOCLE A COLONO: I FATTI DEL 411
verso un’impostazione giuridica piuttosto evidente63, così come sono evi-denti i riferimenti all’effettivo codice penale in uso nell’Atene deltempo64, che prevedeva l’impunità per chiunque avesse ucciso qualcunoper difendersi, nel caso in cui fosse stato l’altro ad aggredire per primo65.Proprio a questa clausola si appella appunto Edipo66, per quanto – ri-spetto alla versione della morte di Laio presentata nell’Edipo Re – la suaricostruzione risulti un po’ forzata67. Ma più in generale, Edipo non sa-peva né poteva sapere chi fossero davvero suo padre e sua madre, e que-sto ha fatto sì che da potenziale colpevole egli sia diventato piuttosto unavittima della volontà altrui68.
Tale linea di difesa risulta efficace: dopo aver appreso la realtà deifatti, i vecchi di Colono – gli stessi che all’inizio si erano ritratti inorriditidi fronte a lui – esortano il loro re a difendere un uomo !"#$%&', «one-sto» e degno di essere aiutato. Teseo, del resto, già in precedenza gliaveva accordato il proprio favore, consentendogli di restare.
63 Cfr. vv. 547-548: ()* +," -./0' 12&.30$) ()* 453$)· / .&µ6 78 ()9)"&',-:7";' 1' %&7’ <59/., «Senza sapere ho colpito e ucciso: innocente per legge, senzasapere giunsi a quel passo» (corsivo mio).
64 Cfr. EDMUNDS (1996), pp. 136-138, che ricorda come proprio la legge diDraconte sull’omicidio fosse stata ripubblicata nel 409 dalla nuova democrazia:«Sophocles then […] says to the democracy: Oedipus can be forgiven under theterms of your own laws». Sulla questione della legge di Draconte, cfr. PEPE
(2012).65 Cfr. MACDOWELL (1978), p. 114.66 Vv. 270-273; vv. 991-999.67 Nella precedente tragedia, Edipo commentava la violenza perpetrata soste-
nendo che il vecchio che lo colpì alla testa «non pagò alla pari il suo gesto» (v.810: /= µ>. ?$#. +’ @%3;$3.). Ciò significa che Laio non aveva mostrato reali in-tenzioni omicide nei suoi confronti. Ma questo poco importa, perché con ogniprobabilità un tribunale di Atene (cioè di una società in cui l’onore poteva e do-veva essere difeso, anche al prezzo del sangue di un altro uomo) lo avrebbe as-solto in ogni caso. Inoltre Laio colpisce Edipo con uno staffile, non a mani nude:il suo gesto sarebbe stato considerato un trauma ek pronoias, cioè un ferimentointenzionale, la cui gravità era paragonabile a quello di un omicidio volontarioconsiderando che era un reato giudicato dall’Areopago, cfr. MACDOWELL (1978),pp. 123-124.
68 Vv. 521-523; vv. 962-990.
MARMAI182
Dunque come riassumere la spinosa questione della responsabilità diEdipo? Giuridicamente parlando, il protagonista di Sofocle ha colpa, manon è colpevole: non gli si può imputare dolo, perché totalmente ignarodi ciò che faceva e delle conseguenze che quegli atti avrebbero avuto69.Egli è stato piuttosto vittima dei piani e del volere altrui: non ha sceltodi nascere a dispetto di un oracolo, non ha attaccato Laio per primo,non ha preteso Giocasta70. Come dirà più tardi un altro notorio perso-naggio della scena, Re Lear, «I am a man / more sinn’d against than sin-ning»71: questa è appunto la realtà che Edipo descrive per sé72.
Dunque il protagonista della tragedia, il personaggio che più di ognialtro suscita empatia e benevolenza, è colui che – pur avendo commessoqualcosa di riprovevole – non merita biasimo. Non si può punire né mo-ralmente né giuridicamente chi agisce in buona fede, credendo di esserenel giusto. La colpa, che è soggettiva, rimanga una questione privata: ma alivello pubblico, e per di più nei momenti critici, i !"#$%&' vanno accolti,non cacciati; vanno aiutati, non aggrediti; vanno reintegrati, non puniti.
Stando all’episodio riferito da Aristotele nella Retorica, tale posizioneideale doveva stare particolarmente a cuore a Sofocle: il suo avallo alleproposte degli oligarchi aveva comportato conseguenze disastrose per lapolis, non solo nell’immediato di una guerra civile sfiorata, ma anchenegli anni successivi a causa dei residui di sospetto e diffidenza reci-proca. Non che la sua responsabilità sia mai stata oggetto di contesa intribunale: non pare infatti che ci siano state ritorsioni formali a suo
69 La questione dell’involontarietà di un comportamento – perfino nei casi diomicidio – dovuta ad ignoranza delle conseguenze del proprio gesto era, per gliAteniesi, tutt’altro che secondaria. Una donna che aveva somministrato ad unuomo una pozione d’amore la quale aveva finito poi per avvelenarlo fu proscioltaperché riuscì a dimostrare che non era a conoscenza della tossicità di ciò che gliaveva dato da bere, cfr. Arist., MM, 1189 b, 29-38.
70 Cfr. DIANO (1957), p. 42: «[Edipo] è colpevole di quella “colpabilità” che,come ha chiarito Heidegger dopo l’analisi fattane da Kierkegaard, è anteriore allasingola colpa operata e ne è la condizione [...]».
71 Atto 3, scena 2, vv. 60-61.72 Significativo, a questo proposito, è che tale attenzione al lessico giuridico è
completamente assente nell’Edipo Re, cfr. LANZA (1986), pp. 39-40: «Per il primoEdipo, l’intenzionalità delle azioni compiute non appare in alcun modo tratto si-gnificativo e qualificante».
183SOFOCLE A COLONO: I FATTI DEL 411
danno. Tuttavia non si può escludere che sia rimasto comunque vittimadi un muto risentimento, né che egli stesso abbia considerato quellascelta fatale come una macchia indelebile nella propria coscienza civica,consapevole del fatto che il favore di una persona stimata come lui avevaspinto senz’altro molti dalla parte degli oligarchi73.
Dunque – e con questo concludiamo – il quesito di partenza, il di-lemma sulle responsabilità reali e percepite di quell’annus horribilis, trovauna risposta concreta proprio tra le righe dell’ultima tragedia sofoclea. Laprospettiva dominante gli studi su quest’opera pare orientata a rovescio:secondo i più, Sofocle avrebbe ambientato il tutto a Colono per inerzia,perché il mito lo prevedeva. Ma a che pro scegliere proprio quel mito mi-sconosciuto, a fronte di centinaia di altre vicende improntate su un ana-logo schema di reintegrazione del reietto? A tale questione risponde laStoria: perché Colono è stato il luogo dove «the weakness and cowardiceof the radical democracy had been laid bare»74, e perché Sofocle stesso (aldi là di tutte le attenuanti che gli si possono concedere) è stato tra coloroche hanno messo a nudo tale debolezza, compiendo l’impresa di «privaredella libertà il popolo di Atene dopo circa cent’anni dalla cacciata dei ti-ranni»75 – un’impresa della quale doveva sentirsi ben poco orgoglioso ecui si può credere abbia tentato di porre rimedio rievocando sulla scenaper l’ultima volta lo sciagurato figlio di Laio.
Edipo a Colono, quindi, ma anche e soprattutto Sofocle a Colono,non a suggerire un’identità netta tra i due, ma un più complesso sistemadi riferimenti al mito del passato e all’Atene del presente. Sofocle a Co-lono, non solo in quanto demotes anziano che brama di tornare alla terrache l’aveva visto nascere, ma per indicare alla patria un luogo e un mo-mento chiave per la comprensione dei propri passi falsi e, di conse-guenza, del modo in cui procedere salda sul sentiero del proprio destino.
Udine SARA MARMAI
73 Cfr. PESELY (1983), p. 96, il quale identifica appunto in Sofocle uno di «co-loro che non si sarebbe mai creduto potessero convertirsi all’oligarchia» (Thuc.,VIII, 66, 5), contribuendo così a sconcertare il demos e ad indebolirne le difese.Secondo CALDER III (1985), pp. 1-14, interi versi scritti per Edipo sarebbero inrealtà un’autodifesa concepita dal poeta per scagionare sé stesso.
74 WILSON (1997), pp. 190-191.75 Thuc., VIII, 68, 4.
MARMAI184
Bibliografia
ALESSANDRÌ (1990) = ALESSANDRÌ S., I dieci probuli ad Atene. Aspetti giuridico-costituzionali, in G. NENCI, G. THÜR, Symposion 1988: Vorträge zur griechi-schen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Siena, Pisa, 6.-8. Juni 1988) (Köln-Wien 1990), pp. 129-147.
AVERY (1974) = AVERY H.C., Sophocles’ Political Career, «Historia» 22 (1974),pp. 509-514.
BEARZOT (1997) = BEARZOT C., Lisia e la tradizione su Teramene. Commento sto-rico alle orazioni XII e XIII del Corpus Lysiacum (Milano 1997).
BEARZOT, LANDUCCI GATTINONI (2010) = BEARZOT C., LANDUCCI GATTINONI F.,Storie di Atene, storie di Greci: studi e ricerche di attidografia (Milano 2010).
BELTRAMETTI (2011) = BELTRAMETTI A., La storia sulla scena. Quello che gli sto-rici antichi non hanno raccontato (Roma 2011).
CALDER III (1985) = CALDER W.M. III, The Political and Literary Sources of So-phocles’ Oedipus Coloneus, in W.N. CALDER III, U.K. GOLDSMITH, P.B. KE-NEVAN, Hypatia. Essays in Classics, Comparative Literature and PhilosophyPresented to Hazel E. Barnes on Her Seventieth Birthday (Boulder 1985), pp.1-14.
CANFORA (2011) = CANFORA L., Il mondo di Atene (Roma-Bari 2011).CARUSI (2003) = CARUSI C., Isole e peree in Asia Minore. Contributi allo studio dei
rapporti tra poleis insulari e territori continentali dipendenti (Pisa 2003).DE STE. CROIX (1956) = DE STE. CROIX G.E.M., The Constitution of the Five
Thousand, «Historia» 5 (1956), pp. 1-23.DIANO (1957) = DIANO C., Edipo figlio della Tyche. Commento ai vv. 1075-85
dell’Edipo Re di Sofocle I, «Delta» 10 (1957), pp. 33-44.EDMUNDS (1981) = EDMUNDS L., The Cults and the Legend of Oedipus, «HSPh»
85 (1981), pp. 221-238.EDMUNDS (1985) = EDMUNDS L., Oedipus: the Ancient Legend and Its Later Ana-
logues (Baltimore-London 1985).EDMUNDS (1996) = EDMUNDS L., Theatrical Space and Historical Place in Sopho-
cles’ Oedipus at Colonus (Lanham 1996).EHRENBERG (1958) = EHRENBERG V., Sofocle e Pericle (Brescia 1958). Titolo ori-
ginale: Sophocles and Pericles (Oxford 1957).FANTASIA (1986) = FANTASIA U., Samo e Anaia, in Serta Historica Antiqua (Roma
1986), pp. 113-143.FORNARA (1971) = FORNARA C.W., The Athenian Board of Generals from 501 to
404 (Wiesbaden 1971).
185SOFOCLE A COLONO: I FATTI DEL 411
HARDING (1993) = HARDING P., Androtion and the Atthis. The Fragments Tran-slated with Introduction and Commentary (Oxford 1993).
HEFTNER (2001) = HEFTNER H., Der oligarchische Umsturz des Jahres 411 v. Chr.und die Herrschaft der Vierhundert in Athen. Quellenkritische und historischeUntersuchungen (Frankfurt am Main 2001).
JAMESON (1971) = JAMESON M.H., Sophocles and the Four Hundred, «Historia»20 (1971), pp. 541-568.
KIRCHNER (1903) = KIRCHNER J., Prosopographia Attica, 2 (Berlin 1903).KRENTZ (1982) = KRENTZ P., The Thirty at Athens (Ithaca-London 1982).LANZA (1986) = LANZA D., Edipo rivisitato da Sofocle, in B. GENTILI, R. PRETA-
GOSTINI, Edipo. Il teatro greco e la cultura europea. Atti del convegno interna-zionale (Urbino 15-19 novembre 1982) (Roma 1986), pp. 27-44.
LEWIS (1955) = LEWIS D.M., Notes on Attic Inscriptions (II), «ABSA» 50 (1955),pp. 1-36.
MACDOWELL (1978) = MACDOWELL D.M., The Law in Classical Athens (London1978).
MARKANTONATOS (2007) = MARKANTONATOS A., Oedipus at Colonus. Sophocles,Athens and the World (Berlin-New York 2007).
MASTRONARDE (1994) = MASTRONARDE D.J., Euripides: Phoenissae (Cambridge1994).
MERITT (1959) = MERITT B.D., The Name of Sophocles, «AJPh» 80 (1959), p.189.
MERITT, WADE-GERY, MCGREGOR (1949) = MERITT B.D., WADE-GERY H.T.,MCGREGOR M.F., The Athenian Tribute Lists, 2 (Cambridge-Princeton1949).
PEPE (2012) = PEPE L., Phonos. L’omicidio da Draconte all’età degli oratori (Mi-lano 2012).
PESELY (1983) = PESELY G.E., Theramenes and Athenian Politics: a Study in theManipulation of History, Ph.D. diss. (Berkeley 1983).
RHODES (1972) = RHODES P.J., The Five Thousand in the Athenian Revolutions of411 B.C., «JHS» 92 (1972), pp. 115-127.
SHEAR (2011) = SHEAR J.L., Polis and Revolution. Responding to Oligarchy inClassical Athens (Cambridge 2011).
TRAILL (1975) = TRAILL J.S., The Political Organization of Attica. A Study of theDemes, Trittyes and Phylai, and Their Representation in Athenian Council(Princeton 1975).
TRAILL (1986) = TRAILL J.S., Demos and Trittys: Epigraphical and TopographicalStudies in the Organization of Attica (Toronto 1986).
TRAILL (2006) = TRAILL J.S., Persons of Ancient Athens, 15 (Toronto 2006).
MARMAI186
UGOLINI (1998) = UGOLINI G., L’immagine di Atene e Tebe nell’Edipo a Colonodi Sofocle, «QUCC» 60 (1998), pp. 35-53.
VERNANT, VIDAL-NAQUET (1991) = VERNANT J.P., VIDAL-NAQUET P., Mito e tra-gedia due. Da Edipo a Dioniso (Torino 1991). Titolo originale: Mythe et tra-gédie deux (Paris 1986).
WILSON (1997) = WILSON J.P., The Hero and the City. An Interpretation of So-phocles’ Oedipus at Colonus (Ann Arbor 1997).
WINKLER, ZEITLIN (1990) = WINKLER J.J., ZEITLIN F.I., Nothing to Do with Dio-nysos? Athenian Drama in Its Social Context (Princeton 1990).
WOODBURY (1970) = WOODBURY L., Sophocles among the Generals, «Phoenix»24 (1970), pp. 209-224.
187SOFOCLE A COLONO: I FATTI DEL 411