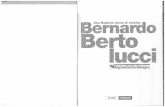Dolore e Giustizia tra mito e mistero: Edipo e Giobbe
Transcript of Dolore e Giustizia tra mito e mistero: Edipo e Giobbe
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 1 — #1 ii
ii
ii
Universita degli Studi di Verona
FACOLTA DI LETTERE
Corso di Laurea in Lettere
Dolore e giustizia tra mito e mistero: Edipo e Giobbe
Candidato:
Zocca ValeriaMatricola VR091965
Relatore:
Ch.mo Prof. Guido Avezzu
Anno Accademico 2011/2012
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 3 — #3 ii
ii
ii
Indice
1 L’Edipo Re sofocleo e Il libro di Giobbe: trama simile 7
2 Struttura genetica: opere aperte 9
2.1 Giobbe nella Mezzaluna fertile 9
2.2 Il mito di Edipo dalle prime testimonianze scritte 10
3 Collocazione cronologica 13
3.1 Il libro di Giobbe 13
3.2 L’Edipo re 13
4 Genere letterario 15
4.1 L’Edipo re sofocleo, una tragedia 15
4.2 Giobbe: mescolanza di generi letterari? 15
5 Dolore e giustizia, tra mito e mistero 21
5.1 Il mistero del dolore in Giobbe 22
5.1.1 Quando le parole non bastano. . . 23
5.1.2 Crisi della comunicazione tradizionale 24
5.2 La contraddizione dell’uomo: Edipo 25
5.2.1 Una contraddizione a più livelli 26
5.2.2 Crisi della parola 28
6 Forme di conoscenza 31
6.1 Edipo re 31
6.1.1 La Sfinge 32
6.1.2 Forme di conoscenza nell’Edipo re 33
6.2 Giobbe: logica umana e sapienza divina 36
7 Conclusione 39
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 5 — #5 ii
ii
ii
Introduzione
Edipo e Giobbe. Due diverse culture, due visioni differenti della vita,due caratteri, due storie. Eppure in loro possiamo leggere molto: sonodue uomini che, messi di fronte al problema del dolore, cercano in tuttii modi una soluzione, cercano di capire.
Di fronte al male innocente, a una colpa involontaria, non sopportanoin silenzio, ma urlano, cercano, indagano, fanno tutto il possibile pergiungere infine a sapere. Sapere che si rivelerà da un lato distruttivo per ilsuo detentore, che alla fine si accecherà; dall’altro invece assolutamentepositivo perchè condurrà a una nuova visione di Dio, alla speranza ealla completa fiducia nel piano divino.
Non solo: hanno in comune anche
L’ambiguità del dio, sia di quello che dice e non dice, che di quello che non si fa maitrovare laddove ci si aspetterebbe che fosse. Forse sono figure diverse di un medesi-mo immemorabile archetipo: l’emigmaticità del mondo; di un medesimo dramma:l’esperienza della scissione. Nella loro diversità, ci indicano, allora, un medesimoineludibile compito: come reggere alla crisi, come fronteggiare la problematicitàdel reale senza perire. È un rischio cui siamo da sempre e per sempre esposti e ilcompito è senza fine. Edipo e Giobbe dicono molto di noi e per questo ci parlanoancora.1
1 Salvatore Natoli (2008), Edipo e Giobbe. Contraddizione e paradosso, Morcelliana, pag. 7.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 7 — #7 ii
ii
ii
1 L’Edipo Re sofocleo e Il libro di Giobbe:trama simile
Due racconti simili che risalgono alla notte dei tempi, due storie cheparlano del dramma umano del dolore e, di fronte all’interrogativoesistenziale sul perché della sofferenza umana, giungono a due esiticompletamente differenti. Giobbe ed Edipo vivono nella loro terra, ri-vestono un ruolo importante, sembrano aver raggiunto una situazionetranquilla e prospera. A rompere quest’armonia sopraggiunge un mor-bo, che ha tutti i sintomi di quella che noi oggi chiamiamo peste e cherovina ogni cosa. Nel momento in cui ogni rimedio umano fallisce, siricorre sempre a una spiegazione divina. Per conoscere chiaramente ilmotivo per cui il morbo continua a colpire, Edipo chiede una rispostadivina: manda Creonte all’oracolo di Delfi; anche Giobbe cerca unarisposta presso Dio; lo raggiungono tre suoi amici, maestri e teologi chegli espongono le loro teorie relativamente alle cause del morbo: anzichéconsolarlo, chiedono che si penta dinnanzi a Dio per una colpa chedeve aver sicuramente commesso contro di Lui. Anche Creonte rivelaa Edipo che a Tebe vi è un uomo che ha commesso una colpa tale percui il dio ha mandato la peste. In entrambi i casi, la malattia sembraessere una risposta del dio alle colpe umane, secondo l’antica logicaretribuzionista.
Qui la prima differenza: Giobbe vive un dolore innocente, Edipo unacolpa involontaria; ma entrambi si dichiarano (e sono) innocenti; noncapiscono il motivo del dolore che li affligge, dunque danno inizio auna serie di discorsi e indagini per comprendere. Sono entrambi allaricerca della vera conoscenza. Edipo, alla fine, sa. E proprio perché sa,sa che è meglio non sapere - per usare un’espressione di Joseph Conradin Cuore di tenebra. Edipo vuole infatti colpire quell’organo che dellaconoscenza è il simbolo, gli occhi: si acceca, lui che con gli occhi nonha saputo vedere. 1 Anche Giobbe giunge a conoscere, ma la sua è unaconoscenza di Dio che viene da Dio stesso, ben diversa dalla conoscenzailluminista dei fatti, che aveva Edipo. L’una riguarda l’uomo da unpunto di vista razionalista, l’altra riguarda il divino da un punto divista teologico. Giobbe alla fine verrà ricompensato per la sua fede,
1 Chiaramente stiamo prendendo in esame solo la versione sofoclea dell’Edipo re. QuiEdipo non considera una scusante l’involontarietà dei suoi crimini: ha ucciso Laio senzasapere che fosse suo padre, ha sposato Giocasta senza sapere che fosse sua madre.Ma, ciò nonostante, si punisce accecandosi. Nell’Edipo a Colono, invece, dichiara: io nonposso essere biasimato, perchè «subii, non volendo, uccisioni e nozze e sventure»: inme non esiste «macchia di colpa». Nel tempo ha maturato l’idea che solo chi ha agitovolontariamente è colpevole e responsabile delle sue azioni.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 8 — #8 ii
ii
ii
8 Capitolo 1
con una prosperità maggiore di quella che aveva all’inizio e con unacomprensione maggiore di Dio.
Dunque due forme di conoscenza opposte, ma facce della stessamedaglia. Tuttavia in entrambi i casi, anche se si conosce, non c’èsoluzione rispetto al problema del dolore: esso resta un mistero, ilmistero della vita umana. Edipo ne costata semplicemente l’esistenzanella realtà (Sofocle, Edipo Re, vv. 1528-1530):
Nessun mortale, se si guarda all’ultimo giorno, è dato reputare mai felice, primache senza sofferenza varchi quel supremo limite.
Anche Giobbe, nonostante abbia conosciuto il vero volto di Dio, tuttavianon ha ricevuto nessuna spiegazione relativamente alla sofferenza; glirimane solo la consapevolezza che il dolore rientra nel disegno divino enon è compito dell’uomo, né è a lui concesso, indagarne i motivi.
Comprendo che tu puoi tuttoe che nessun progetto per te è impossibile.Chi è colui che, da ignorante,può oscurare il tuo piano?Davvero ho esposto cose che non capisco,cose davvero troppo meravigliose per me, che non comprendo.Ascoltami e io parlerò,io t’interrogherò e tu mi istruirai!Io ti conoscevo solo per sentito dire,ma ora i miei occhi ti hanno veduto.2
2 Gb, 42,2-5.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 9 — #9 ii
ii
ii
2 Struttura genetica: opere aperte
E’ impossibile stabilire il nucleo di partenza di un mito; [. . . ] il significato di unmito non sta nel suo valore primigenio, ma nella sua capacità di assumere significatie di mutare forma, epoca dopo epoca, pur rimanendo lo stesso racconto.1
Ciò che ci deve interessare soprattutto non è tanto capire quando perla prima volta venne narrato un mito, ma come si è sviluppato e hapreso forma nel corso del tempo, in quali luoghi e soprattutto con qualisignificati.
Per quanto concerne i nostri due racconti, siamo di fronte a testiindubbiamente molto antichi. La storia di Giobbe, nella sua strutturapiù elementare, nacque da un folk tale che ebbe gran diffusione nelVicino Oriente; Edipo compare nella letteratura greca circa nell’VIIIsecolo a.C., nei poemi omerici, ma sarebbe ingenuo non pensare che,come il resto del patrimonio mitico antico, circolasse oralmente già datempo.
2.1 Giobbe nella Mezzaluna fertile
È possibile ritrovare il nucleo originario della storia di Giobbe in variealtre narrazioni che si sono sviluppate nel corso dei secoli nell’areageografica della Mezzaluna fertile: innanzitutto in Egitto, nel «Dialogo diun suicida con se stesso» e «Proteste di un fellah loquace». Sono raccontiin cui la struttura ideologica è la stessa: felicità- infelicità-lamento- felicità,anche se la trattazione del male riceve un trattamento semplicistico: ilmale nella vita è un destino invincibile e, nel secondo testo, esso haorigine nell’ingiustizia sociale. La soluzione a ogni impasse è solo lasperanza della vita eterna.
Nell’ambiente mesopotamico ritroviamo «L’uomo e il suo dio», testosumerico del 2000 a.C. Nel mondo teologico mesopotamico il destinodell’uomo e della storia è regolato da un determinismo assoluto; l’uo-mo è dominato dall’impero del dio supremo, ma è anche un protettodal suo «dio personale» che gli permette un minimo di autonomia. Inquesto testo, un uomo si lamenta aspramente della sua miseria causatadall’irritazione del suo dio protettore. Il dio protettore era una figuraintermediaria tra l’uomo e il pantheon celeste. Il lamento alla fine haesito positivo: il dio, udendolo, esorcizza il demone che opprime l’o-rante. Un’altra fonte mesopotamica, un poemetto babilonese del 1500
a.C. giunto a noi in una redazione del VII sec. a.C., era un canto diringraziamento per la liberazione da un male; il titolo è costituito dal
1 Maurizio Bettini e Giulio Guidorizzi (2004), Il mito di Edipo, Einaudi, pag. 64.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 10 — #10 ii
ii
ii
10 Capitolo 2
primo versetto: «Ludlul bel nemeqi» («Voglio celebrare il signore dellasapienza»). La trama parla di un uomo di alto rango caduto improv-visamente in disgrazia e abbandonato dagli dei. Nei suoi sogni gliappaiono due uomini e una donna che, con incantesimi, lo guarirannoe lo faranno riconciliare col dio-principe per i babilonesi: Marduk. Iltema centrale è l’interrogativo sugli incomprensibili disegni degli dei.
A Qumran anche questo testo ha attirato subito l’attenzione deglistudiosi di Giobbe: la cosiddetta «Preghiera di Nabonide» di originearamaica, databile attorno al V sec. a. C.. Nabonide, ultimo re dell’im-pero neobabilonese, eleva una preghiera a dio dopo esser stato colpitodalla malattia. Solo dopo il pentimento, il dio gli concederà la salvezza.Nabonide innocente viene colpito come Giobbe da una malattia che loisola da tutto il suo popolo. Egli si trova nell’oasi di Teman, da dove tral’altro arriva Elifaz, l’amico di Giobbe. La limitatezza della narrazionedi Nabonide non può far pensare a un’influenza diretta su Giobbe, mafa pensare all’esistenza di una «forma» letteraria comune, sia a livellofolkloristico, sia a livello colto.
I paralleli esaminati fin qui non possono esser considerati fonti direttedell’opera biblica ma ne costituiscono quasi la paleontologia. Sul pianodella struttura essi ci rivelano che il monologo e il dialogo sul temadella sofferenza datano in pratica dagli esordi stessi della scrittura (c.ca3000 a.C. a Sumer e in Egitto). Già dagli inizi è in vigore lo schemaprologo-epilogo in prosa e lo schema ternario di nove interventi. Vi è lapresenza di un interlocutore-obiettore e una presenza divina finale erisolutrice. Anche a livello ideologico vi sono questi punti in comune:
• il male proviene dal peccato secondo lo schema di una retribuzioneindividuale;
• il male è intrinseco all’essere creato ed è parte del destino umano;• la felicità degli ingiusti avrà una retribuzione differita;• la vita dopo la morte è la forma perfettamente equilibratrice di retribu-
zione differita.• la sapienza divina è troppo trascendente e incomprensibile perché
l’uomo la possa giudicare o criticare.
L’originalità dell’opera biblica consiste nel porre il problema unicamentesul piano morale e teologico, non su quello rituale - magico. La teofaniafinale non rappresenta l’intervento di un deus ex machina come nelracconto popolare, ma una proposta per stimolare la fede, la ricerca delvero volto di Dio.
2.2 Il mito di Edipo dalle prime testimonianze scritte
Gli spettatori conoscono la trama prima ancora che la tragedia incominci. DicoEdipo, e quelli tutto il resto già lo sanno: Laio il padre, Giocasta la madre, queste lefiglie, questi i figli, il suo destino, il suo passato. . . 2
Quando si parla di Edipo, noi moderni tendiamo subito a pensare alprotagonista della tragedia sofoclea, il personaggio roso dall’ansia diconoscere le sue origini, di capire chi è e quali relazioni ha intessutocon chi gli sta attorno. Ma questa è solo una delle due facce dell’Edipo
2 Antifane, (Fr. 189 Kassel – Austin).
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 11 — #11 ii
ii
ii
Struttura genetica: opere aperte 11
antico, quella drammatica, modellata per il teatro dalla tragedia, laquale trasformò gli eroi tradizionali del mito in personaggi complessi etormentati. Ma «le versioni più antiche del mito non dicono nulla delsuo dramma interiore, dell’orrore della scoperta e dell’abisso in cui egliprecipita sulla scena tragica. [. . . ] La disperazione dei personaggi e laloro miseria furono una conquista della tragedia».3
L’Edipo che esisteva in precedenza, nel patrimonio mitico dell’anticaGrecia, rappresenta invece l’altra faccia dell’eroe, quella “epica”. Infattiritroviamo la prima testimonianza scritta del mito di Edipo nell’XI cantodell’Odissea. Odisseo, recatosi a visitare i morti, dopo aver incontratol’ombra della madre, vede passare sui prati dell’Ade una serie di eroinedal passato (vv. 271-80):
E vidi la madre di Edipo, la bella Epicasta,Di un atto nefando colpevole:Cieca di mente fu sposa del figlio,Che ucciso aveva suo padre, e si prese la madre:Ben presto gli dei agli uomini lo resero noto.E dopo le nozze fu noto l’orrore.Egli nella molto amata Tebe, da immensoDolore piegato, regnò sui CadmeiPer funesto volere dei numi.Essa, un laccio legato all’alto soffitto,All’Ade inflessibile, che serra la porta,Oppressa d’angoscia discese, lasciandoAl figlio e marito affanni infinitiQuanti ne danno ai mortali le Erinni materne.
«Parricidio e incesto facevano già parte del racconto, come pure il suici-dio della madre-sposa, anche se in questo caso la donna si chiamavanon Giocasta, ma Epicasta». 4 Si noti che Omero non narra di even-tuali figli nati dall’incesto con la madre. Secondo l’Edipodia antica e ilmitografo Ferecide di Atene (inizio V sec. a.C.) Edipo ebbe figli soloda un successivo matrimonio con Euriganeia. Altri autori riportanodiverse tradizioni genealogiche di Edipo, come Stesicoro (“Papiro diLille”), Pindaro (Olimpica, II, 39-53) ed Esiodo (Opere e Giorni, 161-65).
Questo Edipo epico sembra seguire i codici della morale arcaica per la quale ciòche gli dei mandano, bene o male che sia, bisogna accettarlo come una componenteinevitabile della propria Moira, la parte che ciascuno ha avuto, nascendo. Ciò cheper Sofocle è contaminazione, una macchia intollerabile per un uomo e la sua città,in Omero sembra essere un capriccio oscuro del caso, non tale, però, da determinarequella vendetta di orrore che rende impossibile la permanenza di Edipo nella cittàdi cui è sovrano. La regola dell’espulsione del contaminato non opera ancora inOmero, dove Edipo è tutt’altro che [. . . ] un capro espiatorio.5
Dunque una delle principali differenze tra la versione omerica e quellasofoclea è che «l’Edipo epico» continua a regnare su Tebe, seppuresegnato dalla sventura; per quanto riguarda l’accecamento invece èmolto probabile che fosse ignoto al mito: un re cieco era consideratouna sorta di mostruosità, Edipo non avrebbe proprio potuto continuarea esercitare il potere sulla città, se menomato; inoltre, in seguito allasua morte furono celebrati meravigliosi giochi funebri, come onoranzaper il defunto; quindi doveva godere ancora perlomeno di una discretareputazione.
3 Bettini e Guidorizzi (2004), pag. 56.4 Ivi, pag. 65.5 Ivi, pag. 68-69.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 12 — #12 ii
ii
ii
12 Capitolo 2
Portare l’accento sulla novità drammaturgica della cecità di Edipo non basta achiarire quanto sia radicale l’invenzione sofoclea: [. . . ] con la scelta che Edipo siaccechi con le proprie mani [. . . ] Sofocle consegna alla cultura occidentale l’archetipodel soggetto che si interroga su se stesso e infine punisce l’organo della conoscenzache tante imprese gli ha consentito, ma non di vedersi davvero e di conoscere lapropria storia.6
6 Guido Avezzù (a cura di) (2008), Edipo. Variazioni sul mito, Marsilio.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 13 — #13 ii
ii
ii
3 Collocazione cronologica
3.1 Il libro di Giobbe
Per la complessità strutturale del libro di Giobbe, è necessario premette-re qualche breve considerazione: esso non è frutto di un’unica stesura,ma probabilmente numerose furono le mani che rividero, aggiunsero,modificarono il testo, fino a consegnarci quello che oggi noi leggiamo.La cornice del racconto, in prosa, è la parte più antica e, come giàspiegato precedentemente, ha i suoi antenati in testi mesopotamici edegizi; la sua composizione merita una datazione pre-esilica, anche senon mancano alcuni ritocchi, come la figura di Satana. Per il corpuscentrale poetico, dopo aver esaminato i vari elementi, si può concludereche il terminus a quo sembra essere il testo del profeta Geremia, colquale Giobbe ha legami di dipendenza; quest’ultimo, secondo l’ipotesimaggiormente condivisa dagli studiosi, sarebbe stato composto in Giu-dea nel V a.C. «Il terminus ad quem invalicabile è, invece, il 190 a.C., cioèl’epoca di stesura del Siracide, che in 49,9 cita appunto l’opera di Giob-be».1 Possiamo in definitiva concludere che il corpus poetico centralesia stato composto attorno al IV secolo a.C., dopo l’attività riformatricedi Esdra. Il c. 28 dovrebbe esser frutto della sapienza tardiva (come Pr.cc. 1-9); gli interventi di Elihu sono posteriori al 400 a.C.
3.2 L’Edipo re
Per la collocazione cronologica dell’Edipo Re, siamo di fronte a unaquestione ancora aperta. «L’arco delle ipotetiche cronologie va dal 436
ovvero 434 ovvero 433, al 411, in concomitanza col regime dei Quattro-cento, con un’ovvia predilezione per gli anni della peste che dal 430
in due ondate colpì l’Attica».2 In realtà, il riferimento alla reale pesteateniese non è così scontato sia perché il modello di peste a cui Sofoclefa riferimento non è quello tucidideo, ma quello dell’esordio dell’Iliade,sia perché i tragici evitavano di portare in scena temi contemporanei,per non ridestare le sofferenze presenti, negli spettatori. Anche argo-menti di carattere filologico fanno propendere in definitiva per unarappresentazione negli anni 413- 411.
1 Gianfranco Ravasi (1979), Giobbe, Edizioni Borla, pag. 28.2 Tobia Zanon, Gli autori e i testi, in Avezzù (2008).
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 15 — #15 ii
ii
ii
4 Genere letterario
Dopo aver messo in risalto il fatto che i due testi, almeno nella loroforma originaria, sono racconti popolari, miti, vicende in qualche mo-do note e poi successivamente ampliate o modificate da vari autorisuccessivi, che ora ne hanno messo in risalto un aspetto, ora un altro,vorrei soffermarmi adesso ad analizzarli secondo il genere letterario acui appartengono.
4.1 L’Edipo re sofocleo, una tragedia
L’Edipo re di Sofocle è indubitabilmente una tragedia, un mito riscrittoper la scena ateniese del V secolo, con alcune innovazioni rispetto alracconto originario. Nella sua forma presenta tutte le parti costitutivedi un dramma tragico: un prologo, la parodo, la rhesis, le sticomitie,l’amebeo, l’esodo; parlando di personaggi scenici potremmo invecenominare gli attori e il coro. Chiaramente non è mia intenzione proporreun’analisi dettagliata dell’Edipo re, né tanto meno delle parti costitutivedi una tragedia. Vari altri studiosi si sono occupati di questo, primo fratutti, Aristotele, che indicò proprio l’Edipo re, come il dramma tragicopiù riuscito.1 Io mi limito a ripetere ciò che ormai risulta un’ovvietà:l’Edipo re sofocleo è una tragedia, con tutto ciò a cui questo terminerimanda.
4.2 Giobbe: mescolanza di generi letterari?
Per quanto riguarda il libro di Giobbe la questione è più controver-sa. Gianfranco Ravasi sostiene che sia troppo limitativo vedere in untesto così ricco e complesso, l’influenza di un solo genere letterario,ma propone, come lo studioso G. Fohrer, di leggere l’opera come unarcobaleno letterario: l’autore avrebbe scelto una tavolozza di colorimolto varia, secondo le varie situazioni del dramma. Si potrebbe leggereil libro come un dibattito giudiziario, come una disputa tra saggi, comeuna supplica salmica, come un inno o come una tragedia greca. Inparticolare quest’ultima chiave di lettura risulta interessante ai nostriocchi, soprattutto alla luce del confronto che stiamo facendo con l’Edipore. Per una chiara analisi del testo, è assai utile premettere e ricordarealcune informazioni: come già esposto, il libro di Giobbe è frutto di piùmani, che in epoche diverse hanno ampliato il racconto originario finoa consegnarci ciò che noi oggi leggiamo. Il prologo - epilogo altro non
1 Per una conoscenza generale sulla rappresentazione tragica ateniese del V secolo, sulletecniche drammatiche e sulla struttura di una tragedia, si veda Di Marco (2009).
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 16 — #16 ii
ii
ii
16 Capitolo 4
è che quell’originario folk-tale, noto in tutto il Mediterraneo orientale,dall’Egitto alla Mesopotamia sin dal III millennio a.C. La parte centraleinvece, quella dialogica e in versi, viene datata circa al IV sec. a.C..
Dunque sia l’Edipo re, che Il libro di Giobbe nascono da un raccontopopolare e vengono ampliati e sistemati in forma di dialogo nel IV sec.a.C. È importante notare che in tutto l’Antico Testamento non troviamo,oltre a Giobbe, molti libri con una struttura discorsiva così imponente alloro interno; tra i pochi altri esempi troviamo ad esempio il Cantico deiCantici e i Salmi, ma il potenziale drammatico in Giobbe è indubitabilee pressoché unico. In questo contesto è interessante la teoria sostenutadal filosofo H. Kallen in The book of Job as a greek tragedy restored, pub-blicato nel 1918. Egli ha provato a riconoscere nel libro di Giobbe unarestituzione ebraica di una tragedia greca. La teoria appare interessantesoprattutto se consideriamo alcune premesse. Sin dall’antichità i popo-li affacciati sul Mediterraneo orientale intrattenevano tra loro scambicommerciali.
It has increasingly come to be realized that the Neolithic age was already characte-rized by the existence of far- reaching trade networks, by which coveted mineralsand other commodities were conveyed across hundreds of thousands of miles bysea or over land.2
Questi furono sospesi circa nel XIV, XIII millennio, quando iniziò unperiodo d’insicurezza e violenza dovuto all”attacco di vari popoli nord-occidentali in tutto il bacino dell’Egeo.
This quarter-millennium of thriving international exchange dissolved into a pe-riod of violence and insecurity that spanned the end of the thirteenth and thefirst decades of the twelfth century and changed the political map of the easternMediterranean.3
Gli scambi commerciali ripresero nel IX sec a.C. quando
The volume of commerce between Greece and the Levant was growing steadily.From a little before the middle of the eight century a marked acceleration isobserved.4
Segni di influenza reciproca tra mondo giudaico e mondo greco sonoinconfutabili: si possono trovare non solo grazie a testimonianze archeo-logiche relative alle relazioni commerciali, ma anche nell’arte - si pensial periodo cosiddetto «geometrico», allo stile definito orientalizzante -nei prestiti linguistici e nella somiglianza di molti altri elementi culturalie religiosi. A noi ora principalmente interessa l’aspetto letterario e Westnon manca di sottolineare anche questo dicendo che
A part from Mesopotamian material, we have encountered a remarkable numberof parallels to early Greek literature in the Old Testament, especially in the semi-legendary accounts of eleventh- and tenth- century ’history’ and in the poetry ofthe Psalms and the Prophets.5
Ci stiamo avvicinando alla questione essenziale: costatato che i contatti ele influenze reciproche tra i due popoli sono evidenti nel periodo arcaico,nulla ci fa escludere che questi siano proseguiti nel corso dei secoli, fino
2 Martin Litchfield West (1997), The east face of Helicon, Oxford: Clarendon Paperbacks, pag.4.
3 Ivi, pag.7.4 Ivi, pag 9.5 Ivi, pag.587.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 17 — #17 ii
ii
ii
Genere letterario 17
al IV, momento di sviluppo massimo della tragedia greca. West è riuscitoinfatti a riscontrare alcuni paralleli tra Eschilo e il mondo orientale,in particolare per quanto concerne la caratterizzazione nuova che iltragediografo diede a Zeus, troppo simile in numerosi elementi allateologia orientale, per poter passare come semplice coincidenza. ConSofocle ed Euripide la tragedia ebbe ancora maggior diffusione, e conl’ellenizzazione del bacino del Mediterraneo orientale, venne esportataovunque. Anche dopo aver perso in forza, dopo il suo periodo d’oro, lerappresentazioni tragiche continuarono e, ai concorsi drammatici, unapiccola parte era sempre riservata alla messa in scena di una tragediaappartenente a uno dei tre grandi maestri, Eschilo, Sofocle ed Euripide.In particolare quest’ultimo era molto gradito, il suo successo fu sempregrande non solo tra gli spettatori, ma anche tra i maestri di scuola, chetraevano dai suoi drammi, modelli didattici di poesia.
From his works the Hellenistic teachers chose their models of tragic poetry; hiswork it was they edited for ordinary reading in schools. Vase painters and actors ofpantomime selected their themes from it. Even six hundred years after his deathit was performed, and before enthusiastic audiences. His example set style, themeand form for tragedy so long as the ancients wrote it. [...] In truth, at the beginningof the fourth century Euripides is known and played wherever Greek communitiesare to be found; by its end he is the only member of the ancient trinity whose workstill holds the stage and holds it not only as a part of the regular repertory, but as afavorite in the theatre, so much so that the tragedies of his imitators cannot rival hisin popular regard.6
Kallen insiste, nel suo studio, sulla grande popolarità raggiunta da Eu-ripide perché a suo avviso, il libro di Giobbe avrebbe tratto ispirazioneproprio dai suoi drammi. Infatti
Now it was during the reign of this Ptolemy that the Jews of Alexandria discoveredthat they had become so Hellenized in speech as to need a Greek version of theirholy writ. According to the legend it was his patronage that initiated the miraculousSeptuagint which is the traditional beginning of Judæo-Greek literature. In point offact, the Septuagint was probably the last step in a series of translations that hadbeen needed and initiated many generations earlier, and that point to a century-long acquaintance with Greek speech, and by implication with Greek life and art.The coincidence of this indication of the complete Hellenization of AlexandrianJews, in speech at least, with the most brilliant period of the Alexandrian dramais significant. Willy-nilly, the Jews must for generations have seen the processions,the performances, the competitions; willy-nilly, they must have been impressed andfascinated and eager for more, so much so that in another generation they have atleast one tragedian of their own, who writes tragedies about their own legendaryheroes, and according to Euripidean standards of form.7
Un esempio di questo è Ezechiele di Alessandria, un tragediografoellenistico, che scrisse una tragedia ispirandosi al libro dell’Esodo. Con-siderarlo l’unico esempio di una produzione ellenistica che è statainfluenzata da quella ebraica, sembra un’ipotesi che, quanto meno, vacontro le probabilità, soprattutto se consideriamo quanto detto in pre-cedenza sui contatti e i paralleli riscontrati tra le due civiltà in epocheprecedenti a questa. La tesi di Kallen prosegue da qui, sostenendo chela parte dialogica del libro di Giobbe sia dovuta a un’influenza greca.
In all, by including the prose prologue and epilogue, no less than seven differenthands are thus traceable in the Book of Job. Nevertheless, there is in the booka certain unity not seen in any other. Now this unity is indubitable. The Greek
6 Horace. M. Kallen (1918), The book of Job as a Greek tragedy restored, Moffat, Yard, p. 20-21.7 Ivi, p. 22.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 18 — #18 ii
ii
ii
18 Capitolo 4
influence is, I think, also beyond question. But this influence is, in my opinion, theinfluence neither of Plato nor of Æschylus; it is the influence of Euripides. And thisunity is not an extraordinary accident, but the outcome, in the poetic total of Job, ofa rigidly adhered to plan of composition. This plan I believe to be the typical one ofthe Euripidean tragedy, modified by the literary tradition and spiritual quality ofthe Jewish race into something new and different. In a word, we have in the Bookof Job as it has come down to us, a Hebraized form of the Greek tragedy, withwhat may be the beginning and end of the legend or novel on which the dramawas based attached to it, perhaps unchanged, perhaps altered to suit the necessaryfunctions of prologue and epilogue they so obviously serve.8
L’autore del libro di Giobbe, venuto in qualche modo a contatto ea conoscenza del genere tragico, lo trovò particolarmente adatto peresprimere ciò che poi ritroviamo nel libro di Giobbe: dubbi, accuse,dolore, abbandono. Probabilmente usò l’antica leggenda popolare comecornice del nuovo testo e vi aggiunse un corpus centrale dialogico,adattandolo alla forma della tragedia greca.
Thus, like the Greek tragedies, Job consists of the dramatic treatment of an ancientlegend. It has a prologue which tells as swiftly and deftly as the Euripidean prologueall that precedes the opening of the action. It gives the orthodox preliminary versionof the legend. That its form is prose, even the very prose of the ancient writtenlegend, offers no difficulties. For, beside the swifter and profounder verse of thedramatic dialogue, the Euripidean prologues also must in utterance have had theeffect of prose, particularly to foreign hearers. The poet could well have let thisportion of the legend stand unchanged as prologue, and did. After the prologuecomes the drama itself. It is complained that nothing happens. But from the poet’spoint of view the dialogue is the happening; it culminates in the challenge ofthe justice of God. In form it has the characteristics of the Euripidean agon. Thespeeches are set, argumentative, and however tense with emotion, always withinthe bounds of the literary methods of the «wisdom books».They are in verse, almostexclusively tetrastichs, and there are four speakers who argue in succession, likeHelen and Hecuba before Menelaus.9
Dunque un prologo - epilogo in prosa, ripresa dell’antico raccontopopolare e un corpus centrale dialogico in versi. Ma certamente unatragedia non si può ridurre a questi due semplici elementi. Si puòribattere a questa tesi, come ha fatto Ravasi, sostenendo che
La proposta riconosceva una qualità genuina del testo di Giobbe, cioè la strutturadialogica e dinamica, ma ignorava la complessità delle singole porzioni dell’operairriducibili a un semplice spartito drammatico.10
Ravasi legge nel testo più di una tragedia, ma anche un dibattito giu-diziario, un inno, una supplica salmica, una disputa tra saggi. Ma aben pensarci, cos’è il genere tragico se non tutto questo? Esso contienecertamente orazioni giuridiche, preghiere, suppliche, scontri verbalitra sapienti... La tragedia in sé contiene tutti gli altri generi perché, sequesti ultimi sono specifici di un particolare ambito e momento dellavita umana, la tragedia rappresenta in pieno l’esistenza, in tutte le suemanifestazioni. Apparentemente tuttavia, nel libro di Giobbe mancauna parte essenziale della struttura tragica: il coro. In realtà Kallenriesce a riconoscere ben tre parti corali nel libro, che si differenzianodalle altre dialogiche per metro e/o tema. Sappiamo che le parti coralidividevano i drammi in atti, generalmente in un numero che si aggiravaattorno ai quattro. Ci aspetteremmo in Giobbe che esse compaiano alla
8 Ivi, p. 7.9 Ivi, p.28.
10 Ravasi (1979), p. 34.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 19 — #19 ii
ii
ii
Genere letterario 19
fine di ogni ciclo di discorsi, per chiuderli e farne iniziare un altro, manon è esattamente così.
Giobbe è una tragedia in quattro atti. Le parti corali hanno il caratteredi un commento didattico a quanto avviene e, stando a questa ipotesi,dovrebbero essere tre, nel numero. Kallen afferma:
Now, it happens that Job contains three «interpolations» that satisfy these require-ments. Two of these occur in the «third act», the first, in the twenty fourth chapter,is assigned to Job.11
1. La prima parte corale consiste in una serie di descrizioni di quattroclassi di malvagi e criminali e il loro destino ultimo nelle mani di Dio.È scritta in tristici, che non costituiscono unità strofiche del dialogo.
2. La seconda, al capitolo 28, consta di quattro strofe di tre tetrastici cia-scuna, con una ripetizione di uno stesso distico. Il tema di questa parteè l’inaccessibilità della sapienza da parte dell’uomo e il suo possesso daparte di Dio.
3. La terza è la descrizione di Behemot e Leviatan, le più potenti tra lecreature di Dio. Inizia al capitolo 40, 25 ed è scritta nello stesso metrodel dialogo, ma si differenzia notevolmente per tema e contenuto: glianimali descritti sono creature immaginarie, non reali, come la Sfingedi Edipo.
If these are merely interpolations it is a very extraordinary coincidence that theyshould be three in number, that their themes should fall so pat to the changesof theme in the dialogues, and that two at least should be so different from thedialogue in metre or form. Their nature is generically so like that of many of theEuripidean choruses that it is more plausible than not, that they are such.12
Dunque un prologo ricapitolativo, l’agon, un messaggero, le parti corali,un epilogo con un’epifania, una sorta di deus ex machina che giunge perricomporre una questione altrimenti irrisolvibile. Oltre a somiglianzeformali, anche il pensiero di Giobbe ha dei paralleli nel pensiero tragico:l’ingiustizia divina, l’infelicità umana, il desiderio di morte, la ribellio-ne. . . Tutti questi elementi sono alquanto evidenti e possono denotare,fatte le dovute distinzioni dovute all’ambiente geografico e culturale incui sono nati i due testi, che Il libro di Giobbe sia una restituzione ebraicadi una tragedia greca.
Ma, in qualunque modo questo testo sia venuto alla luce e indipen-dentemente dal genere letterario a cui può appartenere, si può convenireche ogni tentativo di forzare Il libro di Giobbe verso un’interpretazionepiuttosto che un’altra, risulterà sempre difficoltoso perché, possiamoriconoscerlo, grande è la sua complessità.
Le teorie dei vari studiosi che ho cercato di riportare, mostrano quantosia vasto il campo di letture che possono esse date. Ma, usando le paroledi S. Gerolamo, nell’introduzione alla sua traduzione di questo libro:
Spiegare Giobbe è come tentare di tenere nelle mani un’anguilla o una piccolamurena: più forte la si preme, più velocemente sfugge di mano.
11 Kallen (1918), p.35.12 Ivi, p. 36.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 21 — #21 ii
ii
ii
5 Dolore e giustizia, tra mito e mistero
Confrontare la storia di Giobbe col mito di Edipo significa rapportarsicon due visioni del mondo che, sebbene abbiano lo stesso punto dipartenza, tuttavia giungono a due risposte assolutamente contrastantitra di loro. Il motore di entrambe le vicende è il dolore. Tuttavia comemostra Aristotele nella Poetica, non un dolore qualsiasi, ma «fatti terribilie pietosi che capitano contro le aspettative, l’uno a causa dell’altro». Piùavanti il filosofo specificherà anche che l’uomo a cui capitano questieventi tragici «cade nella sfortuna non per vizio o malvagità, ma perun qualche errore, come tra quelli che ebbero grande fama e fortuna,Edipo, Tieste e altri uomini illustri appartenenti a tali famiglie».1 Noipotremmo aggiungere anche, fuori da una definizione strettamentetragica, come Giobbe.
Dunque certamente la sofferenza è il punto di partenza, ma nondarebbe avvio ad alcuna vicenda, se non capitasse improvvisamente,inaspettatamente e soprattutto immeritatamente. Ciò che colpisce inentrambe le storie e che spinge il lettore d’oggi a provare sympatheia, aimmedesimarsi con Giobbe ed Edipo, è il fatto che quanto vede è undolore innocente.
Punto di partenza, ma non punto centrale: esso infatti è solo il mezzograzie al quale due uomini, appartenenti a due culture diverse, mache incarnano l’universale di umanità, indagano più a fondo nella lorovita, nelle radici stesse dell’esistenza per giungere infine a una sola esemplice domanda: perché il male? Ma soprattutto e meglio: perché ame innocente, il male? È il dilemma dell’umanità, sin dalle sue origini,è il quesito di noi tutti. Prima di addentrarci in una trattazione piùdettagliata al riguardo, bisogna operare una distinzione perché, comeinsegna Tolstoj, «Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famigliainfelice è invece disgraziata a modo suo». Fuori dalla citazione, vorreisottolineare la diversa tipologia di dolore che colpisce Edipo e Giobbe.Prenderei dunque a prestito la distinzione che S. Agostino ha propostoper il male e la applicherei, senza tutte le implicazioni cristiane che ilsanto aveva attribuito alle sue definizioni, ai nostri due personaggi: seil male può essere di natura fisica, morale o metafisica, possiamo direche quello fisico riguardi Giobbe, quello spirituale Edipo; chiaramentein questa trattazione non ci interessa il male metafisico.
Dolori differenti dunque per i nostri personaggi: Giobbe viene colpitoprima nei suoi averi e poi nella salute con un morbo terribile, ma lasua fede rimane salda e, sebbene il suo spirito vacilli e protesti contro
1 Aristotele, Poetica, 1453 a.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 22 — #22 ii
ii
ii
22 Capitolo 5
Dio, non arriva mai al punto di negarne l’esistenza. Edipo invece vienecolpito nello spirito sin dalla sua giovinezza, per non dire infanzia: ilsuo rifiuto da parte del vero padre, Laio; l’accusa di essere un bastardo,a Corinto; il terribile oracolo delfico che lo sconvolge e mette in mototutto il dramma che noi conosciamo; la sua sofferenza morale, nelvedere il suo popolo colpito da un morbo terribile («Non c’è nessunoche soffra quanto me», v. 61); il continuo dubitare, nel corso della suaindagine, che lo logora interiormente; e infine la dolorosa scoperta dellasua vera identità.
5.1 Il mistero del dolore in Giobbe
La sofferenza sorge come enigma quando non può più esser inglobata dall’esigenzadi giustizia.2
Il dolore è, nel libro di Giobbe, il banco di prova della fiducia in Dio:infatti come dice Satana all’inizio: «Forse per nulla Giobbe teme Dio?». Eniente di meglio del dolore per verificare l’autenticità della fede perchéesso solleva sempre e inevitabilmente questioni di senso.
Vorrei sottolineare un dato fondamentale prima di proseguire conquest’analisi: si pensa comunemente che la sofferenza sia il tema cen-trale del libro di Giobbe; niente di più falso. Il vero tema centrale, ciòche sta in ballo, non è tanto il dolore di un uomo, ma la giustizia diDio, in quale Dio credere e come crederGli ancora nonostante questo. Ildolore è solamente il mezzo attraverso il quale l’autore del libro vuolepresentarci tutto questo. E, come abbiamo visto, risulterà il mezzo piùefficace, l’unico capace di mettere a nudo l’uomo nel suo rapporto coldivino.
«Satana [. . . ] colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta deipiedi alla cima del capo». Un’unica frase per descrivere la seconda piagache Satana inviò a Giobbe, dopo avergli sottratto beni e figli. Dopo averperso tutto, Giobbe viene colpito anche nella sua persona di un morbotalmente devastante che non una parte del suo corpo venne risparmiata.
A un livello antropologico, la sofferenza è un’esperienza universale.Tuttavia anche se colpiti solo nel fisico, si può ben affermare che «ilbaratro del dolore fisico, in tutta la sua drammaticità, ha sempre riso-nanze di tipo sociale, spirituale, interiore: non esiste mai una sofferenzapuramente esteriore in quanto tale».3
L’uomo vive la sofferenza integralmente, ma molto significativa è lamalattia che colpisce Giobbe perché fa parte di una di quelle «piaghe-simbolo» che nell’antichità erano metafora di qualcosa d’altro. La pellenon è semplicemente un organo come un altro: essa è simbolo dellavita, anche noi diciamo «salvare la pelle». «Le malattie coma la lebbracomportavano l’allontanamento dalla comunità, in quanto considerateparticolarmente infettive. Secondo i passi del Levitico e del Deute-ronomio, queste malattie costituiscono una condanna che punisce itrasgressori della legge e dell’alleanza con Dio».4
Giobbe non capisce il perché di questa sofferenza dal momento cheche è sempre stato uomo giusto. E nel grido a cui giunge infine, maledice
2 P. Ricoeur, La symbolique du mal.3 Ravasi (2003), pag. 31.4 Ivi, pag. 32-33.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 23 — #23 ii
ii
ii
Dolore e giustizia, tra mito e mistero 23
il giorno in cui venne al mondo e desidera che giunga la morte, comeuna liberazione.
Perché dare la luce a un infelicee la vita a chi ha amarezza nel cuore,a quelli che aspettano la morte e non viene,che la cercano più di un tesoro,che godono fino a esultaree gioiscono quando trovano una tomba,a un uomo, la cui via è nascostae che Dio ha sbarrato da ogni parte?Perché al posto del pane viene la mia sofferenzae si riversa come acqua il mio grido,perché ciò che temevo mi è sopraggiunto,quello che mi spaventava è venuto su di me.Non ho tranquillità, non ho requie,non ho riposo ed è venuto il tormento!
Giobbe in questi versi raggiunge l’acme nell’espressione del suodolore: «Nella Bibbia e soprattutto nell’Antico Testamento, la morte èl’anti-Dio per eccellenza: Giobbe quindi invoca la negazione di Dio»5,in una supplica che rasenta la blasfemia, se non capissimo invece che sicolloca come il punto estremo della sua ricerca di Dio.
Per mettere in risalto la sua sofferenza, un’altra espressione è par-ticolarmente efficace: «I miei giorni svaniscono senza più un filo disperanza» (7,6). Mi soffermo a prenderla in considerazione perchémette in risalto, oltre all’estrema disperazione, l’altro aspetto legatoall’antropologia della sofferenza, quello della mancanza di prospettive,mancanza di un centro d’orientamento. Il termine ebraico è tiqwâ, che,come altri nel testo di Giobbe, è polisemantico: significa «speranza» eal contempo «filo» (ha appena parlato di una spola al versetto 6). Lafrase sarebbe «I miei giorni svaniscono senza più tiqwâ» cioè senza filoné speranza, ma meglio: «I miei giorni svaniscono senza più un filo disperanza».
Dunque privato infine dei beni, dei suoi figli, della salute («Ricopertadi vermi e di croste polverose è la mia carne, raggrinzita è la mia pellee si dissolve»), e infine anche dell’ultimo filo di speranza, Giobbe mettein risalto la nudità esistenziale più completa alla quale può arrivare unuomo. Nudità che non è solo fisica, ma anche morale e teologica perché,come detto sopra, Giobbe tocca il limite della blasfemia, nel suo gridodisperato, alla ricerca di risposte da Dio.
5.1.1 Quando le parole non bastano. . .
Il dolore, quando arriva, ha la forza di un tornado, annienta ogni cosa,anche le parole: «Poi [i suoi amici] sedettero accanto a lui in terra,per sette giorni e sette notti. Nessuno gli rivolgeva una parola, perchévedevano che molto grande era il suo dolore».6 Gli amici non sannocosa dire, capiscono di non poter far nulla per alleviare ciò che Giobbesta vivendo e allora tacciono. Il linguaggio umano mostra, in questesituazioni, la sua insufficienza, la sua limitatezza e povertà perché seesso è la manifestazione del pensiero, tuttavia di fronte alla sofferenza,nemmeno la ragione può trovare una spiegazione, una risposta. «Il
5 Ivi, pag. 36.6 Gb, 2, 13.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 24 — #24 ii
ii
ii
24 Capitolo 5
dolore lacera il linguaggio, si colloca sempre al di sotto o al di sopradi esso. Nel dolore, infatti, le parole sono sempre di troppo e sempretroppo poche».7
Dopo ben sette giorni di silenzio, Giobbe improvvisamente esplodein un grido disperato. È un grido autentico, forte, che scuote l’animo dichi lo ascolta ed esprime nella maniera più semplice possibile ciò cheGiobbe cerca: egli «chiede ragione di un dolore senza ragione».8 Ed èproprio quel grido l’inizio della sua ricerca, l’inizio della sua salvezza ericonciliazione con Dio perché esso rappresenta la volontà di Giobbedi capire, il suo non voler accettare un peso così gravoso senza primaessersi appellato a Dio. Ecco che la sofferenza, se espressa, appare anchemeno pesante; se si cerca di problematizzarla, essa non mette a tacere,non annienta l’uomo. E Giobbe infatti esce coraggiosamente dal suosilenzio, si mette in gioco. All’inizio, disperato invoca semplicementela morte, come abbiamo visto; tuttavia questa è una soluzione cheporrebbe solo fine al dolore, non darebbe una risposta al problema dellasua esistenza. Giobbe invece vuole capire, chiede spiegazioni.
Di fronte al dolore le persone non si accontentano di una semplice spiegazionemorale e neppure di una spiegazione teologica classica, di tipo solamente razionale.Tutte le spiegazioni [...] risultano sempre inadeguate e finiscono per scoppiare tra lemani.9
In gioco non c’è soltanto la spiegazione del perché esista il dolore,ma soprattutto si cerca il perché esista il dolore innocente. A un livelloancora superiore, l’uomo s’interroga sulle origini stesse del male, quesi-to che è inevitabilmente legato al problema teologico dell’esistenza diDio. Come può esistere Dio, garante di giustizia e di bene, se il maleimperversa sulla terra? Che Dio è questo?
Giobbe vuole capire, vuole conoscere il vero volto di Dio; dunque nelsuo urlo disperato, si appella a Lui. E questa è una cosa che Edipo, nelsuo mondo sovradeterminato, non potrà mai fare.
5.1.2 Crisi della comunicazione tradizionale
Nel libro di Giobbe è interessante notare come il linguaggio tradizionaleentri in crisi, per una serie di motivi che ci accingiamo ad analizzare.Abbiamo messo in risalto un aspetto di questa crisi, nella sezioneprecedente, parlando dell’insufficienza del linguaggio di fronte a certesituazioni - limite. Ora prendiamo in esame altri momenti particolari incui tale problema si manifesta.
Dopo il grido che lacera l’aria e fa progredire la vicenda, Giobbe sirivolge a Dio e lo fa in maniera paradossale perché sente che qualcosa ècambiato nel Suo atteggiamento, sente qualcosa di simile all’odio neisuoi confronti. Dunque Lo prega di lasciarlo stare, di allontanarsi da luiin modo da lasciargli «inghiottire la saliva»: «Lasciami, perché un soffiosono i miei giorni. Che cosa è l’uomo perché tu lo consideri grande e alui rivolga la tua attenzione e lo scruti ogni mattina e ad ogni istante lometti alla prova? Fino a quando da me non toglierai lo sguardo e nonmi lascerai inghiottire la saliva?».10 È una richiesta semplice, nuda, ma
7 Salvatore Natoli (2008), Edipo e Giobbe. Contraddizione e paradosso, Morcelliana, pag. 47.8 Ivi, pag.46.9 Ravasi (2003), pag. 53.
10 Gb, 7, 16-19.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 25 — #25 ii
ii
ii
Dolore e giustizia, tra mito e mistero 25
è paradossale perché la preghiera è il modo di un credente di cercareun dialogo col suo dio e implica la fede; Giobbe invece prega Dio dilasciarlo in pace e questo denota sicuramente due cose: che Giobbecrede ancora in Dio, ma che al momento non Lo vede come sorgente disperanza. Il linguaggio usuale, tipico di una preghiera è ribaltato.
Esso entra in crisi definitivamente con gli interventi degli amici.Come si sa, si tratta di tre cicli di discorsi, nei quali ognuno dei treamici interviene a esporre il suo pensiero. Ma la comunicazione è soloapparente: ciascuno parla, ma non ascolta; nessuno replica a quantodice l’altro, eccetto Giobbe. Egli è l’unico che ascolta, si mette in gioco,dubita e, ragionando, ribatte ai discorsi degli amici. I tre teologi invece,seppure contraddetti nelle loro affermazioni da Giobbe, continuano aripetere lo stesso ritornello per i tre cicli di discorsi e continuerebberoall’infinito così, se non intervenisse a spezzare questa spirale insensata,prima Elihu, un personaggio che rappresenta o la nuova filosofia, che sicontrappone a quella tradizionale degli amici, o la sapienza profetica (ilnome richiama quello del profeta Elia); poi interviene Dio stesso.
La comunicazione dunque è saltata tra Giobbe e gli amici. Questi sibasano sul principio, ben noto nella Bibbia, del retribuzionismo, secon-do il quale a un comportamento moralmente ineccepibile, corrispondesu questa terra una vita prospera, viceversa a un comportamento moral-mente riprovevole, corrispondono pene e dolori. Nella Bibbia il doloresi qualifica come punizione divina ed è su questa idea che gli amicibasano i loro rimproveri a Giobbe. Da parte sua Giobbe invece si senteinnocente, uomo retto di fronte a Dio; vuole dunque dimostrare tuttal’infondatezza delle credenze tradizionali, si scaglia contro di esse eporta come prova l’insorgenza del reale: infatti la teoria retribuzionistanon si adatta alla realtà dei fatti, è da essi contraddetta perché capitaspesso che gli empi prosperino e i buoni soffrano. Per gli amici invece,tale teoria funziona perfettamente, non vogliono sentire ciò che egliha da dire e gli attribuiscono una colpa che egli in effetti non ha. Essirimangono sordi anche di fronte all’evidenza. E proprio in questo sensosi nota un black out della comunicazione, che impedisce un dialogo vero,autentico, costruttivo.
5.2 La contraddizione dell’uomo: Edipo
La storia di Edipo è quella di un uomo che si crede favorito dallafortuna, ma che in un giorno qualunque passa dal sommo della gioia,alla miseria più assoluta, quando scopre una verità terribile su se stesso:si scopre un mostro, parricida e incestuoso con la madre.
Fu Aristotele per primo, nella Poetica, a fare del dramma di Edipo - naturalmentel’Edipo re di Sofocle - il modello per eccellenza dell’eroe tragico. È il suo mitoche, anche solo a udirlo, provoca un fremito di orrore e pietà; è Edipo l’esempiod’itinerario esemplare di un eroe tragico che consente al pubblico di assistere al«cambiamento di fortuna» (metabolé), senza provocare scandalo poiché la sua è lastoria di un uomo che «senza essere straordinario per virtù e giustizia ma neppureper malvagità e perversione, cade in una sventura da uno strato felice in cui sitrovava, a causa di una colpa (hamartìan).11».12
Il segno del tragico, nella vicenda di Edipo, come in tutta la produzionetragica greca, si manifesta non tanto nella quantità di dolore che l’eroe
11 Aristotele, Poetica, 1453 a.12 Bettini e Guidorizzi (2004), pag. 184.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 26 — #26 ii
ii
ii
26 Capitolo 5
vive sulla scena, ma nella contraddizione che egli si trova inevitabilmentea vivere, a uno o più livelli. Edipo è simbolo, per l’umanità, della ricercadi sé; è la tragedia che più di ogni altra mostra l’ambiguità della realtà,perché Edipo - usando un’espressione di Salvatore Natoli - «è insiemesdoppiamento e doppiezza».13
Se è vero che l’oggetto del mito consiste nel fornire un modello logico per risolvereuna contraddizione, i personaggi della tragedia, agendo e patendo il loro mito come«uomini reali», denunciano senza pietà che il compito di risolvere una contraddizioneè irrealizzabile, quando la contraddizione è reale.14
Ed è proprio quando si rende conto di questo, quando capisce finalmen-te chi è e che cos’è la vita, che Edipo, per la sofferenza, si acceca. Il suodolore, come quello di Giobbe, è dovuto alla presa di coscienza che ilreale è contraddittorio; ma Giobbe, pur vivendo la contraddizione, puòrivolgersi a qualcuno che conosce la risposta di questo problema; Edipoinvece non può levare alcun grido al cielo, perché la Tuche è superioreanche agli dei stessi ed è inappellabile, inconoscibile.
5.2.1 Una contraddizione a più livelli
L’Edipo di Sofocle non è veramente un individuo definibile univoca-mente, perché è troppe persone contemporaneamente. E in questa suamolteplicità, o meglio unione di molte personalità opposte, Edipo mo-stra il senso profondo del tragico, la sua vera essenza, che è l’esperienzadella contraddizione. Contraddizione che noi possiamo vedere a piùlivelli: sul piano teologico innanzitutto, ma anche linguistico e, infine,esistenziale.
Innanzitutto «le antitesi si delineano soprattutto sul piano dell’espe-rienza umana del divino. Non si trova nella tragedia una categoriaunica di religioso, ma forme diverse di vita religiosa, che appaionoantinomiche, l’una escludente le altre».15 «I tragici non si accontentanodi contrapporre un dio all’altro, Zeus a Prometeo, Artemide ad Afrodi-te, Apollo e Atena alle Erinni. Più profondamente, l’universo divino èpresentato nel suo insieme come conflittuale. Le potenze che lo com-pongono appaiono raggruppate in categorie fortemente contrastanti, frale quali l’accordo è difficile o impossibile perché non si trovano situatesu un medesimo piano».16
Il conflitto tra divinità non è così semplice come apparentementepuò sembrare, ma si tratta qui di qualcosa di più profondo: le forze ingioco sono la Moira, la Tuche, gli dei stessi, l’ethos dell’eroe e infine, manon ultima, la volontà dell’uomo. Volontà che si scontra con le potenzeappena nominate e fa sì che l’uomo - per usare un’espressione ancorviva ai giorni nostri - debba continuamente «tentare la sorte».
Tentare la sorte: nei tragici, l’azione umana non ha in sé abbastanza forza per fare ameno degli dei [...]. Nella prospettiva tragica, agire comporta un duplice carattere:da un lato è tener consiglio dentro di sé, soppesare il pro e il contro, prevedere comemeglio si può l’ordine dei mezzi e dei fini; dall’altro, è scommettere sull’ignoto esull’incomprensibile, avventurarsi su un terreno che vi resta impenetrabile, entrarenel gioco di forze soprannaturali delle quali non si sa se preparino, collaborando
13 Natoli (2008), pag. 22.14 Giuseppe Serra (1994), Edipo e la peste, Marsilio, pag. 17.15 Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet (1972), Mito e tragedia nell’antica Grecia, Einaudi,
pag.21.16 Ivi, pag.20.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 27 — #27 ii
ii
ii
Dolore e giustizia, tra mito e mistero 27
con voi, il vostro successo o la vostra rovina. Nell’uomo più previdente, l’azionepiù ponderata conserva il carattere d’un appello azzardato lanciato verso gli dei edi cui si saprà soltanto attraverso la loro risposta, per lo più a proprie spese, checosa valeva e che cosa voleva esattamente dire. Solo al termine del dramma gli attiassumono il loro vero significato e gli agenti scoprono, attraverso ciò che hannorealmente compiuto senza saperlo, il loro vero volto. 17
Edipo, dunque, si deve misurare con il suo carattere, ma anche coidisegni che qualche forza divina ha tessuto per lui. In sostanza c’è,nella tragedia greca, una sovrapposizione di causalità umana e causalitàdivina: sembra che i due piani collaborino, quando ad esempio Edipoconsulta l’oracolo del dio Apollo e questo gli risponde, ma in realtà,come lo spettatore ben sa, il messaggio divino è enigmatico, ambiguo,contraddittorio. E anche per questo, le scelte di Edipo che sembrano det-tate dalla sua stessa volontà e non sovradeterminate, di fatto rientranonell’ordine della necessità, dell’anànke imposta dagli dei. Per ciò, anchequando l’eroe crede di agire per una sua decisione e scelta, in realtàrealizza sempre l’opposto di quanto crede.
Il mondo proprio della tragedia si colloca in questa zona di confine ove gli attiumani acquistano il loro vero senso, ignorato dall’agente, integrandosi in un ordineche supera l’uomo e gli sfugge.18
Ad aumentare il senso di confusione, di ambiguità, e a sottolineare ilrovesciamento che avviene negli eventi della vita umana, Edipo non solosi deve misurare con forze più grandi di sé, ma è addirittura paragonatoa un dio da parte dei cittadini di Tebe. Egli è l’uomo ambiguo; ladoppiezza - come abbiamo detto - è il segno che lo caratterizza. Inquesto senso dunque non appare strano che, soprattutto nella parteiniziale della tragedia, venga invocato dai suoi sudditi quasi comeuna divinità: «Tu ci vedi riuniti presso i tuoi altari», dicono i Tebaniprostrati dalla peste. Ed Edipo con la sua domanda non fa che mettere inevidenza questo loro atteggiamento: «Perché vi tenete così accovacciatiin un atteggiamento di supplica verso di me, coi vostri ramoscelliincoronati di bende?». Egli è visto come possibile salvatore, l’unicoforse in grado di ridonare la salute alla città malata. Poiché già inpassato si è dimostrato il solo capace di risolvere l’enigma della Sfinge,questo costituisce un episodio su cui si basano ora tutte le supplichea lui rivolte: l’ha fatto una volta, lo farà di nuovo. E anche questoragionamento, come il loro atteggiamento, è una forma tipica dellapreghiera, resa con l’espressione latina da quia dedisti. Quel precedenteha dimostrato che Edipo rappresenta la buona sorte della città e daallora è a lui che i suoi cittadini ricorrono. Un’altra caratteristica chesottolinea questa sua somiglianza - seppure esteriore - con un dio, èil rapporto incestuoso che lui ha con Giocasta: solo gli dei, a quantoconosciamo, possono unirsi tra consanguinei senza provocare scandaloo conseguenze disastrose. Edipo invece, malgrado la sua grandezza e laconsiderazione di cui gode, è umano, fin troppo umano. E non esigecerto esser trattato come divinità, sa bene di non esserlo. Forse, nei fatti,l’unica cosa sovrumana è il compito che gli hanno assegnato. «Di fronteall’impossibile, Edipo fa tutto ciò che è umanamente possibile».19 Eproprio qui sta il punto in cui il segno della contraddizione si vede più
17 Ivi, pag.25.18 Ivi, pag.27.19 Serra (1994), pag.36.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 28 — #28 ii
ii
ii
28 Capitolo 5
chiaramente: egli, accettando il compito quasi sovrumano di salvarela città, estremo e pericoloso, pecca di dismisura, perché solo un diopotrebbe farlo e lui certamente non lo è.
5.2.2 Crisi della parola
Anche il linguaggio, come accennato poco sopra, contribuisce a man-tenere viva quella contraddizione che è caratteristica non solo dei fattirecitati sulla scena, non solo della categoria del tragico, ma anche dellavita umana.
Questa presenza nella lingua dei tragici di una molteplicità di livelli più o menodistanti l’uno dall’altro [...] dà al testo una profondità particolare e ne fa agirela lettura su più piani contemporaneamente. Tra il dialogo quale è scambiato evissuto dai protagonisti, interpretato e commentato dal coro, recepito e compresodagli spettatori, esiste uno scarto che costituisce un elemento essenziale dell’effettotragico.20
La crisi della parola coinvolge ogni aspetto del linguaggio soprattuttoperché uno stesso termine, in bocca a vari personaggi può assumeresignificati diversi e «le parole scambiate sullo spazio scenico non hannoallora tanto la funzione di stabilire la comunicazione tra i diversi per-sonaggi, quanto quella di fissare i blocchi, le barriere, l’impermeabilitàdegli spiriti, di delimitare i punti conflittuali».21 Il linguaggio dunquecessa di avere una funzione comunicativa comunemente intesa perché aogni frase pronunciata, si collegano più significati che non sono univoci,ma molteplici. Proprio per l’ambiguità che vi ritroviamo, la comunica-zione tradizionale lascia il posto a relazioni enigmatiche, oscure perchérispecchiano l’oscurità della parola detta. E questa ambivalenza dellinguaggio viene sottolineata ancor di più da quella che generalmen-te conosciamo come ironia tragica, per la quale Edipo viene «preso inparola», quella parola che poi gli si ritorcerà contro, rivelandogli chirealmente è. Invece solo per lo spettatore la polisemanticità del linguag-gio si rivela in tutta la sua trasparenza, solo lo spettatore si fa carico diquella comprensione e conoscenza, tanto simili a quelle di Tiresia, mache a nulla gli valgono, se non a com-patire ancora di più l’eroe sullascena.
La comunicazione salta, a un primo livello, con gli oracoli: alle do-mande poste da Edipo e poi da Creonte, il dio risponde in manieraenigmatica; sempre veritiera, certamente, ma mai completa e chiara. Aquel primo quesito di Edipo se Polibo e Merope fossero i suoi veri geni-tori, Apollo non risponde nulla. Gli fa una predizione che non risolvealcun dubbio, anzi, ne crea di nuovi e peggiori. La parola oracolare sirealizza sempre, ma è proprio il suo essere pronunciata a segnare unasvolta nella vita di chi ascolta.
L’oracolo è una forma di linguaggio diverso da quello abituale: sirealizza per segni che gli uomini non possono comprendere perché laloro mente è differente da quella divina. Dunque esso per sua naturaelude, costituisce una forma di comunicazione zoppa.
Possiamo dire che in questo modo, nella tragedia si scontrano nellastessa parola un discorso umano e uno divino, che subito appaionodistanti, separati, diversi, ma che alla fine, nel momento della verità si
20 Vernant e Vidal-Naquet (1972), pag.22- 23.21 Idem.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 29 — #29 ii
ii
ii
Dolore e giustizia, tra mito e mistero 29
riuniscono per mostrare che non era la loro veridicità che doveva venirmessa in discussione, ma la loro interpretazione da parte dell’uomo.
A un secondo livello, entra in crisi la parola quando parla Edipo:accade infatti che quanto dice sia cosa diversa o contraria da quantointenda. Così quando dice (v. 132)«egò phanò», il significato è duplice: «iosvelerò [il mistero]», ma anche «io svelerò me stesso», in quanto propriolui è l’assassino che cerca. Più avanti, se preso alla lettera sembra predirequanto accadrà, quando dice (v. 139-140) « Io per me stesso disperderòquest’impurità. Perché chi uccise lui potrebbe ben pensare di colpire conuna mano come questa, me». Ma ancora (v. 264) «Ebbene io combatteròper lui questa battaglia come fosse mio padre».22
La crisi del linguaggio, che Edipo mostra, è contemporaneamentecrisi della coscienza di sé. «L’ambiguità dei suoi discorsi non traduce ladoppiezza del suo carattere, che è tutto d’un pezzo, ma, più profonda-mente, la dualità del suo stesso essere. Edipo è duplice. Egli costituiscedi per se stesso un enigma di cui non indovinerà il senso se non sco-prendosi il contrario in tutto e per tutto di ciò che credeva e parevaessere».23
22 Questi sono solo alcuni dei numerosi passi in cui appare evidente l’ambiguità dei discorsie l’ironia tragica. I corsivi sono miei.
23 Vernant e Vidal-Naquet (1972), pag.92.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 31 — #31 ii
ii
ii
6 Forme di conoscenza
«Non potrei mai convincermi a non sapere chiaramente come stanno le cose» diceEdipo a Giocasta (v. 1058- 1061), la quale poco dopo ribatte: «Ah, così non sapessimai chi sei!».
«Ma la sapienza donde si trae, e qual è il posto dell’intelligenza? L’uomo nonne conosce la via, né la si trova nella terra dei viventi. [. . . ] Dio solo ne conosce lastrada e sa dov’ella risiede, poiché vede le estremità della terra e scorge quanto vi èsotto i cieli», afferma Giobbe nel c.28.
È soprattutto di fronte al dolore che l’uomo vuole capire e non si ac-contenta di risposte banali, ma si mette alla ricerca di quella sola verarivelazione che può placare la sua sete di conoscenza. Così Edipo eGiobbe non si accontentano di soluzioni facili, preconfezionate, tradi-zionali, ma indagano, cercano e soprattutto urlano. La loro pace, semai di pace o tranquillità si può parlare per Edipo, giunge solo con lasapienza.
Chiaramente quando parliamo di forme di conoscenza, dobbiamosempre tenere presente l’ambiente culturale a cui facciamo riferimento.Al di là delle somiglianze superficiali nei due racconti, la ricerca per-sonale che Edipo e Giobbe intraprendono, si caratterizza in manieraassolutamente diversa: Edipo rappresenta la cultura greca razionalistadel V sec. a.C., Giobbe invece quella religiosa ebraica. La differenzaè notevole: per Edipo la sapienza è tutta umana e razionale; quandoconosce, si acceca. Essa diventa quasi un delitto contro natura. PerGiobbe invece la sapienza è legata a una conoscenza di Dio, che viene daDio; quando Giobbe conosce, giunge a un nuovo livello di beatitudine.
6.1 Edipo re
La storia di Edipo, si sa, è fatta di enigmi. A porli e a risolverli, lavorano dei eindovini - come Apollo e Tiresia -, mostri e uomini – come la Sfinge e lo stessoEdipo. È naturale quindi che nel testo della tragedia si misurino e si scontrinoforme di sapere diverse, stili di razionalità in conflitto. Questo fa dell’Edipo re unluogo strategico del dibattito intellettuale del V secolo, un laboratorio dove Sofocleanalizza la resistenza e le crisi dei saperi.1.
Conoscere si può dire che sia la parola chiave dell’Edipo re. Durantetutta la vicenda egli è impegnato a capire, a indagare, a decifrareenigmi e oracoli per giungere infine a una visione chiara delle cose.Scrive Vegetti:2
Lungo tutta la tragedia, egli controlla saldamente un sapere metodicamente organiz-zato, si muove con sicurezza lungo i percorsi della razionalità indagatrice. Salutato
1 Mario Vegetti, Forme di sapere nell’Edipo re, in Curi e Treu (1997), pag. 57.2 Idem.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 32 — #32 ii
ii
ii
32 Capitolo 6
dal sacerdote come uomo esperto (empeiros, 44), egli dichiara di aver esploratocon la mente molte vie e presenta il sintagma costitutivo della sua razionalità, lacoppia ricerca/scoperta (skopon euriskon, 67). Ancora alla fine della tragedia, ciecoe costretto all’esilio, egli spiega alle figlie la ragione dell’unione incestuosa conGiocasta attribuendola a una defaillance della conoscenza e dell’indagine: si è unitoa lei «non vedendo né indagando». Questa dimensione della historia connette im-mediatamente Edipo all’atmosfera della cultura “tecnica” e profana del V secolo,la cultura dei fisici, degli storici, dei medici. Come la loro, la ricerca, la historia diEdipo è metodicamente articolata in una serie di momenti che vengono descrittida Sofocle con una terminologia così precisa e ricorrente da escludere qualsiasicasualità.
La ricerca è condotta razionalmente (gnome, 356 ss); essa si svolge a partire da unprincipio, sfrutta il momento opportuno alla scoperta, lavora sui segni e gli indizi.Al termine c’è la scoperta, la heuresis [. . . ]. La scoperta è l’atto che manifesta ciò cheè incognito, è il momento della trasparenza, della visione chiara.
Dunque un sapere razionale e metodico, paragonabile a quello di Anas-sagora, di Tucidide, ma anche e soprattutto, dal momento che di pestesi tratta, a quello della scuola ippocratica. E proprio quel sapere medicoaveva subito una sconfitta attorno al 430, quando la famosa e terri-bile epidemia di peste aveva colpito Atene. Tuttavia quell’insuccessoterapeutico momentaneo non fu inutile poiché servì da incentivo peruna crescita ulteriore di un sapere più efficace. Il metodo conoscitivodi Edipo dunque non subisce una sconfitta formale, ma rappresenta,nonostante alcune mancanze, un procedimento efficace sulla stradadella conoscenza. Forse l’unico procedimento efficace. Infatti a Ediposi contrappone Tiresia, detentore unico di aletheia, perché latore di unsapere che viene dal dio. Ma esso si rivela assolutamente inefficace incampo pratico, è semplicemente una prosecuzione della natura, cheTiresia non desidera né controlla.
6.1.1 La Sfinge
La Sfinge costituisce il primo momento in cui il sapere di Edipo vienemesso alla prova; momento decisivo perché non è solo la risoluzionedi un mistero, ma anche momento essenziale per definire l’identità diEdipo - uomo.
Ma andiamo con ordine. La Sfinge è una donna leonessa, con le ali dauccello, mostro antichissimo, presente nel mito di Edipo da Esiodo, maconosciuta dai Greci ben prima. Essa appartiene alla stessa categoria dimostri delle Sirene o Arpie;
Talvolta queste donne omicide sono - come appunto la Sfinge - padrone di unasapienza nascosta, espressa attraverso il canto (aoidé), un magico canto che seduce,strega e rovina nello stesso tempo. [...] Come la Sfinge, anche le Sirene non possonosopravvivere alla perdita del loro potere canoro: quando un mortale passa indenne,si suicidano gettandosi in mare, come appunto la Sfinge si suicida precipitandosidal monte in cui sedeva a ingannare i mortali. [...]
La funzione narrativa della Sfinge nella storia di Edipo appare chiara e s’inseriscein un modello narrativo universalmente diffuso: è il mostro che l’eroe deve sconfig-gere per compiere la sua prova iniziatica che gli consente il passaggio da uno statussociale e da una classe di età all’altra, da giovinetto a uomo, da celibe a sposato, daoutsider a re. Questo è appunto ciò che accade anche a Edipo: il giovane vagabondodopo avere sconfitto la Sfinge diventerà uomo adulto, re e marito, ottenendo insposa la regina di Tebe. A partire da Sofocle, la sfida tra Edipo e la Sfinge si svolgesulla base di un duello di parole: il mostro propone ai tebani un indovinello e uccidechi non riesce a rispondere.3
3 Maurizio Bettini e Giulio Guidorizzi (2004), Il mito di Edipo, Einaudi, pag. 176-177.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 33 — #33 ii
ii
ii
Forme di conoscenza 33
Dunque essa è la prima che mette in gioco il sapere di Edipo, che lorende uomo. Edipo, divenendo adulto, risolve quell’enigma apparen-temente semplice, ma in realtà più complesso di quanto sembra. Alladomanda «Chi è l’animale dípous, tripous, tetrapous?» Edipo risponde«L’uomo». Crede di aver trovato la risposta, ma in realtà l’ironia tragicaopera ancora perché dell’enigma l’importante era la domanda.
Per Oi-dípous il mistero non è tale se non in apparenza: si tratta certamente di lui,si tratta dell’uomo. Ma questa risposta non è un sapere che in apparenza; essamaschera il vero problema: che cos’è allora l’uomo, che cos’è Edipo?
La Sfinge con quel suo sapere nascosto, quasi divino, voleva renderlovigile chiedendogli in sostanza, chi è l’uomo Oi-dípous. La risposta, secompresa, risiedeva già nella domanda: qual è quell’animale che cambiacontinuamente la sua natura ed è (tetrapous, tripous e) Oi-dípous? SeEdipo l’avesse compreso, se avesse capito che l’uomo- «polimorfo» eralui...
Invece, come sempre accade, ogni volta che Edipo cerca di capirechi è, chiude inconsapevolmente gli occhi della mente e si ferma alleapparenze. «L’uomo» ha risposto in maniera elementare alla Sfinge.Ma anche prima, recatosi a Delfi per conoscere la sua origine, evita di«rispettare» l’unica vera prescrizione del santuario: quella del «Conoscite stesso». Prescrizione che non è un monito che va preso alla lettera,ma un invito all’orante a sapere bene ciò che si vuole conoscere, perché unadomanda posta al dio prevede che il supplice sia pronto a riceverne larisposta, di qualunque natura essa sia.
La risoluzione di questo primo enigma, da parte di Edipo, crea,prendendo in prestito un termine giuridico, il primo precedente sulquale si basano le richieste successive di aiuto:
L’esperienza, facies dinamica della ragione, è propriamente la forza su cui si fondala speranza tebana: essa suggerisce, «interpretando il presente sulla scorta delpassato», come dirà Giocasta (196), che a stimoli simili si possono ipotizzare rispostesimili: dunque come Edipo ha potuto liberarli una volta, potrà farlo una seconda.4
6.1.2 Forme di conoscenza nell’Edipo re
Edipo, un uomo che porta già nel nome il segno del suo destino, il segnodell’ambiguità che renderà la sua storia la più tragica per eccellenza.Esso infatti può essere interpretato in una duplice maniera: Oidos-pous«dal piede gonfio», oppure Oida- pous, «colui che sa, che conosce ilpiede». Con il primo significato il nome ricorda in ogni momento aEdipo la sua infermità, dovuta al suo rifiuto da parte di Laio; il secondosignificato invece mette in risalto il verbo centrale nella tragedia, quellodel «sapere». Più volte lui stesso si vanterà della sua mente - risolutricedi enigmi, primo tra tutti quello postogli dalla Sfinge, appena giuntoa Tebe. Ma «conoscere il piede» significa aver capito che è l’uomoquell’essere mutevole di cui parlava il mostro. «Conoscere il piede»significa aver compreso, grazie al segno che porta proprio ai piedi, chi eche cosa realmente è.
Edipo effettivamente cerca in ogni momento di far chiarezza e lucecon razionalità e determinazione, ma cosa può la volontà di fronte alvolere di quelle forze sovrannaturali che determinano il corso degli
4 Guido Paduano, Il personaggio Edipo, in Curi e Treu (1997), pag. 44.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 34 — #34 ii
ii
ii
34 Capitolo 6
eventi? Edipo non conosce ancora la loro potenza, quando ascolta quelprimo oracolo a Delfi. Fiducioso nelle capacità della sua mente, egli crededi aver capito ciò che il dio Apollo gli ha rivelato: così a quel famosocrocevia in cui le strade si dividono, l’una verso Tebe, l’altra versoCorinto, sceglie comprensibilmente la prima, per sfuggire all’orribilesorte che gli è stata predetta, non sapendo così di andarle proprioincontro. E dopo aver risolto, solo apparentemente - come abbiamo giàesposto nel paragrafo precedente -, l’enigma del mostro che opprimeTebe, prende in sposa Giocasta, la madre.
Il sapere di Edipo non viene più messo alla prova fino al tragicomomento in cui un morbo terribile colpisce la città e sembra non volerfinire mai. Ecco che il risolutore di enigmi deve nuovamente mettersiin gioco, stavolta con un mistero ancora più grande del precedente,un mistero quasi sovrumano. Quando le umane conoscenze medichefalliscono, Edipo, che non è uno stolto, comprende che la razionalitàdell’uomo non può nulla di fronte a un mistero così oscuro, e decide diconsultare un dio, l’unico a questo punto che può sapere qualcosa.
Ed ecco il confronto che ci dà modo di parlare delle due diverseforme di sapere che si scontrano nell’Edipo re: quello umano e quellodivino. Vista la limitatezza della conoscenza umana, Edipo ricorre aquella divina, mandando Creonte al santuario di Delfi. Qui possiamoconoscere la sapienza divina attraverso i grandi oracoli trasmessi aLaio, Edipo e Creonte; si tratta di profezie che definiscono il destinodegli uomini, ma sono veritiere e precise a tal punto, da sembrarequasi irreali ai destinatari, che invece male le interpretano e così lerealizzano in pieno. L’oracolo ricevuto da Creonte è essenziale nellavicenda: il dio stavolta non predice il destino di un uomo, ma si limita aporre delle condizioni: se l’assassino di Laio sarà espulso, allora la cittàsarà purificata. Conosciuto l’oracolo, Edipo chiama Tiresia per averemaggiori informazioni, ma sono solo brevi momenti di fiducia nellasapienza del dio, perché, una volta ottenuto il responso, Edipo ritornaad affidarsi totalmente alla sua mente, potente indagatrice. Infatti
La cecità e la sordità di Tiresia non sono per Edipo un segno divino ma una verae propria deprivazione sensoriale, un’incapacità di aisthesis, che inevitabilmentecoinvolge anche il suo nous (371) [. . . ]. Il coro sostiene all’inizio l’attacco di Edipo(500 ss.): gli dei soltanto sono capaci di uno sguardo che produce la trasparenzaimmediata: fra gli uomini invece non esistono indovini o veggenti.5
Considerazione che non è del tutto erronea se si considerano poi l’ef-ficacia e l’utilità delle due forme di sapere; ma se si guarda al lorocontenuto di verità, allora indubbiamente Tiresia sa di più e meglio diEdipo.
Il sapere di Tiresia è connotato in tutti i suoi tratti da questa origine divina: esso èonnicomprensivo e stabile, cioè esteso sulle tre dimensioni del tempo; è la verità(aletheia) che ne costituisce l’oggetto a imporsi con la sua stabile forza al portatore diquel sapere [. . . ] Ma il portatore di quel sapere [. . . ] avverte tutta la pari irrilevanza,propria e di ogni altro illuminato, nella fattiva gestibilità di quella sapienza, di fattoestranea ai bisogni, alle speranze, ai fini, al tempo stesso dell’uomo [. . . ]. Tiresialamenta quanto sia «Terribile conoscere, quando la conoscenza non giova a chi lapossiede».6
5 M. Vegetti, Forme di sapere nell’Edipo Re, in Curi e Treu (1997), pag. 59.6 Linda M. Napolitano Valditara, Lo sguardo di Edipo, in Curi e Treu (1997), pag.99.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 35 — #35 ii
ii
ii
Forme di conoscenza 35
Essa, infatti, non richiede l’indagine razionale, un lavoro indiziario,un percorso fatto di esperienze, ma gli è data in maniera immediata.Tuttavia, è una conoscenza vuota, priva di utilità sociale:
Egli [Tiresia] vive solo, lontano dalla città, non ha voluto parlare per salvarla dallaSfinge (390 ss.), né vuol parlare ora di fronte al nuovo flagello. È la razionalitàdi Edipo a produrre lo spazio di circolazione e intelligibilità del sapere del suoantagonista, a rendere manifesto il suo valore d’uso; anche se, naturalmente, unavolta che Tiresia ha pronunciato il suo discorso, egli è costretto a invalidarne laverità. [...]
La sua verità, potente ma incrollabile, e in qualche modo inconsapevole, è tuttadalla parte della natura: è capace di mandare in frantumi le certezze di Edipo maha bisogno di lui per essere evocata e non è ulteriormente fruibile; alla fine Tiresiasi allontana dalla città non diversamente da Edipo.7
La conoscenza di Tiresia, alla pari di quella divina, non è dunqueimmediatamente utile all’uomo, a cui è invece necessaria un’altra formadi sapienza che le sappia decifrare, quella razionale di Edipo. Infattitanto il dio, quanto il profeta comunicano un messaggio vero, ma vuotodi informazioni; per riempirlo occorre l’indagine di Edipo, il quale èestremamente fiducioso nelle proprie capacità, si fida meno invece diquelle di Tiresia.
Nel dialogo via via degenerato tra i due, emerge, come vedremo, proprio unconfronto fra il sapere di Tiresia e quello dell’eroe. [. . . ] Se, nella visione delsacerdote guida dei supplici, egli eccelleva in sapere perché aiutato non dai tebani,ma da un dio, nella visione che Edipo stesso ha di sé quale sapiente, egli nega anchetale possibilità, ascrivendo solo a sé l’origine di quel sapere. [. . . ] Al sapere di originedivina, che pareva allora l’unica chance («c’era bisogno dell’arte profetica»), ma chenon ha retto la verifica dell’utilità sociale, Edipo oppone dunque la sua gnome, conla quale, senza gli aiuti umani esclusi dal sacerdote, ma anche senza gli aiuti divinifondanti il sapere di Tiresia, ha risolto, lui e non altri, il problema.8
Lui rimane comunque il protagonista del dramma, lui e la sua raziona-lità. Al sapere di Edipo non c’è alternativa, se non la cecità di Tiresia; edopotutto esso non ha fallito in maniera assoluta: anche nel momento incui si è trovato davanti l’ultimo, grande mistero, è riuscito a risolverlo,nonostante tutto. La soluzione tuttavia si è rivoltata contro il solutore equi possiamo vedere quanto amaramente presente sia l’ironia tragica.La sapienza del dio ha fatto in modo che il sapere di Edipo operasseattivamente fino a volgersi su se stesso, oggetto e soggetto d’indagine.
E nel fare questo, lo spettatore scopre che tanto la sapienza del dio,quanto quella di Edipo sono in sé incomplete, insufficienti: a Edipomanca la visione totale dei fatti, una conoscenza completa della verità;al dio invece manca la capacità di farsi intendere dall’uomo. E in questoincontro - scontro di saperi, nascono incomprensioni, interpretazionierronee, eventi terribili e sofferenza immane.
Edipo scopre chi è: scopre di essere un mostro, scopre che la suaconoscenza a nulla gli è valsa. Lui, che all’inizio della tragedia proclamaai suoi concittadini la sua intenzione di far luce sul mistero della pestecon lo strumento della sua ragione, lui che è divenuto re, marito, padre,lui, potente e grande tra gli uomini, proprio lui ora scopre la suadoppiezza di innocente e omicida, figlio e marito incestuoso, fratelloe padre, trovatello e principe, salvatore e colpevole, cura e malattia,veggente e cieco.
7 M. Vegetti, Forme di sapere nell’Edipo Re, in Curi e Treu (1997), pag. 64-65.8 Linda M. Napolitano Valditara, Lo sguardo di Edipo, in Curi e Treu (1997), pag.91.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 36 — #36 ii
ii
ii
36 Capitolo 6
E in questo gioco di antitesi e ribaltamenti, ecco che infine giungela contraddizione più grande, l’ultima: gli occhi, che nell’antica Greciacostituivano il simbolo della ragione, tanto che il greco usa il verbodel «vedere» per esprimere anche il «conoscere», proprio loro vengonopuniti perché sono stati inutili, strumenti insufficienti, troppo limitati.Edipo, che non ha saputo vedere la verità, che non ha ri-conosciutopersone che avrebbe dovuto riconoscere, si punisce negli occhi perl’errore di conoscenza più elementare nella vita di un uomo, quello cheriguarda la sfera dei rapporti familiari.
Ed ecco l’ironia tragica: Edipo inizia a vedere quando si acceca;nell’oscurità raggiunge la luce, una nuova vista gli è ora donata, similea quella di Tiresia; ma egli, come il profeta, non la desidera, inutileconoscenza e perenne ricordo di quel suo fatale errore.
6.2 Giobbe: logica umana e sapienza divina
Le prime parole di Dio sono decisive e la chiave di lettura dell’interovolume di Giobbe:
Chi oscura il piano divinocon parole senza sapienza?9
Contrariamente a quanto avviene nell’Edipo re, nel Libro di Giobbe e intutta la Bibbia, la sapienza appartiene solo a Dio. Anche se in questotesto sembra che compaia uno scontro tra quella umana, che cerca dicapire, e quella divina, vera fonte di conoscenza, in realtà non possiamomescolare le due cose a livello terminologico. Dio è il detentore uni-co della sapienza; relativamente a Giobbe, sarebbe preferibile quindiparlare di «logica umana».
La logica umana si manifesta sostanzialmente su due livelli: nellepretese di sapienza degli amici teologi e nella ricerca di Giobbe chechiede ragione di un dolore senza ragione. Ma i due piani non sonocomparabili: gli amici parlano credendo di sapere, ma la loro logicaè tutta basata su un principio tanto vecchio quanto umano e limitatoche è quello del retribuzionismo. Il retribuzionismo, come sappiamo,si basa in sostanza sull’ortoprassi: si fonda sulla credenza che a uncomportamento retto corrisponda una «ricompensa» divina. Tuttaviatale teoria non può esser valida agli occhi di chi, come Giobbe, ne vedele contraddizioni nella realtà.
Quella degli amici si presenta come una teodicea, una «giustificazionedi Dio» rispetto al problema della sussistenza del male nel mondo. Macome avviene anche nell’Edipo re, all’uomo che crede di aver capito tuttodel dio, accade poi di rendersi conto della fallacia delle sue convinzioni.Per questo le pretese di sapienza degli amici teologi non possono essermesse sullo stesso piano di quelle di Giobbe, perché mentre i primipeccano in qualche modo di quella che i greci chiamano hybris, Giobbeinvece rimane sempre conscio dei limiti dell’uomo.
Pure, in qualche modo, Giobbe osa contro Dio. Egli «non è super-bo della sua giustizia, ma non può esimersi dal domandarsi perchésoffre».10 Dopo esser stato colpito, lui, innocente, da una sofferenza im-motivata, quello che lui fa è chieder ragione di un dolore senza ragione.
9 Gb, 38, 2.10 Natoli (2008), pag.58.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 37 — #37 ii
ii
ii
Forme di conoscenza 37
E questo, se vogliamo, è il suo errore per il quale Dio lo rimprovererà.Il suo merito sarà invece quello di comprendere subito il suo sbaglio,e di ammettere che la logica umana è limitata e di fronte a Dio vieneridotta al silenzio, deve far silenzio.
Giobbe prese a dire al Signore:«Ecco non conto niente: che cosa ti posso rispondere?Mi metto una mano sulla bocca.Ho parlato una volta, ma non replicherò,due volte ho parlato, ma non continuerò».
L’uomo non può aver la pretesa di parlare perché per quanto con la suascienza «sia capace di inabissarsi nelle profondità e accrescere la suapotenza, non ritrova mai la sapienza che continuamente gli sfugge enon sa proprio ove si nasconda».11
Ma la sapienza donde si trae,e qual è il posto dell’intelligenza?L’uomo non ne conosce la via,né la si trova nella terra dei viventi.12
Dio ha un suo progetto misterioso che l’uomo con la sua esile mentenon riesce a percorrere; anche l’uomo è invitato a collaborare a questoprogetto cosmico - salvifico, ma è proprio l’uomo, l’unico tra gli esseridotato di libertà, che può sottrarsi a questo impegno, anzi che puòostacolarlo e tentare di demolirlo. Ma il piano divino non si arresteràmai: diversamente dalle macchinazioni umane, esso è efficace, irrevocabile,dinamico e storico e pedagogico. Dio invita Giobbe a liberarsi dagli schemiin cui era caduto, a distruggere le oggettivazioni dei propri stati psichiciin Dio che diventava giudice, nemico, arciere, belva solo perché questiaspetti altro non erano che la proiezione dell’angoscia di Giobbe. Dio loinvita a porsi a livello del reale, dell’essere. Questa è la nuova stradasulla quale Giobbe si deve incamminare. 13 Giobbe deve liberarsi nonsolo di quelle false rappresentazioni di Dio che tanto stanno a cuoreai suoi amici, ma deve anche abbandonare ogni pretesa di conoscenzaperché solo così - paradossalmente e ironicamente, come in una tragediagreca - arriverà a capire.
La scoperta dell’incomprensibilità di Dio, dell’impossibilità di inqua-drarlo in uno schema razionale di fini ragionevoli è un punto decisivoper varcare la soglia della fede. «Cos’è dunque ciò che importa nellastoria di Giobbe? Che noi ammettiamo tranquillamente e semplice-mente la nostra incapacità di spiegare l’enigma del dolore e del male.Oppure, per esprimerci in forma positiva, che abbiamo in partenza unafiducia totale, incondizionatamente esclusiva in Dio».14 E, se vogliamo,è questa l’unica forma di conoscenza concessa all’uomo: una nuovaesperienza di Dio a cui si è giunti proprio abbandonando ogni pretesadi conoscenza. E Giobbe stesso, per certi versi in modo simile a Edipo,per altri in modo opposto al suo, dirà alla fine:
Comprendo che tu puoi tuttoe che nessun progetto per te è impossibile.Chi è colui che, da ignorante,
11 Ivi, pag. 62.12 Gb, 28, 12-13.13 Cfr. Ravasi (1979), pag.735 e ss.14 H. Küng, Dio e il dolore, Brescia 1968.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 38 — #38 ii
ii
ii
38 Capitolo 6
può oscurare il tuo piano?Davvero ho esposto cose che non capisco,cose troppo meravigliose per me, che non comprendo.Ascoltami e io parlerò,io t’interrogherò e tu mi istruirai!Io ti conoscevo solo per sentito dire,ma ora i miei occhi ti hanno veduto.15
Il «sentito dire» è la tradizione teologica degli amici di Giobbe; il«vedere», vertice della fede, è l’esperienza diretta e radicale di Dio. Allafine, infatti, Giobbe arriva a capire, a conoscere il nuovo vero volto diDio. Conoscenza che non è comprensione logica di Dio - la mente umanaè troppo limitata per questo - ma accettazione incondizionata del suopiano, accettazione del fatto di non poter avere una risposta all’enigmadella sofferenza. In questo le due storie di Edipo e Giobbe si somigliano:nessuno dei due comprende il perché del dolore, e soprattutto deldolore innocente; ma a Edipo, nel suo mondo sovradeterminato, nonresta altro che accettare il male; a Giobbe invece, pur rimanendo senzarisposte, si spalanca una nuova strada, fatta di cieca fiducia, di fede, maanche di speranza.
15 Gb, 42, 2-6. Corsivi miei.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 39 — #39 ii
ii
ii
7 Conclusione
Edipo e Giobbe. Due nomi, due modi di tener testa alla sfida del dolore,sfida che è, sostanzialmente, la vita. Due culture si raffrontano nelrisolvere il problema del male, due gli esiti a cui giungono. Da unaparte Edipo, un dolore innocente provocato dal dio che, svelando, fadeviare l’uomo. L’uomo si trova al centro di una serie di forze moltopiù grandi di sè, che ne determinano il cammino. Edipo, nonostanteabbia un suo margine di libertà d’azione, viene condotto in erroredall’enigmaticità del mondo, degli dei, della vita.
Dall’altra parte Giobbe, un altro innocente che soffre; ma il suomondo non è determinato dal destino, l’uomo biblico è una creaturaassolutamente libera e per questo capace di modellare la propria vitanella maniera in cui desidera. Pure Giobbe, senza volerlo, senza avercommesso alcuna colpa, soffre. E allora grida, si rivolge a quel Diodell’Alleanza, che non è rimasto ai patti. In gioco non c’è solo la rispostaal dolore, ma è a rischio la fede stessa: «Come si può prestar fede a unDio che non rispetta gli accordi?».
Nikolaj Berdjaev (1874-1948), filosofo russo, scrive nei Cahiers de laQuinzaine:
La comparazione del libro di Giobbe con la tragedia greca, con l’Edipo di Sofoclerende evidente la differenza che esiste tra il tipo ebraico-biblico e il tipo greco -classico. Nell’Edipo è la sottomissione al destino che ci sconvolge. Le parole e legesta di Edipo sono belle per il loro spirito di misura e sottomissione. Racchiudonoin sé una trasfigurazione estetica del dolore. Non c’è nessuno a cui Edipo possaappellare per la sua sofferenza innocente, nessuno contro cui possa lottare. Edipovive in un mondo chiuso in modo immanente e per lui non c’è una potenza su cuiappoggiarsi nella lotta contro il mondo. Il mondo è pieno di dei ma questi dei sonoimmanenti al mondo e il destino regna ugualmente su di essi, quel destino cheimpose a Edipo la sua sofferenza innocente, tragica e senza uscita. Una soluzioneestetica è la sola possibile. L’ antichità classica non conosceva lotta con Dio. MaGiobbe vive in modo ben diverso la sua tragedia. Egli non conosce né sottomissionené tranquillità. Giobbe grida di dolore e il suo grido riempie la storia universale erisuona ancora ai nostri orecchi. Nel grido di Giobbe sentiamo la sorte dell’ uomo.Per Giobbe il destino non esiste come invece nel caso di Edipo. Egli conosce lapotenza di colui che è sopra del mondo, sopra del destino, al quale è possibileappellare per la sofferenza; egli getta a Dio il suo grido e questo grido diviene unalotta contro Dio. Solo la Bibbia conosce il fenomeno della lotta con Dio, della lottafaccia a faccia, della lotta di Giacobbe, dell’Israele tutto.
Due modi dunque di vedere la sofferenza, due modi di esistere. Dueanche gli effetti che da quel dolore nascono: da una parte si scopre lacontraddizione della vita, che mostra, attraverso l’ironia tragica, comel’azione si rovesci nel suo opposto, come ogni cosa non possieda solo unsenso, ma molteplici, a cui l’uomo difficilmente può accedere. All’uomonon resta altro che constatare tutto ciò e accettare semplicemente che
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 40 — #40 ii
ii
ii
40 Capitolo 7
il dolore esista. Dall’altra parte invece si scopre il paradosso: partendoda presupposti generalmente riconosciuti come validi, si giunge a con-clusioni contrastanti con l’esperienza. Dio infatti non è quello che si diceche sia; per definirlo, per credervi, bisogna compiere un cammino che èassolutamente antitradizionalista, personale, nuovo, ogni volta diverso.
Il dolore, in Giobbe come in Edipo, può distruggere un uomo. Diventainvece sopportabile se c’è un dio da interpellare, un dio a cui rivolgersi.E se si scopre che quel dolore, per quanto incomprensibile, rientra in unpiano, anche se di quel piano non possiamo conoscere nulla, allora essoassume un senso; e la speranza che deriva da questa certezza, speranzaunita alla fede nel caso specifico di Giobbe, è ciò che fa in modo chel’uomo eviti di cadere nel profondo abisso della sofferenza.
ii
“Tesi” — 2014/10/1 — 10:53 — page 41 — #41 ii
ii
ii
Bibliografia
Aristotele (1998), Poetica, a cura di Guido Paduano, Laterza.Avezzù, Guido (2003), Il mito sulla scena, Marsilio.– (a cura di) (2008), Edipo. Variazioni sul mito, Marsilio.Bettini, Maurizio e Giulio Guidorizzi (2004), Il mito di Edipo, Einaudi.CEI (a cura di) (2008), La Bibbia di Gerusalemme, Edizioni Dehoniane
Bologna.Ciampa, Maurizio (2005), Domande a Giobbe, Bruno Mondadori.Curi, Umberto e Martina Treu (a cura di) (1997), L’enigma di Edipo, Il
Poligrafo.Di Marco, Massimo (2009), La tragedia greca, Carocci.Kallen, Horace. M. (1918), The book of Job as a Greek tragedy restored,
Moffat, Yard.Natoli, Salvatore (2008), Edipo e Giobbe. Contraddizione e paradosso, Mor-
celliana.Omero (2000), Odissea, a cura di Enzio Cetrangolo, Fabbri Editori.Paduano, Guido (2008), Edipo. Storia di un mito, Carocci.Pasquero, Fedele (a cura di) (1978), La Sacra Bibbia, Edizioni Paoline.Ravasi, Gianfranco (1979), Giobbe, Edizioni Borla.– (2003), Il libro di Giobbe, Edizioni Dehoniane Bologna.Serra, Giuseppe (1994), Edipo e la peste, Marsilio.Vernant, Jean-Pierre e Pierre Vidal-Naquet (1972), Mito e tragedia nell’an-
tica Grecia, Einaudi.West, Martin Litchfield (1997), The east face of Helicon, Oxford: Clarendon
Paperbacks.