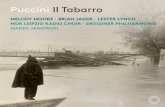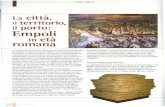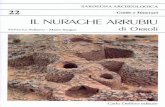Medaglia, F. (2015): Il mistero della strada di Sintra di Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. Il...
Transcript of Medaglia, F. (2015): Il mistero della strada di Sintra di Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. Il...
L’autorialità plurimaScritture collettive, testi a più mani, opere a firma multipla
Atti del XLII Convegno Interuniversitario(Bressanone, 10-13 luglio 2014)
a cura di Alvaro Barbieri e Elisa Gregori
Questo volume è stato stampato con il contributodel Dipartimento di Studi linguistici e letterari
dell’Università degli Studi di Padova
ISBN 978-88-6058-042-9© 2015 Esedra editrice s.a.s.via Hermada, 4 - 35141 PadovaTel e fax 049/723602e-mail: [email protected]
INDICE
Alvaro Barbieri - Furio Brugnolo Premessa IX
Giuliana Benvenuti - Remo Ceserani Autoricollettiviecreazionedicomunità:ilcasoWuMing 1
Andrea SciutoChiracconta,chièraccontato.IcasidiTimiraePoint Lenana 15
Tommaso MeozziInformaticaeautorialitàmultipla:apartiredaSIC 33
Renato NicassioScriverealgoritmicamente.Invisible Seattle,ilromanzodiunacittàscrittodaunacittà 47
Leonardo TerrusiIlnomedell’autoremultiplo 61
Angela FabrisIllimitesfuggentedell’autorialitàplurima:ilcasodeigemelliPressburger 75
Piero Severi - Bianca BaratelliL’enigmaF&L.ComelavoravanoFrutteroeLucentini
87Helmuth MeterBoileau-Narcejacolascritturaeterodossa.Comenascelasuspensedalconnubiodiduementiautonome 107
Marie Luise WandruszkaLa famiglia Floriani(1951)diIngeborgBachmann,JörgMautheePeterWeiser 117
Leonardo VileiIlromanzoenigmaageometriavariabile.IltrioBorges,BioyCasares,Ocampo 129
Elisa GregoriPaulValéry-CatherinePozzi:unascritturaaquattromani? 143
Alexandra VranceanuLereinvenzionedellarelazioneautor-scriptornelromanzoLa famille PerlmutterdiPanaitIstratieJosuaJéhouda 159
Stefania SiniLaplurivocità“ipocrita”.ApropositodeitesticontroversidiMichailBachtin 175
Mario DomenichelliLa natura del reato.IromanziaquattromanidiJosephConradeFordMadoxFord 191
Patrizia MuscaEliot,PoundeThe Waste Land 203
Bruno CapaciLafabbricadellibretto.LascritturaapiùmanidiTosca 223
Francesca MedagliaIl mistero della strada di SintradiEçadeQueirozeeRamalhoOrtigão.Ilgiallonellascritturaaquattromani 235
Donatella Siviero IlromanzocollettivoinSpagnatraOttoeNovecento.DaLas vírgenes locas(1886)aEl nadador(1998)e¿Quién teme a papá Noel?(1998)247
Edgar Sallager EdmondeJulesdeGoncourt:unejumellitélittéraire 267
Attilio Motta Uno,nessunoeiMille.Perunacasisticarisorgimentaledell’autorialitàcomplessa 281
Adone BrandaliseAllesogliedelsistema.MitdenkenemitologiadellaragioneneIl più anticoprogramma di sistema dell’Idealismo tedesco 297
Mario ManciniIlcasoDiderot 305
Kazuaki UraIlgenereRengael’autorialitàplurima 319
Carlo CeniniUncanzoniereapiùmani 335
Tina Matarrese L’Orlando innamorato:uncasospecialediautorialitàmultipla? 353
Stefano PezzèSulprocessoelaborativodelCertame coronario 365
Patrizio Tucci Moriredisetevicinoallafontana.Charlesd’OrléanselapolifoniapoeticaallacortediBlois 379
Michael RyzhikPredicheesermonidiRobertoCaracciolo:frareportationeseoperaindividuale 405
Danielle Buschinger LeRappoltsteiner Parzifal:dixauteursàl’œuvre 421
Veronica Orazi«ElReyfazeunlibro,nonporquelescrivaconsusmanos»(General Estoria,I,216R).AlfonsoXele escuelas alfonsíes:paradigmadiautorialitàmultipla 431
Alvise Andreose Il Devisement dou mondeeilprogettoeditorialediRustichellodaPisa 443
Indicedeinomi 461
Francesca Medaglia
IL MISTERO DELLA STRADA DI SINTRADI EÇA DE QUEIROZ E RAMALHO ORTIGÃO.IL GIALLO NELLA SCRITTURA A QUATTRO MANI
1. La scrittura a quattro mani, una proposta di definizione
La mia analisi si focalizza sul romanzo Il mistero della strada di Sintra di Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão e, di conseguenza, sulla questione del genere giallo-noir in relazione alla scrittura a quattro mani. La definizione rigorosa della prassi scrittoria a quattro mani e la descrizione delle diverse forme di cooperazione tra scrittori, che appaiono un fenomeno multifor-me e variegato, eccederebbe necessariamente lo spazio disponibile in que-sto contributo.1 Pur tenendo conto di questa esigenza, sembra opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari volte ad inquadrare il tema pro-posto dal punto di vista teorico ed a introdurre l’analisi dell’opera Il mistero della strada di Sintra.
Per l’importanza della questione autoriale, in relazione alla coopera-zione di due scrittori, opportunamente Wellek e Warren sottolineano: «Tuttavia il libro rimane un autentico esempio di una collaborazione in cui l’autore risulta dal comune accordo di due scrittori, e anche se nella termi-nologia, nel tono e nell’espressione rimangono senza dubbio alcune lievi discordanze tra i due scrittori, tuttavia essi osano credere alla possibilità di una compensazione di questi limiti nel fatto che due diverse intelligen-ze abbiano raggiunto un accordo così sostanziale».2 Mentre i due studiosi formulano questa definizione a proposito della loro collaborazione per il volume Teoria della letteratura, ho ritenuto possibile e fruttuoso utilizzare questa affermazione in ambito letterario, in quanto da essa emergono alcu-ne caratteristiche notevoli della scrittura a quattro mani, tra cui la volontà condivisa e la programmazione consapevole della cooperazione tra i due autori. Inoltre da quella affermazione si può anche proficuamente dedur-re come la sintesi tra le conoscenze dei due scrittori produca un testo più esauriente di quanto sarebbe stato possibile ottenere dai singoli studiosi.
Lo stesso tipo di operazione è stato realizzato anche per quanto riguarda
1 Rimando, per questo, al mio recente volume F. Medaglia, La scrittura a quattro mani, Lecce-Brescia, Pensa Multimedia, 2014.
FRANCESCA MEDAGLIA236
un breve brano tratto da Poetica del diverso di Glissant, in cui viene descritto il meccanismo di creolizzazione, da me adottato in un’accezione autoriale: «La creolizzazione esige che gli elementi eterogenei messi in relazione ‘si intervalorizzino’, che non ci sia degradazione o diminuzione dell’essere, sia dall’interno che dall’esterno, in questo reciproco, continuo mischiarsi».3 È necessario sottolineare come anche nello studio dei mutamenti linguistici in ambito creolo, nell’elaborazione di Glissant, la mescolanza di elementi etero-genei porta ad un prodotto che preserva i caratteri antecedenti (senza che ci sia alcuna diminuzione), elaborandoli in forme innovative ed imprevedibili.
Dopo aver delineato queste rapide considerazioni di natura teorica è possibile fornire una definizione sintetica ed operativa della scrittura a quattro mani, come una prassi che implica la cooperazione progettata e cosciente di due o più autori e che conduce ad una intersezione innovativa, accrescitiva ed indeterminata dei contributi autoriali.
2. Il genere giallo-noir nella scrittura a quattro mani
Passando ora all’argomento specifico di questo contributo, ovvero il genere giallo-noir in riferimento alla scrittura a quattro mani, si possono presentare alcune necessarie considerazioni. L’analisi della produzione di opere di prosa e di poesia scritte a quattro mani consente di affermare che la scrittura a quattro mani influisce sulla scelta del genere letterario da par-te degli autori: in particolare, considerando i vari periodi storici, si osserva che gli autori si sono serviti di un genere piuttosto che di un altro per la scrittura dei propri testi a quattro mani.
L’ indagine sulla produzione a quattro mani, edita dal 17004 al 2013, che rappresenta l’arco temporale significativo, è condotta sulla base della catalogazione delle biblioteche nazionali e dei repertori bibliografici delle maggiori case editrici degli stati considerati, che definisco per comodità “occidentali”.5 Può essere anche probabile che la pur ampia indagine non
2 R. Wellek, A. Warren, Teoria della letteratura, Bologna, il Mulino, 1991, p. 10.3 É. Glissant, Poetica del diverso, Roma, Meltemi, 1998, p. 16.4 Cfr. F. Medaglia, La scrittura a quattro mani, cit., p. 36: in relazione alla modernità, è
possibile datare, con relativa sicurezza, il primo esempio di opera composta a quattro mani al 1741, quando fu pubblicata l’opera Le memorie di Martino Scriblero, scritta da J. Arbuthnot, J. Gay, T. Parnell, A. Pope e J. Swift. Non è, infatti, da prendere in considerazione la let-tera di Baldassarre Castiglione e Raffaello a papa Leone X sulle rovine di Roma (1519), in quanto non essendovi nessuna creolizzazione autoriale, né una progettualità di scrittura, non può in alcun modo essere considerata a quattro mani; così anche per le due lettere scritte da A. Mascardi a C. Achillini (1630) e per l’“eroica amicizia” di M. Trevisan e N. Barbarigo. La medesima deduzione può essere fatta per i tensos e i partimens occitanici, in quanto non è presente né una componente progettuale, né una creolizzazione autoriale.
5 L’indagine su questa produzione si riferisce in particolare agli stati seguenti: Portogallo, Spagna, Inghilterra, Francia, Svezia, Danimarca, Germania, Italia e Stati Uniti d’America.
IL MISTERO DELLA STRADA DI SINTRA 237
sia del tutto esaustiva, ma certamente è abbastanza rappresentativa dell’in-sieme di opere pubblicate negli stati suddetti.6 Un dato emerge con evi-denza: nella scrittura a quattro mani vi è un inizio, in cui è presente un netto predominio della poesia sulla prosa, ma nel corso del tempo, questa tendenza si inverte a favore di un netto predominio della prosa.
Per l’approfondimento dell’analisi si rende necessario comprendere an-che quali siano i “sottogeneri”, che vengono ad essere la linfa stessa della scrittura a quattro mani. Grazie alle statistiche elaborate, si può osservare che nella letteratura a quattro mani alcuni sottogeneri dominano nettamen-te su altri, come, ad esempio, avviene con il romanzo giallo e noir, che occu-pa addirittura il 27% di tutte le opere censite dal 1700 al 2013 (Grafico 1).
Grafico 1: Sottogeneri in prosa
(Fonte: elaborazione propria su un campione di dati da me raccolti e catalogati fino a dicembre 2013).7
L’evidenza dei dati e la suddivisione della produzione complessiva dei testi scritti a quattro mani per i periodi, che sono oggetto dell’indagine,
6 Nonostante ciò, non è possibile affermare che il campione considerato (che include oltre mille opere) sia esaustivo dell’intero fenomeno. Data la natura sperimentale di tale raccolta di dati non è possibile escludere che, in taluni casi, le differenze linguistiche abbiano potuto condurre ad una sovrastima del fenomeno in alcuni ambiti nazionali a discapito di altri. Per un elenco completo delle opere catalogate, si veda: Medaglia, La scrittura a quattro mani, cit., pp. 273-328.
7 Ivi, p. 45.
FRANCESCA MEDAGLIA238
consentono di affermare che il rapporto dell’incremento/decremento della scrittura a quattro mani e dei suoi generi, nel corso del tempo, non subisce significativi mutamenti (Grafico 2).
Grafico 2: Letteratura a quattro mani. Sottogeneri per periodo storico
(Fonte: elaborazione propria su un campione di dati da me raccolti e catalogati fino a dicembre 2013).8
Il romanzo giallo e noir a quattro mani comincia ad acquisire una certa diffusione già nel XX secolo per arrivare nel primo decennio del XXI se-colo alla sua esplosione, ed appare evidente che tra i generi e i sottogeneri analizzati quello che meglio rappresenta la prassi della scrittura a quattro mani è certamente questa tipologia di romanzo.
Sembra utile sottolineare che utilizzo l’etichetta “giallo e noir” per un discorso di comodità e non perché fino ai primi anni Novanta del Novecen-to i due termini erano totalmente sovrapponibili: in concreto la uso come un’etichetta elastica, che vuole comprendere tutti i romanzi appartenenti ai sottogeneri giallo, noir e postnoir, avendo come punto di riferimento plau-sibile l’idea di una contaminazione tra i generi.
Un dato appare significativo per l’analisi: il rilevante incremento nella produzione di gialli e noir ha prodotto una serie di accuse a questo tipo di
8 Ibidem.
IL MISTERO DELLA STRADA DI SINTRA 239
romanzi, ed in particolare, come sostiene Mondello, quella di essere solo una «moda, seppur non effimera, figlia della vacuità della comunicazione dei media che alimentano un ‘vuoto’ culturale fatto da un ‘troppo pieno’, che consiste in una folla di autori e di titoli privi di una reale energia narrati-va». Sembra ovvio pensare che questo incremento nella produzione di “gial-li” e noir possa spiegare, almeno in parte, un dato evidente: la presenza di tanti testi composti a quattro o più mani all’interno di questo sottogenere.
Sotto questo aspetto la scelta di scrivere a quattro mani all’interno del sottogenere giallo-noir, sembra anche essere determinata dall’idea, presu-mibilmente insita nella mente degli autori, che, se un numero maggiore di focalizzazioni è presente all’interno della trama giallistico-poliziesca, mag-giore diviene la possibilità di fornire elementi allegorici di soluzione del delitto al lettore. La riflessione ovvia può essere questa: la differenza di focalizzazioni proprie, una del giallo e una del noir (ovvero una del detective e una dell’assassino), può comportare la ricerca di un preciso obiettivo, per cui all’interno del testo composto da due autori si tende a realizzare una fo-calizzazione multipla e anche “dialogica” tra gli autori e i loro personaggi.
3. Il mistero della strada di Sintra
Il mistero della strada di Sintra di Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão, edi-to nel 1884, ricopre un ruolo di particolare importanza, in quanto sembra essere il primo romanzo giallo-noir scritto a quattro mani11 ed, inoltre, co-stituisce una delle testimonianze più interessanti12 della scrittura a quattro mani nell’ambito della letteratura portoghese.13
9 E. Mondello, Scritture di genere. New Italian Epic o post-noir? Il noir negli Anni Zero: una querelle lunga un decennio, in Roma Noir 2010. Scritture nere: narrativa di genere, New Italian Epic o post-noir?, a cura di E. Mondello, Roma, Robin, 2010, p. 15.
10 Mi limito a citare la scrittura a quattro mani di C. Fruttero e F. Lucentini, tra cui si ricor-dano tra gli altri Enigma in luogo di mare (1991) e La donna della domenica (1972); Il codice del quattro di I. Caldwell e D. Thomason, (2007); Chosen di P. C. Cast e K. Cast (2010); Non tornare a Mameson (2007) e La forgia del diavolo (2009) di M. Lanteri e L. Luini, solo per citare i due testi più famosi della produttiva coppia di collaboratori; Non aprire questo libro di M. Muntean e P. Lemaitre (2010) e Cartoline di morte di J. Patterson e L. Marklund (2010); L’ultima risposta di Einstein di A. Rovira e F. Miralles (2010); Tre secondi di A. Roslund, B. Hellström (2010); Nero riflesso di Elias Mandreu (2009); Delitto capitale di G. Leoni e M. Pietroselli (2010); L’esecutore (2010), L’ipnotista (2010), La testimone del fuoco (2012) e L’uomo della sabbia (2013) di L. Kepler (pseudonimo di Alexander Ahndoril e Alexandra Coelho Ahndoril); Tempesta a quattro mani di A. Hay e P. Malara (2000); Il labirinto dei libri segreti di P. Di Reda e F. Ermetes (2010) e, in-fine, Il compagno sbagliato di S. Bigazzi e V. Guerrazzi (2010); senza dimenticare il “decalogo” dell’ispettore Martin Beck di M. Sjöwall e P. F. Wahlöö.
11 Questo romanzo è il primo esempio del “sottogenere” giallo-noir del campione da me indagato: Medaglia, La scrittura a quattro mani, cit., pp. 61-75.
12 È stato tratto dal libro un famoso film, ad opera del regista portoghese J. Paixão da Costa, uscito nelle sale cinematografiche nel 2007 con il titolo O mistério da estrada de Sintra.
13 Non è certo l’unico però, e tra gli altri è sufficiente citare: Novas cartas portuguesas, delle
FRANCESCA MEDAGLIA240
Questo romanzo d’appendice, apparso a puntate sul quotidiano «Diário de Notícias» a partire dal 23 luglio 1870, apparentemente era offerto ai lettori sotto l’ingannevole forma di un servizio di cronaca nera su un omi-cidio e sugli sviluppi delle relativa inchiesta di polizia. Solo l’ultima lettera, inviata il 27 settembre dello stesso anno, svelava ai lettori che si era trattato di una “finzione letteraria”; si legge infatti: «Signor redattore del ‘Diário de Notícias’. Poiché, come avrà notato, nell’intero racconto che da due mesi si pubblica nell’appendice del suo giornale, non c’è un solo nome che non sia casuale, né un solo luogo che non sia ipotetico, si ritenga autorizzato da queste parole a datare l’epilogo della storia in questione: Lisbona, 27 settembre 1870, e a sottoscriverla con i nomi dei due firmatari di questa let-tera. Abbiamo l’onore di essere, ecc. Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão».14
La pubblicazione di questo romanzo coincide approssimativamente, come osserva Di Munno, «all’epoca in cui il romanzo poliziesco, con le opere di Gaboriau su Monsieur Lecoq e soprattutto con quelle di Conan Doyle su Sherlok Holmes, evolve dalla fase della mera osservazione a quella più complessa della deduzione logica a partire dagli indizi».15 La scoperta del colpevole viene ad essere, quindi, un vero e proprio “esercizio di intel-letto”, che «[…] si suppone rigoroso ed esatto e che si pensa possa mirare, nello stesso tempo, a sconcertare e soddisfare il lettore».16
Il racconto inizia con il rapimento di un medico, il Dott. ***, e di un suo amico, lo scrittore F., mentre si trovano «a circa metà strada fra S. Pedro e Cacém»17 da parte di tre malviventi mascherati. I due amici rapiti vengono portati in una casa misteriosa, dove si trova il cadavere del signor Rytmel e dove i rapitori pre-tendono che il Dott. *** constati il decesso. Rytmel era un ufficiale britannico morto a causa di una dose eccessiva di oppio, che gli era stata somministrata dalla sua amante Luisa, la contessa di W., sposata con un uomo ricco che, però, non la rendeva felice. Lo svolgimento della trama prosegue attraverso le lettere che giungono al gior-nale dal Dott. ***, da F. e da A.M.C., un giovane e onesto studente di Coimbra, disposto ad aiutare la contessa, dopo che questa gli ha svelato, durante il loro primo incontro, la sua infelicità. La narrazione, poi, si complica e si intreccia ulteriormente, con l’apparizione di nuovi personaggi, tra cui Miss Shorn, che scatena la gelosia di Luisa, in quanto sospetta che il giovane e bello ufficiale Rytmel si voglia fidanzare con lei. È proprio il giovane ed inesperto A.M.C.
cosiddette Tre Marie: I. Barreno, M. T. Horta, M. Velho Da Costa (Le nuove carte portoghesi, Milano, Rizzoli, 1977) e Os olhos do homen que chorava no rio di A. P. Tavares e M. J. Marmelo (Os olhos do homen que que chorava no rio, Lisboa, Camino, 2005).
14 J. M. Eça de Queiroz, J. D. Ramalho Ortigão, Il mistero della strada di Sintra, trad. it. A. Di Munno, Palermo, Sellerio, 1989, p. 274.
15 Ivi, p. 283.16 Ibidem.17 Ivi, p. 17.
IL MISTERO DELLA STRADA DI SINTRA 241
a svelare, sempre con una lettera al giornale, il mistero celato dietro questo racconto: con l’apertura delle lettere private di Rytmel, si scopre sia che Luisa non è mai stata tradita, sia che lei stessa ha ucciso involontariamente il giovane amante. Infatti Luisa ha somministrato al giovane una dose eccessiva di oppio, senza rendersene conto, con il solo fine di farlo addormentare e frugare tra le sue carte in cerca di una prova del suo tradimento.
Il romanzo è stato erroneamente definito come «un “giallo”, prolisso, pasticciato, noioso, con un finale deludente, e per giunta anche involuto e difficile da seguire».18 Questo giudizio sembra, però, quantomeno affret-tato e semplicistico: occorre esaminare, pertanto, attentamente alcuni ele-menti per trarne le motivazioni riguardanti la poetica di Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão.
I due autori, seppur geograficamente distanti (uno era a Leira e l’altro a Lisbona)19 decidono di scrivere insieme «senza un programma, senza un metodo, senza un modello, senza una documentazione, senza uno stile, riti-rati nella semplice “torre di cristallo dell’immaginazione” […] ci demmo al compito di improvvisare questo libro»,20 come recita la Lettera all’editore del “Mistero della strada di Sintra”, premessa al romanzo, in cui vengono spiegate le motivazioni sottese alla riedizione del libro. Questa lettera racchiude le premesse ideologico-stilistiche dei due autori e ben rappresenta la carica ironica che serpeggia in tutto il romanzo;21 da questa chiara affermazione si comprende come i due autori avversino la scrittura artefatta e barocca dei loro predecessori romantici portoghesi e decidano di orientarsi verso una scrittura più spoglia ed incisiva, basata su di una ‘particolare’ imma-ginazione ben ancorata agli aspetti realistici: sotto questo aspetto Il mistero della strada di Sintra presenta i caratteri di un romanzo profondamente con-traddittorio, che trae la sua forza letteraria dalla mescolanza di razionalità ed emotività.
La sezione successiva della Lettera è di notevole interesse, in quanto i due autori tendono a ribadire la portata innovativa del loro testo: «[a dif-ferenza nostra] i nuovi scrittori non avanzano di un passo che non posi sull’orma lasciata da altri».22 Da questa osservazione pare evidente che essi legano la giovinezza di uno scrittore alla sua carica innovativa e la sua vec-chiaia all’idea di una immobilità della scrittura e ad una totale assenza di innovazione. Infatti essi sottolineano che «A vent’anni è necessario essere bizzarri forse non sempre perché il mondo progredisca, ma per lo meno
18 U. Randone, Recensione a “La città e le Montagne”, disponibile su: <www.tiraccontoiclasici.it/opera.php?id=178> (06/2014).
19 Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Il mistero della strada di Sintra, cit., p. 9.20 Ivi, p. 9.21 Ivi, p. 10.22 Ivi, p. 12.
FRANCESCA MEDAGLIA242
perché il mondo [della letteratura] si agiti. Per essere ponderati, corretti e immobili c’è tempo d’avanzo nella vecchiaia».23 Per loro i giovani raffigu-rano l’invenzione, il potere creativo e l’originalità artistica grazie proprio alla loro «indisciplina»24 e alla loro «ribelle forma di resistenza alle correnti della tradizione»:25 sembra evidente che i due autori si schierano contro la tradizione, cioè contro il “canone” già stabilito, e a favore di una rottura degli schemi letterari fissati in precedenza. La “giovinezza”, che richiamano come criterio di giudizio, non è quella biologica o anagrafica, ma quella letteraria: l’autore deve essere “giovane”, come “giovane” deve essere la sua scrittura.26 Pertanto questo testo «può contenere, per una generazione che ha bisogno di riceverla, un’utile lezione di indipendenza».27
Il piano del reale e quello del “fantastico” vengono mescolati e, quindi, il racconto rimane sempre in bilico tra una “verità romanzesca” e un “roman-zo realista” immerso nella «veste letteraria di un dramma misterioso».28 Ciò comporta uno straniamento, che viene creato dai due autori, ed è alimen-tato continuamente: pertanto non è possibile comprendere, fino a L’ultima lettera inviata dai due autori al giornale, se essi presentino informazioni su un omicidio realmente avvenuto o se si tratti di un romanzo; ed infatti in una lettera inviata al giornale, un lettore, Z., afferma: «Il mistero della strada di Sintra è un’invenzione: non un’invenzione letteraria, come dapprima ho creduto, ma un’invenzione delittuosa, con un fine determinato».
Un ulteriore elemento deve essere preso in considerazione. I due scrit-tori riescono, sempre grazie ad indicazioni sparse attraverso l’opera, a muovere delle profonde critiche al romanzo portoghese contemporaneo, affermando, ad esempio: «Quella povera contessa adora il romanzesco! In Portogallo non lo si trova neppure nei romanzi»;30 come conseguenza a questa critica alla situazione della letteratura contemporanea, dichiarano il loro modo di scrivere: la scrittura risulta da ciò che lo scrittore vive in prima persona nella realtà. Infatti per loro «[…] quando il romanzo, che è oggi una forma scientifica appena balbuziente, avrà raggiunto l’evoluzione che gli spetta come espressione della verità, i Balzac e i Dickens, attraverso una sola passione, risaliranno a un carattere completo e a tutta la psicologia di un’epoca così come i Cuviers già oggi ricostruiscono un animale sconosciu-to attraverso un unico osso».31
23 Ibidem.24 Ibidem.25 Ibidem.26 Ibidem.27 Ivi, p. 12.28 Ivi, p. 95.29 Ivi, pp. 94-95.30 Ivi, p. 108.31 Ivi, p. 182.
IL MISTERO DELLA STRADA DI SINTRA 243
Questa affermazione si comprende senza alcuna difficoltà, perché si collega perfettamente con le questioni che interessavano il gruppo degli scrittori di Coimbra, ovvero “la generazione del ’70”. Una di tali questioni è certamente legata alla necessità di una critica più marcatamente sociale, ed infatti i due autori prendono posizione anche in questo caso.32 È interes-sante notare che quest’opera viene utilizzata da Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão come una sorta di “manifesto” delle loro idee in campo letterario, oltre che sociale, tanto che arrivano ad affermare che l’unico modo per comprendere qualcosa davvero è scriverla.33 Sotto questo aspetto l’unica possibilità di analisi si ha attraverso la scrittura, che è anche l’unico modo di elaborare le proprie emozioni: «Raccontare un dolore è un po’ alleviar-lo».34 Da ciò scaturisce il presupposto critico-letterario che solo attraverso la scrittura si “purificano” le proprie idee e le proprie emozioni, e se questo è vero per Luisa, personaggio femminile del romanzo, è anche vero per Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão.
Bisogna anche sottolineare che la figura della donna in questo romanzo viene ad essere sempre centrale, anche in relazione all’idea che nel XIX secolo «l’emancipazione della donna è vista come un corollario dell’eman-cipazione del proletariato».35 La figura di Luisa è, per così dire, un vero e proprio “avvenimento”: è un’idea, una rappresentazione sociale plasmata dai due autori. Luisa è il personaggio per eccellenza: alcune volte rappre-senta la società, altre volte la voce dei due autori, altre ancora il romanzo stesso; è anche una sorta di moderna Didone, che si sente ferita e abbando-nata e vorrebbe uccidersi, ma in lei è presente il furore di una Medea che, folle di gelosia, vuole vendetta.36
Per la questione che qui interessa, quella della scrittura a quattro mani, la prima cosa da dire è che a partire dalla Lettera all’editore si comprende che quest’opera «[…] è il testimone dell’intima fratellanza di due vecchi uomini di lettere».37 In realtà non sembra possibile distinguere quali siano le parti attribuibili all’uno o all’altro scrittore, ma «già al primo sguardo è facile riconoscere la pennellata magistrale di Eça de Queiroz nella maggior parte dei capitoli del romanzo»,38 come ad esempio: «[…] chorei por me sentir chorar».39 Lo stile di entrambi gli autori è essenzialmente asciutto e lucido e, quindi, è piuttosto complicato riconoscere le diverse mani nel testo. Forse in alcuni punti – soprattutto nelle descrizioni dei luoghi e nelle
32 Ivi, p. 188.33 Ivi, pp. 208-209.34 Ivi, p. 217.35 A. Di Munno, Nota, cit., p. 284.36 Ivi, p. 231.37 Ivi, p. 13.38 Ivi, p. 282.39 «[…] piansi perché mi sentivo piangere»: ivi, p. 252.
FRANCESCA MEDAGLIA244
battute ironiche che puntellano il testo – si riesce ad intravedere la scrittu-ra di Eça de Queiroz, ma questa resta solo un’ipotesi. Ciò che importa in questo caso è che i due autori abbiano voluto comporre un romanzo come questo (esso è anche e soprattutto una dichiarazione di poetica), e che non abbiamo in alcun modo tentato di rendere riconoscibili le loro scritture.
Una serie di indicazioni per i lettori, da parte degli autori, sono pre-senti nel romanzo, nascoste ed inserite all’interno del racconto, come ad esempio: «[…] i lettori che tranquillamente leggeranno a casa loro questa lettera, potranno trarre migliori conclusioni, stabilire deduzioni più sicure e, attraverso l’induzione e la logica, avvicinarsi alla verità occulta».40 Inoltre è continuamente sottolineata l’importanza della figura del lettore con frasi come «[…] aspettare dagli altri, dal pubblico la soluzione del problema che non sapevo risolvere da solo»,41 poiché del resto, come sostiene F. Bertoni, «l’interesse non si fissa più sull’opera in se stessa ma sul rapporto comuni-cativo tra testo e lettore. In base a questa prospettiva, il lettore diventa una condizione indispensabile per l’esistenza dell’opera letteraria, una sorta di co-creatore che permette alla letteratura di essere ciò che è».42 Se questo è vero, nell’ambito della scrittura a quattro mani questo rapporto si moltipli-ca e si amplifica, perché “gli agenti” che si relazionano diventano tre: due autori e – almeno – un lettore.
I due autori, durante tutto lo svolgimento di questo racconto, si celano dietro al Dott. *** ed allo scrittore F., cercando di fornire ai lettori indi-cazioni, che consentano di comprendere la loro visione poetica. Sembra interessante sottolineare che, al termine dell’opera, i due autori scrivono: «F. e Carlos Fradique Mendes si trovano da alcuni giorni in una villa della periferia di Lisbona a comporre […] un libro che stanno scrivendo a quat-tro mani e nel quale […] porteranno a calci alla distruzione tutte le pastoie a cui le scuole letterarie imperanti in Portogallo hanno voluto assoggettare le inviolabili libertà dello spirito».43 In realtà questa è l’ennesima beffa dei due autori che si celano, in questa occasione, proprio dietro F. e Carlos Fra-dique Mendes per trattare, ancora una volta, del loro stesso libro appena terminato. Carlos Fradique Mendes è infatti un eteronimo collettivo creato dal gruppo “Cenáculo”, che era ospitato a casa di J. Batalha Reis e frequen-tato, tra gli altri, dallo stesso Eça de Queiroz. Il personaggio creato – per certi versi simile a Eça de Queiroz – si presenta come un immaginario poeta irriverente ed eccentrico, avventuroso e al passo con i tempi: la sua vita è narrata nel romanzo postumo La corrispondenza di Fradique Mendes. Memorie e
40 Ivi, p. 54.41 Ivi, p. 91.42 F. Bertoni, Il testo a quattro mani. Per una teoria della lettura, Firenze, La Nuova Italia,
1996, p. xi.43 Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Il mistero della strada di Sintra, cit., p. 273.
IL MISTERO DELLA STRADA DI SINTRA 245
note, pubblicato nel 1900,44 seguito poi da Cartas inéditas de Fradique Mendes e mais páginas esquecidas (1929).45
In conclusione in questo romanzo ciò che Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão rifiutano non è il canone classico, ma la tendenza di molti autori ad ancorarsi unicamente a quel canone senza modificarlo e trasformarlo, conducendo così la letteratura verso prove stilistiche che la portano ad ina-ridirsi: ed in questo senso l’uso della scrittura a quattro mani può essere una buona base da cui partire per rendere l’opera, come direbbero i due autori, più “giovane”.
44 Cfr. J. M. Eça de Queiroz, La corrispondenza di Fradique Mendes. Memorie e note, Reggio Emilia, Diabasis, 2008.
45 Cfr. Medaglia, La scrittura a quattro mani, cit., p. 74.