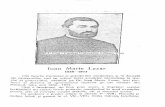In cerca del mistero. La “poetica vita” del giovane Bertolucci
La Vita Nuova, Marte, Venere, le eclissi e il mistero della lettera perduta
Transcript of La Vita Nuova, Marte, Venere, le eclissi e il mistero della lettera perduta
Rice University Alberto Pimpinelli September 4, 2015
La Vita Nuova, Marte, Venere, le eclissi e il mistero della lettera perduta
1. Introduzione La Vita Nuova è un libretto pieno di misteri. Frasi sibilline, dichiarazioni sconcertanti,
immagini astruse. E una lettera che non c’è.
Il libello, come Dante lo chiama, contiene una serie di componenti poetici—25 sonetti, 3
canzoni, 1 ballata, e 2 stanze di canzoni—accompagnate da parti in prosa che svolgono il ruolo
di commenti e di connessione tra le poesie. Canzoni e prosa si riferiscono all’incontro e successiva
“relazione” di Dante con la misteriosa Beatrice, e coprono un intervallo di tempo imprecisato che
termina dopo la morte di Beatrice.
L’opera è tradizionalmente divisa in 42 capitoli (31 secondo una recente proposta di Gorni)
preceduti da un Proemio in cui Dante dichiara:
In quella parte del libro della mia memoria dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit Vita Nova. Sotto la quale rubrica io trovo scripte le parole le quali è mio intendimento d'asemplare in questo libello, e se non tutte, almeno la loro sententia.
Questa frase non è anodina. Sappiamo ormai, dai lavori di Frances Yates, Paolo Rossi e
Mary Carruthers, che l’espressione libro della memoria è tipica di quell’Ars Memorandi che era una
componente essenziale della letteratura antica. Essa non si limitava ad essere una mnemotecnica,
ma era bensì una procedura che informava pienamente il processo inventivo della composizione
di un testo.
LETTERA PERDUTA !1
La mia ipotesi di lavoro, maturata a partire da un precedente lavoro , è che la Vita Nuova sia 1
un testo che riprende nella sua forma la struttura stessa della memoria dell’autore. In questo
lavoro preciserò quest’ipotesi, e la utilizzerò per identificare l’epistola che Dante in VN XXX
dichiara aver redatto in latino alli principi della terra, e di cui, se di una vera epistola si tratta, non si
è mai trovata traccia.
Quest’ipotesi ha avuto come punto di partenza l’osservazione di un fatto che mi parve
curioso. Il primo incontro di Dante con Beatrice è introdotto da un’elaborata perifrasi
astronomica (VN I) ed è inoltre caratterizzato dall’uso—due volte—del verbo apparire:
Nove fiate già apresso lo mio nascimento era tornato lo cielo della luce quasi a uno medesimo puncto quanto alla sua propria giratione, quando alli miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare. Ella era già in questa vita stata tanto, che nel suo tempo lo Cielo Stellato era mosso verso la parte d'oriente delle dodici parti l'una d'un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, e io la vidi quasi dalla fine del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore umile e onesto sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima etade si convenia.
Verso la fine dell’opera (VN XXXIX) un’immaginazione fa parere a Dante di assistere alla
ripetizione del primissimo incontro:
(…) si levò un die, quasi nell'ora della nona, una forte imaginatione in me, che mi parve vedere questa gloriosa Beatrice con quelle vestimenta sanguigne colle quali apparve prima agli occhi miei, e pareami giovane in simile etade in quale prima la vidi. Allora cominciai a pensare di lei, e ricordandomi di lei secondo l'ordine del tempo passato, (…)
Questa ripetizione mi sembrò dover alludere a un fenomeno periodico nel tempo, perché
non solo Beatrice appare nell’immaginazione vestita come nel primo incontro, ma anche della stessa
età. Inoltre, Dante afferma che a partire da quel momento is suoi ricordi riprendono secondo
l’ordine del tempo passato.
Siccome i fenomeni periodici per antonomasia sono astronomici, nacque in me l’ipotesi che
Dante si riferisse qui a congiunzioni planetarie. Più precisamente, alle congiunzioni di Marte e
Venere, che si ripetono (quasi) nello stesso punto dell’eclittica dopo un numero (quasi) intero di
anni, 32. Nel precedente lavoro1 non ho approfondito per motivi di spazio le ragioni di questa
scelta. E’ dunque opportuno rivedere in maggior dettaglio tutto l’argomentare. Per prima cosa,
esaminerò brevemente la questione delle tecniche di memorizzazione. In seguito, spiegherò come
e perché l’ipotesi di un sostrato astronomico della tecnica di memoria usata da Dante sia
A. Pimpinelli, Eclissi di sole, congiunzioni planetarie e “luoghi” di memoria: uno sfondo astronomico-mnemotecnico per la Vita Nova 1
di Dante? in corso di pubblicazione su l’Astronomia.
LETTERA PERDUTA !2
accettabile e a mio avviso plausibile. Ciò mi porterà a parlare delle configurazioni celesti alla data
di nascita del Poeta, nonché della possibile data di nascita di Beatrice. Descriverò quindi le
congiunzioni di Marte e Venere, discuterò come esse possano essere utilizzate in un’ars memorativa,
e quale sia la loro relazione con la struttura del libello. Passerò in seguito a discutere l’eclisse di
Sole del paragrafo XXIII, della morte di Beatrice, e della citata lettera ai principi della terra che
Dante dichiara aver scritto, ma che si suppone perduta. Utilizzando l’ipotesi che la Vita Nuova sia
strutturata come un “libro della memoria”, cercherò di dimostrare che questa lettera che non c’è,
è invece una delle epistole di Dante a noi note, quella che porta il numero XI nel moderno
catalogo, e che è chiamata “l’epistola ai Cardinali Italiani”. Si ritiene che essa sia la lettera che
Dante inviò (secondo quanto riporta Giovanni Villani) ai Cardinali italiani riuniti nel Conclave di
Carpentras del 1314, dopo la morte di Clemente V. Argomenterò che la lettera fu scritta subito
dopo il 1309, il che implica—cosa che qualche dantista, ma sono pochissimi, ritiene vera—che si
debba rivedere la datazione della Vita Nuova o perlomeno che si ammetta una stesura in più fasi,
con almeno una revisione posteriore al 1309.
2. Tecniche di memoria dall’antichità al Medio Evo La fonte principale—se non l’unica—delle nostre conoscenze in materia di memoria
nell’antichità è un manuale di retorica scritto nel I secolo a.C. da un ignoto insegnante per i suoi
allievi, e dedicato ad un altrettanto ignoto “Erennio”. Noto semplicemente come Ad Herennium, e
considerato per secoli opera di Cicerone, il testo contiene un capitolo sulla memoria in cui si
spiega che quest’ultima si divide in naturale e artificiale. La memoria naturale è la funzione
innata che ci permette di “memorizzare” le informazioni. La memoria artificiale è il risultato di
una specifica formazione che permette di rafforzare o confermare la memoria innata. L’Ars 2
Memorandi si basa sull’utilizzazione di una struttura artificiale, lo “sfondo”, e di “immagini”. Lo
sfondo è un insieme di “caselle” (loci), che possono essere le stanze di una casa, i recessi di una
stanza, o persino, come vedremo, i “gradi” dello zodiaco. In queste caselle vanno riposte i ricordi.
Le immagini (imagines) sono figure, segni od anche rappresentazioni del ricordo corrispondente,
che vanno riposte nella casella appropriata.
Sunt igitur duae memoriae: una naturalis, altera artificiosa. Naturalis est ea, quae nostris animis insita est et simul cum cogitatione 2
nata; artificiosa est ea, quam confirmat inductio quaedam et ratio praeceptionis.
LETTERA PERDUTA !3
L’autore dell’Ad Herennium spiega che se si conoscono le lettere dell’alfabeto si può scrivere e
leggere un testo. Ugualmente, lo sfondo della memoria artificiale è come una tavoletta di cera, su
cui le immagini sono disposte come le lettere di uno scritto. Ricordare diviene dunque un
processo analogo alla lettura. Proprio come la scrittura, le caselle dello sfondo devono essere
disposte in un ordine sequenziale preciso, di modo che non ci sia confusione quando si
recuperano le immagini. qualunque sia la loro posizione nelle caselle. La successione delle caselle
dello sfondo deve essere perfettamente appresa e rivista spesso, perché come la tavoletta di cera
viene più volte utilizzata dopo aver cancellato le lettere, così lo sfondo della memoria resta
immutato, mentre cambiano le immagini. Per facilitare la numerazione delle caselle, si può porre
un segno ogni cinque caselle. Ciascuno può costruirsi lo sfondo che preferisce, con il tipo de
caselle che preferisce, se si rispettano queste regole.
Venendo alle immagini, l’autore dichiara che poiché esse rappresentano oggetti concreti,
possono essere scelte in modo da rassomigliare o al tema trattato, o alle parole. Esse devono
comunque essere non banali per essere facilmente ricordate. Come l’esperienza quotidiana
mostra ci ricordiamo facilmente d’avvenimenti che escono dall’ordinario, e dimentichiamo gli
altri. Le albe e i tramonti sono eventi giornalieri, e si assomigliano tutti, ma le eclissi di Sole sono
fonte di meraviglia perché rare e costituiscono dunque un buon modello su cui costruire le 3
imagines della memoria.
Gli studiosi moderni sono rimasti a lungo perplessi di fronte a questi sistemi . In effetti, 4
come dichiara l’autore dell’Ad Herennium, ciò che si vuole ricordare deve comunque essere
imparato “a memoria” ossia immagazzinato dalla memoria naturale; perché allora aggiungere
allo sforzo di memorizzazione l’apprendimento dei loci e delle imagines della memoria artificiale?
L’autore dell’Ad Herennium è consapevole del problema, e dichiara che le immagini non
servono che a stimolare (exsuscitare) la memoria naturale . Che cosa ciò significhi è stato chiarito 5
Solis> exortus, cursus, occasus nemo admiratur, propterea quia cottidie fiunt; at eclipsis solis mirantur, quia raro accidunt, et solis eclipsis 3
magis mirantur quam lunae, propterea quod hae crebriores sunt.
L’esempio più lampante in questo senso è Frances Yates, che nel suo The Art of Memory si dice incapace di 4
comprendere appieno l’utilità dei loci e delle imagines.
Sed haec imaginum conformatio tum valet, si naturalem memoriam exsuscitaverimus hac notatione, ut versu posito ipsi nobiscum primum 5
transeamus bis aut ter eum versum, deinde tum imaginibus verba exprimamus. Hoc modo naturae subpeditabitur doctrina. Nam utraque altera separata minus erit firma, ita tamen, ut multo plus in doctrina atque arte praesidii sit.
LETTERA PERDUTA !4
da Mary Carruthers nel suo The Book of Memory : le immagini servono da “etichette”, da “punti 6
di riferimento” mnemonici che permettono di ritrovare e recuperare rapidamente l’informazione
conservata nelle memoria naturale. Come ella scrive dopo aver direttamente sperimentato
questa tecnica, “ciò che stavo dimostrando era il potere di questi strumenti mentali [le imagines]
non come congegni di memorizzazione, ma come strumenti di ritrovamento.” In altre parole,
memorizzare è inutile, se non si dispone di uno strumento efficace per ritrovare rapidamente i
ricordi quando servono. Questa è la vera funzione della memoria artificiale.
3. La Vita Nuova e il libro della memoria Il Proemio della Vita Nuova citato sopra è importante non solo perché Dante ivi utilizza
l’immagine classica—quella del libro—per parlare della memoria, ma anche perché pone il tema
della memoria in primissimo piano. Termini come sententia, nonché simulacra che ricorre in VN
XII e, come visto, imagines o imaginationes, sono tutti termini tecnici dell’arte della memoria. E’
dunque più che legittimo chiedersi in che modo Dante abbia deciso di asemplare (che vale
“assemblare, riunire”, nonché “utilizzare come esempio”) il materiale contenuto nel libello. Ancor
più, ci si può chiedere se Dante non abbia voluto scrivere la Vita Nuova proprio cone essa era
scritta nel libro della sua memoria: questa sarà in effetti la mia tesi. Punto di partenza, come
ricordato sopra, l’ipotesi che Beatrice, che simboleggia tra l’altro l’Amore incarnato, avvolta in
vestimenta sanguigne, faccia riferimento a una congiunzione di Venere (l’Amore) con Marte (di cui il
rosso sangue è il colore tipico.) Come discusso più avanti, le congiunzioni di questi due pianeti
seguono uno schema ben preciso—25 congiunzioni in 32 anni—che si ripete quasi esattamente
nel tempo (per esempio, la congiunzione del 7 Luglio 1274 si ripete l’8 Luglio 1306, con una
differenza di meno di 13 ore dalla prima) e nello spazio (la prima avviene nel XIV grado del
Cancro, la seconda nel XVII) e fornisce quindi uno schema che, scelto una volta per tutte,
fornisce una griglia spazio-temporale che come si vedrà è intrinsecamente separata in 5 gruppi di
5 “caselle”, soddisfacendo così automaticamente a una delle regole dell’Ad Herennium. Elemento
importante, le congiunzioni planetarie, e in particolare quella di Marte e Venere, sembrano
Carruthers, Mary, The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture (Cambridge Studies in Medieval 6
Literature) . Cambridge University Press, 2008 : “What I was demonstrating was the power of such mental devices as finding tools rather than as retention devices.”
LETTERA PERDUTA !5
giocare un ruolo importante nel tema natale—e dunque nella vita—del Poeta. Questo sarà il
soggetto del prossimo Paragrafo.
L’uso di uno schema astronomico/astrologico come sfondo di mnemotecnica non è una
novità: Quintiliano nelle sue Istitutiones cita l’esempio di Metrodoro di Scepsis, che avrebbe
utilizzato come griglia i 360 gradi del cerchio zodiacale. Quintiliano sembra perplesso di fronte a
questa scelta, ma un commentatore moderno , che a mio avviso fraintende Quintiliano, ritiene 7
poter individuare l’origine di questo numero nei 36 decani in cui l’astrologia antica divideva lo
zodiaco, e che rimangono negli oroscopi odierni.
Da un lato, fare appello ai decani non è necessario, perché lo zodiaco di 12 segni di 30
gradi ciascuno, contiene comunque 360 gradi, che li si raggruppi in gruppi di 10 a formare i 36
decani, oppure no.
D’altro lato, però, l’intuizione che i decani possano essere connessi al sistema di
memorizzazione di Metrodoros può essere corretta; la tradizione astrologica assegna ai singoli
gradi dello zodiaco—i cosiddetti monomoiria—lo stesso tipo di immagini fantastiche che essa
associa ai decani (immagini di cui si possono vedere esempi nel Ciclo dei Mesi del palazzo
Schifanoia di Ferrara) ed anche agli “dei planetari”, immagini che arrivarono al Medioevo e poi
al Rinascimento attraverso scritti come Picatrix. Chiaramente queste rappresentazioni soddisfano
senza dubbio al criterio di “suscitare meraviglia”, come si constata facilmente . 8
Dante costella la Vita Nuova di questo genere di immagini: quando Beatrice, nove anni dopo
la sua “apparizione”, rivolge finalmente la parola al Poeta, egli si rifugia in una camera per pensare
a questa cortesissima. Si addormenta, ed ha la visione di una nuvola color fuoco in cui si osserva “un
signore di pauroso aspetto”, che tiene nelle braccia una donna nuda, ed ha in una mano un
L.A. Post, Ancient Memory Systems, The Classical Weekly 25, pp. 105-110 (1932)7
Il primo decano d’Ariete, “un uomo di pelle scura, occhi rossi, robusto, con giacca e pantaloni bianchi, stracciati. 8
Sta in piedi, in atteggiamento minaccioso, è cinto in vita da una corda, di cui tiene un capo con la mano sinistra” secondo la descrizione dell’affresco della parete Est del Salone dei Mesi, ricalca l’immagine tradizionale corrispondente: Aethiopem oculis nigris, superciliis extensis.Est haute de Gigantibus, jactabundus, obvolutus pallio albo magno, fune praecintus,, iracundus, stanno in pedes suos secondo quanto riporta Charles Dupuis nel suo trattato De la sphère et de ses parties.
LETTERA PERDUTA !6
oggetto fiammeggiante . Benché non sia chiaro che cosa la figura rappresenti, essa potrebbe 9
essere uscita da un libro di esempi di mnemotecnica, tanto quanto da un manuale come Picatrix,
dove per esempio della figura di Mercurio si dice che essa è un barone seduto su di un trono con la testa
di un gallo e le zampe di un’aquila ed ha una fiamma nella mano sinistra . 10
Allo stadio attuale, è difficile dire se Dante usasse questo tipo di immagini come suggerito
dalla Carruthers, ossia come “puntatori” per facilitare, o permettere, il recupero dei ricordi
immagazzinati nella memoria naturale. Ed è anche difficile dire se Dante avesse in mente una
relazione con aspetti astronomici. L’unico riferimento astronomico certo è costituito dall’eclissi di
Sole descritta in VN XXIII. Io credo però che ci siano elementi almeno indiziari che lasciano
pensare che Dante, la cui memoria, come spesso accadeva per gli intellettuali dell’epoca, era
considerata strabiliante , utilizzasse uno schema astronomico per la sua memoria artificiale. 11
L’argomento è alquanto complesso, e dobbiamo cominciare a trattarlo dall’inizio, ossia dalla
nascita del Poeta. Questa è la prima occasione in cui le congiunzioni planetarie fanno la loro
apparizione, anche se Dante non ne parla esplicitamente.
4. Sulla data di nascita di Dante: primo excursus astronomico/astrologico Da un complesso e minuzioso esame delle testimonianze interne ed esterne, possiamo affermare con quasi assoluta
certezza che Dante nacque in Firenze in un giorno tra il 14 maggio e il 13 giugno dell'anno 1265 (…) Se siamo sicuri
dell'anno e del periodo, la costellazione dei gemelli (…), non del giorno, possiamo invece esser certi della data del battesimo:
26 marzo 1266, il giorno del Sabato santo (…)
pensando di lei, mi sopragiunse uno soave sonno, nel quale m'apparve una maravigliosa visione. Che mi parea vedere nella mia camera 9
una nebula di colore di fuoco, dentro alla quale io discernea una figura d'uno signore, di pauroso aspecto a chi la guardasse; e pareami con tanta letitia quanto a sé, che mirabile cosa era; e nelle sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea se non poche, tra le quali io intendea queste: «Ego Dominus tuus». Nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in uno drappo sanguigno leggieramente; la quale io riguardando molto intentivamente, conobbi ch'era la donna della salute, la quale m'avea lo giorno dinanzi degnato di salutare. E nell'una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta; e pareami che mi dicesse queste parole: «Vide cor tuum!». E quando elli era stato alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormia; e tanto si sforzava per suo ingegno, che le facea mangiare questa cosa che in mano li ardea, la quale ella mangiava dubitosamente.
Sulle caratteristiche di questa visione, si veda il Paragrafo 9. 10
Fu ancora questo poeta di maravigliosa capacità e di memoria fermissima e di perspicace intelletto, intanto che, essendo egli a Parigi, e 11
quivi sostenendo in una disputazione de quolibet che nelle scuole della teologia si facea, quattordici quistioni da diversi valenti uomini e di diverse materie, con gli loro argomenti pro e contra fatti dagli opponenti, senza mettere in mezzo raccolse, e ordinatamente, come poste erano state, recitò; quelle poi, seguendo quello medesimo ordine, sottilmente solvendo e rispondendo agli argomenti contrari. La qual cosa quasi miracolo da tutti i circustanti fu reputata. Tratto da Giovanni Boccaccio, Trattatello in laude di Dante (Editoriale Laterza)
LETTERA PERDUTA !7
Queste parole si leggono nella Vita di Dante del Petrocchi , una delle biografie più citate in 12
letteratura, e su Internet. Vedremo nel seguito che cosa si può dire della data di nascita del Poeta.
Si noti però un punto importante: per quel che riguarda le date, niente di ciò che si dice in
letteratura deve essere preso per oro colato. Un esempio tipico compare in queste righe: il 26
Marzo 1266 non fu il Sabato Santo, perché il 26 Marzo fu un Venerdì, non un Sabato. In questo
caso, poiché il Sabato Santo fu invece il 27, è possibile che si tratti di un semplice errore di
stampa . E’ però sintomatico che la data sia ripetuta dappertutto, senza che nessuno si preoccupi 13
di verificarla. E’ anche sintomatica la maniera con cui certe informazioni a carattere astronomico
vengono date: il periodo che include la data di nascita di Dante è descritto come la costellazione dei
gemelli, frase che è astronomicamente (se non sintatticamente) scorretta, perché tra il 14 Maggio e
il 13 Giugno il Sole si trova nel segno e non nella costellazione dei Gemelli.
Per l’esattezza, Dante scrive nel Paradiso (22.112-117): O glorïose stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto, qual che si sia, il mio ingegno, con voi nasceva e s'ascondeva vosco quelli ch'è padre d'ogne mortal vita, quand' io senti' di prima l'aere tosco;
Alla fine del Canto (22.151-154) Dante precisa che nel rivolgersi a queste stelle egli si trova
nei Gemelli: L'aiuola che ci fa tanto feroci, volgendom' io con li etterni Gemelli, tutta m'apparve da' colli a le foci; poscia rivolsi li occhi a li occhi belli.
Il senso del testo sembra chiaro: Dante dichiara essere nato quando il Sole (padre d’ogni mortal
vita) si levava e tramontava con delle stelle che
dovrebbero appartenere ai Gemelli. Ma si tratta
della costellazione, o del segno? Nel 1265, i confini del
segno dei Gemelli sono delimitati da Aldebaran,
Vita di Dante di Giorgio Petrocchi, Editori Laterza, 1997. Collana: Economica Laterza, 15. 12
Benché il discorso sia lungo, si può osservare che ancora nel ‘300, il 25 Marzo era considerato il giorno 13
anniversario della Passione di Cristo, e il 27 quello della Risurrezione, di modo che il 26 era l’anniversario del primo Sabato Santo. Ad esempio, i commentatori trecenteschi della Commedia, tra cui il Buti e il Boccaccio, chiamano “Venerdì Santo di Marzo” il 25 di quel mese. Non sapendo quale sia la fonte del Petrocchi, non è possibile sapere se in essa si dicesse che il Battesimo avvenne il 26 Marzo, oppure di Sabato Santo, o cos’altro.
LETTERA PERDUTA !8
l’occhio rosso del Toro, e da una linea che passa per Alhena e Mebsuta, rispettivamente gamma ed
espilon dei Gemelli. Le due stelle principali della costellazione, Castor e Pollux (i Gemelli
propriamente detti) si trovano all’interno del segno seguente, il Cancro. La carta astronomica qui
accanto indica che in questa regione—che si estende dalla punta delle corna del Toro sino ad
Alhena e Mebsuta—passa la Via Lattea. Questo punto è interessante perché la terzina 22.151-153
richiama immediatamente un testo latino del V secolo, il Commentarius Somnii Scipionis di
Macrobio.
Il Somnium Scipionis di Cicerone, contenuto nel VI libro del De Republica e corrispondente al
racconto del Mito di Er nella Repubblica di Platone, riferisce il sogno del generale romano Scipione
l’Africano. Questi si ritrova nella Via Lattea, ch’egli apprende essere la sede delle anime degli
uomini illustri. Da questa posizione, Scipione guarda le sfere planetarie, e in fondo in fondo la
Terra, che gli pare piccola e insignificante,
proprio come l'aiuola che ci fa tanto feroci di Dante.
Il commento neoplatonico di Macrobio,
notissimo in tutto il Medio Evo, precisa che la
Via Lattea, nella sua intersezione con l’eclittica,
determina le due porte attraverso cui passano le
anime per ascendere alla sfera delle stelle fisse.
Dante ha evidentemente in mente questo
passaggio, perché in Paradiso 22.118-120 scrive,
riferendosi sempre ai Gemelli:
e poi, quando mi fu grazia largita d'entrar ne l'alta rota che vi gira, la vostra regïon mi fu sortita.
In quella regione, ossia nella Via Lattea, il Sole si trova all’incirca dal 27 Maggio al 13
Giugno. L’8 Giugno è quasi esattamente nel mezzo di questo periodo di tempo. Come si vedrà
LETTERA PERDUTA !9
più avanti, e come sanno i lettori della Vita Nuova, l’8 Giugno è la data della morte di Beatrice, e
l’unica che Dante precisa esplicitamente in tutta la sua opera . 14
Il periodo dal 27 Maggio al 13 Giugno 1265 ha una caratteristica interessante, che non si
può dedurre dagli scritti del Poeta, ma solo da un’esame della carta dei cieli. Il 13 Giugno 1265,
si produsse una configurazione astronomica assai notevole: il Sole si trova sulla cuspide Gemelli/
Cancro, la Luna, Mercurio, Giove e Saturno sono raggruppati tra il Iº e il VIIº grado dei
Gemelli, mentre Marte e Venere sono vicinissimi tra il VIIº e il Xº grado del Leone. Queste
configurazioni sono interessanti per la loro struttura simmetrica, ma anche, e certamente ancor
più, per il loro significato astrologico. Le congiunzioni di Giove e Saturno, che ricorrono
approssimativamente ogni 20 anni, avevano un’importanza diversa secondo certi elementi che
sarebbe troppo lungo considerare in questa sede. Ma una delle loro caratteristiche principali era
di annunciare dei cambiamenti nell’ambito religioso, e specialmente l’arrivo di un profeta . La 15
presenza di Mercurio (pianeta dell’eloquenza) nei Gemelli darebbe a questo profeta le doti di un
poeta.
Vorrei qui far notare che queste considerazioni, che alla mente moderna sembrano
piuttosto peregrine, erano senza dubbio importanti per lo spirito medievale. In particolare, è
possibile che gli aspetti celesti caratterizzanti la nascita del Poeta fossero ben noti ai suoi
contemporanei. Il Boccaccio (ancora lui!) in un passaggio mai ricordato del suo Trattatello in laude
Potrebbe essere l’8 Giugno la data di nascita di Dante? Nessuno può rispondere a questa domanda. Il Boccaccio 14
segnala che una persona che si sarebbe trovata accanto al Poeta subito prima della sua morte, lui riferì che Dante era nato nel Maggio del 1265. Non sapendo quale fosse l’informazione originale, è impossibile giudicarne l’attendibilità. Si noti che persino sulla data di morte del Poeta ci sono informazioni contrastanti (anche se si farebbe fatica a trovarle nella storiografia dantesca.) Il Boccaccio—ancora lui—riferisce che Dante morì a Ravenna del mese di settembre negli anni di Cristo MCCCXXI, nel dì che la esaltazione della santa Croce si celebra dalla Chiesa (Trattatello in laude di Dante, 1357-61). La festa liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce ricorre il 14 Settembre. Scrivendo all’incirca un secolo più tardi, Cristoforo Landino dichiara che Dante si morì del MCCCXXI. del mese di Luglio. Perché questa discrepanza? Perché la fonte del Landino, di tutta evidenza, era Giovanni Villani, che nel Libro 10, Cap. 136 della Nuova cronica, scrive: Nel detto anno MCCCXXI, del mese di luglio, morì Dante Allighieri di Firenze ne la città di Ravenna in Romagna. Il Villani era di una decina d’anni più giovane di Dante, e secondo il nipote Filippo, fu amico del Poeta. Il vicentino Ferreto dei Ferreti riporta come data della morte il 13 di Agosto. Non è chiaro perché si presti fede incondizionata al Boccaccio. Ma ritornando alla nascita di Dante, mi limito ad osservare che nei Cicli dei Mesi medievali e rinascimentali, il mese di Maggio era sempre associato al segno dei Gemelli, benché il Sole si trovi in questo segno solo per metà del mese. E’ dunque possibile che la fonte del Boccaccio abbia trasformato in “nato in Maggio” la frase “nato sotto il segno dei Gemelli” che è appunto quanto Dante dice di sé nella Commedia.
Così si esprime Jacopo della Lana nel suo commento al Canto 33 del Purgatorio, dove si trova la profezia “del 15
Cinquecento diece e cinque”: Or questa signorìa quando dee avvenire nel mondo si può bene sapere per astrologìa, sicome chiaro appare in lo libro di Albumazar Delle congiunzioni, che le congiunzioni dei superiori pianeti in alcuni segni adduceno nel mondo principi, li quali sono di tanta possanza ch'hanno potere di mutare sètte, e fare grandissime varietadi e usanze nel mondo. Or dice l'autore: io cognosco la gran colpa, cognosco la grandezza dei peccatori, cognosco che in tale tempo sarà tale congiunzione, che induce precetto di potente: puossi concludere in quello tempo sarà la vendetta.
LETTERA PERDUTA !10
di Dante, accusa, seppure a malincuore, Dante di essere un lussurioso . Questo aspetto della 16
personalità del poeta dell’Amore per Beatrice sembra talmente assurdo che i commentatori e
biografi lo ignorano senza vergogna. Ma lo stesso Boccaccio, nel suo compendio mitologico-
astrologico Della Geneologia degli Dei, scrive:
però da un certo Filosofo chiamato Ali nel commento quadripartito, è stato detto, che ogni volta che nella natività d’alcuno Venere insieme con Marte partecipa, eglino hanno potere, & concedeno a quel tale, che nasce, la dispositione atta alle lussurie, & fornicationi, la quale attitudine opra, che tantosto, che costui vede alcuna donna, la quale piaccia a suoi sensi esteriori, subito alle virtù sensitive interiori viene riportato quello, ch'ha piacciuto, & questo prima perviene alla fantasia, & da questa è transportato alla consideratione: da questi poi sensitivi viene condotto a quella spetie di virtù, la quale tra le apprensive virtudi è la piu nobile, cioè all'intelletto possibile, il quale è il ricetto delle spetie, si come nel libro della anima mostra Aristotele. Ivi adunque conosciuta, & intesa se viene per volontà del patiente, dove è la libertà di cacciare, & ritenere, che si come approvata, sia ritenuta nella allhora fermata memoria; questa passione della cosa lodata, la quale già si dice Amore, overo Cupido, si ferma nell'appetito sensitivo, & ivi per diverse cagioni alle volte tanto grande, & potente diviene, che costringe Giove lasciar il Cielo, & pigliar forma di toro. Alle volte poi essendo se non fermata, & approvata di maniera passa, & annulla, che da Venere, & Marte non si genera passione alcuna. Ma secondo, che di sopra è stato detto, gli huomini atti a ricever la passione secondo la corporal dispositione sono generati, il che non essendo, non si produrebbe la passione; & cosi largamente pigliando, da Marte, & Venere si come da cagione un poco alquanto piu remota Cupido si genera.
Il grassetto nel testo è evidentemente mio. Ho riportato per esteso questo brano perché esso
descrive gli stati d’animo di Dante alla vista di Beatrice (VN I) molto più fedelmente che non il
raccontino da novella del Trattatello.
5. Sulla data dell’apparizione di Beatrice a Dante La prima apparizione di Beatrice deve situarsi nel 1274, all’incirca 9 anni dopo la nascita di
Dante (VN I). Il Boccaccio fa di questo evento un incontro avvenuto al primo di Maggio durante
una festa.
Come visto, Marte e Venere sono congiunti nel Giugno 1265 (il 18 per l’esattezza, nel
Leone.) Quasi esattamente 9 anni più tardi, il 7 Luglio 1274, i due pianeti si ritrovano congiunti
nel Cancro.
Ora, si legga ciò che dice il Villani (Nuova Cronica, Libro 8, Cap. 89):
Nell'anno appresso MCCLXXXIII, del mese di giugno, per la festa di santo Giovanni, essendo la città di
Firenze in felice e buono stato di riposo, e tranquillo e pacifico stato, e utile per li mercatanti e artefici, e
Certo, io mi vergogno dovere con alcuno difetto maculare la fama di cotanto uomo; ma il cominciato ordine delle cose in alcuna parte il 16
richiede; perciò che, se nelle cose meno che laudevoli in lui mi tacerò, io torrò molta fede alle laudevoli già mostrate. A lui medesimo adunque mi scuso, il quale per avventura me scrivente con isdegnoso occhio d'alta parte del cielo ragguarda. Tra cotanta virtù, tra cotanta scienzia, quanta dimostrato è di sopra essere stata in questo mirifico poeta, trovò ampissimo luogo la lussuria, e non solamente ne' giovani anni, ma ancora ne' maturi. Il quale vizio, come che naturale e comune e quasi necessario sia, nel vero non che commendare, ma scusare non si può degnamente. Ma chi sarà tra' mortali giusto giudice a condennarlo?
LETTERA PERDUTA !11
massimamente per gli Guelfi che signoreggiavano la terra, si fece nella contrada di Santa Felicita Oltrarno, onde
furono capo e cominciatori quegli della casa de' Rossi co.lloro vicinanze, una compagnia e brigata di M uomini o
più, tutti vestiti di robe bianche, con uno signore detto dell'Amore. Per la qual brigata non s'intendea se non in
giuochi, e in sollazzi, e in balli di donne e di cavalieri e d'altri popolani, andando per la terra con trombe e diversi
stormenti in gioia e allegrezza, e stando in conviti insieme, in desinari e in cene. La qual corte durò presso a due
mesi, e fu la più nobile e nominata che mai fosse nella città di Firenze o in Toscana; (…)
Questo stato felice di Firenze durò secondo il Villani sino al 1284; si può quindi dedurne
che la “festa dell’Amore” qui descritta si celebrasse anche nell’anno seguente. Inoltre, il Villani
riferisce (Nuova Cronica, Libro 8, Cap. 132) che le celebrazioni delle calende di Maggio si tennero a
Firenze a partire dalla vittoria sugli aretini del Giugno 1289 a Campaldino.
Se ammettiamo che “l’apparizione” di Beatrice abbia avuto luogo durante una festa, come
vuole il Boccaccio, allora il Luglio 1274 sembra essere la data più appropriata—vista anche la
presenza in queste feste di uno signore detto dell’Amore—cosicché Dante avrebbe consegnato alla sua
memoria questo incontro associandolo alla congiunzione Marte-Venere del 7 Luglio.
6. Sulla data di nascita di Beatrice: secondo excursus astronomico/astrologico Secondo VN I, al momento della sua apparizione Beatrice aveva 8 anni e 4 mesi, e sarebbe
quindi nata nel Marzo 1266: e il 10 Marzo 1266 troviamo un’altra congiunzione Marte-Venere.
Ho osservato nel mio precedente lavoro che
il 13 Marzo 1266 si produsse una configurazione
astronomica simile a quella del 13 Giugno 1265:
Marte e Venere sono separati da soli 2º
nell’Aquario, Luna, Giove e Saturno sono
raggruppati in un intervallo di 6º nei Gemelli,
mentre il Sole è all’Equinozio di Primavera
congiunto con Mercurio. Queste due singolari
configurazioni celesti, a 9 mesi di distanza esatti
l’una dall’altra, potrebbero essere la ragione della
misteriosa frase di VN XXIX, in cui Dante dice di
Beatrice che nella sua generatione tutti e nove li mobili cieli perfectissimamente s'aveano insieme.
LETTERA PERDUTA !12
Ad avvalorare l’idea che Beatrice sia nata all’Equinozio di Primavera del 1266 c’è un altro
sibillino passaggio della Vita Nuova, in VN XXIV, in cui Dante ci racconta di come un giorno vide
arrivare Beatrice accompagnata da Giovanna, la quale era di famosa beltate, e che per la sua bellezza
era detta Primavera. Amore spiega a Dante che questo nome le era stato attribuito proprio in vista
di quel giorno, in cui si sarebbe presentata precedendo Beatrice (Primavera, cioè Prima–verrà).
7. Sulle congiunzioni Marte-Venere Se dunque il primo incontro di Dante e Beatrice avvenne il 7 Luglio 1274 e fu associato alla
congiunzione Marte-Venere di quel giorno, al XVº del Cancro, Dante potrebbe aver tratto
ispirazione dalla presenza di congiunzioni tra Marte e Venere nel suo tema natale ed in quello di
Beatrice per costruire un sistema mnemonico basato sulle posizioni delle successive congiunzioni
sull’eclittica: queste gli avrebbero fornito i loci in cui e se Dante vuole effettivamente situare la
visione della ripetizione dell’evento in corrispondenza del completamento di un ciclo di 32 anni,
ossia in corrispondenza con la congiunzione Marte-Venere dell’8 Luglio 1306, al XVIIIº del
Cancro. La morte di Beatrice, l’8 Giugno 1290, è a mezza strada tra queste due date. Inoltre,
contando le due congiunzioni estreme come identiche, tra le due date troviamo 25 congiunzioni,
tante quante i sonetti della Vita Nuova. Partendo dalla congiunzione del 10 Marzo 1266, a ridosso
dell’Equinozio di Primavera, sino a quella del 7 Luglio 1274, se ne trovano altre 6, per un totale
di 31, tante quante tutti i componimenti poetici della Vita Nuova.
LETTERA PERDUTA !13
Queste congiunzioni sono distribuite sullo zodiaco secondo lo schema illustrato in Fig. 1:
La prima congiunzione considerata nella figura è appunto quella del 10 Marzo 1266, nel
XXº grado dell’Aquario (cerchietto blu più a sinistra). Le 3 congiunzioni successive sono
rappresentate dai cerchietti blu (da sinistra a destra), e avvengono a circa 687 giorni di distanza
l’una dall’altra, corrispondenti al periodo sidereo di Marte (per questo esse avvengono nella stessa
zona dello zodiaco.) Dopo questa serie di 4 congiunzioni, la quinta ha luogo all’inizio dell’Ariete
(cerchietto rosso tra Pesci e Ariete) con Venere in moto retrogrado, sei anni dopo la prima (9
Marzo 1272). Cinque mesi dopo all’incirca (16 Agosto 1972) inizia una nuova serie di 4
congiunzioni che dalla fine del Cancro si muovono verso i Gemelli (cerchietti e freccia rossi). La
congiunzione successiva con Venere retrogradante avviene ancora circa sei anni dopo la prima
nel Cancro (28 Luglio 1278), in una posizione (cerchietto verde) che si trova partendo dal
cerchietto rosso all’inizio dell’Ariete e seguendo la freccia gialla verso il Leone. Come si vede dal
diagramma, le due posizioni sono ai vertici di un pentagono regolare, separate da 144º. Dopo
altri cinque mesi circa (18 Dicembre 1278), inizia una nuova serie di 4 congiunzioni (cerchietti e
freccia verdi) dallo Scorpione alla Bilancia. Circa sei anni dopo l’inizio di questa serie (25
Dicembre 1284), una quinta congiunzione—con Venere retrogrado—avviene nel Capricorno, a
144º dalla precedente (cerchietto grigio al vertice superiore del pentagono.) Dopo circa 6 mesi (10
Giugno 1285) comincia la serie delle 4 congiunzioni dal Toro all’Ariete (cerchietti e freccia grigi)
che termina circa 6 anni più tardi (9 Maggio 1291) con Venere in moto retrogrado nei Gemelli (a
144º dal Capricorno, cerchietto azzurro.) Circa cinque mesi dopo (17 Ottobre 1291) inizia
l’ultima serie di 4 congiunzioni dalla Vergine al Leone, che terminano un po’ meno di sei anni
più tardi (5 Ottobre 1297) con Venere retrogrado all’inizio dello Scorpione (cerchietto blu tra
Scorpione e Bilancia.) La congiunzione seguente, al 14 Marzo 1298, nel XVIº grado
dell’Aquario, coincide essenzialmente con la congiunzione iniziale, avvenuta 32 anni prima. Le
due posizioni non si ripetono esattamente, come discusso nel Paragrafo seguente. Però, se si
dovessero utilizzare le posizioni successive delle congiunzioni tra i due pianeti come loci di un
sistema di memoria, allora si può immaginare di utilizzare una sequenza idealizzata di 25
“stazioni”, che corrispondono a una serie ideale di continui planetarie che si ripetono
esattamente ogni 32 anni. Dopo tutto, lo scopo della costruzione—semmai questa fu l’intenzione
di Dante—non è di fare astronomia, ma di costruire un sistema mnemonico.
LETTERA PERDUTA !14
8. Qualche dato di astronomia planetaria
Ho parlato più volte del periodo di 32 anni per le congiunzioni di Venere e Marte, ma
senza dare nessuna spiegazione. Qualche dettaglio è ora necessario. Innanzi tutto, si deve
osservare che ci sono due tipi di pianeti: i due detti inferiori, Mercurio e Venere, e i tre superiori,
Marte, Giove e Saturno. In una descrizione di tipo eliocentrico, i primi due sono i pianeti interni
all’orbita della Terra attorno al Sole, gli altri tre si trovano invece all’esterno di essa. In una
descrizione geocentrica, la differenza tra i due tipi di pianeti è solo un dato di fatto che non ha
spiegazione: Mercurio e Venere alternativamente seguono o precedono il Sole, senza allontanarsi
da quest’ultimo per più di 28º (Mercurio) o 48º (Venere). Al tempo di Dante era ben noto che
Venere si mostrava come stella del mattino all’Est, prima dell’alba, e come stella della sera
all’Ovest, dopo il tramonto, e che era occultata dal Sole nei periodi intermedi tra queste
apparizioni. Il lasso di tempo tra
le due medesime posizioni di
Venere rispetto al Sole, detto
periodo sinodico, è di circa 584
giorni (583.92 secondo il sito
web della NASA.) Questo
numero implica che 5 periodi
sinodici di Venere sono quasi
uguali a 8 anni solari, poiché 5
x 584 = 2920 = 8 x 365,
ment re 8 ann i G iu l i an i
contengono 2 giorni di più (8 x 365.25 = 2922.) Quindi, ogni 8 anni la stessa configurazione
Sole-Venere si riproduce quasi nello stesso giorno dello stesso mese. Ne consegue che se si osserva
una particolare configurazione dei due astri—ad esempio gli allineamenti di Venere con il Sole
come nella figura qui sopra—questa configurazione si ripete 5 volte in 8 anni, formando
sull’Eclittica un pentagono regolare . Questo pentagono corrisponde al pentagono regolare che 17
si osserva nella figura 1. Questa regolarità dell’orbita di Venere fa sì che le posizioni successive del
Come si nota dalla figura, la prima e l’ultima congiunzione non si ripetono esattamente nello stesso punto 17
dell’Eclittica perché esse avvengono a circa 2 giorni di distanza, in cui il pianeta e il Sole percorrono circa 2 gradi.
LETTERA PERDUTA !15
pianeta sull’Eclittica nell’arco degli 8 anni, si ripetono, con l’approssimazione di 2 giorni, ogni 8
anni. Questa è la base per la costruzione dei cosiddetti Almanacchi planetari, di cui quello di
Profazio di cui si parlerà in seguito è un esempio. Un Almanacco è una serie di Tavole che
riportano le posizioni zodiacali dei pianeti per un numero di anni dato; dopo questi, le posizioni
del pianeta si ripetono ciclicamente. In generale, un correzione deve essere applicata per rendere
l’Almanacco perpetuo, cioè per poter conoscere le posizioni del pianeta in questione dopo un
gran numero di cicli. Ad esempio, è noto che in una delle rime dette petrose Dante descrive una
congiunzione superiore di Venere avvenuta in prossimità del Solstizio d’Inverno, in opposizione 18
a Saturno . Una congiunzione con queste caratteristiche avvenne il 24 Dicembre 1296. Da 19
quanto detto sopra, dobbiamo concludere che Venere fu in congiunzione superiore al Solstizio
d’Inverno durante la vita di Dante anche nel 1272, 1280, 1288, 1304, 1312 e 1320. Solo nel
1296 Saturno si trovava però in opposizione al Sole.
I pianeti superiori come Marte hanno un comportamento molto diverso. La loro distanza
dal Sole non è limitata, e può arrivare—come detto a proposito di Saturno—sino ad una
distanza angolare di 180º dal Sole—l’opposizione appunto. Per questi pianeti è importante
distinguere due periodi: il periodo sidereo, corrispondente al ritorno del pianeta nella stessa
posizione rispetto ad una stella ; il periodo sinodico, corrispondente come già detto al ritorno del 20
pianeta nella stessa posizione rispetto al Sole. Nel caso dei pianeti superiori, una configurazione
importante è appunto l’opposizione rispetto al Sole: il periodo sinodico è talvolta definito come il
lasso di tempo tra due opposizioni successive . I due periodi hanno una relazione interessante tra 21
di loro, e con l’anno solare. Utilizzando un planetario numerico si può osservare che Marte si
trovava al XV grado della Vergine ed era in opposizione rispetto al Sole al 25 Febbraio 1271.
Chiediamoci ora: dopo quanto anni Marte si ritrovò in opposizione nella stessa posizione
Si parla di congiunzione superiore quando Venere (o Mercurio) si trova allineato con il Sole e la Terra, al di là del Sole. 18
Una congiunzione inferiore corrisponde a un simile allineamento con Venere tra la Terra e il Sole.
Si veda la discussione di questa rima petrosa nel saggio di Robert Durling e Ronald Martinez Time and the Crystal: 19
Studies in Dante's Rime petrose. Berkeley: University of California Press, 1990.
In Par. 16.34-39 Cacciaguida utilizza proprio il periodo sidereo di Marte per determinare la propria data di 20
nascita. Si veda il mio articolo in linea http://www.princeton.edu/~dante/ebdsa/pimpinelli031212.html
I pianeti superiori hanno sempre il loro moto retrogrado quando sono in opposizione rispetto al Sole, un fatto che 21
diventa banale in una descrizione eliocentrica.
LETTERA PERDUTA !16
sull’Eclittica? La risposta dipende dal grado di approssimazione che siamo disposti a tollerare. Si
guardi la Tabella seguente:
Dopo 15 anni dalla prima opposizione, Marte si ritrova in opposizione nella Vergine. In
questo intervallo di tempo, Marte è stato in opposizione al Sole per altre 7 volte, e si è trovato
nella Vergine per altre 8 volte. Ovviamente, 7 + 8 = 15. Questo non è un caso. Il numero di cicli
siderei, addizionato al numero di cicli sinodici, fornisce la durata in anni solari del periodo in
questione. Ma il dato più interessante sono le durate dei periodi. Dopo 15 anni, Marte è in
opposizione a 13 gradi dall’opposizione iniziale. Dopo 32 anni, a 8 gradi. Dopo 47 anni, a 6
gradi. Dopo 79 anni, la differenza tra le posizioni della prima e ultima opposizione è di soli 2
gradi. In questo periodo Marte ha effettuato 42 cicli siderei, e 37 cicli sinodi. Un periodo di 79
anni permette quindi di riprodurre le posizioni di Marte con ottima approssimazione, e questo
periodo è utilizzato nell’Almanacco di Profazio (si veda più avanti.) Ma l’intervallo che ci
interessa di più è quello di 32 anni. Difatti 32 è multiplo di 8, e 8 anni è l’intervallo
corrispondente a 5 periodi sinodici di Venere: dopo 32 anni, sia Marte che Venere si trovano
all’incirca nella stessa posizione rispetto al Sole e rispetto alle stelle. Le Tabella seguenti
forniscono rispettivamente le posizioni di Marte e Venere ogni 32 anni a partire dalla
congiunzione del 18 Giugno 1265, e le date e posizioni delle congiunzioni del 1297 e del 13029:
Posizione di Marte data dell’opposizione
XV grado della Vergine 25 Febbraio 1271
II grado della Vergine 12 Febbraio 1286
XXIII grado della Vergine 5 Marzo 1303
IX grado della Vergine 19 Febbraio 1318
XVIII grado della Vergine 27 Febbraio 1350
data Posizione di Marte Posizione di Venere
18 Giugno 1265 XIV grado del Leone XIV grado del Leone
18 Giugno 1297 XVII grado del Leone XV grado del Leone
18 Giugno 1329 XX grado del Leone XVII grado del Leone
LETTERA PERDUTA !17
E’ chiaro da queste Tabelle che le congiunzioni tra Marte e Venere si ripetono con un
periodo di 32 anni, con un errore di 2 o 3 gradi al massimo.
9. Un riassunto a guisa di parziale conclusione
Riassumendo: Dante utilizza senza alcun dubbio un sistema di memorizzazione del tipo
descritto nel testo fondatore delle tecniche di memoria, l’Ad Herennium. I riferimenti espliciti al
libro della memoria; ai simulacra ; l’uso di immagini sconcertanti come il signore che tiene in palmo 22
di mano un cuore fiammeggiante, e la terrificante eclissi di sole—immagine quest’ultima che,
come ricordato sopra (cf. nota 2) l’Ad Herennium cita come esemplare; le divisioni che pure Dante
afferma servire a aprire la sentenzia della cosa divisa sono essenziali alla memorizzazione; tutti questi
elementi ne sono prova sufficiente.
Quale sia la struttura della memoria artificiale di Dante è però difficile a dirsi.
La mia ipotesi parte dal passaggio discusso nell’Introduzione, e che voglio ripetere qui: mi
parve vedere questa gloriosa Beatrice con quelle vestimenta sanguigne colle quali apparve prima agli occhi miei, e
pareami giovane in simile etade in quale prima la vidi. Allora cominciai a pensare di lei, e ricordandomi di lei
data Posizione di Marte e Venere
20 Giugno 1297 XVIII grado del Leone
23 Giugno 1329 XXIII grado del Leone
VN XII: Avenne quasi nel mezzo del mio dormire che mi parve vedere nella mia camera lungo me sedere uno giovane vestito di 22
bianchissime vestimenta, e pensando molto quanto alla vista sua, mi riguardava là ov'io giacea. E quando m'avea guardato alquanto, pareami che sospirando mi chiamasse, e diceami queste parole: «Fili mi, tempus est ut pretermictantur simulacra nostra». Amore ha invitato Dante a scegliere delle donne-schermo che devono mascherare l’amore che egli porta a Beatrice. Ma quest’ultima se ne adombra, e toglie al Poeta il suo saluto. Amore appare una volta di più a Dante e lo invita a cambiare simulacra che si interpretano come un riferimento alle donne schermo. Il sostantivo è però anche un termine tecnico della memoria artificiale, e corrisponde a imagines: Rethorica Ad Herennium, III.16: Constat igitur artificiosa memoria locis et imaginibus. Locos appellamus eos, qui breviter, perfecte, insignite aut natura aut manu sunt absoluti, ut eos facile naturali memoria conprehendere et amplecti queamus: <ut> aedes, intercolumnium, angulum, fornicem et alia, quae his similia sunt. Imagines sunt formae quaedam et notae et simulacra eius rei, quam meminisse volumus: quod genus equi, leones, aquilae; [memoriam] si volemus habere imagines eorum, locis certis conlocare oportebit. Nunc, cuiusmodi locos invenire et quo pacto reperire et in locis imagines constituere oporteat, ostendemus.
LETTERA PERDUTA !18
secondo l'ordine del tempo passato (…) La chiave è nell’ultima frase: ricordandomi di lei secondo l'ordine del
tempo passato. Il ricordo utilizza un sistema ordinato temporalmente che si ripete in maniera ciclica.
Questa è la natura propria degli eventi astronomici e Dante, che ama utilizzare strumenti di
misura del tempo insoliti—si pensi ai vari calendari con cui è riportata la data di morte di
Beatrice in VN XXIX, all’uso del moto del Cielo Stellato (la precessione degli Equinozi) per
determinarne l’età in VN I e all’uso delle rivoluzioni sideree di Marte in Par. XV—sembra
suggerire con l’immagine di Beatrice-Amore avvolta in una vesta rosso sangue, una congiunzione
tra i pianeti Venere e Marte . Una di queste congiunzioni caratterizza il tema natale di Dante, e 23
forse quello di Beatrice (se quest’ultima nacque all’Equinozio di Primavera del 1266.)
Ho descritto la struttura spazio-temporale di queste congiunzioni sull’Eclittica tra il 1266 e
il 1298. Ne vorrei ora enunciare alcune caratteristiche che mi sembrano importanti.
1. Come risulta evidente dalla figura 1, le congiunzioni di Marte e Venere si suddividono
naturalmente in cinque gruppi di 5 congiunzioni, 4 successive più una quinta con Venere
retrogradante: queste ultime congiunzioni si situano ai vertici di un pentagono regolare. Il
fatto di per sé è piuttosto interessante, perché nella Retorica ad Herennium, si raccomanda che i
“luoghi” della memoria siano appunto raggruppati cinque a cinque . 24
2. Gli eventi narrati nella Vita Nuova hanno inizio nel 1274. La morte di Beatrice avviene
nel 1290—16 anni più tardi. Come visto, la morte di Beatrice occupa un posto centrale nel
libro che, se una simmetria esiste, dovrebbe concludersi 16 anni dopo, nel 1306. Ora, nel
Convivio Dante si riferisce direttamente alla Vita Nuova con queste parole (Tratt. II II):
Cominciando adunque, dico che la stella di Venere due fiate rivolta era in quello suo cerchio che la fa parere
serotina e matutina secondo diversi tempi, apresso lo trapassamento di quella Beatrice beata che vive in cielo
Come menzionato nel Paragrafo 3, Dante ha una seconda visione, descritta in VN III, nove anni esattamente dopo 23
la prima, in cui Beatrice appare in sogno avvolta in un drappo sanguigno, addormentata nelle braccia di un signore di pauroso aspetto, che si capisce essere Amore, e che tiene in una mano il cuore fiammeggiante del Poeta. Come osservato sopra, Picatrix descrive una delle immagini di Mercurio come un essere mostruoso con una fiamma nella mano sinistra. Nove anni dopo il primo incontro, nel 1283, non ci sono congiunzioni di Marte e Venere. In questo tipo di sistema, se Dante vuole “riporre” questo ricordo nello stesso luogo del primo—visto che la data è la stessa—egli deve trovare un modo di distinguerlo dal precedente. Nel 1274, quand Marte è congiunto a Venere si osserva anche una congiunzione di Mercurio con la stella Regolo del Leone, detta nell’antichità Cor Leonis, il Cuore del Leone. Si noti che nel suggerire, come faccio qui, che quest’immagine astronomico-astrologica sia alla base dell’immagine della visione, non voglio implicare che il significato della scena sia astronomico, o sia determinato da Picatrix: l’astronomia e l’astrologia non fanno altro che fornire le immagini di cui si serve il sistema di memoria.
Locos, quos sumpserimus, egregie commeditari oportebit, ut perpetuo nobis haerere possint: nam imagines, sicuti litterae delentur, ubi 24
nihil utimur; loci, tamquam cera, remanere debent. Et, ne forte in numero locorum falli possimus, quintum quemque placet notari: quod genus, si in quinto loco manum auream conlocemus, <si> in decumo aliquem notum, cui praenomen sit Decumo; deinde facile erit inceps similis notas quinto quoquo loco conlocare. (Rhetorica ad Herennium 3.19)
LETTERA PERDUTA !19
colli angeli e in terra colla mia anima, quando quella gentile donna [di] cui feci menzione nella fine della Vita
Nova, parve primamente, acompagnata d'Amore, alli occhi miei e prese luogo alcuno nella mia mente. Questo
passaggio è stato lungamente dibattuto, sia per comprendere il senso della perifrasi
astronomica (altro esempio di misura del tempo non convenzionale) sia per comprendere chi
sia la gentile donna di cui si parla. Si legga ad esempio il passaggio corrispondente nell’articolo
Vita Nuova di Mario Pazzaglia nell’Enciclopedia Dantesca Treccani:
Le maggiori difficoltà nascono dall'interpretazione dei passi del Convivio che contengono la ragionata... cagione (III XII 1) di Voi che 'ntendendo, a cominciare da II II 1 ss., dove D. identifica la gentile donna menzionata ne la fine de la Vita nuova con la Donna gentile o Filosofia. Solo che mentre l'amore per lei (Vn XXXV-XXXVIII) è presentato nel libello come avversario de la ragione e malvagio desiderio (XXXIX 1-2), presto debellato col ritorno a Beatrice, nel Convivio, pur avvertendo di non volere minimamente derogare alla Vita N., D. celebra la vittoria conclusiva dell'amore per la Donna gentile.
Come Pazzaglia riferisce, un’uscita possibile dall'impasse fu suggerita dal Pietrobono,
che ipotizzò una redazione della Vita Nuova in più tempi: una di queste si sarebbe chiusa
prima della redazione del Convivio, con la vittoria della Donna gentile, mentre gli ultimi capitoli
dell’attuale Vita Nuova, con il trionfo di Beatrice, sarebbero stati aggiunti in seguito, forse dopo
il 1312, per armonizzare Vita Nuova e Convivio, nonché alla Commedia che Dante componeva in
quel periodo. La proposta del Pietrobono è stata in seguito respinta dalla maggior parte della
critica, in parte, come detto, sulla base del passaggio del Convivio riportato qui sopra, in cui
si fa riferimento a due rivoluzioni di Venere in quello suo cerchio che la fa parere serotina e matutina.
Per noi moderni, la più ovvia interpretazione di questo cerchio è l’orbita di Venere attorno al
Sole, che diventa l’epiciclo di Venere in una versione “Tolemaica” semplificata. In altri
termini, Dante farebbe qui riferimento a due periodi sinodici del pianeta, per un totale di
1168 giorni, o poco più di 3 anni. Esiste per un’altra possibile lettura della frase due fiate rivolta
era in quello suo cerchio che la fa parere serotina e matutina secondo diversi tempi. Lettura che è coerente
con l’ipotesi di questo articolo che Dante prestasse un’attenzione particolare ai cicli planetari.
Questa lettura assume che Dante si riferisca a 2 rivoluzioni di Venere in quel suo ciclo che la
fa passare periodicamente attraverso le sue apparizioni come stella del mattino e della sera,
ossia nel ciclo di 8 anni discusso nel Paragrafo precedente. A sostegno di quest’ipotesi, da un
lato il fatto che questa lettura porterebbe a 16 anni l’intervallo tra la morte di Beatrice e la
fine della Vita Nuova, ristabilendo la simmetria temporale del testo. Dall’altro, ci sono esplicite
LETTERA PERDUTA !20
testimonianze che la tradizione astronomica medievale identificava esplicitamente questo
periodo di 8 anni del pianeta Venere come la sua revolutio, riconoscendone esplicitamente la
natura di ciclo astronomico. La principale di queste testimonianze viene dall’Almanacco di
Profazio citato in precedenza. Fin verso la fine del secolo XV gli almanacchi erano tavole
perpetue per i moti celesti. Le tavole astronomiche composte in ebraico verso il 1300 da
Profazio Giudeo (in ebraico Iacob ben Machir, morto nel primo decennio del sec. XIV) da
Montpellier, furono immediatamente tradotte in latino con il titolo di Almanach perpetuum ed
ebbero grandissima voga anche in Italia nella prima metà del sec. XIV (oltre alla grande
quantità di manoscritti latini si veda quello che nel 1345 scrive Giovanni Villani nella sua
Cronica, XI, 41, di calcoli che si facevano secondo l'almanacco di Profazio Giudeo). L'opera di
Profazio forniva le posizioni del Sole, della Luna e dei cinque pianeti per un'epoca qualsiasi,
sotto forma di tavole basate sui cicli planetari. Ognuno di questi cicli—di cui quello di Venere
ha una durata di 8 anni—viene chiamato revolutio; la spiegazione dell’uso delle tavole dice che
esse contengono la prima revolutio, che fornisce le posizioni dei pianeti e per la quale nessuna
correzione è necessaria, mentre correzioni devono essere apportate per le revolutiones
successive. Coerentemente con quest’uso, propongo quindi di leggere due fiate rivolta era in quello
suo cerchio come “aveva effettuato due rivoluzioni di quel ciclo (di 8 anni)”. Gli eventi finali
della Vita Nuova si situerebbero dunque 16 anni dopo la morte di Beatrice, e 32 anni—un
intero ciclo di congiunzioni tra Venere e Marte—dopo il primo incontro tra quest’ultima e
Dante, ossia nel 1306. Quest’interpretazione sosterrebbe l’ipotesi del Pietrobono che la Vita
Nuova sia stata rimaneggiata a più riprese nel corso del tempo, anche parecchi anni dopo la
morte di Beatrice.
3. Come detto, Marte e Venere entrarono in congiunzione 25 volte in ogni ciclo di 32 anni
all’epoca di Dante. Indubbiamente, 25 “luoghi” possono sembrare pochi per un sistema di
memoria. Però, è chiaro che ogni sistema deve contenere un numero finito di “luoghi”,
ciascuno dei quali deve ospitare più ricordi. Lo svantaggio dovuto al numero apparentemente
piccolo di “luoghi” è compensato dal fatto che questi ultimi sono associati ad eventi che si
svolgono nel tempo, e permette quindi di memorizzare avvenimenti in corrispondenza a date
precise. Questi avvenimenti in generale saranno marcati con “puntatori” di natura diversa,
cosicché si possano facilmente distinguere. Questi possono essere costituiti da altri fenomeni
astronomici come le eclissi, che possono a loro volta servire a determinare altri “luoghi”
LETTERA PERDUTA !21
corrispondenti a momenti del ciclo in cui non ci sono congiunzioni dei due pianeti. Per
chiarire questo punto farò un esempio concreto nel prossimo Paragrafo. Si noti comunque il
punto essenziale: la natura limitata di ogni sistema di memoria—formato necessariamente da
un numero finito di “luoghi”— rende inevitabile assegnare allo stesso “luogo” eventi accaduti
in tempi diversi. La natura periodica nel tempo di un sistema di “luoghi” astronomico permette
di effettuare questa assegnazione multipla in riferimento ad avvenimenti celesti di datazione
sicura.
8. Di eclissi di Sole, Papi, lettere scritte e lettere perdute
Esaminiamo ora un esempio preciso: l’eclisse di Sole che annuncia la morte di Beatrice.
Come già ricordato, questo fenomeno celeste è suggerito nell’introduzione dell’Ad Herennium
come un eccellente tipo di immagine marcante da utilizzare come “puntatore” per un ricordo
immagazzinato in un “luogo”. Per di più, la morte di Beatrice è preceduta dall’eclisse del 12
Marzo 1290, che anche se non visibile da Firenze, è astronomicamente (e astrologicamente)
notevole perché avviene a qualche ora dall’Equinozio di Primavera, in congiunzione con Saturno
entrante in Ariete. Quest’eclisse può dunque essere considerata come il corrispondente “reale” di
quella “fittizia” che si trova nel testo.
La morte di Beatrice non è, come noto, descritta in alcun modo nel libello. Dante ne
apprende la notizia quando sta componendo la canzone Sì lungiamente, che è interrotta nel testo
dalla frase latina Quomodo sedet sola civitas plena populo! facta est quasi vidua domina gentium. E come
Dante stesso spiega più avanti:
Poi che fue partita da questo secolo, rimase tutta la sopradecta cittade quasi vedova dispogliata da ogni dignitade. Onde io, ancora lagrimando in questa desolata cittade, scrissi alli principi della terra alquanto della sua conditione, pigliando quello cominciamento di ieremia profeta Quomodo sedet sola civitas. E questo dico acciò che altri non si maravigli perché io l'abbia allegato di sopra quasi come entrata della nuova materia che apresso viene.
Questo passaggio ha sollevato moltissime perplessità principalmente per due ragioni: in
primo luogo, appare assai strano che Dante scriva ai principi della terra una lettera in latino per
discutere della morte di Beatrice (che oltretutto, se di Beatrice Portinari si tratta, era sposata ad
un altro); inoltre, Dante scrisse ulteriormente una lettera in latino ai Cardinali italiani che aveva
per inizio la frase di Geremia di cui sopra. Questa seconda lettera ci è pervenuta (ed era
LETTERA PERDUTA !22
abbastanza conosciuta perché Giovanni Villani la ricordi nella sua Cronica) mentre della prima
non esiste alcuna traccia.
Sembra naturale chiedersi se le due lettere non siano in qualche modo collegate, visto che 25
tra l’altro i Cardinali italiani possono essere indicati con l’espressione “principi della terra” in
maniera molto più appropriata che non i notabili di Firenze, interpretazione oggi accettata dalla
maggior parte dei commentatori. Diversi dantisti dell’Ottocento—il Witte, il Balbo e il Rossetti
fra gli altri—credettero che le due epistole fossero una sola. Però, la lettera ai Cardinali fu da
Dante scritta nel 1314, quando questi si trovavano a Carpentras per il Conclave che doveva
scegliere il successore di Papa Clemente V, morto il 20 Aprile di quell’anno. Questo Papa, che
Dante per bocca di San Pietro taccia di usurpatore del trono pontificio, era responsabile del
trasferimento della Santa Sede da Roma ad Avignone. Secondo le fonti, Clemente fece il suo
primo ingresso nella città provenzale nel Marzo 1309, forse il 9. Dopo la sua morte, Dante
puntava sul Conclave per l’elezione di un Papa italiano, che avrebbe riportato il soglio pontificio
nella sua sede propria, Roma. Dunque, anche se la lettera fu inviata nel 1314, l’avvenimento
cruciale a cui essa si riferisce data della Primavera del 1309.
Darò subito la mia conclusione: le due lettere sono, in realtà, una sola. Dante scrisse la
lettera in latino con l’incipit di Geremia nel 1309-10, subito dopo il trasferimento della curia
pontificia ad Avignone. Per un accidente astronomico—un ciclo luni-solare di 19 anni noto come
“ciclo di Metone”—tutte le eclissi di Sole e di Luna del biennio 1290-91 si ripetono, nelle stesse
date, durante il biennio 1309-10. Nel primo decennio del ‘300, Beatrice assume sempre di più
per Dante i connotati della Sposa di Cristo , immagine della Chiesa militante tradita dai 26
Cardinali. Nel sistema di memoria artificiale di Dante, gli eventi prossimi alla morte di Beatrice e
quelli che circondano la traslazione della Curia ad Avignone dalla sua legittima sede romana, si
identificano, essendo individuati dagli stessi eventi astronomici, in particolare l’eclissi di Sole del
“Dante, nella Vita Nova (xxx, 1-2) afferma di aver composto, subito dopo la morte di Beatrice, una lettera in latino, 25
diretta ai principi della terra, sulle condizioni della città di Firenze, ≪desolata≫ e ≪quasi vedova, dissigillata da ogni dignitade≫ per quella morte. La lettera cominciava con lo stesso versetto di Geremia ≪Quomodo sede sola civitas≫, cola quale ha inizio anche l’epistola ai Cardinali italiani del 1314. Ma la lettera alla quale allude Dante nella Vita Nova è andata perduta, né è facile immaginare che sia stata poi adattata e rifusa nella lettera del 1314, per la troppo evidente differenza di contenuto tra le due composizioni.” Tratto da Raffaello Morghen, Dante profeta: tra la storia e l’eterno, Editoriale Jaca Book, 1998, nota 1, pag. 109. Si noti per inciso che Dante non cita mai Firenze nella Vita Nuova, e che se la lettera ai principi della terra è andata perduta, sul suo contenuto non si può dire granché.
Nella Lettera ai Cardinali Italiani, Dante chiama la Chiesa Sponsa Christi e nel Canto XXX del Purgatorio 26
l’apparizione di Beatrice è salutata dal canto Vene, Sponsa, de Libano, un versetto del Cantico dei Cantici
LETTERA PERDUTA !23
12 Marzo. Dante ritorna quindi sulla redazione della Vita Nuova, e vi aggiunge la menzione della
Lettera ai Cardinali subito dopo che Beatrice fue partita da questo secolo, evento identificato con la
partenza della Chiesa da Roma.
In dettaglio, il mio argomento si basa sui punti seguenti:
(1) Nella Vita Nuova Dante riferisce di aver scritto una lettera in latino ai principi della terra
dopo la morte di Beatrice, con un incipit tratto dalle Lamentazioni di Geremia; la lettera,
apparentemente perduta, descrive la desolazione di un’imprecisata città dopo quella morte;
Dante fornisce la data completa della di lei dipartita—il Novilunio dell’8 Giugno 1290—
esattamente a mezza via tra due eclissi solari, avvenute rispettivamente il 12 Marzo e il 5
Settembre 1290; nel testo, un’eclissi solare, descritta in gran dettaglio, annuncia al Poeta la
morte dell’amata.
(2) Giovanni Villani ci informa che dopo la morte di Papa Clemente V, Dante invia una
lettera in latino ai Cardinali italiani . 27
(3) In un manoscritto della mano del Boccaccio è conservata una lettera in latino attribuita
a Dante, con lo stesso incipit di quella della Vita Nuova; la lettera, che si rivolge ai Cardinali
italiani responsabili della nomina di Clemente V nel 1305, lamenta la desolazione di Roma
dopo il trasferimento della sede papale ad Avignone; essa porta nella numerazione attuale
delle epistole dantesche il numero XI.
(4) Secondo le cronache dell’epoca Clemente V entrò ad Avignone a ridosso della 28
Primavera del 1309, seguito poco dopo dalla Curia;
(5) Le cronache riportano come di consueto numerosi fenomeni astronomici osservati nel
biennio 1309-1310. Il 16 Gennaio 1309, Marte si congiunse con Saturno ; la congiunzione 29
avvenne nel Sagittario che è il segno della Provenza. Un mese dopo, il 25 Febbraio, si osservò
in tra.ll'altre fece tre nobili pistole; l'una mandò al reggimento di Firenze (…) la terza a' cardinali italiani, quand'era la vacazione dopo 27
la morte di papa Chimento, acciò che s'accordassono a eleggere papa italiano; Giovanni Villani, Nuova cronica (Biblioteca Italiana Zanichelli)
Vita Clementis V, auctore Joanne canonico Sancti Victoris Parisiensis: “All’inizio della Primavera il papa venne ad 28
Avignone da Bordeaux, dove svernava.” (In principio veris venit papa de Burdegala, ubi hyemaverat, Avinionem). Citato in Etienne Baluze (1630-1718), Vitae Paparum Avenionensium (1693).
Eodem autem tempore facta est conjunctio Martis cum Saturno. Da Ptolomaei Lucensis Hist. eccles.. Citato in Etienne 29
Baluze, Vitae Paparum Avenionensium (1693).
LETTERA PERDUTA !24
una notevole eclissi di Luna, in cui l’astro fu dapprima color sangue, poi nero . Dopo un 30
anno circa, il 31 Gennaio 1310, un’eclisse anulare di Sole fu chiaramente visibile nella città
provenzale ,29, e in seguito, il 14 Febbraio , e l’11 Agosto , due eclissi di Luna. 31 32 33 34
(6) L’epistola XI contiene un riferimento, sia pure figurato, ad un’eclissi di Sole : 35
21 [10]. E perché tale proposito una gloriosa magnanimità assecondi e difenda, la città di Roma, ora privata dell'uno e dell'altro lume, ora degna d'essere compassionata nonché da altri da Annibale stesso, sedente sola e vedova (come nella profezia sopra ricordata), quale è, come misura della vostra immaginazione, occorre che fissi davanti agli occhi della mente.
22 E queste cose riguardano soprattutto voi che conosceste fin da fanciulli il sacro Tevere. Poi sebbene la capitale laziale debba essere piamente amata da tutti gli Italiani, come principio comune della loro civiltà, si dirà giustamente che tocca a voi venerarla con la più grande devozione, essendo per voi il principio anche dello stesso essere.
Eodem anno [1309], in crastino beati Matthie [25 Febbraio], luna passa est eclipsim in crepusculo diei, et primo 30
fuit sanguinea, postea nigra. Da Ptolomaei Lucensis Hist. eccles.. Citato in Etienne Baluze, Vitae Paparum Avenionensium (1693).
Eodem quoque anno Domini MCCCIX , ultima die januarii [31 januarii], circa meridiem, fuit eclipsis solis, non 31
tamen tanta quod dies notabiliter fuerit obscurata; que prius a plerisque10 futura major fuerat publicata. Dalle cronache dette Flores chronicorum seu Cathalogus pontificum romanorum, opera di Bernardo Guido, Vescovo di Lodi. Citato in Etienne Baluze, Vitae Paparum Avenionensium (1693).
Anno Domini MCCCX, ultima die januarii, in septima hora diei, apud Avinionem, fuit eclipsis solis, et eclipsatus 32
est ultra medietatem, sicque notabiliter quod si aliqua sintillatio notabilis tunc fuisset in nostro emisperio, visa fuisset; duravitque ultra nonam horam. Eodem anno, xiiij die februarii, circa occasum solis, fuit eclipsis lune. Da Ptolomaei Lucensis Hist. eccles.. Citato in Etienne Baluze, Vitae Paparum Avenionensium (1693).
Joanne Canonico Sancti Victoris Parisiensis. Citato in Etienne Baluze, Vitae Paparum Avenionensium (1693): Die 33
sabbati, pridie kalendas februarii [31 januarii 1310], circa meridianam horam, in XVIIJº gradu Aquarii, facta [est] solis particularis eclipsis, prescita et predicta multis ante diebus a quibusdam clericis Parisiensibus expertis in astronomie facultate. Et tempore subsequenti, circa medium martii, circa auroram, apparuit in medio orbis lune crux rubea cum tribus circulis quorum major erat albus,
Eodem anno, in augusto, luna passa est eclipsim in duodecima hora noctis usque ad medietatem, et facta est nigra 34
sive cinericia, et duravit plus quam duabus horis usque ad crepusculum diei. Da Ptolomaei Lucensis Hist. eccles.. Citato in Etienne Baluze, Vitae Paparum Avenionensium (1693).
(21)[10]. Quod ut gloriosa longanimitas foveat et defendat, Romam urbem, nunc utroque lumine destitutam, nunc 35
Annibali nedum alii miserandam, solam sedentem et viduam prout superius proclamatur, qualis est, pro modulo vestre ymaginis ante mentales oculos affigatis oportet. (22) Et ad vos hec sunt maxime qui sacrum Tiberim parvuli cognovistis. Nam etsi Latiale caput pie cunctis est Ytalis diligendum tanquam comune sue civilitatis principium, vestrum iuste censetur accuratissime colere ipsum, cum sit vobis principium ipsius quoque esse. (23) Et si ceteros Ytalos in presens miseria dolore confecit et rubore confudit, erubescendum esse vobis dolendumque quis dubitet, qui tam insolite sui vel Solis eclipsis causa fuistis?
LETTERA PERDUTA !25
Tabella 1. Eclissi di Sole e di Luna nei bienni 1290-91 e 1309-10.
Anno Eclissi di Sole Eclissi di Luna
1290 12 Marzo; 5 Settembre; 25 Febbraio; 22 Agosto
1291 31 Gennaio 14 Febbraio, 11 Agosto
1309 11 Febbraio; 12 Marzo; 6 Agosto, 4 Settembre 25 Febbraio, 21 Agosto
1310 31 Gennaio 14 Febbraio, 11 Agosto
23 E se oggi la miseria ha annientato nel dolore e ha confuso nel rossore tutti gli altri Italiani, chi dubiterà che dobbiate arrossire e dolervi voi che siete stati allora la causa di una straordinaria eclissi di quello che si dice il suo Sole?
(7) Nella stessa epistola, Dante fa un curioso riferimento all’astrologia : 36
4 [3]. Rattrista, ahimè, (…) che, cosa più abominevole, degli astronomi e dei rozzamente profetanti affermano essere necessario quello che voi, male usando della libertà dell'arbitrio, preferiste scegliere.
(8) Il mio assunto, come dovrebbe essere ormai chiaro, è che Dante “cataloghi” gli
avvenimenti storici seguendo un sistema di “luoghi di memoria” astronomici. In particolare,
egli memorizza in “luoghi” in stretta prossimità, e con simili “puntatori”, eventi che sono tra
loro legati da un ciclo astronomico. Se quindi esiste una relazione tra gli eventi astronomici
del periodo 1309-10, e quelli del 1290-91, si può supporre che eventi avvenuti nel 1309-10
siano collocati in memoria “accanto” a quelli del 1290-21.
(9) Ma l’argomento deve essere ancora più stringente: gli avvenimenti del 1290—la morte
di Beatrice—sono contrassegnati da eclissi di Sole, sia esplicitamente nel testo, sia attraverso
la simmetria dei componimenti poetici che richiama la simmetria delle eclissi. Gli
avvenimenti del 1309 dovrebbero quindi essere anch’essi contrassegnati da eclissi, in qualche
modo analoghe a quelle del 1290 per il tramite di un ciclo astronomico. Ed è così. Il 1309
dista 19 anni dal 1290. Questo lasso di tempo corrisponde a un “ciclo di Metone o
Metonico”, il ciclo astronomico per cui una lunazione si ripete quasi esattamente nello stesso
giorno del mese della precedente . Ma non solo. Il Novilunio è una condizione necessaria, 37
anche se non sufficiente, per che il Sole sia eclissato. Per ragioni che sarebbe lungo spiegare in
questa sede, il ciclo di Metone può anche essere un ciclo di eclissi, per un numero limitato di
ripetizioni. E così fu. Come ricordato sopra, il 12 Marzo 1290 è la data dell’eclisse di Sole che
precedette la morte di Beatrice: ugualmente, la Luna eclissò il Sole anche il 12 Marzo 1309.
Inoltre, ci fu un’eclissi di Luna il 25 Febbraio 1290, un’altra eclissi di Sole il 31 Gennaio 1291
ed ancora due eclissi di Luna il 14 Febbraio e l’11 Agosto dello stesso anno! Come richiede il
Piget, heu!, non minus quam plagam lamentabilem cernere heresium, quod impietatis fautores, Iudei, Saraceni et 36
gentes, sabbata nostra rident, et, ut fertur, conclamant: "Ubi est Deus eorum?"; et quod forsan suis insidiis apostate Potestates contra defensantes Angelos hoc adscribunt; et, quod horribilius est, quod astronomi quidam et crude prophetantes necessarium asserunt quod, male usi libertate arbitrii, eligere maluistis.
Il ciclo, che prende il nome dall’astronomo greco Metone (V sec. a.C.), è fondato sull’osservazione che 19 anni 37
solari corrispondono, con un’errore di circa 2 ore e 5 minuti, a 235 lunazioni. Su questo ciclo si basava il computo della data della Pasqua.
LETTERA PERDUTA !26
mio assunto, dal punto di vista delle eclissi, il biennio 1290-1291 si ripete nel 1309-1310. La
tavola seguente riporta le eclissi citate nelle cronache avignonesi (in grassetto) e quelle che
hanno un corrispondente nei due bienni (sottolineate). Tutte le eclissi di Sole e di Luna del
biennio 1290-91 si ripetono nel 1309-10 . 38
9. Conclusione (per ora)
Ho esposto in questo articolo gli argomenti che mi permettono di concludere che la Vita Nuova è un’opera unica nel suo genere, essendo costruita in modo da ricalcare fedelmente il “libro della memoria” del suo autore. In quanto tale, essa rappresenta forse il solo esempio concreto conosciuto di applicazione delle tecniche di memorizzazione a base di “luoghi” ed “immagini”, teorizzate nell’Ad Herennium. I luoghi qui utilizzati da Dante sono di natura astronomica: le posizioni sull’eclittica delle 25 congiunzioni tra Marte e Venere che si ripetono ogni 32 anni, nonché le posizioni di eventi notevoli, come le eclissi di Sole che accompagnarono e legarono tra loro due eventi fondamentali nella vita del Poeta: la morte di Beatrice, e il trasferimento della Curia romana ad Avignone.
Utilizzando questo legame fornito dalla periodicità dei fenomeni astronomici, ho
argomentato che la “lettera ai principi della terra” che Dante dichiara aver scritto dopo la morte
di Beatrice non è altro che l’“epistola XI”, in cui che Dante rivolge un accorato appello ai
Cardinali italiani perché riparino all’obbrobrio dell’esilio della Sede Apostolica da Roma. I 19
anni, dal 1290 al 1309, che separano i due eventi corrispondono al periodo di un ciclo di eclissi,
cosicché tutte le eclissi di Sole e di Luna del 1290—comprese quelle che inquadrano
simmetricamente la morte di Beatrice—si ripetono alle stesse date nel 1309. Il ricordo della
redazione dell’epistola ai Cardinali viene da Dante “messo in memoria” nello stesso “luogo” dove
si trova memorizzata la morte di Beatrice, sotto il contrassegno dell’eclissi di Sole di VN XXIII, e
i due eventi vengono riportati l’uno di seguito all’altro, come se fossero contemporanei.
E’ inevitabile che questo tipo d’argomenti lascino perplessi più d’uno. Di fronte
all’impossibilità di fornire una dimostrazione, non posso che appellarmi alla loro conformità al
pensiero dell’epoca. Che la periodicità dei fenomeni astronomici fosse considerato uno strumento
utile a tener traccia di eventi accaduti in epoche diverse, stabilendo una relazione tra di essi, è un
Solo due eclissi di Sole del 1309 (11 Febbraio e 6 Agosto) non sono ripetizioni di eclissi del 1290, proprio perché il 38
ciclo di Metone non è un ciclo di eclissi esatto. Tutte quelle del biennio 1290-91 si ritrovano però nel 1309-10.
LETTERA PERDUTA !27
concetto espresso esplicitamente da questo brano di Giovanni Villani (Nuova Cronica, Lib. XIII,
cap. 41):
Ora potrà dire chi questo capitolo leggerà, che utole porta di sapere questa strolomia al presente trattato? Rispondiamo che a chi fia discreto e proveduto, e vorrà investigare delle mutazioni che sono state per li tempi adietro in questo nostro paese e altrove, leggendo questa cronica assai potrà comprendere per comparazione di quelle sono passate pronosticate delle future, aconsentiente Idio, che questa congiunzione in questa tripicità de' segni dell'aere fu e cominciò a questi nostri presenti tempi gli anni MCCCV nel segno della Libra; e poi gli anni MCCCXXV nel segno del Gemini. A ciascuno fu ed è assai manifesto le novità state nella nostra città e altrove, ch'assai sono fresche dall'una congiunzione e.ll'altra, che sono state quasi di XX anni in XX anni poco meno; ch'è.lla più leggera, e in LX anni tornò, ch'è più grave e muta tripicità. E anche si possono leggermente ritrovare le novità che furono, e.lla discordia e guerra dalla Chiesa e.llo 'mperio, e l'altre novitadi e dell'antico popolo di Firenze, e della tralazione della signoria del re Manfredi al re Carlo, e in CCXL overo in CCXXXVIII l'avrà fatta XII volte in XII segni, le novitadi che furono in que' tempi adietro, il passaggio d'oltremare e altre grandi cose, e.lla mutazione della signoria del regno di Cicilia a Ruberto Guiscardo. E in DCCCCLX overo DCCCCLIII anni fornite XLVIII congiunzioni, e tornando alla prima, ch'è la più ponderosa di tutte, se cerchi adietro troverrai il cominciamento del calo della potenza del romano imperio alla venuta de' Gotti e di Vandali inn Italia, e molte turbazioni a santa Chiesa etc. E questo basti alla presente materia, e diremo d’altro.
Che Dante condividesse un approccio alla Storia per cui gli eventi si possono comprendere
attraverso il confronto con il passato e che ciò permetta di pronosticare avvenimenti futuri, è
dimostrato dalle numerose profezie che si trovano nella Commedia. Il ruolo delle stelle propinque nel
darne il tempo (Purgatorio 33, 40-42) è anch’esso ben chiaramente enunciato. La Vita Nuova ci
fornisce un primo esempio di questo atteggiamento, in cui l’appropinquarsi e il congiungersi dei
pianeti scandiscono la classificazione mnemonica degli eventi, e ne stabiliscono rapporti e
relazioni di somiglianza, che potranno in seguito evolvere sino a diventare un vero sistema di
cause ed effetti.
LETTERA PERDUTA !28




























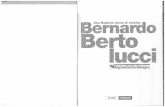












![Giovanni Virginio Schiaparelli: le «lacrime di San Lorenzo» portano a Marte [I parte]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633f180803c3a3f0c206a458/giovanni-virginio-schiaparelli-le-lacrime-di-san-lorenzo-portano-a-marte-i.jpg)