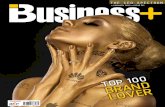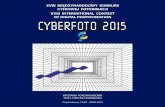2015 - Lettera sull'enunciazione
Transcript of 2015 - Lettera sull'enunciazione
1
Lettera sull’enunciazione
Massimo Leone, Università di Torino
“Caro/a studente/essa,
è una splendida domenica pomeriggio, ma io sono qui, seduto di fronte al mio computer portatile,
intento a scriverti questa lettera. Vorrei infatti mettere per iscritto ciò che ti ho già spiegato a lezione
a proposito dell’enunciazione. Ti ricordi?”
1. Misurare le distanze.
Quasi certamente, il paragrafo che hai appena letto ti avrà sorpreso. In effetti, ti saresti aspettato
piuttosto un inizio di questo tipo:
“Scopo di questa lettera è quello d’illustrare le caratteristiche principali del concetto di
enunciazione nella semiotica”.
Ebbene, storicamente gli studi sull’enunciazione nascono proprio per cercare di capire e
formalizzare questo tuo stupore. Ti sarai accorto/a, infatti, che, nonostante i due paragrafi dicano
praticamente la stessa cosa, o abbiano praticamente lo stesso senso generale (si esprime il desiderio
di spiegare cosa sia l’enunciazione), vi è fra di essi una differenza fondamentale. Leggendo il primo
paragrafo ti sarai sentito/a anche tu qui, seduto/a accanto a me, di fronte a questo computer (ehi,
spostati!). Avrai sentito intorno a te questa splendida domenica pomeriggio, o perlomeno te la sarai
rappresentata mentalmente, ricorrendo alle immagini di splendide domeniche pomeriggio depositate
nella tua memoria. Inoltre, il fatto che sin dall’inizio ti abbia dato del tu, chiamandoti “cara
studentessa”, o “caro studente” ti avrà fatto percepire sin da subito che chi ti scriveva non era
qualcuno distante da te, ma qualcuno a te vicino, come un amico che ti scrive una lettera. Ora, prova
a leggere il secondo paragrafo: il senso è lo stesso, come ti dicevo, ma la distanza che percepisci fra
te e questo messaggio, fra te e questo testo, è cambiata radicalmente. Ti senti nuovamente una
studentessa, o uno studente, seduto/a in un’aula universitaria, chino/a sui tuoi appunti (o intento/a a
chiacchierare, come al solito!) Nessuno ti dà più del tu, sono scomparsi i riferimenti espliciti a chi ti
scrive o parla, non ti si racconta nulla sul luogo da cui ti giunge il messaggio, sul tempo in cui esso
è stato composto dal suo autore. Così, dopo aver letto il primo paragrafo avvertirai nel secondo una
certa freddezza, un certo distacco. Non ti sembrerà più di leggere la lettera di un amico, ma il
libretto delle istruzioni di una nuova aspirapolvere.
2
Ebbene, se non ti è chiaro fino a questo punto te lo ripeto: la gran parte degli studi sull’enunciazione
ha avuto come scopo proprio quello di spiegare la natura linguistica (e poi semiotica) di tutte queste
differenze, di comprendere attraverso quali meccanismi la lingua ci consente di mettere in scena
una certa vicinanza, o una certa distanza, fra i protagonisti di una comunicazione.
2. L’enunciazione in pratica.
A questo punto mi chiederai (o forse ti chiederai, se sei una persona garbata): e a me che cosa
importa? Te lo chiarisco subito: per un professionista della comunicazione, è molto importante
saper manipolare il linguaggio (non solo quello delle parole, bene inteso, ma anche quello delle
immagini, dei gesti, delle distanze, e chi più ne ha più ne metta) al fine di progettare la distanza fra
chi produce un messaggio e chi lo riceve. Ti sarà stato spiegato in mille modi, infatti, che ogni
comunicazione nasce con un progetto, esplicito o implicito, e che la comunicazione è tanto più
efficace quanto più i suoi esiti reali sono conformi a tale progetto. Così, non sapendo nulla
dell’enunciazione, quando sarai un/a celebre pubblicitario/a ti potrà capitare di creare slogan come:
“si consiglia vivamente l’ingestione di Coca-Cola”,
messaggio che, lo riconoscerai, ha un impatto comunicativo assai improprio rispetto a
“bevi Coca-Cola”
(anche se il primo funziona benissimo come parodia del secondo). Se invece sarai un/a famoso/a
giornalista, e ti capiterà di condurre il Tg1 delle 20:00, munito di sobria giacca e composta cravatta,
oppure fasciata in un impeccabile tailleur, se non avrai letto e memorizzato con attenzione questa
lettera sull’enunciazione ti capiterà di congedarti dai telespettatori dicendo:
“Non ho più nulla da raccontarvi, ci vediamo domani sera, stesso luogo, stessa ora”,
invece di
“Questo telegiornale termina qui. La prossima edizione del TG1 è alle ore 23:00”.
3
Così ti licenzieranno su due piedi, ma niente paura: sarai ingaggiato/a da Striscia la notizia,
programma che, semioticamente, funziona proprio sullo stravolgimento dell’enunciazione tipica dei
telegiornali ufficiali.
Potrei fornirti ancora molti esempi per dimostrare il fatto che la tua vita sarà una tragedia se non
leggerai attentamente questa lettera. Ma credo proprio che non ce ne sia bisogno. Sei comodo
sul(la) sedia/poltrona/divano/scalino/tappeto di chiodi? Allora cominciamo.
Come avrai capito, il fatto di percepire che certi messaggi costruiscono fra emittente e ricevente una
distanza, cognitiva ed emotiva (pensieri + emozioni) maggiore o minore rispetto ad altri messaggi,
non è qualcosa dell’altro mondo. Al contrario, fa parte della nostra esperienza quotidiana. Tutti ci
arrabbiamo, c’innamoriamo, ci lasciamo adulare o convincere ora dopo ora, giorno dopo giorno,
anche sulla base della percezione di queste distanze. D’altra parte, quantunque tu sia forse incline a
ritenere il contrario, lo scopo della semiotica non è quello di complicarti la vita, o di studiare
fenomeni che non fanno parte della tua realtà; scopo della semiotica è, al contrario, proprio quello
di aiutarti a comprendere in un quadro formale fenomeni che toccano le esistenze di moltissimi
individui, spesso quotidianamente. In altre parole, tutti sappiamo che dire:
“la televisione contemporanea raggiunge livelli poco elevati di pregio estetico”,
e dire
“la TV di oggi mi fa schifo”
non esprimono la stessa soggettività. Tuttavia, nessuno si era mai occupato di stabilire le leggi di
questa differenza, di cogliere il modo in cui queste diverse espressioni della soggettività si
costruissero attraverso il linguaggio. Nessuno, sino a Émile Benveniste, il nostro eroe.
3. Émile Benveniste a proposito dell’enunciazione.
Forse sarai curioso/a di sapere che Benveniste nacque ad Aleppo il 27 gennaio del 1902 e morì a
Versailles il 3 ottobre 1976, a sette anni di distanza da un grave attacco che lo aveva reso afasico
(cioè incapace di esprimersi verbalmente). La sorte è stata amaramente ironica con questo geniale
studioso, che ha contribuito così tanto a svelare i misteri della parola. Ma non lasciamoci prendere
dalla malinconia, e proseguiamo. Grosso modo, gli scritti di Benveniste esplorano due grandi aree:
4
quella dello studio comparato delle lingue e delle culture indoeuropee, e quella della linguistica
generale. Sospetto che le lingue iraniche per il momento non t’interessino, per cui passiamo alla
seconda area. I contributi di Benveniste in questo secondo settore sono raggruppati in due volumi:
Problemi di linguistica generale, vol. 1 (Parigi: Gallimard, 1966, trad. it. Milano: il Saggiatore,
1971) e Problemi di linguististica generale, vol. 2 (Parigi: Gallimard, 1974, trad. it. Milano: il
Saggiatore, 1985)…beh, non molta fantasia sui titoli, eh?
4. Gli elementi dell’enunciazione.
La grande intuizione di Benveniste è stata semplice (come gran parte delle grandi intuizioni): nella
lingua vi sono delle espressioni il cui significato non può essere determinato senza un riferimento a
chi le utilizza. Facciamo un esempio. Se io dico (ti chiedo scusa per questi esempi auto-
referenziali):
“Massimo Leone è docente di semiotica presso l’Università di Torino”,
il significato di questa frase (poi scopriremo che possiamo chiamarla anche “enunciato”) è lo stesso
sia che tale espressione sia pronunciata da te, sia che essa sia pronunciata da uno dei tuoi colleghi; il
contenuto della frase rimane identico: c’è un giovanotto che si aggira per i corridoi di Palazzo
Nuovo, e che ogni giovedì venerdì e sabato (maledetto!) s’infila dentro una grande aula sotterranea
e parla di segni, significanti, significati, etc. Ora prova a considerare la frase seguente:
“Io sono docente di semiotica presso l’Università di Torino”.
Il significato, il senso, il contenuto di questa frase, di questo enunciato cambia radicalmente se a
proferirla è un giovanotto con barbetta (che sarei io) o un signore con i capelli bianchi (che sarebbe
Guido Ferraro). Entrambi siamo docenti di semiotica presso l’Università di Torino, per cui la frase
“Io sono docente etc.” cambia profondamente di significato se a pronunciarla sono io oppure se si
tratta di Guido. L’intuizione geniale di Benveniste è stata quella di comprendere l’esigenza di
studiare questi fenomeni linguistici, vale a dire tutti quegli elementi del linguaggio verbale il cui
significato non è indipendente da chi li ha utilizzati, dal luogo in cui sono stati utilizzati, dal tempo
in cui sono stati utilizzati.
Benveniste riconobbe perlomeno tre gruppi di tali espressioni:
5
1) i pronomi personali, come “io”, “tu”, “noi”, “voi”, etc.;
2) i deittici, una parola misteriosa che però ancora una volta cela una realtà linguistica assai
comune; la definizione teorica dei deittici è: “espressioni di contenuto ostensivo”, vale a dire
espressioni che servono a indicare il contesto spaziale cui l’enunciato si riferisce; in pratica, ci si
può facilmente ricordare dei deittici definendoli come “quella classe di espressioni che sono
estremamente utili in una pasticceria”: “mi dia codesto pasticcino, no mi dia piuttosto quello, anzi
mi faccia provare anche quello…”;
3) gli indicatori della temporalità, come “oggi”, “ieri”, “domani”, ma anche i tempi verbali come
“studiai”, “studiavo”, “ho studiato”, “studio”, “studierò” (OK, mi sembra il caso di fare una pausa).
Non ti sarà sfuggito che la frase da cui siamo partiti, il paragrafo iniziale di questa lettera, contiene
tutte e tre le classi di espressioni: 1) pronomi: “io sono qui”; 2) deittici: “io sono qui”; 3) espressioni
temporali: “è una splendida domenica pomeriggio”. Come vedremo, infatti, gli elementi individuati
da Benveniste, quelli il cui significato si evince in relazione a chi li utilizza, a quando sono
utilizzati, a dove li si utilizza, sono anche gli elementi che, all’interno di un enunciato, consentono
di modulare la distanza tra i poli della comunicazione, introducendovi una dose più o meno
consistente di soggettività.
5. L’istanza dell’enunciazione.
Ma procediamo con ordine, non vorrei che ti confondessi. Le espressioni come “io”, “qui”, “oggi”,
etc. hanno, come dicevamo, un significato che si può precisare soltanto in relazione a chi le ha
utilizzate, al tempo in cui sono state utilizzate, al luogo in cui sono state utilizzate. L’insieme di
queste indicazioni sui protagonisti, il tempo e lo spazio che fanno da contesto a un enunciato si
definiscono come “istanza dell’enunciazione”.
Ma attenzione: ci vogliono di solito anni e anni di meditazione per capire cosa sia in realtà
“l’istanza dell’enunciazione”. All’inizio, ti sarà quasi naturale pensare che “l’istanza
dell’enunciazione” consista in chi concretamente ha pronunciato una certa frase, nel luogo in cui
questa frase è stata pronunciata, nel tempo in cui è stata pronunciata. Non vi è niente di più
sbagliato. Se anche solo per un attimo ti è capitato di pensare che l’istanza dell’enunciazione sia
questo, esci a fare una passeggiata, bevi una tazza di tè, fai dieci flessioni, insomma qualunque cosa
pur di eliminare questo pensiero dalla tua mente. L’istanza dell’enunciazione non è affatto costituita
dalle circostanze concrete, tangibili, empiriche della comunicazione. Vorrei allora spiegarti cos’è
l’istanza dell’enunciazione con una piccola metafora teatrale.
Sarai sicuramente stato/a a teatro almeno qualche volta nella tua vita. Ebbene, sulla scena teatrale vi
sono dei personaggi che comunicano in un certo spazio e in un certo tempo. Tu sai che dietro questi
6
personaggi, le cose che (si) dicono, lo spazio e il tempo il cui le dicono vi è qualcuno che ha
organizzato la messa in scena, scritto un copione con le indicazioni sui personaggi, sul modo in cui
devono parlare, muoversi nello spazio, esistere nel tempo. Tuttavia, di tutto questo apparato di
istruzioni che sono dietro la messa in scena tu non puoi conoscere assolutamente nulla. Esso si situa
inesorabilmente al di là delle quinte, dove alcuni individui esistono in uno spazio e in un tempo che
è radicalmente altro rispetto a quello della scena. Di tutto questo apparato, insomma, tu non puoi
conoscere che le tracce che esso ha lasciato nella messa in scena stessa, la sola cosa che ti è dato di
osservare, conoscere, studiare.
Il rapporto fra enunciato e istanza dell’enunciazione è, per certi versi, assai simile a quello fra una
messa in scena teatrale e ciò che si situa dietro le quinte. Dal punto di vista della semiotica, quando
ci troviamo di fronte a un testo, sia esso una semplice frase o un intero romanzo, noi lo
consideriamo sempre separatamente rispetto a ciò che si trova “dietro le quinte”, ossia il contesto
empirico che lo ha prodotto concretamente. Di tale contesto, infatti, dal punto di vista della
semiotica, noi non studiamo che le tracce, le marche, gli indizi che esso ha disseminato lungo il
testo. È proprio in base a queste tracce, a queste marche, a questi indizi che possiamo ricostruire
l’istanza dell’enunciazione che sta dietro a un determinato enunciato. Tu ti chiederai giustamente:
ma studiare l’istanza dell’enunciazione non è la stessa cosa che studiare le circostanze empiriche
della produzione di un messaggio? No!!! Assolutamente no!!! E perché mai, mi chiederai tu,
sempre più confuso/a?...perché le tracce dell’istanza dell’enunciazione che noi possiamo ritrovare
all’interno di un enunciato sono sempre una simulazione, una messa in scena, esattamente come se
si trattasse di una messa in scena teatrale.
Per essere più chiari, torniamo al nostro esempio iniziale. Sia la prima frase:
“è una splendida domenica pomeriggio, ma io sono qui, seduto di fronte al mio computer portatile,
intento a scriverti questa lettera. Vorrei infatti mettere per iscritto ciò che ti ho già spiegato a lezione
a proposito dell’enunciazione. Ti ricordi?”
sia la seconda:
“scopo di questa lettera è quello d’illustrare le caratteristiche principali del concetto di enunciazione
all’interno della semiotica”
sono state prodotte nelle stesse circostanze reali (nella fattispecie, me stesso seduto di fronte al
computer, anche se oramai lo splendido pomeriggio è stato sostituito da una piovosa serata…).
7
Tuttavia, dal punto di vista della semiotica, non interessano queste circostanze empiriche (esse
riguardano, più che altro, il sociologo che studi la vita quotidiana dei giovani docenti italiani), ma
piuttosto il progetto di comunicazione che io ho inserito all’interno del primo testo, oppure
all’interno del secondo. Se le condizioni empiriche in cui queste frasi sono state prodotte sono le
stesse, infatti, le marche, le tracce, gli indizi che l’istanza dell’enunciazione ha disseminato nelle
due frasi sono radicalmente diversi. Per comprendere questa differenza, sarà allora necessario
studiare, all’interno delle due frasi, proprio gli elementi di cui si era occupato Benveniste, ovvero le
espressioni pronominali, i deittici, e le espressioni temporali. Solo così, infatti, riusciremo a capire
in che modo si organizzi la relazione fra l’enunciato e l’istanza dell’enunciazione che esso
presuppone. Scopriremo, allora, che in alcuni casi l’enunciato contiene alcune marche che simulano
una distanza ravvicinata fra l’enunciato stesso e l’istanza dell’enunciazione, mentre in altri casi
l’enunciato è costruito in maniera tale da negare tale vicinanza. È pero importante ricordare che in
entrambi i casi si tratta di un effetto del linguaggio, di una messa in scena che noi organizziamo
attraverso l’uso degli elementi espressivi studiati da Benveniste.
Insomma, sia che io scriva “adesso dovresti aver capito”, sia che io scriva “a questo punto il lettore
dovrebbe avere elementi sufficienti per la comprensione” nulla cambia a livello empirico, mentre
cambiano i simulacri, i modelli della produzione e della ricezione della comunicazione che sono
inseriti all’interno del testo e cercano di guidarne la ricezione empirica (in questo caso, utilizzando
la prima frase non mi avvicino fisicamente a te, o studente/studentessa, ma diminuisco la distanza
fra le tracce che ci rappresentano all’interno dell’enunciato).
6. Enunciazione e simulacri.
Se il concetto di simulacro dell’enunciazione non ti è ancora ben chiaro, pensa “WhatsApp”, o a
qualunque altro social network che ti permetta di chattare con i tuoi amici. Ebbene, ogni volta che
sei in chat di solito sei rappresentato da un omino, tecnicamente detto “avatar”, che segnala la tua
presenza in rete. Ora, le tracce dell’istanza dell’enunciazione all’interno dell’enunciato funzionano
un po’ allo stesso modo di un avatar: pensa a quando stai studiando le dispense del docente di
semiotica, e dunque non puoi assolutamente chattare con i tuoi amici: imposterai il tuo avatar in
modo che appaia diversamente in rete, per esempio come assente (anche se è contro la netiquette, il
codice di comportamento in rete) oppure occupato, o al telefono oppure quant’altro. Ciò che cambia
non è il contesto reale della comunicazione (tu sei sempre tu, sei sempre seduto sul(la) tu(a) sedia
poltrona divano scalino etc.), ciò che cambia è il modo in cui sei rappresentato all’interno della
comunicazione telematica (nella fattispecie, come un individuo che non può o non vuole
comunicare, almeno per il momento).
8
7. L’enunciazione fra langue e parole.
L’enunciazione può essere studiata anche da un altro punto di vista, più teorico e generale ma non
meno interessante. Ritorniamo all’esempio dell’avatar: nel momento in cui tu scegli quale
simulacro ti rappresenterà on-line, lo fai a partire da una lista finita di possibilità. Gli avatar a tua
disposizione potranno essere moltissimi (che so io, un omino con l’ombrello per indicare che piove
e che pertanto non hai voglia di chattare, uno con sigaretta in bocca per segnalare che sei in pausa
fumo, etc. etc.), ma nel momento in cui tu costruisci il tuo simulacro, devi selezionarne uno e uno
soltanto. Ti è infatti impossibile selezionare più avatar allo stesso momento, in quanto ciò
contraddirebbe lo scopo stesso della scelta, che è quello di comunicare la tua posizione on-line.
Ogni volta che un’istanza dell’enunciazione (adesso il significato di questa espressione dovrebbe
esserti familiare) produce un enunciato, succede più o meno la stessa cosa: a partire da un insieme
di forme, o da un inventario sistematico di segni, si costruiscono delle combinazioni individuali di
queste forme, di questi segni. Tu mi dirai: ma queste due espressioni, “inventario sistematico di
segni” e “combinazioni individuali di forme” le ho già sentite da qualche parte. E infatti hai proprio
ragione, si tratta delle definizioni che il padre della linguistica strutturale, Ferdinand de Saussure,
diede dei concetti di langue e parole, che dovrebbero esserti molto noti. L’istanza dell’enunciazione
è dunque anche un’istanza di mediazione fra queste due dimensioni del linguaggio, cioè consente di
passare dalla langue come deposito di forme semio-linguistiche socialmente costruite e condivise
alla parole come costruzione semio-linguistica individuale basata sull’uso di alcune di queste
forme.
Ancora una volta, dobbiamo a Benveniste questa intuizione: Saussure aveva definito e studiato i
concetti di langue e di parole, ma non aveva approfondito molto il problema del loro rapporto. In
altri termini, rimaneva da spiegare come avvenisse il passaggio dall’una dimensione del linguaggio
all’altra: in che modo, a partire dell’insieme di forme semio-linguistiche appartenenti a una
determinata langue, il singolo comunicante si appropria di alcune di esse e le piega alla propria
volontà comunicativa individuale? A questa domanda cercano di rispondere gli studi
sull’enunciazione, che hanno dato luogo a un nuovo tipo di linguistica, a un nuovo tipo di
semiotica. Se Saussure si era occupato principalmente di una linguistica, così come di una
semiologia, della langue, da Benveniste in poi ci si comincia a interessare anche di una linguistica
del discorso. Il discorso è infatti quella dimensione del linguaggio che si produce attraverso
l’enunciazione, quella dimensione del linguaggio nella quale si utilizzano le forme generali della
langue per esprimere una intenzionalità comunicativa individuale. Il frammento di discorso
prodotto da una determinata enunciazione è detto “enunciato”.
9
8. L’enunciazione come luogo della soggettività.
E qui siamo alla filosofia: secondo Benveniste, il discorso è anche quella dimensione del linguaggio
nella quale è possibile esprimere la propria soggettività. Come si esprime la soggettività nel
linguaggio secondo Benveniste? Per capirlo, pensa a una conversazione fra amici, in cui si discute
di politica o di religione. Prova a immaginarti il modo in cui si esprimerebbero coloro che
partecipano a questa discussione. Sicuramente si utilizzerebbero frasi (o, per meglio dire,
“enunciati”) come questi: “io credo nella transustanziazione ma non nella resurrezione dei corpi”;
oppure “io ritengo che il tuo partito abbia preso un abbaglio”, etc. etc. In tutti questi enunciati
emerge con forza l’uso di pronomi, come “io” e “tu”, ma anche di altri elementi “soggettivi” del
discorso (i pronomi possessivi, i deittici, le forme verbali), i quali esprimono tutti lo stesso
fenomeno: un’appropriazione individuale delle forme del linguaggio verbale, al fine di costruire il
simulacro di una soggettività personale. Secondo Benveniste, il linguaggio verbale sarebbe infatti
l’unico ambito nel quale è possibile manifestare la propria soggettività. Insomma, per Benveniste è
solo nel linguaggio e attraverso di esso che possiamo dire “io”. Per averne una conferma, prova a
comunicare il tuo innamoramento per qualcuno senza utilizzare né pronomi personali, né aggettivi
possessivi, né deittici, né forme verbali alla prima persona singolare o plurale: sarai costretto/a a
proferire enunciati come
“Massimo Leone ama Scarlett Johansson”,
che non sono il massimo della soggettività, e sicuramente sarebbero inappropriati se Massimo
Leone volesse chiedere la mano della celebre attrice americana.
Il seguente schema permette di riassumere il rapporto fra langue, parole, soggetto e situazione di
discorso:1
1 Lo schema è tratto dalla “bibbia” degli studi sull’enunciazione, il saggio di Giovanni Manetti La teoria dell’enunciazione – Le origini del concetto e alcuni più recenti sviluppi (Siena: Protagon, 1998).
10
9. Discorso dialogico e discorso storico.
Dall’inizio di questa lettera ti sarai accorto/a che ho deciso di comunicarne i contenuti attraverso un
uso personale e soggettivo del linguaggio. Ho utilizzato pronomi personali, forme verbali
soggettive, pronomi possessivi anch’essi soggettivi, deittici, spesso oscillando tra l’enunciazione di
una soggettività individuale “desidero spiegarti che cos’è l’enunciazione” e una soggettività plurale
che spesso includeva anche te in quanto lettore/rice (ad esempio: “passiamo a questo argomento”,
“tralasciamo questa questione”, etc. etc.). Questa scelta potrà averti stupito/a, forse divertito/a, forse
irritato/a, ma aveva come scopo anche quello di mostrarti, attraverso il testo stesso di questa lettera,
un fenomeno linguistico assai comune, che ancora una volta Benveniste fu il primo a studiare. Si
tratta di questo: ogni volta che nel linguaggio verbale e attraverso di esso (per la precisione: nel
discorso, o in quella parte di esso che denominiamo “enunciato”) io esprimo la mia soggettività e
costruisco un simulacro linguistico di chi produce la comunicazione (cioè nella fattispecie: me
stesso), nello stesso momento costruisco anche il simulacro di chi riceve questa comunicazione, e
ne esprimo l’alterità rispetto a me. In termini più semplici, ogni volta che l’istanza
dell’enunciazione produce un “io”, essa produce simultaneamente anche un “tu”. Ripensa al modo
in cui è scritta questa lettera: io esprimo la mia soggettività in quanto colui che ne comunica i
contenuti, ma al contempo costruisco un simulacro linguistico di te, o studente/essa, che questi
contenuti sei invece destinato/a a riceverli. Nel caso di questo frammento di discorso, di questa serie
di enunciati che costituiscono la lettera che hai dinanzi ai tuoi occhi, il simulacro del mio “io” e
quello del tuo “tu” avranno sempre lo stesso contenuto: da un lato la soggettività del docente,
dall’altro l’alterità dello/a studente/essa. Ma ciò accade perché questo tipo di comunicazione scritta
11
è per definizione unidirezionale, nel senso che chi produce la comunicazione e chi la riceve
mantengono sempre gli stessi ruoli. Ma supponiamo che, invece di scrivere questa lettera, io avessi
deciso di spiegarti l’enunciazione intorno a un paio di cappuccini. Saremmo dunque seduti in un
bar, e io dopo averti parlato per una mezz’ora dell’enunciazione ti chiederei:
“Allora, io ho cercato di essere il più chiaro possibile, tu hai capito adesso che cos’è
l’enunciazione?”
E tu mi risponderesti:
“Assolutamente no, quando tu parli io non capisco nulla”.
Ebbene, considera il significato dei pronomi “io” e “tu” all’interno di questi due enunciati. Come si
diceva, esso non può essere afferrato se non con riferimento a chi ha utilizzato queste forme
linguistiche, a chi se ne è appropriato individualmente per costruire un frammento di discorso. Nel
primo enunciato sono io docente che dico “io”, mentre tu studente/essa sei rappresentato/a
all’interno dell’enunciato da un simulacro dell’alterità, della ricezione del messaggio, vale a dire un
“tu”:
“Allora, io ho cercato di essere il più chiaro possibile, tu hai capito adesso che cos’è
l’enunciazione?”.
Nel secondo enunciato, la situazione si ribalta radicalmente: tocca a te esprimere la tua soggettività
mentre tocca a me essere rappresentato, all’interno dell’enunciato, da un simulacro passivo, l’avatar
di qualcuno che riceve la comunicazione invece di produrla:
“Assolutamente no, quando tu parli io non capisco nulla”.
Questo esempio dovrebbe chiarirti il fatto che in una comunicazione orale, ma in generale in ogni
comunicazione in cui i poli della produzione e della ricezione possono essere scambiati
(tecnicamente, si definiscono “comunicazioni biunivoche” o “interattive”),2 anche i simulacri di
questi poli all’interno degli enunciati non hanno un contenuto fisso, ma ne hanno uno che varia a
seconda di chi intende esprimere la propria soggettività. Rimane però il fatto che un “io”, ovvero un
2 Anche le chat on-line sono un esempio di questo tipo di comunicazione.
12
simulacro della produzione soggettiva di una comunicazione, implica sempre un “tu”, ovvero un
simulacro della ricezione soggettiva di questa stessa comunicazione. Come ha suggerito un grande
studioso russo, Michail Michailovič Bachtin, il monologo puro non esiste, perché ogni espressione
individuale del linguaggio costruisce sempre al proprio interno il simulacro di un’audience.
Ma pensa al primo confronto che abbiamo fatto, quello tra il primo e il secondo modo di esprimere
lo scopo di questa lettera. Nel primo comparivano tracce evidenti di una personalità soggettiva:
quelle di un “io” comunicante, ma anche quelle di un “tu” ricevente; eccoti lo stesso enunciato,
dove ho evidenziato tutti gli elementi che esprimono tale soggettività in corsivo (quelli del mio
“io”) o in neretto (quelli del tuo “tu”):
“è una splendida domenica pomeriggio, ma io sono qui, seduto di fronte al mio computer portatile,
intento a scrivere questa lettera per te. Vorrei infatti mettere per iscritto ciò che ti ho già spiegato a
lezione a proposito dell’enunciazione. Ti ricordi?”
Nel secondo enunciato, invece,
“Scopo di questa lettera è quello d’illustrare le caratteristiche principali del concetto di
enunciazione nella semiotica”
non compaiono affatto tracce di un “io” o di un “tu”.3 Il discorso, infatti, invece di parlare di questi
simulacri della produzione e della ricezione della comunicazione, parla di un asettico e impersonale
“egli”, cui il discorso si riferisce. Tant’è vero, che anche il verbo è alla seconda persona singolare.
Come avrai capito facendo un breve confronto fra questa lettera e altri testi da te già letti, il discorso
accademico tende di solito a evitare ogni espressione della personalità soggettiva dell’autore, come
pure di quella del suo pubblico. Gli autori di saggi infatti normalmente manipolano le tracce
dell’enunciazione presenti all’interno dei propri enunciati in modo da eliminare ogni marca di
soggettività, e costruire l’illusione che il senso degli enunciati stessi sgorghi autonomamente da una
realtà oggettiva, esterna a un “io” che parla e a un “tu” che ascolta. Di conseguenza, l’uso di
espressioni soggettive nel discorso accademico trasmette non di rado un’espressione di scarsa
serietà. Ma attenzione: si possono dire cose scientificamente fondate attraverso un uso soggettivo
del linguaggio, così come si possono dire delle fandonie mascherandole attraverso il linguaggio
asettico dell’accademia. Il grado di maggiore o minore soggettività evocato dal linguaggio non è 3 Ad eccezione del dittico “questa”, che simula la condivisione di uno spazio fra i simulacri della produzione e della ricezione del messaggio all’interno dell’enunciato.
13
infatti che un’illusione linguistica, del tutto simile a un’illusione ottica, e trasmette un senso di
maggiore o minore serietà del discorso in base a convenzioni culturali largamente diffuse che nulla
hanno a che vedere con il contenuto del discorso stesso.
Ad esempio, io posso affermare:
“Ti dico che l’energia è uguale al prodotto della massa per la velocità della luce al quadrato”
oppure posso affermare:
“L’autore di questo saggio sostiene che la somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti è
inferiore all’area del quadrato costruito sull’ipotenusa”.
Il primo enunciato contiene alcune marche della soggettività (un “io” e un “tu”), mentre il secondo
si riferisce a un impersonale “egli” (tanto è vero che anche l’io dell’autore non è indicato più dal
pronome personale “io” ma dalla locuzione perifrastica “l’autore di questo saggio”, un modo
tortuoso che gli accedemici usano per evitare di dire “io” all’interno dei propri discorsi). Il secondo
enunciato sembra più oggettivo del primo, perché più impersonale. Tuttavia, ti sarai accorto che il
contenuto del primo enunciato è vero, mentre il contenuto del secondo è falso.
Ti ho proposto questo semplice esempio per ribadire il concetto che, sia che in un enunciato
compaiano un “tu” o un “io”, sia che compaia un “egli”, questi non sono che simulacri inseriti nel
discorso al fine di conseguire un certo obbiettivo comunicativo. Non di rado, infatti, è possibile
manipolare le tracce dell’enunciazione presenti all’interno dell’enunciato per aumentarne il grado di
soggettività o di oggettività, indipendentemente da quale sia il contenuto dell’enunciato stesso.
Così, nel momento in cui un enunciato esprime una certa personalità, ovvero il fatto che le forme
semiotiche contenute nella langue sono state oggetto di un’appropriazione individuale, si pone
sempre la scelta tra un’appropriazione che manifesta questa individualità (attraverso marche come
“io”, “tu”, i deittici, etc.) e un’appropriazione che non palesa questa individualità, riferendo il
discorso a un “egli” impersonale. Gli studi sull’enunciazione di solito distinguono dunque fra due
diversi regimi discorsivi: quello dell’io/tu, detto anche regime dialogico (in quanto è nel dialogo
che tale tipo di enunciazione si manifesta più chiaramente) e quello dell’egli, detto anche regime
storico (in quanto è nel discorso storico, quello che racconta la realtà, che tale regime si riscontra
più agevolmente).
14
Lo schema seguente, tratto sempre dal manualetto di Manetti, riassume le relazioni fra personalità,
soggettività e le espressioni pronominali “io”, “tu” ed “egli”:
Il grado di soggettività evocato dalla coppia “io/tu” da un lato e dall’“egli” dall’altro deriva dal fatto
che mentre il significato di “io” e di “tu” varia a seconda di chi utilizza queste espressioni, il
significato di “egli” si può evincere senza alcun riferimento a una realtà esterna al discorso. Ecco
dunque uno dei motivi per cui il regime del discorso storico appare più oggettivo e autonomamente
sensato di quello dialogico.
10. Mi dia del Lei.
Se ci fai caso, vi sono però alcuni tipi di dialogo in cui “l’io” e il “tu” scompaiono, e vengono
sostituiti dall’“egli”. Molte lingue, infatti, ma non tutte, posseggono le cosiddette “forme di
cortesia”, che servono a indirizzarsi dialogicamente a un individuo considerato come degno di
particolare rispetto. Se tu fossi uno studente/essa dell’Università di Torino nei primi anni ’50,
sarebbe impensabile che io mi rivolga a te dandoti del tu. Dovrei scrivere, invece: “Lei ha
sicuramente compreso il significato del concetto di enunciazione”; e se andassimo ancora più
indietro nel tempo io ti direi persino “Ella afferra adesso il senso della mia lezione”, rimettendomi il
cilindro e accarezzandomi i baffi a manubrio. Quest’uso del pronome “egli” all’interno di una
comunicazione dialogica non è però un’eccezione, ma un’ulteriore conferma di quanto detto prima:
ogni volta che nel linguaggio verbale, all’interno del discorso dialogico, si utilizzano il “lei” o
“l’ella”, o qualunque altro pronome impersonale, lo si fa proprio al fine di introdurre un’illusione
d’impersonalità, di distacco, di assenza di soggettività, in seno al dialogo stesso. Se io ti dicessi:
“mi dia del Lei, per favore”, questo enunciato suonerebbe ostile, in quanto implicherebbe che i
15
rapporti fra di noi sono divenuti tali che non intendo più mantenerli a un livello personale, e voglio
perciò mettere una distanza fra me e te. Un’altra occasione in cui si utilizza “l’egli” in un discorso
dialogico è infatti proprio quella di un litigio, quando s’intende eliminare il senso di personalità di
chi ci sta innanzi. Il seguente esempio chiarirà immediatamente di cosa sto parlando:
“Hai mangiato ancora una volta la mia Nutella. Il signorino è troppo impegnato per andare a
comprarsela al supermercato…”
Sia la prima che la seconda parte di questo enunciato sono indirizzate alla stessa persona (il ladro di
crema alle nocciole), ma se nella prima il pigro ghiottone è evocato con un simulacro soggettivo
dell’alterità (sei tu che hai mangiato la mia Nutella), nella seconda parte dell’enunciato colui al
quale questo tu si riferisce è evocato tramite un egli, che ne annulla dunque la presenza soggettiva
all’interno dell’enunciato stesso. Questa strategia linguistica, molto comune, serve proprio a
sminuire la soggettività dell’altro, nonché a trasformarlo in oggetto del discorso di una collettività
immaginaria, che biasima tale riprovevole inclinazione al furto di Nutella. Di solito, questa strategia
linguistica provoca molta irritazione in chi ne è la vittima, in quanto lo spoglia della sua presenza
all’interno del dialogo, e quindi della capacità di trasformare il “tu” con il quale è accusato (“tu hai
rubato la mia Nutella”) in un io che si difende da tale accusa (“non sono stato io, ma uno scoiattolo
di passaggio”). Questo ribaltamento del dialogo non è più possibile nel momento in cui l’accusato
vi sia evocato per mezzo di un “egli”.
11. La terminologia.
Fino a questo momento, mi sono limitato a illustrare dei concetti. Per velocizzare la comunicazione,
è però tempo di introdurre una terminologia specifica. Dal punto di vista degli studi
sull’enunciazione e sul discorso, i due poli della produzione e della ricezione di una comunicazione
sono detti rispettivamente “locutore” e “locutario”. Il locutore e il locutario corrispondono, per
sommi capi, all’autore e al lettore empirico della comunicazione verbale scritta. “Locutore” e
“locutario” sono però termini più generici, che abbracciano i due poli della comunicazione, dal
punto di vista degli studi sull’enunciazione, indipendentemente dai mezzi espressivi di cui tale
comunicazione si serve. È importante, però, non confondere questi poli empirici dell’enunciazione
con i simulacri che essa installa all’interno dell’enunciato. Il simulacro della produzione della
comunicazione (ovvero, del locutore) all’interno dell’enunciato è detto “enunciatore”; il simulacro
della ricezione della comunicazione (ovvero, del locutario) all’interno dell’enunciato è detto
16
“enunciatario”. Vi sono altre terminologie per descrivere questi stessi concetti, ma questa che ti ho
appena illustrato mi sembra la più chiara.
12. L’enunciazione in Greimas.
A partire dai saggi pionieristici di Benveniste, l’area degli studi sull’enunciazione si è ampliata
moltissimo, nella semiotica così come nelle altre discipline del linguaggio, diventando uno dei
settori più significativi e promettenti. In questa breve lettera, non mi è possibile soffermarmi
dettagliatamente su ciascuno di questi sviluppi, ma vorrei invitarti a esplorare quello che ritengo sia
il più interessante per i tuoi studi: il modo in cui il concetto di enunciazione forgiato da Benveniste
è stato reinterpretato nella teoria di Greimas. Tu mi dirai: basta, ancora Greimas! Ma io ti rispondo:
sì, ancora Greimas. Per due motivi: il primo è che i tuoi studi di semiotica ti avranno
familiarizzato/a con la semiotica generativa e i suoi percorsi, dal quadrato semiotico su su fino alla
manifestazione testuale. Ebbene, come vedrai l’enunciazione è un elemento fondamentale di questi
percorsi, di questo modello generativo del senso. Conoscerne solo i livelli più astratti senza avere
perlomeno un’idea di quello discorsivo è come mangiare solo il primo strato di una fetta di torta
Sacher: per godere pienamente di una fetta di torta Sacher bisogna mangiare la base insieme con il
primo strato di crema insieme con la fetta di pan di spagna centrale insieme con l’altro strato di
crema e così via su su fino alla panna montata (i migliori fra i semiotici avranno persino diritto alla
ciliegina).
L’altro motivo è che con Greimas gli studi sull’enunciazione prendono un’altra piega. Le intuizioni
di Benveniste sono valide sia per la linguistica che per la semiologia; tuttavia, quando lo studioso di
Aleppo forgiò la prima teoria del discorso aveva in mente soprattutto il discorso verbale, e
specialmente quello orale, e particolarmente quello faccia a faccia (vale a dire il dialogo, la
conversazione). Ma Greimas, si sa, era un tipo ambizioso: assorbe allora la teoria dell’enunciazione
e del discorso di Benveniste ma la trasforma in modo da inquadrarla all’interno non più di una
linguistica generale (o di una linguistica del discorso), ma all’interno di una semiotica strutturale. E
tu ti dirai: accidenti, meno male…con un lieve sorriso ironico. E invece io insisto sul fatto che
questa svolta è stata fondamentale, perché ha permesso di applicare alcuni dei concetti della
linguistica di Benveniste, opportunamente rielaborati, a forme di comunicazione diverse da quella
linguistica, come il linguaggio pittorico, quello cinematografico, quello televisivo, etc. etc. Così, se
oggi tu, studente/essa, disponi di uno schema teorico per comprendere le strategie del discorso dei
telegiornali, ad esempio, lo devi in parte a Benveniste, e in parte a Greimas, che della teoria
linguistica di Benveniste ha fatto un versatile strumento semiotico.
17
13. Débrayage e embrayage.
Per poter affermare di conoscere la teoria dell’enunciazione in Greimas ti sarà necessario
comprendere il significato di due termini che sin dal nome si presentano come piuttosto difficili: il
débrayage e l’embrayage. Sono due termini francesi, e se non hai mai studiato la lingua francese in
passato, per pronunciarli correttamente ti basti sapere che fanno rima con “garage”, e che l’“em” di
“embrayage” si pronuncia come un “an” pronunciato da qualcuno con un fortissimo raffreddore.
A mio avviso, vi sono due modi di studiare l’enunciazione nella semiotica di Greimas. Uno è quello
di capire quale sia il suo ruolo nel percorso generativo. L’altro è quello di capire in che cosa
consista l’enunciazione stessa. Entrambi gli approcci sono necessari e si completano a vicenda.
Cominciamo dal primo. Saprai che in sostanza per Greimas i testi non sono altro che eleganti
macchine per la comunicazione del senso, e che il percorso generativo non è altro che l’insieme
degli strumenti che la semiotica ha messo a punto per descrivere e analizzare queste macchine,
esattamente come la cassetta degli attrezzi di un meccanico da officina. Greimas è un meccanico
piuttosto ordinato, per cui ha preferito disporre i suoi strumenti lungo un percorso che va dal più
astratto al più concreto, dal più generico al più specifico. Così, nei piani bassi della cassetta degli
attrezzi troverai gli strumenti che servono in tutte le occasioni, per tutte le riparazioni, per tutte le
analisi: sono quelli che descrivono e analizzano le caratteristiche più generali o, come si suole dire, i
livelli più profondi della macchina testuale. Restando fedeli alla nostra metafora meccanica: di
un’automobile noi vediamo la carrozzeria, non il motore, eppure conoscere il motore è
fondamentale per capire come è fatta un’automobile. Inoltre, mentre le carrozzerie sono
numerosissime, anche se non infinite, i motori si riducono a pochi modelli, e anzi il principio del
motore è sostanzialmente sempre lo stesso (una combustione che produce energia meccanica). Ora,
i testi secondo Greimas funzionano più o meno allo stesso modo: la carrozzerie sono tante, anche se
non infinite (ad esempio, possiamo avere testi verbali, musicali, architettonici, romanzi, relazioni
commerciali, dialoghi teatrali, etc. etc.) ma dietro quest’apparente varietà del loro livello espressivo
(il livello della manifestazione testuale) si cela una realtà in cui tale varietà si riduce moltissimo,
specie se ci addentriamo nei livelli profondi della loro struttura semantica (il loro motore).
Studiando semiotica, avrai imparato a utilizzare il quadrato semiotico e la grammatica semio-
narrativa, insieme con la teoria delle modalità, per descrivere e analizzare il funzionamento del
motore dei testi, quello della narratività. Questa sezione ha invece l’obbiettivo di spiegarti come
questo meccanismo produttore di energia, la narratività, si comunichi alla macchina testuale, quella
di cui abbiamo esperienza. Ebbene, la teoria dell’enunciazione è lo strumento principale che
Greimas ha messo a punto per studiare questo livello del percorso generativo. Non a caso, i due
termini principali della teoria greimasiana dell’enunciazione, débrayage e embrayage, sono stati
18
presi a prestito proprio dal lessico automobilistico: débrayage indica il disinnesto dell’albero
motore, mentre embrayage indica il suo innesto. Se non sai come funziona un’automobile te lo
spiego brevemente: c’è un motore che trasforma l’energia della combustione in energia meccanica,
e poi ci sono le ruote. Ebbene, perché la prima si trasmetta alle seconde c’è bisogno di un aggeggio
chiamato albero motore. Quando stai guidando, e schiacci la frizione, l’albero motore si disinnesta,
in modo tale che l’energia prodotta dal motore non è più trasmessa alle ruote e tu puoi rallentare,
evitando di andare a sbattere contro quell’albero. Se invece abbandoni la frizione e pigi
sull’acceleratore, l’albero motore ristabilisce una connessione fra il motore e le ruote, e tu puoi
riprendere il tuo viaggio.
Cosa ha a che vedere tutto ciò con la semiotica? Moltissimo. Infatti, fino a questo punto, con lo
studio del quadrato semiotico e della grammatica semio-narrativa, tu hai studiato il motore della
macchina testuale, quello che ne produce il principio di funzionamento generale, ma non ti è ancora
ben chiaro come questo principio possa tradursi in un testo vero e proprio. Ebbene, per
comprenderlo bisogna studiare l’albero motore della macchina testuale, che è proprio
l’enunciazione. Attraverso l’enunciazione le forme semiotiche virtuali contenute nei livelli semio-
narrativi profondi (il quadrato), attualizzate in quelli di superficie (la grammatica attanziale), si
realizzano in un discorso. Come vedi, non vi è nulla di estremamente diverso da quanto sosteneva
Benveniste a proposito del rapporto fra langue e parole: attraverso l’enunciazione, le forme
semiotiche virtuali contenute nella prima si realizzano in una parole, in una porzione di discorso, in
un enunciato.
Come avviene, dunque, questa realizzazione? Questo passaggio da una virtualità attualizzata a una
realizzazione, da una langue a una parole? Qui entrano in gioco i concetti di débrayage e
embrayage. Una premessa: per Greimas come per Benveniste, dell’istanza dell’enunciazione noi
non possiamo sapere nulla, se non ciò che ci è consentito ricostruire a partire dalle tracce, dalle
marche, dagli indizi, dai simulacri che questa stessa istanza ha disseminato all’interno di un certo
enunciato. Prima dell’enunciazione, infatti, queste marche, queste tracce, questi indizi, tutti gli
elementi che esprimono l’appropriazione individuale della langue da parte di una certa parole, sono
presenti come pure virtualità, come possibilità che il sistema offre in vista di una comunicazione
individuale. Fedele alla logica dello strutturalismo, Greimas immagina questa congerie di virtualità,
questo sistema, come una serie di opposizioni, in cui l’elemento x e il suo elemento contrapposto
sono compresenti. Nel momento in cui tali virtualità si realizzano, si passa però dalla compresenza
paradigmatica dei due poli dell’opposizione alla selezione di uno solo di essi. Così, nel sistema di
virtualità che precede l’enunciazione vi sono sia la possibilità di esprimere la soggettività all’interno
del discorso (la coppia io/tu), sia quella di occultarla (l’egli); sia la possibilità di esprimere una
19
concomitanza temporale fra l’istanza dell’enunciazione e il suo simulacro all’interno dell’enunciato
(“l’adesso”, la simultaneità), sia quella di esprimere una non concomitanza fra di essi (“l’allora”, o
il “non ancora”, la non-simultaneità); sia la possibilità di inserire, all’interno dell’enunciato, delle
marche che simulino una coincidenza dello spazio in cui si colloca l’istanza dell’enunciazione con
quello in cui si situa il suo simulacro all’interno dell’enunciato (il “qui”), sia delle marche che, al
contrario, simulano una distanza spaziale fra questi due elementi (“l’altrove”).
Così, si dice che il sistema prevede un sincretismo virtuale di io/tu vs egli; ora vs allora; qui vs
altrove (vs sta per versus, parola latina utilizzata dai semiotici per designare la presenza di
un’opposizione).
Al momento dell’enunciazione, il discorso seleziona alcuni poli di queste opposizioni, di solito in
modo che le selezioni siano coerenti fra loro. Posso infatti dire:
“Napoleone fu sconfitto a Waterloo”,
che è un enunciato in cui si sono realizzate tutte le virtualità del sistema che esprimono una distanza
fra l’istanza dell’enunciazione e l’enunciato (Egli, cioè Napoleone, allora, cioè il 18 giugno del
1815, altrove, cioè a Waterloo); oppure posso dire (con la voce un po’ nasale di Wellington):
“oggi in questa piana ti sconfiggo, Napoleone”,
in cui invece l’enunciato contiene delle marche che simulano una coincidenza con l’istanza
dell’enunciazione (io sconfiggo te, qui e ora).
La grande intuizione di Greimas è consistita nel comprendere che l’enunciazione prevede sempre
un débrayage iniziale, ovvero un disinnesto del motore rispetto alle ruote, per tornare alla nostra
metafora automobilistica. Ciò significa che ogni enunciato prevede un allontanamento dall’istanza
che lo ha prodotto, proprio come se si trattasse (e qui torniamo, invece, alla nostra metafora teatrale)
di una messa in scena. Attraverso il débrayage, l’enunciato si distacca dal sincretismo delle
virtualità di un sistema linguistico (o, più generalmente, semiotico) e installa al proprio interno dei
simulacri. Questi simulacri creano l’illusione che gli attori, lo spazio e il tempo della comunicazione
siano indipendenti dall’istanza dell’enunciazione (un “egli”, un “altrove”, un “allora – non ancora”).
Una volta compreso il concetto di débrayage, ti sarà molto semplice afferrare quello complementare
di embrayage: esso consiste proprio nella simulazione di un riavvicinamento alla macchina testuale,
un reinnesto rispetto all’istanza dell’enunciazione. Così, se ogni enunciazione prevede un
20
débrayage iniziale, che a partire dal sincretismo di virtualità contenute nell’istanza
dell’enunciazione, proietta al di fuori di essa (e in contrapposizione a essa) un egli, un altrove, un
allora-non ancora (vale a dire costruisce una messa in scena con degli attori, uno spazio e un tempo
suoi propri), l’embrayage simula un ritorno verso l’istanza dell’enunciazione, e quindi un
annullamento di questa contrapposizione. I simulacri della produzione e della ricezione
dell’enunciato, installati all’interno dell’enunciato stesso, simulano dunque una coincidenza con il
locutore e il locutario dell’enunciato stesso (vale a dire i poli empirici della comunicazione); ma
questa simulazione riguarda anche il tempo e lo spazio: non più un “allora – non ancora” e un
“altrove” come nell’enunciato prodotto dal semplice débrayage, ma un “qui” e un “adesso”.
Ritorniamo ai nostri due enunciati napoleonici. Nel primo:
“Napoleone fu sconfitto a Waterloo”,
il débrayage iniziale effettua una selezione a partire dalle virtualità contenute a livello di sistema
nell’istanza dell’enunciazione, e proietta all’interno dell’enunciato alcuni attori (Napoleone, “l’egli”
del discorso), uno spazio (Waterloo) e un tempo (il passato remoto che segnala la presenza di un
tempo non simultaneo e anteriore rispetto a quello dell’istanza dell’enunciazione). Questi attori,
questo spazio e questo tempo sono altri rispetto a quelli dell’istanza dell’enunciazione: si esprime
dunque una certa distanza fra quest’ultima e l’enunciato che la presuppone.
Consideriamo adesso la seconda frase:
“oggi in questa piana ti sconfiggo, Napoleone”.
Innanzitutto, vi è da dire che in un testo scritto sarebbe impossibile incontrare questo enunciato
senza le virgolette. Le virgolette sono infatti l’artificio grafico che segnala la presenza di un
embrayage all’interno del discorso verbale. Come si costruisce secondo Greimas questo secondo
enunciato? Ebbene, a partire da un débrayage iniziale, che proietta l’enunciato con i suoi attori, il
suo tempo e il suo spazio, contrapposti a quelli dell’istanza dell’enunciazione, l’embrayage consiste
nell’annullamento delle marche testuali di tale alterità, e nella simulazione di una coincidenza fra
gli attori, il tempo e lo spazio dell’enunciazione da un lato e gli attori, il tempo e lo spazio
dell’enunciato dall’altro.
L’effetto semantico dell’embrayage è solitamente quello di creare un effetto di realtà, di
riavvicinamento, sia cognitivo che emotivo, all’istanza dell’enunciazione.
21
Il modo in cui ho scritto questa lettera può fornirti un esempio di questo effetto testuale. Quando mi
rivolgo a te alla prima persona singolare, esprimendo la mia soggettività di autore, dandoti del tu,
facendo dei riferimenti al tempo e allo spazio dell’enunciazione all’interno dell’enunciato (ricordi la
nostra splendida domenica pomeriggio?), inevitabilmente tu sentirai che il tuo rapporto di
lettore/lettrice con il testo è cambiato. Dimostrerai così di essere un/a lettore/lettrice collaborativo/a,
che aderisce al progetto di comunicazione da me inserito all’interno di questa lettera. Dal punto di
vista dell’analisi greimasiana dell’enunciazione, questo progetto consiste in una serie di embrayage,
che annullano la distanza tra enunciazione ed enunciato tipica del discorso accademico (un discorso
che è, solitamento, puramente débrayato).
14. Concatenazioni di débrayage e/o embrayage.
I concetti di débrayage e embrayage sono interessanti anche perché consentono di formalizzare
delle strutture discorsive più complesse, ad esempio quelle in cui un primo débrayage iniziale
(quello che proietta l’enunciato contrapponendone gli attori, lo spazio e il tempo rispetto al
sincretismo virtuale dell’istanza dell’enunciazione) è seguito da un secondo débrayage, contenuto
all’interno del primo. Questo tipo di struttura s’incontra con grande frequenza. Pensa a un enunciato
come:
“Massimo Leone raccontò agli studenti che Benveniste era stato affetto da afasia negli ultimi anni
della sua vita.”
Ebbene, in questo caso un primo débrayage proietta un “egli”, un “altrove” e un “allora”
contrapposti rispetto al sincretismo dell’istanza dell’enunciazione (“Massimo Leone raccontò agli
studenti”), mentre un secondo débrayage crea un secondo “egli”, un secondo “altrove” e un
secondo “allora” contrapposti ai primi (“Benveniste era stato affetto da afasia etc.”). L’espressione
dichiarativa “che” segnala la presenza di un secondo débrayage a partire dal primo enunciato
débrayato, mentre i tempi verbali (l’uso del trapassato prossimo “era stato”) segnalano il fatto che il
tempo dell’enunciato 2 è anteriore rispetto a quello dell’enunciato 1, il quale è a sua volta anteriore
rispetto a quello dell’enunciato 0.
Non vi è limite alla possibilità di incassare débrayage, innestandoli gli uni dentro gli altri come
delle matrioske, o come delle scatole cinesi. Tecnicamente, questo processo è spesso denominato
“enunciazione enunciata”, in quanto vi è un primo enunciato débrayato che a sua volta diviene
l’istanza dell’enunciazione rispetto alla quale si débraya il secondo enunciato. Frasi come:
22
“Massimo Leone raccontò che uno dei suoi studenti gli aveva menzionato che l’altro professore di
semiotica aveva dichiarato che Benveniste aveva sostenuto che Saussure non aveva spiegato il
rapporto fra langue e parole”
prevedono una vera e propria catena di débrayage.
Ogni volta che gli attori installati in un enunciato diventano a loro volta i poli di una seconda
enunciazione che produce un secondo enunciato débrayato, i poli di questa seconda enunciazione
sono definiti “narratore” e “narratario”: essi hanno infatti l’obbiettivo di far circolare un secondo
enunciato all’interno del primo. Non ti sfuggirà che il narratore e il narratario svolgono la stessa
funzione dell’enunciatore e dell’enunciatario, i quali a loro volta rappresentano le funzioni
comunicative del locutore e del locutario. Attraverso la costruzione di un certo narratario, il locutore
può dunque offrire un certo modello di ricezione della comunicazione al suo locutario. Ad esempio,
nella frase:
“Massimo Leone raccontò ai suoi attoniti studenti che Benveniste era stato affetto da afasia negli
ultimi anni della sua vita”
la reazione passionale (una profonda meraviglia) che l’enunciato attribuisce ai narratari (cioè agli
studenti) è destinata a fare da paradigma anche per i locutari del primo enunciato débrayato, vale a
dire chiunque legga questo enunciato stesso.
Vi possono essere però anche degli enunciati in cui débrayage e embrayage si combinano
variamente. Ad esempio, nell’enunciato:
“Massimo Leone entrò in aula e disse: ‘Benveniste fu affetto da afasia negli ultimi anni della sua
vita’”
un primo débrayage (quello che produce l’enunciato stesso) è seguito da un embrayage (di qui l’uso
delle virgolette), che a sua volta è seguito da un secondo débrayage (l’enunciato prodotto da
Massimo Leone). Come in un’espressione algebrica, la rappresentazione grafica del discorso
verbale di solito serba memoria di questi incassamenti, per cui ad esempio ogni embrayage ulteriore
è segnalato dall’uso di un tipo diverso di virgolette:
23
“Massimo Leone si avvicinò alla cattedra ed esclamò: ‘il mio professore di semiotica una volta mi
disse: «Gli studi di Benveniste hanno un’importanza capitale nella storia della semiotica»’”
Il fatto che per ogni tipo di virgoletta (così come per ogni tipo di parentesi nelle espressioni
algebriche) si debbano chiudere tutte le virgolette che si sono aperte, segnala il fatto che a ogni
embrayage deve corrispondere un débrayage successivo, che riconduce l’enunciato al livello del
suo primo distacco dall’istanza, dal “grado zero” dell’enunciazione.
Ogni qual volta l’enunciatore e l’enunciatario di un enunciato (vale a dire gli attori che fanno da
simulacro ai poli empirici dell’enunciazione, il locutore e il locutario) sono oggetto di un
embrayage, seguito da un secondo débrayage, essi si definiscono “interlocutore” e
“interlocutario”. A questa struttura (un débrayage iniziale che installa i simulacri dell’enunciato,
seguito da un embrayage che ne simula la coincidenza con l’istanza dell’enunciazione, seguito da
un secondo débrayage che attribuisce un secondo enunciato a tali simulacri) si ricorre normalmente
per rappresentare i dialoghi all’interno dei testi letterari.
Scommetto che a questo punto ti gira la testa, e cominci a nutrire un’irritazione crescente nei
confronti di questa lettera. Mi dispiace, ma ti invito a ritenere sostanzialmente questo: in
un’enunciazione, vi è sempre un débrayage iniziale che produce l’enunciato. A partire da questo
primo débrayage, tutto è concesso, ma con il limite seguente: ci si può allontanare a piacere
dall’istanza dell’enunciazione, concatenando débrayage su débrayage (ricordi l’enunciato
“Massimo Leone raccontò che uno dei suoi studenti gli aveva menzionato che l’altro professore di
semiotica aveva dichiarato che Benveniste aveva sostenuto che Saussure non aveva spiegato il
rapporto fra langue e parole”), mentre il numero degli embrayage inseriti in un enunciato non può
mai essere superiore a quello dei débrayage contenuti nello stesso enunciato. Per un motivo molto
semplice: l’embrayage è la simulazione di un riavvicinamento all’istanza dell’enunciazione, ma
questo riavvicinamento non può essere simulato se prima non è avvenuto un allontanamento.
Il secondo punto che ti invito a ritenere è il seguente: la sintassi dei débrayage e degli embrayage
non serve solo a far divertire i semiotici greimasiani, ma ha degli effetti semantici (anzi, è proprio
per comprendere questi effetti che utilizziamo questa teoria). In generale, gli embrayage hanno la
funzione di mostrare al locutario il progetto che il testo propone in vista della propria ricezione
(pragmatica, cognitiva, patetica), mentre i débrayage tendono a occultare la presenza di questo
progetto. È forse questo il motivo per cui, ogni volta che un débrayage è seguito da un embrayage,
la presenza del secondo tende a conferire un effetto di realtà al primo.
24
Potrei raccontarti ancora molte cose sull’enunciazione. Ti invito soprattutto ad approfondire nelle
tue letture il modo specifico in cui Greimas e la sua scuola concepiscono la costruzione del discorso
attraverso l’enunciazione (ricordi i concetti di attorializzazione, spazializzazione,
temporalizzazione, aspettualizzazione?); ti invito anche a riflettere sul modo in cui le diverse
semiotiche specifiche (quella dei testi visivi, quella del teatro, quella della musica, fino alla
semiotica della televisione e dei linguaggi persuasivi) hanno potuto formulare nuovi approcci di
analisi alla dimensione discorsiva dei propri testi grazie al quadro formale proposto dalla teoria
dell’enunciazione di Greimas e alla sua rielaborazione delle intuizioni di Benveniste.
Restiamo in contatto…
Cordialmente…