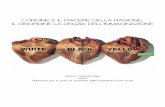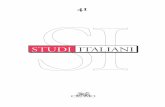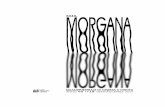"Per sghignazzarmi del mondo". La lettera faceta nel Cinquecento
Transcript of "Per sghignazzarmi del mondo". La lettera faceta nel Cinquecento
FILOLOGIACRITICA&
rivista quadrimestrale diretta da
bruno basile, renzo bragantini, roberto fedi,
enrico malato, antonio palermo, manlio pastore stocchi
direttore responsabile: enrico malato
ANNO XXVII • 2002
SALERNO EDITRICEROMA
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 16065 del 13.10.1975L’annata viene stampato con un contributo del C.N.R.
Tutti i diritti riservati - All rights reserved
Copyright © 2002 by Salerno Editrice S.r.l., Roma. Sono rigorosamente vietati lariproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasiuso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, lamemorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della
Salerno Editrice S.r.l. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
DirettoriBruno Basile, Renzo Bragantini, Roberto Fedi,
Enrico Malato, Antonio Palermo, Manlio Pastore Stocchi
Direttore responsabileEnrico Malato
Segretario di RedazioneClaudio Gigante
206
«PER SGHIGNAZZARMI DEL MONDO».LA LETTERA FACETA NEL CINQUECENTO
1. La lettera, in quanto istituzione scrittoria primaria finalizzata alla co-municazione in absentia, è presente nella storia della cultura occidentale sindai suoi albori.1 Fonte privilegiata di dati riguardanti la quotidianità delmittente, la qualità dei suoi rapporti interpersonali, la genesi delle sue ope-re, la produzione epistolare è spesso letta e citata come materiale ausiliarioche illumini alcuni snodi biografici o intellettuali dell’autore; la tendenzaromantica prima e, mutatis mutandis, positivistica poi, a considerarla comepara-testo2 ha influito, dilatata retrospettivamente, sul prolungato disinte-resse di filologi e critici letterari per quell’amplissimo settore della produ-zione letteraria cinquecentesca occupato dal “libro di lettere”.3 Fenomenoeditoriale e di mercato di incredibile portata, il “libro di lettere” cinque-centesco nasce sotto il segno della letterarietà differenziandosi dall’“episto-lario” non solo, com’è ovvio, sul piano della produzione e della ricezionema, in maniera piú significativa, su quello dello statuto comunicativo: essosi rivolge non a un lettore che prenda visione, quasi voyeuristicamente, dimateriale che in linea di principio dovrebbe essergli estraneo perché nato,secondo la definizione umanistica, come pars altera dialogi, ma a un pubbli-co allargato al quale non un corrispondente ma un autore si rivolge sfrut-
1. Già nel libro vi dell’Iliade si fa menzione di una lettera segreta: cfr. E. Avezzú, Alleorigini dell’epistolografia. I Greci e la “lettera”, in Alla lettera. Teorie e pratiche epistolari dai Greci alNovecento, a cura di A. Chemello, Milano, Guerini e Associati, 1998, pp. 3-4. Per un’analisidiacronica della storia dell’epistola nell’antichità e nella classicità, vd. A. Pennacini, Situazio-ne e struttura dell’epistola familiare nella teoria classica, in La lettera familiare (= «Quaderni di reto-rica e poetica»), Padova, Liviana, 1985, pp. 11-15, e G. Bernardi Perini, Alle origini della letterafamiliare, ivi, pp. 17-24.
2. Cfr. E. Giammattei, In memoria dello scriver lettere. Il gioco dei carteggi, in «Prospettive set-tanta», 2-3 1991, pp. 415-28.
3. Solo a partire dagli anni Ottanta si sono acquisiti i fondamentali contributi del gruppo diricerca sui “libri di lettere” del Cinquecento, concretizzatisi da un lato nel volume miscella-neo Le “carte messaggiere”. Retorica e modelli di comunicazione epistolare: per un indice dei libri di letteredel Cinquecento, a cura di A. Quondam, Roma, Bulzoni, 1981, e dall’altro in una collana dianastatiche promossa, a partire dal 1985, dall’Ist. di Studi Rinascimentali di Ferrara, diretta daG. Baldassarri e stampata presso Arnaldo Forni. Tra i pochi interventi precedenti si segnala,per la lucida proposizione di questioni teoriche inerenti le raccolte cinquecentesche di lette-re, M. Marti, L’epistolario come “genere” e un problema editoriale, in Studi e problemi di critica testuale.Atti del Convegno di studi di filologia italiana nel centenario della Commissione per i testi dilingua (Bologna, 7-9 apr. 1960), Bologna, Commissione per i Testi di Lingua, 1961, pp. 203-8.
la lettera faceta nel cinquecento
207
tando un genere di consolidata fortuna.4 Poco importa allora il datomeramente cronologico di raccolte di lettere volgari, quali quella manuzianadelle lettere di s. Caterina, che videro la luce prima del 1538; è solo inquest’anno, con l’uscita del Primo libro de le lettere di Pietro Aretino, chenasce il genere nuovo del “libro di lettere” volgari.5 E questo non soloperché per la prima volta si tratta non di raccolta postuma ma allestitadirettamente da un autore che, con «gesto traumatico, avvolto nella reti-cenza e nel pudore paragonabili all’imbarazzo di chi si mette pubblica-mente a nudo»,6 rende pubblico ciò che dovrebbe restar privato, ma per laportata rivoluzionaria di un’operazione che in un colpo solo si lascia allespalle sia la tradizione del “formulario”, manuale per eccellenza della scrit-tura epistolare e bagaglio tradizionale della formazione del letterato basa-ta, lungo l’arco dei secoli XI e XV, sulla retorica,7 sia il pesante fardello delpetrarchismo,8 assumendo in proprio la piena dignità modellizzante per il
4. L’apporto della stampa e il ruolo dell’officina tipografica che fa del testo un “oggettostampato” destinato al mercato, ridiscutendo gli statuti linguistici della comunicazione lette-raria, sono studiati da A. Quondam, La letteratura in tipografia, in Letteratura italiana, dir. A.Asor Rosa, vol. ii. Produzione e consumo, Torino, Einaudi, 1983, pp. 555-687 (in partic., per il“libro di lettere”, vd. pp. 606 e 676-78).
5. Per un’accurata ricostruzione della genesi dell’epistolario aretiniano (in partic. del Pri-mo Libro de le Lettere), vd. P. Larivaille, Pietro Aretino fra Rinascimento e Manierismo, Roma,Bulzoni, 1980, pp. 297-330, e C. Cairns, Pietro Aretino and the Republic of Venice. Researches onAretino and his Circle in Venice 1527-1556, Firenze, Olschki, 1985, pp. 125-61. Sull’Aretino inventordel “libro di lettere” volgari, cfr. almeno G. Innamorati, Tradizione e invenzione in PietroAretino, Messina-Firenze, D’Anna, 1957, pp. 230-36, e G. Baldassarri, L’invenzione dell’epistolario,in Pietro Aretino nel cinquecentenario della nascita. Atti del Convegno di Roma-Viterbo-Arezzo(28 sett.-1 ott. 1992), Toronto (23-24 ott. 1992), Los Angeles (27-29 ott. 1992), 2 voll., Roma,Salerno Editrice, 1995, i pp. 157-78.
6. A. Battistini, L’io e la memoria, in Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi,a cura di F. Brioschi e C. Di Girolamo, vol. ii. Dal Cinquecento alla metà del Settecento, Torino,Bollati Boringhieri, 1994, p. 437.
7. Cfr. N. Longo, De epistola condenda. L’arte di « componer lettere» nel Cinquecento, in Id., Let-teratura e lettere. Indagine nell’epistolografia cinquecentesca, Roma, Bulzoni, 1999, pp. 119-40. Vd.anche F. Morenzoni, Epistolografia e artes dictandi, in Lo spazio letterario del Medioevo. 1. Il Medioe-vo latino, dir. G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menestò, vol. ii. La circolazione del testo, Roma,Salerno Editrice, 1994, pp. 443-64; il paragrafo dedicato alle artes dictandi da A. Battistini-E.Raimondi, Retoriche e poetiche dominanti, in Letteratura italiana, cit., vol. iii. Le forme del testo.Teoria e poesia, Torino, Einaudi, 1994, pp. 24-30, e, per una visione di largo respiro, E.R. Curtius,Letteratura europea e Medio Evo latino (1948), trad. it. Scandicci, La Nuova Italia, 1992, pp. 168-87.
8. Cfr. l’introduzione di F. Flora a P. Aretino, Lettere. Il primo e il secondo libro, Milano,Mondadori, 1960, p. x: «Con una uscita piena di allusioni polemiche, riferendosi ai letteratiche giudicavano gli scritti secondo che i lor vocaboli fossero oppur no in Petrarca, l’Aretinoconchiude: “E se nol disse il Petrarca, suo danno”». Per un’ampia raccolta di passi tratti da
gianluca genovese
208
genere che stava inaugurando. Che già quest’archetipo del “libro di lette-re” cinquecentesco rappresenti, «prima di essere un documento di vita»,«lo spiegamento di una cultura letteraria assai raffinata»,9 che sia non soloimproduttivo ma affatto fuorviante leggerlo esclusivamente come prezio-so documento di vita privata o di fatti pubblici, è dimostrato da dati quantita-tivi (l’infittirsi della produzione epistolare in séguito alla decisione di pub-blicare una raccolta delle proprie lettere)10 e qualitativi (l’autonomia lette-raria del testo che rende irrilevante il referente esterno)11 che vanno nelladirezione dell’assimilazione dell’epistolografia alla letteratura, dell’assun-zione del genere lettera come forma vuota, fittizia, stilizzata, usato comecontenitore capace di aperture alle istanze piú diverse in quanto estraneoalla forte codificazione e alla conseguente chiusura tematica e stilistica pro-prie dei generi che la tradizione aveva codificato come gerarchicamentealti. La storia dei cento anni dei “libri di lettere” è già stata mirabilmentetracciata;12 ci limiteremo ora pertanto a fornire solamente alcune indica-zioni indispensabili all’economia dell’argomentazione che seguirà.
opere aretiniane in cui si attaccano gli “imitatori” in generale, e quelli di Petrarca e di Boccaccioin particolare, a testimonianza di una posizione antipedantesca e antibembiana, vd. G.Aquilecchia, Pietro Aretino e altri poligrafi a Venezia, in Id., Nuove schede di italianistica, Roma,Salerno Editrice, 1994, pp. 99-110.
9. Battistini, L’io e la memoria, cit., pp. 438-39.10. Da quando, nel giugno 1536, l’Aretino matura l’idea di pubblicare una raccolta di
lettere, non solo si preoccupa di conservare la minuta delle lettere spedite e di cercare direcuperare copia di testi precedentemente inviati, ma moltiplica a ritmo vertiginoso la pro-pria produzione epistolare. Basti considerare che nel Primo libro sono contenute, per gli anni1527, 1528, 1529, risp. solo cinque, due e quattro lettere, mentre di un sol giorno (il 5 dic. 1537)sono presenti ben sette lettere. Inutile sottolineare che scrivere per la pubblicazione è ope-razione dettata da motivazioni “letterarie”: cfr. G. Innamorati, La nascita delle lettere, in Id.,Tradizione e invenzione in Pietro Aretino, cit., pp. 221-51.
11. Si prenda ad es. la lettera del 25 giu. 1537, importante documento teorico e programma-tico, in origine indirizzata a Nicolò Franco e nelle successive edizioni, a seguito della violen-tissima rottura tra questi e l’Aretino, indirizzata a Lodovico Dolce. Il testo inalterato nellasua autonomia è ciò che conta, mentre sono intercambiabili tutti gli elementi ad esso esterni(la data, il destinatario), a dimostrazione del valore esclusivamente letterario dell’epistola. Suquest’ultimo punto, cfr. Longo, De epistola condenda, cit., p. 129.
12. Si rimanda al vol. cit. Le “carte messaggiere”, partic. al saggio di A. Quondam, Dal “for-mulario” al “formulario”: cento anni di “libri di lettere”, pp. 13-156. Quondam delimita cronologi-camente il campo “libri di lettere” assumendo come punto di partenza la pubblicazione delprimo volume delle Lettere di Aretino (1538), e come punto terminale la data di edizionedelle Lettere di Giambattista Marino (1627). L’arbitrarietà insita in questa come in tutte lenette cesure cronologiche è attenuata dal dato oggettivo dell’esaurimento, alle soglie del1627, delle edizioni di tutti i grandi protagonisti della stagione cinquecentesca del “libro di
la lettera faceta nel cinquecento
209
Lo straordinario exploit aretiniano (il Primo libro fu ristampato piú didieci volte, e da diversi editori, in due anni soltanto) rappresentò la venainaugurale di un aureo filone editoriale sfruttato in primis da chi a quel pro-getto aveva in prima persona partecipato: Nicolò Franco e Anton France-sco Doni, entrambi facenti parte, sia pur a livelli diversi, dell’entourage diAretino,13 ed entrambi presto in violenta rottura con quest’ultimo, furonorispettivamente il secondo (1539) e il terzo (1544) autore di un libro di let-tere volgari, con operazioni che, pur avendo introiettato il modello, si di-chiaravano programmaticamente antagoniste a esso.
A dimostrazione delle potenzialità di mercato prospettate da questo nuovogenere, nel 1542 due editori, Curzio Troiano di Navò e Paolo Manuzio,14
diedero alle stampe raccolte miscellanee di lettere di «huomini illustri»che, situandosi su un versante che potremmo definire di «ciceronianesimovolgare»,15 meno problematico di quello inaugurato dall’epistolario aretinianoe forte di una tradizione già consolidata, si proponevano di fornire un cam-pionario di esempi «del ben scrivere». A queste raccolte molte seguirono,collettive o d’autore unico, animate dai medesimi intenti ed etichettate come“familiari”, con riferimento evidente alle Familiares di Cicerone;16 la defini-zione non suggerisca conclusioni errate: il carattere “familiare” non implica
lettere”: l’ultima edizione di Aretino risale al 1609, di Calmo e Rao al 1610, di Parabosco al1617 e cosí via via per tutti gli altri.
13. Per una ricostruzione della biografia di Franco e Doni e del loro apporto all’edizionedel Primo libro delle lettere di Aretino, cfr. P.F. Grendler, Critics of the Italian World (1530-1560).Anton Francesco Doni, Nicolò Franco and Ortensio Lando, Madison, Milwaukee and London,Univ. of Wisconsin Press, 1969, pp. 38-65. Vd. anche P. Procaccioli, Cosí lavoravano perAretino. Franco, Dolce e la correzione di ‘Lettere’ i, in F.eC., a. xxi 1996, pp. 264-80.
14. Per le indicazioni tipografiche complete riguardanti i frontespizi delle edizioni cin-quecentesche degli epistolari citati qui e oltre e per una prima sommaria ricognizione delloro contenuto, si rimanda all’imponente repertorio di J. Basso, Le genre epistolaire en langueitalienne (1538-1622). Repertoire chronologique et analytique, 2 voll., Roma, Bulzoni, 1990.
15. Cfr. G. Moro, Selezione, autocensura e progetto letterario: sulla formazione e la pubblicazione deilibri di lettere familiari nel periodo 1542-1552, in La lettera familiare, cit., pp. 67-90. Moro legge alla lucedella categoria del «ciceronianesimo volgare» un gruppo di epistolari a stampa editi tra il 1542,anno della pubblicazione delle raccolte di Navò e Manuzio, e il 1552, data del completamentodell’epistolario di Bembo, ma si chiede anche se «valutando attentamente l’operato di questiautori il richiamo a Cicerone non sia frutto di un equivoco, mentre gli epistolari dati allestampe ricordano in realtà quelli, retoricamente costruiti, di Plinio, di Frontone, di Simmaco».
16. Le Epistole o Lettere volgari di Cicerone furono edite in volgare a partire dal 1544 edebbero almeno 24 ristampe tra il 1544 e il 1700, 17 delle quali nel Cinquecento. Le decine diedizioni delle lettere ciceroniane, non solo volgarizzate ma anche latine con dotti commen-ti, compendiate, ridotte a formulario, testimoniano che Cicerone, unico tra i classici, costituíun punto di riferimento imprescindibile per l’epistolografia volgare.
gianluca genovese
210
una semplice e neutra giustapposizione di materiale che passa dalla dimen-sione privata a quella pubblica,17 ma è la risultante di una selezione miratae dell’adattamento, spesso della riscrittura, in base al principio unificatoreche presiede alla raccolta;18 la sistematica manipolazione operata dall’autoreo dall’editore persegue una rigorosa corrispondenza con i criteri retorici diinventio, dispositio, elocutio al fine di affermare l’esemplarità della raccolta einsieme la perizia linguistica, retorica, dottrinale del mittente.19 Non stupi-sce pertanto che da una forma-madre “familiare” tanto retoricizzata e gui-data da criteri letterari20 si diramino articolazioni specialistiche, vere e pro-
17. Un primo importante riferimento ai problemi sollevati dal rapporto tra l’insieme dellelettere prodotte e quelle che effettivamente compaiono nelle raccolte è in G. Baldassarri,Fra « corpus» e «membra disiecta». Considerazioni metodologiche e operative in margine al progetto diricerca, in Le “carte messaggiere”, cit., pp. 167-68.
18. Il processo di adattamento assume i tre aspetti principali ed eventualmente concomitantiindividuati nel saggio già cit. di Moro, Selezione, autocensura e progetto letterario, pp. 86-87: taglio,di porzioni piú o meno ridotte dell’originale; mascheramento, che ricopre e trasforma i datireferenziali piú individuanti (nomi propri); riscrittura, anch’essa quantitativamente assai varia-bile. Interessante è il caso delle Lettere di Luca Contile, pubblicate a Pavia nel 1564 a seguitodi un’accurata scelta e di interventi di limatura e riscrittura. L’elaborato processo di organiz-zazione del materiale per la stampa delle lettere contiliane è documentato da Quondam, Dal“formulario” al “formulario”, cit., pp. 19-29. Studia invece la selezione e il rimaneggiamento dilettere raccolte da Beccadelli allo scopo di propagandare una costruita immagine di sé G. Fra-
gnito, L’Epistolario di Ludovico Beccadelli: autoritratto e manuale epistolografico, in La correspondance 2.Actes du Colloque franco-italien, Aix en Provence, Univ. de Provence, 1985, pp. 185-203.
19. L’attenzione alla retorica ha come risultato che « la lettera si trasforma da confessioneamichevole e confidenziale, in un genere, che sottostà a certe regole, s’avvantaggia di certenorme, richiede certi requisiti » (D. Bianchi, Trattati d’epistolografia nei secoli XVI e XVII. Per lastoria del Seicentismo, in G.S.L.I., lxxxix 1927, p. 114). Illuminante a questo riguardo è l’analisidell’epistolario “familiare” del Parabosco, letto secondo le regole retoriche da N. Longo, Ilsistema letterario nelle ‘Lettere famigliari’ di Girolamo Parabosco, in Id., Letteratura e lettere, cit., pp. 35-66. Dallo studio di Longo si evince che spesso l’unico scopo della lettera è offrirsi comemodello in una sorta di nuovo formulario. Secondo una sua ipotesi, in alcuni casi addiritturala scelta del cognome del destinatario è dettata da intenti esclusivamente letterari (ad es.nella lettera indirizzata a Pietro Rivale il mittente dichiara l’intenzione di voler rompere ilrapporto di amicizia a causa delle parole sconvenienti pronunciate contro di lui).
20. Un esempio per tutti, precoce e di straordinaria originalità, è costituito dalle Letteresopra le diece giornate del ‘Decamerone’ di Francesco Sansovino, stampate a Venezia nel 1542 (sucui vd. Ch. Roaf, Francesco Sansovino e le ‘Lettere sopra le diece giornate del Decamerone’, in La letterafamiliare, cit., pp. 91-98). Sebbene nella raccolta sansoviniana ognuna delle lettere abbia l’aspettogenuino di una “familiare” (presentandosi, ad es., come risposta a una lettera precedente o adiscussioni intavolate col destinatario), la simmetria tra l’argomento delle lettere e le novelledel Decameron, che corrispondono anche nella disposizione testuale, dimostra il caratterefittizio e studiato a tavolino di ogni singolo brano, pensato in funzione del macrotesto che loavrebbe contenuto.
la lettera faceta nel cinquecento
211
prie tipologie settoriali governate da criteri omogenei e qualificanti, impli-citamente o dichiaratamente fittizie; ci imbatteremo cosí in raccolte di let-tere amorose, che immediatamente rifiutano ogni parvenza di “familiarità”ponendosi sotto l’egida di una tradizione diversa, la lirica petrarchesca; insillogi spirituali, direttamente legate al clima controriformistico e animate daintenti didascalici in linea con i precetti del concilio tridentino; in libri dilettere consolatorie, campionari di tópoi “consolatori” (per chi è malato, hasubíto perdite affettive o economiche, ecc.) di ascendenza classica; in discorsive,che utilizzano la forma lettera al fine di discutere temi di carattere linguisti-co o letterario (esempio piú illustre di questa tipologia è la raccolta dellelettere di Torquato Tasso, che comprende le cosiddette “poetiche”).21 Pocostudiata, ma molto e a lungo praticata e ricchissima di interferenze con ge-neri attigui o di segno opposto rovesciati antifrasticamente, è la tipologiaoggetto di questo intervento: la lettera faceta.22
2. È utile avviare la nostra indagine intorno all’epistolografia faceta en-trando in medias res e lasciando, in abbrivo, la parola a un autore di decisivaimportanza per questo sottogenere: Anton Francesco Doni che, già nelfebbraio del 1544, cosí concludeva, da Padova, la lettera che accompagnavail primo volume delle sue Lettere inviato al Giolito:
Sí che, messer Gabriel mio, per tornare al proposito, tutte le cose che si dicono etche si scrivono, non son vere: ma bisogna spregnar la fantasia. Dove voi troveretemolte delle mie lettere piacevoli dette et scritte solamente per dare spasso a chi leleggerà: cosí farete intendere a chi le vedesse, parendosi forse cosa dentro nonconveniente, il che non credo per esser i Vinitiani pieni di lettere buone, di giudicioottimo, et di sincera mente. Et cosí mi vi offero, et raccomando senza fine.23
Parlando di lettere «piacevoli»24 scritte «solamente per dare spasso a chi le
21. Per una panoramica completa sulle articolazioni dell’epistolografia cinquecentesca,si rimanda ancora una volta al decisivo intervento di Quondam, Dal “formulario” al “formu-lario”, cit.
22. Un ottimo punto di partenza, purtroppo isolato, è costituito dall’intervento di A. De
Nichilo, La lettera e il comico, in Le “carte messaggiere”, cit., pp. 213-35.23. A.F. Doni, Tre libri di lettere del Doni e i termini della lingua toscana, Vinegia, Francesco
Marcolini, 1552, p. 205.24. Per la genealogia dell’aggettivo «piacevole», con valore di una precisa designazione di
genere, cfr. S. Longhi, Introduzione a Lettere facete e piacevoli di diversi grandi huomini e chiariingegni, a cura di Dionigi Atanagi, Venezia, B. Zaltieri, 1561 (rist. an. a cura di S. Longhi,Sala Bolognese, Forni, 1990), p. xiii, e Ead., Lusus. Il capitolo burlesco nel Cinquecento, Padova,Antenore, 1983, pp. 23-30, 138-54.
gianluca genovese
212
leggerà», il Doni da un lato conferma il carattere fittizio del “libro di lette-re” in opposizione al valore testimoniale dell’epistolario,25 dall’altro segna-la la novità della tipologia “faceta” rispetto alla semplice assunzione delregistro giocoso già previsto da Cicerone tra le “funzioni” della lettera.26
Cicerone ebbe infatti larga presenza, accanto ad Aristotele27 e a DemetrioFalereo,28 tra le auctoritates prese a modello dalla teorizzazione cinquecen-
25. Ciò non esclude la possibilità, sfruttata dagli studiosi di fatti e cultura cinquecenteschi,di utilizzare alcune informazioni estrapolate da raccolte come quella del Doni per ricostrui-re in maniera attendibile vicende biografiche individuali e rapporti interpersonali tra i pro-tagonisti della scena culturale ed editoriale veneziana – e non soltanto veneziana – di queglianni. È il caso, ad es., degli studi di C. Di Filippo Bareggi, Il mestiere di scrivere. Lavorointellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1988, e segnatamente delcap. ii, Circuiti epistolari e relazioni culturali: la figura del collaboratore editoriale, pp. 156-91, nel qualela ricostruzione dell’ambiente editoriale veneziano e dei rapporti tra personaggi quali ilDoni, Ludovico Domenichi, il Parabosco è attuata con l’ausilio dei libri di lettere.
26. Il passo in questione (Ad familiares, ii 4) è molto noto: «Epistolarum genera multa essenon ignoras, sed unum illud certissimum, cuius causa inventa res ipsa est, ut certiores faceremusabsentis, si quid esset quod eos scire aut nostra aut ipsorum interesset. Huius generis litterasa me profecto non expectas; domesticarum enim tuarum rerum domesticos habes et scriptoreset nuntios, in meis autem rebus nihil est sane novi. Reliqua sunt epistolarum genera duo,quae me magnopere delectant, unum familiare et iocosum, alterum severum et grave. Utrome minus deceat uti, non intellego. Iocerne tecum per litteras? Civem mehercule non putoesse, qui temporibus his ridere possit. An gravius aliquid scribam? Quid est quod possitgraviter a Cicerone scribi ad Curionem nisi de re publica? Atque in hoc genere haec meacausa est, ut neque ea quae sentio audeam, neque ea quae non sentio velim scribere». Houtilizzato l’ed. critica curata da L.A. Constant, Paris, Les Belles Lettres, 1971.
27. Chi guardava ad Aristotele applicava anche al genere epistolare la classificazione pen-sata per il discorso oratorio, dividendo la materia in tre generi: deliberativo, giudiziario,dimostrativo o epidittico. Ci riferiamo, ovviamente, alla classificazione proposta nella Reto-rica, i 3. Sulla relazione tra la codificazione dell’“arte di scriver lettere” e le norme retorichederivanti dalla diffusione dell’aristotelismo, che favorí l’accoglimento dell’opinione anticache vedeva l’epistola come un ramo dell’eloquenza e di conseguenza i suoi tre grandi ramicome gli stessi dell’oratoria, cfr. Bianchi, Trattati d’epistolografia nei secoli XVI e XVII, cit., pp.111-26. Un panorama sulle varie concezioni della retorica mutuate dall’aristotelismo nel Cin-quecento si legge nella nota critica generale di B. Weinberg in Trattati di poetica e retorica delCinquecento, Bari, Laterza, 1970, vol. i pp. 541-62. Ampia visione d’insieme sulle tradizioniaristotelica, platonica e altre che contribuirono alla nascita delle poetiche e alla codificazionedei generi è in G. Patrizi, La nascita delle poetiche, in Manuale di letteratura italiana. Storia pergeneri e problemi, cit., vol. ii pp. 627-58. Vd. anche l’esaustivo studio di Battistini-Raimondi,Retoriche e poetiche dominanti, cit.
28. Ancora oggi non identificato, era allora creduto un retore greco discepolo di Aristotelee identificato con un Demetrio di Fàlero, governatore di Atene per conto dei Macedoni nelIII sec. a.C. La composizione del suo manuale oscilla, secondo studi di inizio Novecento, trail II sec. e la metà del I sec. a.C. Per le teorizzazioni di Demetrio in materia epistolare, vd.Avezzú, Alle origini dell’epistolografia, cit., pp. 7-10. Anche la dottrina epistolografica del Tasso,
la lettera faceta nel cinquecento
213
tesca riguardante la classificazione dei generi della lettera. È però indispen-sabile, preliminarmente, sgombrare il terreno da una facile e strumentaleconsiderazione che potrebbe affascinare lo studioso della lettera faceta, ten-tato di attribuire un valore arbitrario all’accenno al genus iocosum che piúvolte si incontra nell’epistolario ciceroniano e nei teorici che da esso dipen-dono, quasi come se già nell’archetipo indiscusso dell’epistolografia si indi-casse la lettera “giocosa” come articolazione indipendente, come genereautonomo retto da regole proprie. Il registro burlesco o giocoso era da Ci-cerone considerato semplicemente come uno dei tanti utilizzabili nellacomunicazione con un assente; la sua presenza deriva da una scelta sugge-rita dalla natura stessa della lettera familiare, rivolta a un destinatario nonfittizio ma reale, con il quale si può ovviamente anche scherzare. Ancheuno scrittore poco incline alla burla come il Tasso può, in un gruppo dilettere tarde indirizzate ad Antonio Costantini, il segretario di ScipioneGonzaga, lasciar emergere quelle opzioni scherzose che sono propriedell’epistolografia familiare, senza tuttavia che questi testi episodici debba-no essere considerati come consapevole pratica di un genere.29 E nel car-teggio intrattenuto da Machiavelli con Vettori e Guicciardini tra il 1513 e il152730 il registro scherzoso ha un ruolo primario,31 all’interno della “varie-tà” dei casi della vita,32 ma non prescinde mai da riferimenti a eventi di vita
esposta nel Secretario, ruota intorno a un circuito filo-demetriano. Sulla convergenza tassianacon le teorie di Demetrio, cfr. E. Raimondi, Poesia della retorica, in Id., Poesia come retorica,Firenze, Olschki, 1980, pp. 25-70. Per un’analisi dei metodi di classificazione epistolare, inspecial modo riguardante la lettera familiare, cfr. J. Basso, La lettera “familiare” nella retoricaepistolare del XVI e del XVII secolo in Italia, in La lettera familiare, cit., pp. 59-65.
29. Cfr. D. Della Terza, Il Tasso epistolografo: il culto “ostinato” della verità e la petizione degliaffetti, in La lettera familiare, cit., pp. 124-26, e M.L. Doglio, Le lettere del Tasso: scrivere per esistere,in Ead., L’arte delle lettere. Idea e pratica della scrittura epistolare tra Quattro e Seicento, Bologna, IlMulino, 2000, pp. 145-69. È evidente che quando andremo a parlare degli autori di letterefacete ci soffermeremo solo su quelli che praticano consapevolmente un genere dai trattifortemente distinti e codificati, e non su chi, come il Tasso, utilizza il registro scherzosonell’àmbito di una comunicazione marcata da intenti del tutto diversi.
30. Vd. N. Machiavelli, Lettere a Francesco Vettori e Francesco Guicciardini, a cura di G. In-
glese, Milano, Rizzoli, 1989.31. Cfr. quanto scriveva, in una lettera del 23 ott. 1502, Bartolomeo Ruffini a Machiavelli:
«Le vostre lettere ad Biagio et alli altri sono a tucti gratissime, et li mocti et facezie usate inepse muovono ogni uno ad smascellare dalle risa».
32. Si rilegga un passaggio della celebre lettera al Vettori del 31 genn. 1515: «Chi vedessele nostre lettere, honorando compare, et vedesse le diversità di quelle, si maraviglierebbeassai, perché gli parrebbe ora che noi fussimo huomini gravi, tutti vòlti a cose grandi, et chene’ petti nostri non potesse cascare alcuno pensiere che non havesse in sé honestà et gran-
gianluca genovese
214
vissuta o ad accadimenti condivisi, facilmente identificabili dal destinatario;la lettera può essere “gioco”33 ma non è ancora “giocosa”, può essere anchefelice ed elegante esercitazione di stile ma non nasce specificamente per lalettura di un pubblico allargato, non è studiata a tavolino per la pubbli-cazione.
Proprio prendendo a metro di paragone questo discrimine fondamenta-le (lettere scritte direttamente per la pubblicazione e lettere raccolte solodopo la loro effettiva circolazione privata), possiamo proporre un’ulterioresuddivisione all’interno del campo “libro di lettere del Cinquecento”; se èvero che i criteri retorici che governano scelta e riscrittura di materiali an-tologizzati fanno di ogni raccolta data alle stampe un “libro”, è anche veroche c’è differenza tra scrittura e riscrittura. Nella fattispecie, la lettera facetaemerge e si rende autonoma come tipologia settoriale quando il polo dellaproduzione e il polo della ricezione si attestano sul condiviso versantedella finzione letteraria, della letteratura al secondo grado che, perdutaogni ansia di verosimiglianza, si offre al lettore nella sua gratuità comica oparodistica. Giunti a questo livello di consapevolezza per gradi (che piúavanti tenteremo di ricostruire nella loro evoluzione diacronica), pocoimporterà che una lettera “faceta” o “burlesca” abbia per destinatario unpersonaggio reale, immaginario o addirittura un oggetto: il codice squisita-mente letterario adoperato sarà ormai assestato su livelli che la rendonoclassificabile sotto un “capo” specifico.34
Tralasceremo pertanto, in questa sede, un pur utile approfondimentodei due volumi miscellanei di Lettere facete e piacevoli di diversi grandi huomini,stampati rispettivamente nel 1561 a cura di Dionigi Atanagi e nel 1575 acura del suo continuatore Francesco Turchi. Pur essendo tra le poche rac-colte ad esibire in limine, sul frontespizio, un’etichetta tipologica cosí mar-
dezza. Però dipoi, voltando carta, gli parrebbe quelli noi medesimi essere leggieri, incostanti,lascivi, vòlti a cose vane. Questo modo di procedere, se a qualcuno pare sia vituperoso, a mepare laudabile, perché noi imitiamo la natura, che è varia; et chi imita quella non può essereripreso». Cfr. G. Ferroni, Tra lettera familiare e lettera burlesca, in La lettera familiare, cit., pp. 49-55. Un commento a questa lettera nel quadro dei rapporti tra Machiavelli e Vettori è in E.Raimondi, L’arte dello stato e i ghiribizzi dell’esistenza, in Id., Politica e commedia, Bologna, IlMulino, 1998, pp. 17-21. Vd. anche M.L. Doglio, “Varietà” e scrittura epistolare: le lettere delMachiavelli, in Ead., L’arte delle lettere, cit., pp. 75-104.
33. Cfr. F. Grazzini, Machiavelli, Guicciardini e le regole di un gioco epistolare, in Passare il tempo.La letteratura del gioco e dell’intrattenimento dal XII al XVI secolo. Atti del Convegno di Pienza (10-14 sett. 1991), 2 voll., Roma, Salerno Editrice, 1993, i pp. 651-64.
34. Sulle tavole dei “capi” introdotte come metodo di classificazione, cfr. Basso, La lettera“familiare” nella retorica epistolare, cit., pp. 59-61.
la lettera faceta nel cinquecento
215
cata (e costituendo interessante esempio di interferenza con la tradizionesincrona del capitolo burlesco in terza rima),35 quasi mai scivolano dal cri-nale della “familiarità” sul versante della lettera “faceta”. Ritornando a quantodicevamo sopra della classificazione ciceroniana, l’Atanagi e il Turchi pro-pongono lettere che nascono come “familiari” indirizzate, senza pensare aun’eventuale pubblicazione, a un corrispondente reale nell’àmbito di unconsolidato scambio epistolare; in esse è evidente l’accentuazione di quellacomponente della comunicazione familiare rappresentata dal registro co-mico e scherzoso, ma le raccolte che le contengono non si emancipano maida una generica funzione di “ricreazione”36 offerta al lettore da testi di «huo-mini di pronto ingegno». La raccolta a cura del Turchi, poi, porta il segnodel clima pienamente controriformistico che fa da sfondo alla sua uscita; ilregistro comico perde il vigore corrosivo derivante, nella miscellanea alle-stita dall’Atanagi, dalla derisione della corte papale, dalle metafore oscene,dai riferimenti demistificanti al sacro;37 la volontà didascalica di «parimentedilettare et giovare al mondo» si accompagna spesso a toni pietistici checausano un inevitabile deflusso della componente comica.
La De Nichilo, con argomentazione in parte condivisibile, sostiene che«la lettera faceta non perviene, comunque, mai a un’autosufficienza che leconsenta di assurgere al rango di genere: essa ha un significato solo al-l’interno dell’economia generale della produzione di lettere».38 Ma una “au-tosufficienza” pare acquisita nel punto che possiamo assumere come ter-minale per l’avventura del “libro di lettere”, l’epistolario di Marino, chepresenta sin dal frontespizio, in una ormai scontata suddivisione per “capi”,la convivenza di lettere “gravi” e “facete”,39 tra loro nettamente divise eclassificate in sezioni distinte comprendenti le differenti tipologie “familia-ri”, “dedicatorie”, “poetiche” e, appunto, “burlesche”.40 L’ambizione delMarino di veder pubblicata una propria raccolta di lettere nell’àmbito di
35. Uno studio approfondito su questo genere nel Cinquecento è quello di Longhi, Lusus,cit. In particolare, per i rapporti e le interferenze tra capitoli in terza rima e lettere facete, vd.il cap. vi, Una lettera in capitoli, pp. 182-209.
36. Il tópos della “ricreazione” e del “diletto”, al quale ricorre l’Atanagi nella dedica delleFacete del 1561, attraversa, sulla scorta delle rigide posizioni platoniche e aristoteliche sul riso,gran parte della produzione teorica cinquecentesca in materia di comicità: cfr. N. Ordine,Teoria della novella e teoria del riso nel Cinquecento, Napoli, Liguori, 1996.
37. Cfr. De Nichilo, La lettera e il comico, cit., pp. 234-35.38. Ivi, p. 215.39. lettere / del / cavalier marino / Gravi, Argute, Facete e Piacevoli. / Con diverse Poesie
del medesimo / non piú stampate, Venezia, Francesco Baba, 1627.40. Vd. G.B. Marino, Lettere, a cura di M. Guglielminetti, Torino, Einaudi, 1966.
gianluca genovese
216
un progetto editoriale finalizzato alla decisa affermazione della propriapersona sul proscenio letterario anche in questo genere non ebbe, come sisa, successo in vita; solo nel 1627, immediatamente a ridosso della mortedell’autore, amici e tipografi diedero alle stampe una serie di sue letterecon l’intento di utilizzarle quali documenti polemici da contrapporre aidetrattori del poeta e dei suoi seguaci. Una selezione cosí orientata ha com-portato la precarietà e la frammentarietà ancor oggi non del tutto superatadell’epistolario mariniano.41 Tuttavia, quando Marino parla della volontàdi pubblicare una raccolta di lettere, dimostra di avere ben chiara la diffe-renza tra le varie tipologie praticabili. Nel 1620, da Parigi, a Giovan BattistaCiotti scriveva di non affrettarsi a ristampare le Dicerie sacre perché avevaintenzione di aggiungerne di nuove e «d’accopiarle con un libro di letteregravi e piacevoli».42 E, nello stesso anno, ad Andrea Barbazza esponevaancor piú dettagliatamente il suo progetto:
Ho determinato adunque a primavera (piacendo a Dio) senz’altro ritornarmene acotesta volta, e passando di Bologna, pretendo che mi si apparecchi la mia solitacamera in casa vostra, percioché non voglio alloggiare altrove. Avrei effettuataquesta deliberazione molto prima, ma mi hanno dall’essecuzione di essa distornatole passate guerre, ed ora mi ritiene la stampa di questo poema e di un volume dilettere, che non saranno forse ordinarie. È diviso in lettere gravi, famigliari, amo-rose e burlesche, ed in esse non mi scorderò d’onorarvi gli amici, ma spezialmentevoi, che siete tra’ cari il carissimo.43
Quanto l’autore facesse realmente conto sul proprio disegno, e quantofosse consapevole della riuscita artistica delle “burlesche”, si evince da unpassaggio di una lettera indirizzata, l’anno seguente, ancora una volta alCiotti:
Ma io vi prometto, e statene sulla mia parola, che quando pur cosí fusse, non vilascierò mancar guadagno. Tengo in procinto la Strage degl’innocenti, a mio gusto unadelle migliori composizioni che mi sieno uscite dalla penna e senza comparazione
41. Per la ricostruzione dell’interessantissima storia di questo testo si rimanda all’introdu-zione di M. Guglielminetti a Marino, Lettere, cit. Vd. anche il paragrafo dedicato alleLettere da G. Fulco, Giovan Battista Marino, in Storia della letteratura italiana, dir. E. Malato,vol. v. La fine del Cinquecento e il Seicento, Roma, Salerno Editrice, 1997, pp. 597-652. Dettagliatae ricca la ricostruzione proposta da M. Pieri, Per Marino, Padova, Liviana, 1976, pp. 32 sgg.Cfr. anche R. Simon, Giambattista Marino et les artistes de son temps d’après l’Epistolario, in Lacorrespondance 2, cit., pp. 259-75.
42. Marino, Lettere, cit., p. 258.43. Ivi, p. 269.
la lettera faceta nel cinquecento
217
piú perfetta dell’Adone, il qual poema non è presso di me in tanta stima quanta nefa il mondo. Questo vi assicuro che non l’averà altri che voi, insieme con un volu-me di lettere, le quali faranno gran riuscita (e voi lo vedrete), massime le burlesche.44
Ed è proprio da qui, dal punto in cui si manifesta piú netta la consapevo-lezza di una pratica scrittoria dalle ben definite caratteristiche,45 che con-viene cominciare a esplorare le peculiarità della lettera faceta, salvo poiricostruire diacronicamente, attraversando le raccolte d’autore piú signifi-cative, i momenti e le tappe che conducono a questo approdo.
La sezione delle lettere burlesche dell’epistolario mariniano, cosí comesi è andata configurando a séguito delle varie stratificazioni conseguenti alrecupero di testi che hanno permesso di arricchire le raccolte originarie dicui sopra si diceva, comprende solamente sette esemplari. All’interno diquesta pur esigua silloge è possibile operare un’ulteriore significativa sud-divisione tra lettere del tutto e dichiaratamente fittizie (Al padre naso, Il pu-polo alla pupola e la relativa risposta de La pupola al pupolo) e lettere comicheindirizzate a destinatari reali (a Ludovico d’Agliè sulla prigionia di Torino,ad Arrigo Falconio sulle peripezie del viaggio che lo aveva condotto inFrancia e a Lorenzo Scoto sulle strane abitudini della società parigina).46
Le lettere fittizie – svincolate quindi da qualsiasi interferenza con la tipologiafamiliare che spesso si sovrappone alla lettera comica – portano all’esaspe-razione quel gusto del “ghiribizzo” già tipico delle lettere facete del Doni,combinandolo con la sperimentazione linguistica e l’esplosione delle in-venzioni lessicali tipiche dell’età barocca. La lunga lettera Al padre naso47
contiene un mirabolante insieme di variazioni su un tema di per sé privo
44. Ivi, p. 299.45. «Le lettere “burlesche” sono la parte delle raccolte postume piú vicina al progetto
d’autore. Marino contava su quel divertissement per affermarsi come prosatore faceto, estrosoe originale, dopo essersi avvalso del registro comico per le anfibologie oscene delle compo-sizioni d’ascendenza bernesca e per le sortite polemico-satiriche» (Fulco, Giovan BattistaMarino, cit., p. 643).
46. Sulla vicenda redazionale di alcune delle lettere comprese in questa sezione, studiataavvalendosi del ritrovamento di reperti originali autografi, si sofferma utilmente G. Fulco,Notizia di novità mariniane in Trivulziana, in F.eC., a. xv 1990, pp. 551-82, ora in Id., La «meravi-gliosa» passione. Studi sul Barocco tra letteratura ed arte, Roma, Salerno Editrice, 2001, pp. 118-51.Oltre a quelle citate è presente una lettera, di dubbia paternità (compresa nel Carteggio delBoccalini e a lui attribuita: cfr. Pieri, Per Marino, cit., p. 42 n. 78) che descrive, mettendolo inridicolo, l’ingresso solenne in Roma d’un ambasciatore d’origine tedesca, indirizzata a un nonmeglio identificato “amico”, il che lascia supporre anche in questo caso un’esercitazione burlesca.
47. «Personalissimo rifacimento del divertissement firmato dal Caro»: cfr. Fulco, Notizia dinovità mariniane, cit., p. 559 n. 14 (pp. 126-27 della nuova ed.).
gianluca genovese
218
di rilevanza contenutistica, ma tradizionalmente equivoco:48 il naso, ap-punto. L’accumulazione di exempla deformati e di giochi di parole si ac-compagna a coniazioni di neologismi a ripetizione:
L’importanza sta in avere un naso famongomadano e scarabombardone, un nasoditirambico ed heautontimerumenonico, un naso da una mano e meza a da quat-tro sòle co’ tacconi, ch’ecceda gli ordini communi delle Prammatiche e delle Pan-dette, come avete voi.49
La medesima pirotecnica inventività emerge nella lettera del Pupolo allaPupola e nella risposta della Pupola al Pupolo, costruite con un insieme dinomi propri di letterati che alludono a nomi comuni morfologicamentesimili deformati in senso comico e osceno. Citiamo un solo passo che benrende l’idea dell’insieme:
Chi vuol esser l’Ammirato ed il Caro bisogna che facci il Giovio ed il Cortese;senza Cassiodoro non si può far il Clavio: pensate forsi d’esser il Franco, o andar-vene Villifranchi? So il costume degli uomini, i quali dipoi che hanno fatto ilFregosio, hanno le donne nel Colenuccio. Averei ben del Pazzi a lasciarmi attaccaril Battaglio alla Campana, e far Cornazano mio marito senza Lucrezio. Ora io quifo Pausania, né voglio darvi altro avertimento, se non che siate Castiglione, Ca-stelvetro e Castelletti. E con tal fine bacciandovi le mani, vi raccomando a Diogene;e state Sanazzaro.50
Lo stile giocoso in questo primo gruppo di lettere si presta quindi a unaassoluta gratuità comica svincolata da qualsivoglia incombenza di caratterecomunicativo; la lettera è puro divertissement, e si snoda lungo un percorsofitto di similitudini e metafore spesso oscene accoppiate a una compiaciutasperimentazione linguistica edonistica e anticlassica. Il secondo gruppocontiene alcuni dei capolavori della scrittura epistolare mariniana, tra i qualispicca la lettera a Lodovico d’Agliè in cui viene descritta la prigionia diTorino.
Per meglio evidenziare il procedimento comico che fa di questo testoun godibilissimo esemplare “faceto”, pur narrando cose in sé del tutto estra-nee al dominio del riso, possiamo metterlo a confronto con un’altra straor-dinaria lettera di un recluso che descrive la sua prigionia assumendo invece
48. Per il valore equivoco del naso (sostituto metaforico dell’organo maschile) nella tradi-zione burlesca, cfr. J. Toscan, Le carnaval du langage. Le lexique erotique des poetes de l’equivoquede Burchiello à Marino (XVe-XVIIe siècles), 4 voll., Lille, Univ. de Lille iii, 1981, pp. 1207-8.
49. Marino, Lettere, cit., p. 516.50. Ivi, p. 543.
la lettera faceta nel cinquecento
219
un punto di vista “grave”: ci riferiamo, si sarà già capito, a una delle lettereche il Tasso invia dall’ospedale ferrarese di Sant’Anna. Il confronto non èperegrino poiché, oltre l’evidente similitudine di contenuto, c’è lo specifi-co riferimento, nella lettera del Marino che stiamo per esaminare, allaprigionia del Tasso.51 A Maurizio Cataneo, il 18 ottobre del 1581, Tassoesponeva la difficoltà dello scrivere causata dalle intollerabili condizionidell’ambiente che lo circondava:
Ma perch’ella non può ora esser in tutto rimossa da me, darò solamente avviso aVostra Signoria de’ disturbi ch’io ricevo ne lo studiare e ne lo scrivere. Sappiadunque che questi sono di due sorte: umani e diabolici. Gli umani sono grida diuomini e particolarmente di donne e di fanciulli, e risa piene di scherni, e varievoci d’animali che da gli uomini per inquietudine mia sono agitati, e strepiti dicose inanimate che da le mani de gli uomini sono mosse. I diabolici sono incanti emalie; e come che de gl’incanti non sia assai certo, percioché i topi, de’ quali èpiena la camera, che a me paiono indemoniati, naturalmente ancora, non solo perarte diabolica, potrebbono far quello strepito che fanno, ed alcuni altri suoni ch’ioodo potrebbono ad umano artificio, com’a sua cagione esser recati, nondimeno mipare d’esser assai certo ch’io sono stato ammaliato; e l’operazioni della malia sonopotentissime, conciosia che quando io prendo il libro per istudiare o la penna, odosonarmi gli orecchi d’alcune voci ne le quali quasi distinguo i nomi di Pavolo, diGiacomo, di Girolamo, di Francesco, di Fulvio e d’altri, che forse sono maligni edella mia quiete invidiosi.52
Le inquietudini interiori, le manifestazioni del male, la rabbia per l’ingiu-stizia che ritiene di aver subíto da parte di chi lo ha relegato tra folli strepi-tanti, la speranza di riacquistare la libertà: tutti dati concorrenti alla dipinturadi un quadro a tinte fosche che attinge il proprio linguaggio dal registro deltragico e mai lascia spazio a quella distanza tra sé e il mondo necessariaperché, vedendo quanto accade da un punto di vista esterno e superiore, sipossa cogliere anche il lato umoristico che è il rovescio di ogni tragedia.
Tutta spostata sul versante del comico è invece la missiva composta, perdescrivere situazioni analoghe (anche se oggettivamente meno difficili), dalMarino. Irresistibile la galleria di personaggi veterotestamentari ai quali loscrittore si paragona minimizzando le loro sofferenze al confronto delleproprie, fino a giungere addirittura al riferimento al Salvatore (non dimen-
51. «A Torquato Tasso non fu usato mai simil rigore da Alfonso da Este duca di Ferrara,mentre lo tenne in prigione. Se non in altro posso andar del pari con quel grandissimouomo, almeno son piú matto di lui» (ivi, p. 536).
52. T. Tasso, Le lettere […] disposte per ordine di tempo ed illustrate da C. Guasti, 5 voll.,Firenze, Le Monnier, 1852-1855, ii pp. 161-62.
gianluca genovese
220
tichiamo che nel 1624 la progettata pubblicazione dell’epistolario venneaccantonata proprio perché il Marino, già preoccupato per l’Adone, nonardí sottoporre al giudizio inquisitorio le lettere burlesche):
Mastro Noè, che fu il primo ingeniero che ritrovasse i bucintori, se ne stette chiu-so nel fondo della gran caravana quaranta dí e quaranta notti; ma passato questotempo, spalancando il pertugio sopra coperta vide cessato il diluvio. Gioseppe, ilpoveretto, fu messo dentro una cisterna piena di pantaniccio a tener bordone a’ranocchi per un pezzetto; e pur alfine, benché alquanto imbrodolato, ne fu cavatofuora. Daniele fu calato nella fossa de’ leoni; ma intanto venivano fin gli profetiper l’aria a recarli il fiasco con la pagnotta. Giona, che fu anch’elli di quelli all’an-tica, spogliatosi in calze e brache, si lasciò inghiottir dall’orca, a cui doppo esserstato nelle budella una trinca de giorni, fu cacato in su l’asciutto. Che piú? Lostesso Dio incarnato non volle trattenersi dentro la sepoltura se non per pochissi-me ore; pensate voi come la possa passar io, che son appena un semplicissimoomiciuolo, serrato dentro una caverna per nove mesi!53
Il lettore di questa sequenza di deformazioni per deminutio capitis non puòfar a meno di sorridere. Il procedimento comico si struttura secondo quel-lo che Bachtin avrebbe definito «abbassamento»:54 il lessico utilizzato ten-de volutamente verso il basso, trasponendo ogni elemento sul piano mate-riale e corporeo (Giuseppe tirato fuori «imbrodolato» dal pozzo nel qualei fratelli lo avevano relegato, Daniele nella fossa dei leoni con «fiasco» e«pagnotta», Giona che si spoglia «in calze e brache»); l’accostamento ditali elementi nientemeno che ai venerabili profeti veterotestamentari pro-voca quella «sorpresa o annullamento di un’attesa»55 che porta al riso. Al-tro espediente è la rilettura e il rovesciamento di vicende il cui nucleo èstato cristallizzato in luogo comune, in tópos antonomastico («paziente comeGiobbe»):
Quell’altro meschino di Giobbe fu pazientissimo, come dicono i cronisti delleanticaglie: con tutto ciò si lamentava forte e gridava di cuore: «Miseremini mei,miseremini mei, saltem vos, amici mei». E perché? e perché? «Quia manus Domi-ni tetigit me». Se per un semplice tocco delle dita di Dio faceva sí grande schia-mazzo, che averebbe egli fatto, se si fosse sentito percotere a pugna chiuse, overoscudicciare a carni ignude con uno scudiccio di soatto? Perdette un branco di
53. Marino, Lettere, cit., p. 526.54. M.M. Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione
medievale e rinascimentale, trad. it. Torino, Einaudi, 1979. Cfr. anche G. Gorni-S. Longhi, Laparodia, in Letteratura italiana, cit., vd. v. Le questioni, Torino, Einaudi, 1986, pp. 459-87, a p. 460.
55. Cfr. N. Borsellino, Il comico, ivi, pp. 419-57, a p. 425, e relativi rimandi bibliografici.
la lettera faceta nel cinquecento
221
pecore; ma pure le avanzarono le pelli e le corna, delle quali dovette cavar parecchibaiocchi. S’egli avesse provato star in prigione a discrezione di chi non l’ha, non sose l’averebbe sofferto senza scapuzzare.56
Tasso rappresentava, con linguaggio sorvegliato, l’ambiente che lo cir-condava a Sant’Anna, immettendo nelle proprie descrizioni una forte cari-ca realistica. Marino, al contrario, adopera quel procedimento di descrizio-ne deformante già tipico delle produzioni burlesche del Burchiello o delBerni,57 a conferma dell’uso consapevole e coerente di un registro facetoche a quelle produzioni spesso si rifà:
Voglio perciò raccontarvi una parte della vita ch’io meno. In primis alloggio in unacamera smattonata e smantellata, esposta (Iddio grazia) alle prime furie del rovaio;talmente che la tramontana mi darebbe la stretta, se non mi appiattissi talvoltadentro una pelliccia, a guisa di Adamo nel paradiso terrestre. Le mura sono tutteistoriate col carbone di gieroglifici e di grottesche. Oh che belle figure! uccelli esparavieri con sonagliere! Per mio flagello mi trovo in questa stanza senza cacatoio[…]. Queste sí che sono tribulazioni: piscio senza riverenza dentro una pignataper penuria di pitali; ed acciocché le essalazioni delli arabi odori non mi giunganoal naso, soglio tenerla coperta con un pezzo di tegola. Questa notte mi si è rottacon un eccidio memorabile, talché mi è stata forza far una nuova metamorfosi,trasformando le pantofole in orinali […]. Circa il mangiar devono imaginarsi, midubito, questi nostri pensionari che ’l mio corpo sia glorificato e che non abbiabisogno del vitto. Ogni quindeci giorni mi danno tanta carne quanta pascerebbeun girafalco, e de’ quartieri passati non se ne può cavar robba, né danari. Il venerdí,il sabato e le vigilie, perché sanno che ordinariamente digiuno, per accrescer me-rito alla mia astinenza, dicono che i galli a questi tempi freddi hanno giuratocastità alle galline ed osservano il celibato, e perciò è vanità trovar un ovo, se sicercasse con la lanterna di Diogene […]. Le mie morbide piume sono un pagliaric-cio foderato di lesine ed una schiavina tessuta di sete di porco, dove Luca e LuigiPulci, al toglier delle candele, compongono a tutte ore sonetti mordaci, e la patro-na, come quella che si diletta di polizia mirabilmente, ogni principio di calende micambia un par di lenzuola soffritte nel brodo lardiero e bollati col marchio delsignor marchese […]. Le puttane qui, se non si fanno spiriti, non passeranno pergli spiracoli di questa spelunca, o per le fessure di queste ferrate. Per questo biso-gna ch’io mi diletti piú della contemplativa che dell’attiva, e che mediante la pro-fondità di questa speculativa filosofica mi trattenga con Menalca, Menandro, Me-nelao e Menalippo. Ma la puppola non vuol venirmi a vedere, guardate se si trovastato piú infelice.58
56. Marino, Lettere, cit., p. 527.57. Cfr. Longhi, Lusus, cit., pp. 19-21.58. Marino, Lettere, cit., pp. 532-35.
gianluca genovese
222
Descrizione deformante, autocaricatura, gusto per l’alterazione comica dinomi propri (già constatato nell’analisi delle lettere fittizie): tutti elementiche richiamano, per stile e tono, il genere burlesco. E, se non bastasse, unsegnale chiarissimo della consapevolezza con la quale l’autore ha costruitoil proprio testo viene lanciato all’interno del testo stesso. La lettera, diceva-mo, appartiene a quel gruppo di burlesche pensate per un destinatario rea-le. Nella fattispecie, ha lo scopo di perorare presso Lodovico d’Aglièun’intermediazione che renda possibile la scarcerazione dell’autore. Men-tre Tasso persegue uno scopo simile senza umorismo, Marino lascia la se-rietà dell’appello soltanto alla fine della lettera e evidenzia lo stacco, lafrattura tra la lettera burlesca che fino e quel punto è andato componendoe la serietà della richiesta che sta per rivolgere: «Una donna ingrata, unamico traditore, un padrone inesorabile. Lasciarò le burle; in questa ultimaclausola consiste tutto ’l punto».
«Lasciarò le burle»: quale segnale piú evidente a rimarcare la coscienzadel genere praticato?59 Se non che anche nel prosieguo, che ci aspetterem-mo di tono encomiastico-petitivo, dopo alcuni periodi seriosi la comicitàriaffiora, sia pure adeguata al nuovo registro, sfruttando quello che Bretondefinirebbe humour noir:60
Voi potreste esser per me come una specie di San Gregorio per Traiano imperato-re, liberandomi con le vostre orazioni dalle unghie del brutto babauo. Se vi verràin taglio di vederlo sfacendato e di vena, ditegli da mia parte: «Et tu, Domine,usquequo?». Infino a quando questo diavolo durerà questa festa? «Ubi sunt miseri-cordiae tuae antiquae, Domine?». Dove sono gli onori, i favori, le promesse, lesperanze? Fateli anche sapere che io in questa gabbia sono diventato un rossignuolo;ma non canto altro verso che quello di monsignor Bembo: «Aprasi la prigione, inch’io son chiuso».61
L’analisi di questi testi mariniani è particolarmente utile non solamenteperché, come si diceva sopra, testimonia l’avvenuta cristallizzazione di ungenere – quello della lettera faceta, o burlesca che dir si voglia – praticatoe diffuso ormai con piena consapevolezza, ma anche perché evidenzia una
59. Da rilevare l’uso di questa formula di transizione da parte di autori antologizzati nellecit. Lettere facete e piacevoli dell’Atanagi nell’opposizione tra «parlar per burla» e «parlar dadovero»: «Ma lasciando le burle da parte, delle quali mi son servito per trovar materia dascrivervi, e da dovero parlando» (p. 164); «Horsú, lasciando andar le burle, dico» (p. 235).Cfr. l’introduzione di S. Longhi, p. xiii.
60. A. Breton, Antologia dello humour nero, trad. it. Torino, Einaudi, 1970.61. Marino, Lettere, cit., p. 536.
la lettera faceta nel cinquecento
223
sorta di dicotomia operante all’interno dell’epistolografia faceta. Da un latoesercitazioni e sperimentazioni linguistiche prodotte esclusivamente perlo “spasso” dei lettori, in forma di lettera non per intima necessità, ma per-ché genere di ampia diffusione e sicura vendita sul mercato editoriale cin-quecentesco; dall’altro la lettera, “faceta” anch’essa, che nasce però dallaforma familiare, s’intreccia con essa, ne condivide spesso i tratti tipologici eriesce infine ad affrancarsi e rendersi autonoma.
Un’interessante testimonianza di questa avvertita autonomia, non sol-tanto sul versante della produzione e della fruizione, ma anche su quellodella selezione editoriale, giunge dalla Nuova scielta di lettere di diversi nobilis-simi huomini stampata a Venezia nel 1574 da Andrea Muschio su iniziativa diAldo Manuzio il giovane. Muschio sceglie esemplari delle piú importantiantologie epistolari stampate a Venezia (come dichiara il frontespizio: fattada tutti i libri sin’hora stampati), ma lascia fuori le raccolte di “amorose” e di“facete”:62 queste ultime sono evidentemente sentite dal curatore cometipologie settoriali che non testimoniano correttamente l’esemplarità dei«nobilissimi huomini et eccellentissimi ingegni». Piú o meno a quest’al-tezza cronologica, dunque, le articolazioni del genere epistolare e la deli-mitazione degli spazi che esse possono occupare sono ormai evidenti.63
In embrione, le diramazioni cosí palesemente definite dalla raccolta po-stuma delle Lettere di Marino erano già contenute nel punto di partenzaimprescindibile per qualsiasi discorso intorno all’epistolografia volgare: lostraordinario exploit delle Lettere di Pietro Aretino.
3. Sebbene tanto sul versante della produzione quanto su quello dellaricezione non si possa parlare ancora di una netta delimitazione di genere (odi sottogenere “lettera faceta”), dal momento che lo scopo perseguito sirisolve spesso «in un furioso esercizio di imposizione della voce dell’emit-tente su tutte le voci possibili»,64 con la conseguenza che «i numerosi ele-menti giocosi e comici presenti in queste lettere dell’Aretino (specialmentenei primi libri) vengono filtrati e assorbiti in questo meccanismo autopro-
62. Cfr. l’introduzione di G. Moro al Novo libro di lettere scritte da i piú rari auttori e professoridella lingua italiana, rist. an. delle edd. Gherardo 1544 e 1545, a cura di G. Moro, Sala Bologne-se, Forni, 1986, pp. xxxi-xxxv.
63. Solo alcuni anni prima, l’edizione del 1569 del Secretario di F. Sansovino presentavauna Tavola de generi delle lettere con le loro parti: tra i diciannove generi epistolari studiati unasezione autonoma è occupata dalla “lettera burlesca”, suddivisa in lettera “di sé proprio” e“di terza persona”. La tavola è riprodotta in Basso, Le genre epistolaire, cit., p. 241.
64. Ferroni, Tra lettera familiare e lettera burlesca, cit., p. 53.
gianluca genovese
224
mozionale, tutto fissato nella propria concentrazione interna, tutto impe-gnato a trasmettere una scrittura che sia modello di singolarità e di eccezio-nalità»,65 è anche vero che sono antologizzate lettere leggibili integralmentecome gustosi esemplari faceti dal valore certamente paradigmatico, in ispecieper quelli tra i suoi collaboratori che si avvieranno a seguirne le orme dandoalle stampe epistolari nei quali la settorializzazione e la compresenza di let-tere ascrivibili a diverse tipologie raggiungono una piú alta maturazione (epenso in primo luogo a Franco e a Doni). Proviamo dunque a isolare alcunielementi che nel caso dell’Aretino possiamo definire solamente “comici”,all’interno di un sistema piú vasto e complesso mirante a dare rilievo nazio-nale e internazionale all’autore, ma che entrano a far parte del repertorio dichi in maniera piú consapevole si accingerà alla scrittura “faceta”.
Innanzi tutto il ricorso a un serbatoio di tópoi di larga fortuna in altri ge-neri che la tradizione consegnava come canonicamente aperti alla comici-tà, in primo luogo la commedia e la novella. C’è chi ha parlato di «deca-meronismo della letteratura italiana del Cinquecento»,66 e non c’è dubbioche si possa adattare questa formula a gran parte della produzione di lette-re facete, a cominciare proprio da quelle nelle quali Aretino si rifà, riscri-vendole a suo modo, a situazioni già oggetto di narrazioni novellistiche.Pensiamo, ad esempio, al tópos che dà origine a tante delle novelle comichedi Boccaccio (e degli autori del Tre e Quattrocento) e che si richiama espli-citamente alla tradizione antica della palliata plautina: l’unione, dalle preve-dibili e pruriginose conseguenze, tra un senex e una giovane e bella donna.L’Aretino propone una riscrittura in chiave autoironica del tema dell’amo-re senile:
O fratello, questo Amore è la mala bestia, né può compor versi né intagliar gem-me chi gli va dietro al culo […]. Per ciò chi ama simiglia un di quei tori furibondispronati da l’assillo, ché cosí nel mio paese si chiama lo stimolo che le zecche, lemosche e le vespe danno a le cavalle e a le micce. Amore in là, poi che mette gliscultori e i poeti in sul portante. Il bolino non taglia, né la penna non rende, comelo impiccato ci cava da i gangheri. Ma voi sete giovane, e stavvi bene ogni male.Ma il Sansovino e io, vecchi alleluia, rinneghiamo l’Omnia vincit nel vederci assas-sinare dalle sue mariolarie, le quali ci giurano che la zappa e la vanga ce lo caveràde la brachetta. Per la qual cosa, avendo voi qualche bella tinta da far nere le barbe,me vobis comendo; ma guardate di non me la far turchina, che per Dio simigliarei idue gentil’uomini che stettero per cotal novella murati in casa un anno.67
65. Ibid.66. Borsellino, Il comico, cit., p. 451.67. Lettera del 23 nov. 1537 a Luigi Anichini (ed. Flora cit., pp. 305-6).
la lettera faceta nel cinquecento
225
L’orizzonte comico della novella è a tal punto presente da essere spessoinglobato utilizzando la lettera come cornice per una narrazione.68 Unesempio tra tanti è costituito dall’inserto di un episodio, nella lettera alconte di San Secondo del 24 giugno 1537, anche tematicamente riferibilealla tradizione boccaccesca (si parla di omosessualità). Dopo un’aperturagenerica sulle “pene d’Amore”, Aretino inserisce quella che definisce una“parabola”, e la introduce scrivendo che «si doveria sculpire in lettre d’orociò che disse un perugino»:
Egli cavò de l’amor d’una amica tanto mal francioso che averebbe fatto disperare illegno d’India; onde se ne coperse dal capo a i piedi pur troppo bestialmente. Neavea ricamate le mani, smaltata la faccia, ingemmato il collo e coniata la gola, talche pareva composto di musaico. Ed essendo cosí mal concio, ecco che lo guardauno di quegli… voi mi intendete; e doppo le meraviglie e i conforti, disse: –Fratello, ella si coglie al nascere: bisogna che chi può ce la mandi buona. Ma buonper te se tu avessi imparato l’arte mia! – Volesselo Cristo! – rispose egli – che sifaria per questa pelle, ch’io ho abotita cento volte al nostro santo Arcolano; maperché non faria un piacer a Dio col pegno, sto come tu vedi –.
Altro luogo comune mutuato dalla novellistica (ma sempre presenteanche nella commedia, da quella classica fino a Molière) è la satira controi medici: « la sufficienza dell’arte di Galeno si ferma tutta nella malva di unclistere», scrive nel dicembre 1537 in una lettera che assume come pretesto(potremmo parlare anche in questo caso di “cornice”) le «persecuzioni dei medici» nei confronti del destinatario, Dionigi Cappucci, e che si svilup-pa integralmente come invettiva contro i loro metodi e la loro supponenza.Non è un caso che le lettere sinora citate appartengano alla seconda metàdel 1537 quando, per le ragioni di cui sopra si discuteva,69 Aretino infittiscela propria produzione. Una lettera come quella appena citata è evidente-mente composta per la pubblicazione (i riferimenti a un rapporto coldestinatario si limitano a poche righe introduttive e conclusive) e riscrivetemi comici, in modo da essere sfruttata nella dispositio del “libro di lettere”per accrescere la sensazione di varietas e quindi da un lato evitare “il tedio”del lettore, dall’altro dimostrare come l’autore sia capace di sfruttare virtuo-sisticamente sino in fondo tutte le occasioni di “varietà” offerte dalla lette-
68. Dalla novella la lettera faceta mutua spesso anche quel particolare stile che Testa hadefinito « simulazione di parlato», ossia la finzione d’oralità, centrale per questa come pertante altre produzioni comiche; cfr. E. Testa, Simulazione di parlato. Fenomeni dell’oralità nellenovelle del Quattro-Cinquecento, Firenze, Accademia della Crusca, 1991.
69. Cfr. n. 10.
gianluca genovese
226
ra familiare. Oltre a commedia e novella, un autore di pungenti sonettisatirici e burleschi (si pensi anche soltanto alle pasquinate o alla frottolaPax vobis, brigata che il Papa, quando l’ebbe letta, si lasciò cadere dalle manipiangendo)70 non poteva non attingere alla tradizione sincrona dei capitoliburleschi. Sebbene piú d’una volta attacchi nelle Lettere la poesia burlescadi Berni e dei suoi seguaci bollandola come «poesia dell’insalata»,71 è pos-sibile ritrovare nel famoso “sogno di Parnaso”,72 «capostipite di una tenacetradizione di viaggi e cronache demistificanti e satiriche, che attraversoCesare Caporali farà capo al Boccalini»,73 elementi che a quella tradizionesi riferiscono, primo tra tutti la dissertazione sulla cucina.74
Spesso, proprio sfruttando motivi della tradizione bernesca capace dielogiare paradossalmente cose che possono apparire insignificanti, Aretinoriesce a trasformare una lettera di ringraziamento (che sarebbe stucchevoleper il lettore) in una lettera “piacevole” in lode di un vino che «bacia emorde» e «pone la lagrimetta in su gli occhi»,75 di una collana,76 di lepri,quaglie e uccelli dal becco lungo,77 delle primizie,78 delle pere79 e cosí via.
Anche il violento attacco personale, di cui il sonetto era stato portavoceelettivo (si pensi al sonetto del Berni Può far il ciel però, papa Chimenti, gravi-do di insulti contro Clemente VII, alle Rime contro Pietro Aretino di NicolòFranco o ai sonetti dell’Aretino stesso), entra, con la sua prepotente e vele-nosa carica satirica, nel repertorio di chi compone lettere: basti ricordare laviolenza dell’invettiva contro il Franco nella lettera indirizzata a LodovicoDolce il 7 ottobre 1539:
Ridetevi, compare, mentre udite non in che modo il Franco lordo lacera i buoni,perché in lui non è facultà di poter far ciò, ma come gli vorrebbe lacerare se labestialità de la sua pedanteria fosse da tanto. Il meschino simiglia un cane da ogniunoscacciato e a tutti odioso, il quale, adocchiato l’osso che non può mordere, comin-cia ad abbaiar sí forte che è forza che altri intenda che gli si muor di fame […]. PerDio, che non so pensarmi quale amorevolezza potesse trovare un porco par suo,
70. Cfr. Aquilecchia, Pietro Aretino e altri poligrafi, cit., p. 86.71. Cfr. Longhi, Lusus, cit., p. 60.72. Narrato nella lettera a Gianiacopo Lionardi del 6 dic. 1537 (ed. cit., pp. 348-54).73. Longhi, Lusus, cit., p. 57.74. Accurata l’analisi di questa parte del sogno e del rapporto con la poesia burlesca, ivi,
pp. 57-60.75. Lettera a Girolamo Agnelli dell’11 nov. 1529 (ed. cit., pp. 24-25).76. Lettera al vescovo di Vasone del 17 sett. 1530 (ivi, p. 28).77. Lettera al conte Manfreddo di Collalto del 10 ott. 1532 (ivi, pp. 40-41).78. Lettera a Francesco Marcolini del 3 giu. 1537 (ivi, pp. 168-70).79. Lettera a Gianfrancesco Pocopanno del 15 dic. 1537 (ivi, pp. 369-70).
la lettera faceta nel cinquecento
227
che pareggiasse quella con cui gli ho temporeggiato lo andare a la furfa […]. Matosto che la prosopopea di cotal pecora conobbe di non aver piú briga con lanecessità, si diede a far miracoli ne i Sonetti […]. Ma io merito che le penne diPasquino mi cavino gli occhi del nome, poiché spendo gli inchiostri in ragionar disí vil verme.
Tutte queste possibilità comiche – l’intreccio con la novella innanzi tut-to, il risalto conferito ai temi “burleschi” messi in prosa, l’uso della faceziaincastonata nel discorso “familiare”, reale o simulato – messe a profitto neiprimi due libri delle lettere di Aretino, entreranno a far parte del reperto-rio degli autori di lettere facete. L’intreccio, la sovrapposizione tematica, lariscrittura e il riuso di materiali già adoperati in sedi diverse e in generiletterari altri e fatti confluire nella lettera utilizzata quale capiente conteni-tore di rapida diffusione e sicuro successo editoriale: caratteristiche signifi-cative del primo esemplare dell’epistolografia volgare che lasciano il segnoe si ritrovano, amplificate, nella seconda raccolta di lettere volgari, quelladel beneventano Nicolò Franco.
4. Già in prima persona coinvolto nell’operazione aretiniana (a tal puntoche una tesi suggestiva, ma ancora tutta da verificare, gli assegnerebbe unruolo di primo piano nella genesi dell’idea di pubblicare lettere, grazie allasua padronanza del latino che gli avrebbe permesso di conoscere e vulgarea beneficio dell’Aretino il De conscribendis epistolis di Erasmo),80 il Franco daquella ricava suggestioni ricalcate fino allo scivolare nell’inverosimile (sipensi alle lettera indirizzata al re di Francia da Benevento e datata 1531, quan-do l’autore era sedicenne); ma riesce tuttavia a imprimere un tono perso-nale alla raccolta, che rimarca la propria differenza sin dal frontespizio (nonlettere ma pistole), esclude – e non potrebbe essere diversamente, vista lamarginalità sociale del beneventano rispetto al peso del «secretario delmondo» – i temi della cronaca per presentarsi con un maggior gradiente diesemplarità, e riesce anche a proporre nuovi e fortunati tópoi, in primo luo-
80. Ci riferiamo agli studi di C. Cairns, Nicolò Franco, l’Umanesimo meridionale e la nascitadell’epistolografia in volgare, in Cultura meridionale e letteratura italiana. I modelli narrativi dell’etàmoderna. Atti dell’xi Congresso Aislli (Napoli-Salerno, 14-18 apr. 1982), a cura di P. Gian-
nantonio, Napoli, Loffredo, 1985, e Pietro Aretino and the Republic of Venice, cit. Cfr. ancheProcaccioli, Cosí lavoravano per Aretino, cit. Nelle suggestioni erasmiane leggibili in filigranain alcune lettere di Aretino si riscontra senza dubbio l’apporto di membri del suo entourageaffezionati cultori dell’opera di Erasmo. Oltre al Franco, si ricordi almeno Francesco Coccio,traduttore per Marcolini nel 1539 dell’Institutio principis Christiani di Erasmo, su cui vd. S.Seidel Menchi, Erasmo in Italia 1520-1580, Torino, Bollati Boringhieri, 1987, p. 398 n. 86.
gianluca genovese
228
go quello dell’epistola moraleggiante rivolta a oggetti personificati, a cate-gorie di persone, a valori astratti.81
Violento contro la pedanteria, il Franco ha in comune con la generazio-ne di “anticlassicisti”82 un rapporto ambiguo con la tradizione: a un rifiutodi pedissequa emulazione dei modelli accompagna un uso libero delle fontispesso attinte da repertori maneggevoli che permettono l’accumularsi dicitazioni ed exempla: questa ambivalenza è da tenere in conto per affronta-re con cognizione di causa la lettura di gran parte della produzione “irre-golare” cinquecentesca.83 La mobilità dei confini del genere lettera, giàsperimentata dall’Aretino, ha in Franco la sua piú evidente manifestazione.Nelle Pistole ricorrono con frequenza temi cari all’autore e da lui sviluppatiin opere di genere diverso. Prendiamo ad esempio un Leitmotiv già areti-niano, un idolo polemico contro cui tutta questa generazione di “irregola-ri” si scaglia: l’attacco alla pedanteria, che vuol dire innanzi tutto attaccoagli stanchi epigoni del Petrarca. Nell’ottobre del 1539, presso Giolito, vie-ne dato alle stampe il dialogo del Franco intitolato Il Petrarchista, nel qualesi ridicolizzano gli autori dei commenti neoumanistici al Canzoniere e iltravestimento del Petrarca spirituale di Girolamo Malipiero. Il dialogo, pun-gente e spassoso, tratta i petrarchisti alla stregua di feticisti e profani caccia-tori di reliquie. Nello stesso 1539, ancora presso Giolito, escono i Dialogipiacevoli. Il terzo di questi dialoghi è ancora una volta un’irrisione delpetrarchismo che utilizza gli stessi argomenti del Petrarchista svolti in ma-niera estrema e parodistica.84 Lo stesso tema, svolto con le medesime ar-
81. Quanto a questo punto, è l’autore stesso a dimostrarsi consapevole dell’innovazioneintrodotta in un genere che egli contribuisce a rendere aperto a sollecitazioni ulteriori. Inapertura del iii libro scrive infatti: « I gridi andranno fino all’orecchie di Dominus Vobiscum,quando vedranno ch’io in una lettera scriva a la Fortuna, in un’altra a la Fama, e che entroducala Libertà scrivere a la Servitú, e ch’io scriva a la Lucerna, e ch’ella poi mi risponda, et altresimili fantasie. Qui non è dubbio, ch’io non habbia ad havere de le mazzate. Diranno insomma, ch’io ho fatto il mondo a mio modo, e che sia in tutto uscito da la via de i mulattieri,come fusse cosa nuova il potere entrodurre l’animato parlar con l’inanimato, e l’inanimatorispondere, e come sia stato un dar di corda a le fintioni ciò che ho finto io […]» (N.Franco, Le Pistole Vulgari, rist. an. dell’ediz. Gardane [1552] a cura di F.R. De’ Angelis, SalaBolognese, Forni, 1986, c. 184v).
82. Cfr. N. Borsellino, Gli anticlassicisti del Cinquecento, Roma-Bari, Laterza, 1973.83. Cfr. gli interventi contenuti in Cinquecento capriccioso e irregolare. Eresie letterarie nell’Italia
del classicismo, a cura di P. Procaccioli e A. Romano, Manziana, Vecchiarelli, 1999, e sulrapporto, spesso occultato, con le fonti classiche, P. Cherchi, Polimatia di riuso. Mezzo secolo diplagio (1539-1589), Roma, Bulzoni, 1998.
84. Cfr. F. Pignatti, Invenzione e modelli di scrittura nei ‘Dialogi piacevoli’ di Niccolò Franco, inCinquecento capriccioso e irregolare, cit., pp. 99-129, a p. 121, e Grendler, op. cit., pp. 38-42.
la lettera faceta nel cinquecento
229
gomentazioni e caricato di uguale valenza polemica e satirica, è anticipatonella lettera Al Petrarca contenuta nelle Pistole vulgari stampate da Gardanenell’aprile del 1539.85
Legittimata dal Petrarca stesso che indirizzò, per la «grandissima affezio-ne» che gli portava, una lettera a «M. Tullio, […], in quel mondo dov’era»,la “pistola” del Franco non è un modo per porsi in comunione spiritualecon un grande del passato ma un espediente per polemizzare contro coloroche a quel grande «van togliendo le parolette da i Sonetti e da le canzoni, efacendone i Paternostri gli van vendendo per robbe loro». Il passo contro la«infelicità» degli innumerevoli commentatori merita di essere letto:
Hor questi dunque, perché si conosceano non valere ad altro, si son posti a comenta-re le vostr’opere vulgari, ingegnandosi di trovarci novità di chimere per parereingegnosi, e di recarci ciancie infinite per mostrarsi facondi. Ma con che rumor discodelle i lavaceci si vadano poi imboccando le vostre fantasie, volendole intende-re al vostro dispetto, non ve ’l potrei scrivere per una lettra. E volesse pur Iddio chefussero stati soli i processi fattivi sopra i versi et i tormenti dativi sopra i sensi,perché son stati piú i chiassi fattivi in dishonor de l’honore e del nome: per havervoluto investigare se voi feste o non feste quella cosa con Monna Laura, s’ellahebbe marito o no, se fu sterile o fé figliuoli, se ’l Cardinal Colonna ve la tolse aforza d’oro, se ’l Papa vi promettesse il Capello volendogli consentire una sorella dicui era invaghito, con tante altre sporche dispute ch’io mi vergognerei d’annove-rarle scrivendo.
Il contributo del Franco alla storia della lettera faceta non sta, a nostroavviso, nella pratica consapevole di questo sottogenere (il comico nellePistole è «interamente subordinato ai fini oratori»),86 ma nell’incontro – ilprimo nella storia dell’epistolografia volgare – tra lettera dichiaratamentefittizia e registro comico. Sebbene il registro comico sia presente a tratti inlettere indirizzate agli amici piú intimi e in alcune occasioni perda «il suoprevalente carattere sussidiario per assumere una funzione egemone»87 (èil caso di una lettera sulla “settimana santa” inviata a Leone Orsini,88 non acaso dedicatario tanto delle Pistole che dei Dialogi piacevoli), è in lettere co-me quella indirizzata al Petrarca citata sopra, o come l’Epistola alle Puttane ead altre categorie di persone dai forti e caratterizzati tratti tipologici (se-condo un collaudato schema comico che porta all’estremo questa caratte-
85. Franco, op. cit., cc. 238v-241r. La lettera Al Petrarca è la cclxix.86. De Nichilo, La lettera e il comico, cit., p. 222.87. F.R. De’ Angelis, Introduz. a Franco, op. cit., p. xliii.88. Ivi, lettera cxcvii (cc. 153r-155r).
gianluca genovese
230
rizzazione: si pensi ai prologhi delle commedie plautine in cui sono pre-sentati servo, senex, adulescens secondo una convenzione che giungerà sinoalla Mandragola)89 che la comicità, svincolata dalle incombenze comunica-tive “familiari”, comincia a divenire ingrediente compositivo autonomo edi per sé sufficiente di una lettera.
Non tutte le lettere fittizie di Franco sono lettere comiche (se cosí fossepotremmo già collocare il Franco tra gli autori di lettere “facete” senza leriserve esposte sopra), anzi la maggioranza di esse, indirizzate alla Libertà,alla Fama, alla Fortuna, all’Invidia sono, al pari di molti dialoghi, un modoper esprimere il risentimento derivante dalla marginalità in cui lo relegavala società veneziana del tempo, o per affermare un punto di vista moralisticosu questioni che sentiva molto vicine. Tuttavia l’irrisione graffiante dellalettera Al Petrarca, il divertito catalogo delle follie derivanti dalla passioneerotica nella lettera All’Amore,90 la risposta di Cupido,91 il linguaggio meta-forico, i doppi sensi e le studiate similitudini della lettera Alle Puttane sonogià un gradino piú su, verso la definitiva specializzazione della lettera face-ta, rispetto a quanto si diceva dell’epistolario aretiniano. Il pezzo forse meglioriuscito, e di sicuro il piú noto, tra quelli che coniugano struttura fittizia,fervore moralistico e registro comico-satirico è la Risposta della Lucerna.92
Alla Lucerna il Franco chiede cosa «faccia tutta la notte»; e la lunga rispo-sta di quest’oggetto che, in quanto inanimato, può assistere indisturbato allavita reale delle persone, è un lungo e cinico smascheramento delle ipocri-sie sociali (cinico secondo la definizione di Oscar Wilde: «il cinismo èsemplicemente l’arte di vedere le cose come sono, non quali dovrebberoessere»).93 Quasi inutile sottolineare la parentela che l’espediente utilizza-to dal Franco ha con un’antica tradizione, anch’essa fortemente connotatain senso comico e moralistico, che ha come proprio archetipo L’asino d’orodi Apuleio.94 A essa si somma una chiara matrice erasmiana95 che toglie il
89. Per Machiavelli comico e il suo rapporto con le fonti, cfr. Raimondi, Politica e comme-dia, cit.
90. Franco, op. cit., cc. 227r-231v, lettera cclxi.91. Ivi, cc. 231v-232r, lettera cclxii.92. Ivi, cc. 186r-202v, lettera ccxxxvii.93. O. Wilde, Aforismi, introd. di R. Reim, Roma, Newton & Compton, 1992, p. 57.94. Sulla condizione privilegiata dell’asino che può conoscere e descrivere la vita quoti-
diana e privata, in quanto nessuno fa conto della sua presenza, e sui riflessi letterari di essa,si veda M.M. Bachtin, Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo, in Id., Estetica e romanzo,trad. it. Torino, Einaudi, 1979, pp. 258-77, partic. pp. 268-74.
95. Sull’importanza del rapporto che lega il Franco a Erasmo, oltre agli studi di Cairns
citati sopra, cfr. anche U. Rozzo, Erasmo espurgato dai ‘Dialogi piacevoli’ di Nicolò Franco, in
la lettera faceta nel cinquecento
231
velo alle realtà convenzionali per mostrare la follia e l’ipocrisia che alber-gano in ogni professione e condizione sociale, dalle «puttane» alle suore,dai «mercatanti» agli stampatori, dai barbieri ai « librari». Intorno a que-sti ultimi scrive, in un passo che ben esemplifica il tenore dell’intera let-tera:
me ne vo ai Librari per solazzarmi, poiché sempre rido quando leggo le cosealtrui. Veggo le cataste de i libri tanto alte, che mi tremono i ginocchi a guardarcisu. Leggo solamente i titoli, che stan fuora segnati in lettere maiuscole, come ilnome de gli Apostoli in mezzo il Credo. Veggo pur gli strani nomi de libri. Chi sichiama Enchiridio, chi Corno de la Divitia e chi Bibliotheca. Veggo tante Anno-tationi, Racemationi, Osservationi, Cacationi che veggendole mi maraviglio comeSan Giovanni del Comparatico possa trovare tanti compari per battezzare. Veggoil Petrarcha commentato. Il Petrarcha sconcacato. Il Petrarcha imbrodolato. IlPetrarcha tutto rubbato. Il Petrarcha Temporale et il Petrarcha Spirituale. Veggonon so che baie di Trabisonde, non so che rumore di Mambriani, non so chepistelentie d’Ancroie, d’Orlandi, di Rinaldi, di Buoi d’Antona, di Sacripanti, diFalconetti e di Moschetti […].
Se l’Aretino già si situa sul versante della “letterarietà” (esemplificabilecon l’intercambiabilità del destinatario), il Franco non si preoccupa comelui di dissimulare questa scelta mantenendo sempre e comunque le carat-teristiche formali di una lettera “reale”, che richiede innanzi tutto la pre-senza di destinatari in carne e ossa e di contenuti verosimili, ma sfalda laconvenzionalità formale del genere-lettera insediandosi definitivamente alcentro del testo non come semplice voce di corrispondente in un dialogoa due, ma come autore di un libro. Il suo libro di Pistole vulgari diventa accesostrumento di una battaglia ideologica e personale affiancandosi all’altra suaproduzione, spesso sovrapponendosi e confondendosi con essa, ma gio-vandosi della possibilità, preclusa ad altri generi dalla codificazione piúrigida, della varietas che caratterizza l’epistolografia. I toni moralistici elivorosi, gli schemi laudatori e la ricerca di decoro in competizione coi mo-delli classici lasciano campo raramente al comico come ingrediente com-positivo; ma quando esso emerge rendendosi autonomo lo fa in modo dalasciare il segno.
Erasmo, Venezia e la cultura padana nel ’500. Atti del xix Convegno Internaz. di Studi Storici(Rovigo, 5-9 mag. 1993), a cura di A. Olivieri, Rovigo, Minelliana, 1995, pp. 193-207. Quantopeso avessero certi fermenti religiosi legati alla Riforma nella vita e nell’opera della granparte degli autori di cui ci stiamo occupando, è ben mostrato nei saggi di G. Fragnito, Inmuseo e in villa. Saggi sul Rinascimento perduto, Venezia, Arsenale, 1988.
gianluca genovese
232
5. Terzo a provarsi nella composizione di un epistolario in volgare, maprimo a pubblicare lettere che «si possono qualificare come prevalente-mente comiche, anche se sottostanno ad un generico schema laudativo,pubblicitario e familiare»,96 lontano da esperienze marginali per bacinod’utenza o per capacità d’autore quali quelle del Calmo e del Rao (dellequali tra breve parleremo), e da questi visto e assimilato come archetipoprincipe del genere praticato, il Doni epistolografo offre il destro per ana-lizzare nel suo punto di svolta la tipologia della lettera faceta, in un mo-mento nel quale, se ancora massiccia è l’influenza onnicomprensiva della“familiare”, si vedono tuttavia a mano a mano delinearsi le forme indipen-denti delle varie articolazioni specialistiche dell’epistolografia cinquecen-tesca. Autore straordinariamente fecondo dal ritmo “industriale”,97 per unbreve periodo stampatore in proprio,98 successore dell’Aretino quale auto-re di punta del Marcolini nell’intenso biennio 1551-’52,99 poligrafo,100 il Donidissemina di lettere tutte le sue opere, sperimentandone anche gli esiti estre-mi del pastiche (nelle Prose antiche inserisce una lettera ingiuriosa alla città diVenezia attribuita a Dante ma da lui composta con tale capacità mimetica
96. De Nichilo, La lettera e il comico, cit., p. 223.97. Egli stesso e il Marcolini accreditano la composizione contemporanea di piú libri via
via che si stampavano (con vicenda analoga alla stesura degli Adagia erasmiani nella tipogra-fia del Manuzio), sfruttando promozionalmente l’immagine di una mitica vena inesauribiledall’evidente riferimento agonistico all’opera dell’Aretino. Cfr. G. Masi, «Quelle discordanze síperfette ». Anton Francesco Doni 1551-1553, in «Atti e Memorie dell’Accademia Toscana di Scien-ze e Lettere “La Colombaria”», vol. liii 1988, pp. 9-112 (cfr., per questo punto, le pp. 38-40).
98. Dopo la Chiesa e la corte cercava una via di emancipazione nella stampa: via tentataa Firenze tra il 1546 e il 1547 contando sulla crisi della monopolistica industria editoriale deiGiunta, ma presto destinata al fallimento economico, vista anche la politica di controllo suglistrumenti di potere messa in atto da Cosimo I. Le edizioni del Doni, di bassissima qualità,comprendono, oltre a sue opere (Lettere, Gli spiriti folletti e le Prose antiche di Dante, Petrarcha eBoccaccio), anche testi di Martelli, Gelli, Giambullari, Gottifredi e di altri. Vd., per una detta-gliata e completa esposizione, C. Ricottini Marsili-Libelli, A.F. Doni scrittore e stampatore.Bibliografia delle opere e della critica e degli annali tipografici, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1960.
99. Cfr. A. Quondam, Nel giardino del Marcolini. Un editore veneziano tra Aretino e Doni, inG.S.L.I., clvii 1980, pp. 75-116.
100. Sulla figura del “poligrafo” e sulla cautela con la quale bisogna maneggiare questadefinizione si sofferma R. Bragantini, “Poligrafi” e umanisti volgari, in Storia della letteraturaitaliana, cit., vol. iv. Il primo Cinquecento, Roma, Salerno Editrice, 1996, pp. 681-754. Vd. anchel’intervento dello stesso al dibattito riportato in appendice a Cinquecento capriccioso e irregolare,cit., pp. 185-86. Per quanto ci riguarda possiamo accettare la definizione «ristretta» di poligraficome «quegli autori che produssero letteratura in volgare in stretta collaborazione con leofficine tipografiche veneziane» proposta da Aquilecchia, Pietro Aretino e altri poligrafi, cit.,p. 126.
la lettera faceta nel cinquecento
233
da essere a lungo ritenuta autentica) e, addirittura – con sensibilità pre-sterniana –, della pagina bianca che frantuma la vuota convenzionalità del-la lettera di dedica (le Foglie della Zucca del Doni si aprono con Il luogo dellaepistola dedicatoria: «un espace blanc et sa justification!»).101 Il ruolo decisivodel Doni nella strutturazione del codice linguistico e stilistico della letterafaceta meriterebbe un approfondimento che non è possibile affrontare inquesta sede; ci limiteremo, nel tentativo qui abbozzato di ricostruire l’evo-luzione diacronica di tale tipologia, ad accennare agli elementi di scarto, divariazione significativa e consapevole da lui apportati e fatti propri daisuccessivi autori di facete.
Tornando al passo della lettera al Giolito citato sopra, Doni ammette diusare spesso la forma lettera solo per lo “spasso” del lettore; e non è raroimbattersi nella medesima epistola, con o senza variazioni, in opere diver-se; evidentemente la lettera è considerata materiale compositivo intercam-biabile e utilizzabile nella dispositio di un testo qualsiasi alla stregua di unaneddoto o di una novella, smarrita ormai l’originale destinazione comu-nicativa in un dialogo privato. Il primo libro delle Lettere d’AntonfrancescoDoni, presentato come insieme «utile» e «giocoso», fu stampato a Veneziadallo Scotto nel 1544; nel 1546, a Firenze, una nuova edizione arricchitainaugurò l’attività del Doni editore. In quest’ultima l’ordine delle lettere,prima rigorosamente cronologico, subí numerosi cambiamenti: molte fu-rono corrette sopprimendo alcuni passaggi particolarmente licenziosi e,soprattutto, a testimonianza del processo di «svincolo di questi brani dallaloro specificità corresponsiva», «le medesime epistole, tratte dall’edizione“regolare” del 1544, comparivano già con l’omissione delle date».102 Ultimae definitiva silloge allestita dall’autore, libro “mescidato”, è quella marcoli-niana del 1552: Tre libri di lettere del Doni e i termini della lingua toscana. Anchein quest’edizione molte lettere vennero rivedute, e spogliate in parte dallemassime irreligiose e dalle invettive contro i frati, ma questo non impedíche la libertà di linguaggio e la componente oscena portassero quest’epi-stolario a essere «uno dei pochissimi libri non trattanti ex professo di teolo-gia, che veggonsi proibiti nelle prime stampe dell’Indice tridentino».103 La
101. Basso, Le genre epistolaire, cit., p. 87.102. Masi, op. cit., p. 30. Il discorso di Masi tocca solo incidentalmente le edizioni di cui ci
stiamo occupando, essendo incentrato sull’analisi dei Fiori della Zucca che contengono, nellaparte finale, una scelta di lettere doniane, elencate col nome del destinatario ma senza data.
103. S. Casali, Annali della tipografia veneziana di F. Marcolini, rist. a cura di A. Gerace,Introduz. di L. Servolini, Bologna, A. Gerace, 1953 (rist. dell’ed. di Forlí, presso MatteoCasali, 1861), p. 231.
gianluca genovese
234
presenza di un indice delle materie trattate è già di per sé indicativa di unaconcezione dell’epistolografia quale genere squisitamente letterario appa-rentabile, ad esempio, alla trattatistica; la tradizione della lettera “familia-re” (soggetta anch’essa, come abbiamo dimostrato sopra, alla retoricizzazionein forma di “libro”) e di epistolari che da essa cominciano a discostarsi co-me le Pistole vulgari del Franco si limitavano a offrire tavole cronologiche e/o dei destinatari, per mantenersi all’interno di una pur fragile e illusoriacoerenza di genere; viceversa per lettere composte appositamente per lapubblicazione indicare l’argomento è facile (ed esamineremo tra brevel’esempio, piú tardo e memore della lezione doniana, del Rao). Una scorsaal sommario dei Tre libri di lettere, organizzato non secondo la dispositio deltesto ma per ordine alfabetico, ci dà un’idea precisa delle scelte operatedall’autore in merito al sottogenere da lui prediletto.
Troviamo, limitandoci a un campionario significativo, «andamenti paz-zi da scrivere stravagantemente cose che rilievin pochi fatti et assai parole»,«baie dette per gratuità et stile in burla da savio», «componimento di vo-caboli pazzi da fare farneticar le persone», «cicalamento mezzo da dovero,et il resto da beffe», «eccellenza della padella», «levata di parole, simili a icastelli in aere», «novella de gobbi», «passatempo di certi furbi in dialogo,scritto per amaestramento d’un furbo», «scherzamenti in briglia nello scri-vere per dare spasso a i grandi, et uscir dall’ordinario».
Prima ancora dei contenuti, salta agli occhi l’importanza attribuita al-la lingua e allo sperimentalismo linguistico:104 «pochi fatti et assai parole»,«componimento di vocaboli pazzi», «levata di parole» e cosí via. Nel Cin-quecento, «secolo climaterico nella vita della lingua italiana»,105 essere fio-rentino poteva voler dire reagire alla idealizzazione, operata da non tosca-ni, di una lingua trecentesca cristallizzata e sentita quasi come “morta”,recuperando il «sapore del dialetto, il senso della lingua con tutte le suepossibilità espressive»;106 e di sicuro questa componente ha la sua impor-tanza nell’originale impasto linguistico doniano in cui «marcata resta l’im-pronta demotica nella lingua»,107 sebbene «altrettanto evidente risulta nel-lo scrittore dei Marmi il rifiuto di ogni normativa stretta e rigorosa, anche
104. Cfr. F. Chiappelli, Sull’espressività della lingua nei ‘Marmi’ del Doni, in L.N., a. vii 1946,pp. 33-38.
105. Cfr. C. Segre, Edonismo linguistico nel Cinquecento, in Id., Lingua stile e società, Milano,Feltrinelli, 1974, pp. 369-96.
106. Ivi, p. 378.107. Masi, op. cit., p. 33.
la lettera faceta nel cinquecento
235
in campo linguistico, pur nella fedeltà ai canoni dell’idioma nativo; a diffe-renza dei risentiti appelli degli strenui difensori della fiorentinità e dellavisione egemonica linguistica cosimiana».108 La lingua è strumento che ilDoni sa maneggiare con “divertimento”: si pensi al suo mimetismo lingui-stico, «pronto a fare il verso al Boccaccio come agli scrittori cortigianicome alla plebe»109 che può giungere, lo abbiamo accennato, sino al pastiche.In questi casi il testo elaborato dall’autore si configura come testo di secon-do grado110 e presuppone, quale condizione di lettura, la conoscenza del-l’opera imitata o, piú frequentemente, parodiata (ma con l’introduzionedell’indice delle materie al lettore è facilitato il compito d’identificare ilbersaglio dell’autore e di decifrare le sue intenzionalità: cosí avremo lo«stile in burla da savio», il «discorso per parere un sofficiente pedante», la«imitazione d’un altro stile che il suo», e cosí via).
Le parodie del Doni colpiscono non solo altri autori o uno stile avverti-to come aulico e pedante, ma anche molte delle tipologie epistolari codi-ficate; esempio eclatante, nei Tre libri di lettere, è la parodia della lettera de-dicatoria, una tra le tipologie piú diffuse a corredo di opere dei generi piúdisparati, in tempi in cui gli uomini di lettere avevano estrema necessità disovvenzioni e contributi privati. Se l’Aretino aveva spinto sino al virtuosi-smo l’arte di chiedere favori per mezzo di adulanti epistole dedicatorie, leparodie del Doni ridicolizzano questo genere dal tono smaccatamenteencomiastico-petitivo. Che non lo si debba prendere sul serio, lo dice giànel sommario presentando una di queste epistole laudatorie, indirizzata alCardinal Santa Fiore, come «cicalamento mezzo da dovero, et il resto dabeffe».111 E in un’altra (guarda caso, nella dispositio finale del testo, imme-diatamente precedente una lettera indirizzata a Pietro Aretino), offre lesue opere premurandosi, con accenti chiaramente parodistici, di non chie-dere nulla in cambio:
io mando a vostra Eccellentia un mottetto di Giacchetto Berchem, degno certo divenire alle mani di tal Signore, et mando a vostri cantori una mia canzone, mandovidue sonetti composti dalla mia sprofondata memoria scritti di mia mano […], etnon pensate che io uccelli con questi oncini d’aprirvi la scarsella, ringratiato siaIddio, io ho tanti dinari, che non gli posso spendere, vivo di Chirieleison […]; néricerco altro da vostra Eccellentia se non ch’ella perseveri nel farsi eterno con la
108. Ibid.109. Segre, op. cit., p. 384.110. Cfr. G. Genette, Palinsesti. La letteratura al secondo grado, trad. it. Torino, Einaudi, 1997.111. Doni, Tre libri di lettere, cit., p. 53.
gianluca genovese
236
Fede, con la Giustitia et con la Bontà, la quali vi fanno immortale al mondo et viapparecchiano seggio appresso Iddio.112
Se il culto cinquecentesco per la forma aulica portò alla reazione toscana diritorno alla “favella” e al materiale linguistico popolare con vicinanza a sin-tassi e ritmo del parlato, questo recupero nella lingua del Doni sa sempredi artificio e c’è chi ha parlato di «retorica popolaresca», di «falsa prosaviva» e di «compiacimento» nell’uso del parlato, di «effetti cromatici»ottenuti mediante proverbi e modi di dire.113
Certo, è difficile parlare di spontaneità leggendo i suoi “ghiribizzi”, sa-pientemente costruiti con attenzione alle forme retoriche e agli effetti fonicidella lingua: «Dal corrier di Carafulla habbiamo inteso l’opinione di MonnaLucca di Balucca, moglie del signor Asiderato, capitano de gli Arpioni, ilquale ha mandato a dire che tutto l’essercito della città di Baldracca è inordine con le trabacche, e beltresche».114 Rispetto agli epistolari dell’Are-tino e del Franco «è piú vistosa l’intenzione di forzare l’angusto spazioretorico del genere per mezzo della trasgressione comica»;115 il Doni ri-prende e amplifica i procedimenti già in parte descritti sopra codificandoli.Anche ciò che può apparire, nei successivi autori di facete, come novità èspesso solo ripresa di suggestioni doniane; ad esempio, parlando di Rao,nel suo ottimo studio la De Nichilo dice che «la novità introdotta da Raoè semmai quella di aver dato forma di lettere a quelle “orazioni in lode” dioggetti abitualmente biasimati»,116 con riferimento al filone burlesco dimatrice bernesca.117 Ebbene, rinvio implicito alla tradizione a cui accennala De Nichilo si rinviene già nella Lode della castagna,118 ed esplicito richia-mo ad essa c’è nell’Eccellenza della padella: «mi maravigli molto del Berna,del Mauro et di Giovanni della bottega, che si scordassero una cosa tantoimportante non cantando le sue lode hora secondo Rabhilac, che fu il
112. Ivi, pp. 41-42.113. Nell’ordine, Momigliano e Chiappelli: cfr. Segre, op. cit., p. 383 n. 30.114. Doni, Tre libri di lettere, cit., p. 47.115. De Nichilo, La lettera e il comico, cit., p. 223.116. Ivi, p. 228.117. Nella vicenda cinquecentesca dell’elogio paradossale, all’eredità del Berni si somma
quella derivante dall’Encomium moriae di Erasmo, che ha come proprio referente la tradizio-ne paradossale della Seconda Sofistica, con le sue lodi di oggetti o fatti insignificanti (perricordare solo due esempi tra i piú noti, la Mosca di Luciano e l’Elogio della calvizie di Sinesio).Cfr. il capitolo dedicato a L’elogio paradossale da Longhi, Lusus, cit., pp. 138-81, in cui si studiaanche l’esito cinquecentesco forse piú alto di questa linea, i Paradossi di Ortensio Lando.
118. Doni, Tre libri di lettere, cit., p. 102.
la lettera faceta nel cinquecento
237
primo scorticatore de’ segreti […]».119 Il rifarsi alla tradizione comica dellanovella e della commedia, già evidenziato a proposito degli epistolari citatisopra, permette anche l’uso di un dettato piú rilevato e disinvolto, linguisti-camente popolaresco e sperimentale (questo avviene, lo dicevamo, in specialmodo per gli scrittori toscani), che sfrutta anche la «scappatoia del gene-re», ossia l’appiglio teorico del «canone dell’adeguazione dello stile allamateria» che «dalle poetiche classiche a quelle medievali era disceso sinoai teorici del ’500».120
Se l’Aretino si serve della novella come gradevole inserto diegetico, man-tenendo salve le caratteristiche del genere lettera, il Doni va oltre alteran-do la struttura della lettera per mezzo della totalizzante invasione di novel-le o “parabole” che assumono valore autonomo;121 ne dà riscontro indiret-to ma significativo il fatto che il Poggiali prima, per la sua raccolta delleNovelle di alcuni Autori fiorentini, il Gamba e il Bongi poi, giudicarono op-portuno raccogliere in volume alcune delle novelle disseminate dal Doninelle sue opere, scegliendone parecchie dalle Lettere.122 Che sia corretto par-lare di “libro” risulta evidente anche dalle connessioni intratestuali chespesso denunciano esercitazioni burlesche. Un esempio per tutti è costituitodalla coppia di lettere che hanno per argomento la descrizione del museodel Giovio: la prima, indirizzata al Tintoretto, è una descrizione «fatta inburla»;123 la seconda, al conte Agostino Landi, è «scritta da vero».124 Con-frontiamone due passaggi, cominciando dalla seconda:
Cosí si gustano molte belle cose; oltre che vi sono mille antiquità, poi vi sono altreaccomodate stanze, et luoghi mirabili. E uscito fuori, et ritornato nella corte, ologgia tutta dipinta dalle colonne sostenuta, si passa all’altro portico: nel quale è
119. Ivi, p. 163.120. Segre, op. cit., p. 382.121. La concezione dell’epistolario come contenitore eterogeneo e “libro mescidato” ri-
sulta evidente non soltanto da questi esempi macroscopici ma anche da particolari menovisibili. Ad esempio, una lettera è il pretesto per inserire nella raccolta un frammento didialogo tra uno scrivano e il suo interlocutore (Doni, Tre libri di lettere, cit., pp. 137-42).
122. Cfr. Casali, op. cit., p. 231. Vd. anche il giudizio, in verità riduttivo, giusta l’ascenden-za crociana, di E. Bonora (Storia della letteratura italiana, dir. E. Cecchi e N. Sapegno, Milano,Garzanti, vol. iv 1966, p. 443): «È evidente comunque che il Doni resta un prosatore di pocorespiro, che sa essere efficacissimo in scritti brevi e occasionali come le Lettere ; riesce soventea trovare una giusta misura artistica nelle novelle e novellette disseminate nelle sue opere eancor meglio nelle facezie, nelle quali egli eccelse tra i non pochi autori che ne scrisseroprima e dopo di lui per il suo spirito pronto e mordace».
123. Doni, Tre libri di lettere, cit., pp. 75-79.124. Ivi, pp. 80-86.
gianluca genovese
238
una fontana, che in gran copia getta acqua per il petto di una figuretta di pietracome la natura. Ci sono certe donne dalle sponde dipinte: le quali trahendosi lacamiscia fingono voler lavarsi con assai altri adornamenti et figurini. Poi ci sono insei quadri distinti molte favole sotto la detta loggia: come Marsia, che Apollo glileva la pelle da dosso (forse perché sudava) per averlo vinto a sonare.
Alla descrizione seria (ma la tentazione di un inserto burlesco è troppoforte per non cedervi: e allora si domanda se Marsia non fosse stato scor-ticato perché sudava) si contrappone quella in burla:
Et slanciatomi piú inanzi sotto un soppalco, che si posava sotto certi sassi lunghicome botte da carri, mi vedeva intorno tanti visi, tanti ceffi et tante maschere, conle mani del medesimo huomo lisciati sulla calcina, ch’io mi sguazzavo tutto. Ov’era pure una bella cosa: una donna sotto un altro solaro dura come un marmo,c’haveva piú poppe assai ch’una cagna, et in capo una paniera di frutte, come lavenisse dal mercato. Ma ella non haveva né mano, né piedi; et per le sue tettinebelline bianche com’una rugiada, la pisciava acqua in un catino grande; et due don-ne che parevano che si volessero lavare si cavavano la camicia. O l’erano bellebianche, rosse. O Dio se l’erano vive eh? poi v’era dipinto in sei pezzi di qua et dilà. Il primo mi pareva un San Bartholomeo, ma non haveva la pelle sulla spalla:ch’uno huomo che portava la ribeca, l’appiccava a un albero; et poi gli era legatocome un san Bastiano. Che domine era egli!?
Questa coppia di lettere è di estremo interesse per analizzare genesi, com-ponenti e tipologia della lettera faceta. Infatti gran parte delle lettere facetehanno per argomento descrizioni burlesche di ambienti (ad esempio, ilcarcere dove era rinchiuso il Marino), degradazioni del mito (si pensi alCalmo) e allusioni oscene. In questo caso l’autore però ci offre non soltan-to il verso ma anche il recto, non solo la deformazione ma il materiale dadeformare; dà ai suoi lettori, che con ogni probabilità non hanno visitato illuogo in questione, la possibilità di apprezzare e raffrontare da un lato unadescrizione “alta” e dall’altro il suo rovescio burlesco. Confrontarle è comepenetrare nell’officina dell’autore e osservarlo mentre applica i suoi acidimutando il serio in faceto, servendosi di quei procedimenti comici che, giàlo sappiamo, formano il bagaglio e il repertorio degli autori di lettere gio-cose. Immediatamente si sente, nel passaggio da una tipologia all’altra, uncambiamento non soltanto nel tono e nel linguaggio, ma in primo luogonel punto di vista e nelle possibilità culturali della voce narrante. Questa sifinge, nella descrizione in burla, stupita e, soprattutto, incapace di decifrarecorrettamente ciò che sta guardando: non riconosce gli episodi del mito,ma tenta di descriverli ricorrendo a un patrimonio iconografico umile, da
la lettera faceta nel cinquecento
239
vita dei santi e da affresco di chiesa di campagna; cosí, ciò che il serio ecolto visitatore riconosce immediatamente raffigurare l’episodio di Apolloe Marsia (che qualche anno dopo rivivrà in una straordinaria tela di Tiziano),appare allo sprovveduto come un «san Bartholomeo» che «non haveva lapelle sulla spalla» appiccato a un albero da «uno huomo che portava laribeca». Ciò che il primo liquida come «una fontana, che in gran copiagetta acqua per il petto di una figuretta di pietra come la natura», al secon-do appare «una bella cosa» sulla quale vale la pena soffermarsi, anche peri suoi attraenti dettagli anatomici («tettine belline bianche come una ru-giada»); le similitudini introdotte rimandano sempre a un universo umile,quotidiano, popolaresco (per degradazione del mito): se ha sul capo un pa-niere ricolmo di frutti somiglia a qualcuno di ritorno «dal mercato». Illessico non è ricercato ma volutamente tende verso il basso: non piú «unafontana, che in gran copia getta acqua per il petto», ma «tettine bellinebianche» dalle quali la figura «pisciava acqua in un catino grande». El’allusività non manca («o Dio, se l’erano vive, eh?»).
Allusività erotica e doppio senso osceno sono, d’altra parte, ingredientiprivilegiati di ogni tipo di produzione comica, e gli autori di facete (dal-l’Aretino al Marino) sfruttano a piene mani questo filone; il Doni nonpoteva non offrirne un ricco catalogo. Esaminiamo due casi, uno al limitedell’ammiccamento, l’altro esplicitamente osceno. In una lettera indirizza-ta alla «magnifica et virtuosa madonna Francesca Baffa»,125 l’autore siripromette, qualora andasse a Venezia, di farle visita: «voglio venire a toc-carvi la mano; bacierommela; et caveromivi la berretta; et dirovvi (dietro atutte le parole): io vi sono servidore». L’apparente innocenza di questoproposito è ribaltata dall’immediato riferimento, che un lettore smaliziatodeve immediatamente cogliere, a una novella del Boccaccio:126 «ma vede-te, fatemi poi buona accoglienza; con patto però che voi non mi faceste daMonna Belcolore; ch’io voglio il tabarro per me, sapete?». Inutile sottoli-neare, per chi è in grado di mettere insieme i pezzi intra ed extratestuali, lacomicità insita in quel «fatemi poi buona accoglienza», dove «accoglien-za» deve intendersi alla maniera in cui l’intendeva il prete da Varlungo
125. Doni, Tre libri di lettere, cit., pp. 56-58. La Baffa è personaggio realmente esistito, tral’altro interlocutrice nel Raverta, dialogo di M.G. Betussi, nel quale si ragiona d’amore e degli effettisuoi, stampato per la prima volta a Venezia da Giolito nel 1544.
126. Si tratta della seconda novella dell’ottava giornata del Decameron: « Il prete da Varlungosi giace con monna Belcolore; lasciale pegno un suo tabarro, e accattato da lei un mortaio, ilrimanda e fa domandare il tabarro lasciato per ricordanza; rendelo proverbiando la buonadonna».
gianluca genovese
240
della novella. Altro caso è costituito dalla lettera sulla «nobiltà, virtú, gran-dezza e perfezione della chiave».127 Un dato per noi di estremo interesse èquello che riguarda la provenienza di questa lettera, già pubblicata in ap-pendice a un’edizione dello Specchio d’amore128 di Bartolomeo Gottifredi,stampato a Firenze nel 1547 proprio per i tipi del Doni. Ebbene, moltoprima della silloge curata dall’Atanagi, sul frontespizio di questa edizionela lettera del Doni viene qualificata come “piacevole”, utilizzando pertantoun’etichetta che ha «valore di una precisa designazione di genere»,129 eindica una di quelle lettere fittizie e fantasiose, che già nel 1544 il Donidefiniva, come si è detto, «scritte solamente per dare spasso a chi le leg-gerà».
L’epistola cosí si risolve in un gioco letterario, muovendo da un testo echiosandolo con un pezzo di prosa immaginativa, divagante, ricca di meta-fore scherzose e oscene (inutile sottolineare il senso equivoco della coppiachiave-toppa su cui è giocato tutto il testo). Un’altra lettera al Gottifredi,che si legge nell’edizione delle Lettere del 1547, è costruita col medesimospirito e pare corollario dell’altro suo dialogo, perduto, Dell’amor santo dellemonache: il Doni vi inscena una sorta di dialogo con una suora che, Aretinodocet, rivela lo spirito di una mezzana.130 Il genere epistolare è pertanto pie-gato agli usi piú svariati e i risultati che ne derivano, visto il comune spirito“piacevole” che ne anima la produzione, possono essere straniati dal loroluogo originario, decontestualizzati dal rapporto con altri testi che pure necondizionarono la genesi, risemantizzati in un contesto diverso e offerti allettore in una silloge. Ma se la varietà comica è caratteristica dominante diquesta raccolta, una sorta di uniformità tematica e ironica è alla base di unulteriore esperimento epistolare doniano di estrema importanza, a nostroavviso, nella storia della lettera faceta: ci riferiamo ai Pistolotti amorosi.131
127. Doni, Tre libri di lettere, cit., pp. 155-61.128. Specchio d’amore, dialogo di m. B. Gottifredi, nel quale alle giovani s’insegna innamorarsi: con
una lettera piacevole del Doni in lode della chiave e la risposta del Gottifredi, Firenze, Doni, 1547. Sipuò leggere in Prose di G. Della Casa e altri trattatisti cinquecenteschi del comportamento, a cura di A.Di Benedetto, Torino, Utet, 1970. Per la figura del Gottifredi si rimanda a R. Scrivano,Bartolomeo Gottifredi trattatista e poeta, in Id., La norma e lo scarto. Proposte per il Cinquecento lette-rario, Roma, Bonacci, 1980, pp. 107-24; in partic., per riassunto e commento del dialogo inquestione, vd. pp. 112-20.
129. Longhi, introduzione a Lettere facete e piacevoli, cit., p. xiii. Il genere che designanocon tanta precisione è quello della poesia burlesca del Cinquecento.
130. Cfr. Scrivano, Bartolomeo Gottifredi trattatista e poeta, cit., p. 113 n. 19.131. È singolare notare che questo testo doniano sia stato rubricato anche dagli esegeti piú
attenti come appartenente alla tipologia “amorosa”. Il fondamentale saggio di Quondam
la lettera faceta nel cinquecento
241
Per inquadrare correttamente quest’opera, è indispensabile una premes-sa sul sottogenere amoroso, immediatamente autonomo come articolazio-ne specialistica dell’epistolografia cinquecentesca. A differenza dei primiepistolari contenenti facete, l’appartenenza generica di queste sillogi è im-mediatamente identificabile sin dal frontespizio che le presenta come “amo-rose”. Dimostrare il carattere fittizio e artificiale di queste lettere non èneppure necessario; esse infatti si rifanno non alla tradizione della “fami-liare”, ma al genere lirico, «con tutta la sua formidabile carica modellizzantee la sua tradizione iperformalizzata»,132 riversato in prosa. Pertanto la veri-simiglianza di un rapporto epistolare reale è del tutto subordinata alla vo-lontà di presentarsi come formulario.133 Questi testi hanno la comune ca-ratteristica di proporre un repertorio di situazioni amorose avvalendosi del-la lingua della lirica, inevitabilmente caratterizzata nel proprio ripetitivorepertorio lessicale e topico: si sprecano «strali, ami, esche, fiamme cocen-ti, perpetue fiamme, ardenti faci, prieghi, pianti, amare lagrime, ardentisospiri, acerbissima morte, martiri».134
L’esemplare piú fortunato e diffuso, nonché il primo a presentarsi sulmercato con caratteristiche tipologiche cosí marcate, è quello del Parabo-sco, la cui prima raccolta data al 1545; è di sicuro con questo testo, elabo-rato da un suo conoscente e amico, che il Doni si misura quando decidedi dare alle stampe il primo nucleo dei suoi Pistolotti amorosi: nel 1552,infatti, il primo volume delle Lettere amorose del Parabosco era già statostampato cinque volte da Giolito, il secondo due volte da Gherardo estava per vedere la luce il terzo presso il Griffio.135 Nella dedica a GottardoOccagna che apre il primo volume, il Parabosco motiva e riassume l’in-tento della raccolta quasi come tentativo terapeutico per lenire le soffe-renze prodotte dalla passione amorosa: «sono scritte, come vederete, piú
(Dal “formulario” al “formulario”, cit., p. 97) compie, con disattenzione difficile da riscontrare inaltre parti della sua argomentazione, una svista di questo tipo collocando i Pistolotti amorosi afianco delle raccolte amorose del Parabosco, del Pasqualigo, di Celia Romana. Anche nellostudio della De Nichilo, La lettera e il comico, cit., p. 226, si legge che per esaminare i Pistolottiamorosi è necessario ricorrere non al sottogenere “faceto” ma a quello della lettera d’amore.Grendler (op. cit., pp. 58-59) legge il testo doniano come un mediocre tentativo di emulazionedelle lettere amorose del Parabosco.
132. Quondam, Dal “formulario” al “formulario”, cit., p. 97.133. Cfr. Longo, Letteratura e lettere, cit., p. 11.134. Cfr. Quondam, Dal “formulario” al “formulario”, cit., p. 99.135. Per queste indicazioni si rimanda all’appendice del volume Le “carte messaggiere”, cit.,
p. 306.
gianluca genovese
242
tosto per disacerbare il dolore, che per speranza di muover pietà nell’al-trui cuore».136
L’abbrivo non lascia dubbi sulla matrice petrarchesca, ricalcata senzaintenti polemici o parodici, dell’opera, nella quale la condizione malinco-nico-riflessiva («In tristo humor vo li occhi consumando, / e ’l cor in do-glia»,137 direbbe il poeta) fa aggio sulla componente erotica. La conven-zionalità reiterata dell’equazione amore-dolore resta sempre nell’àmbitodi una prosa geneticamente alta e lontana da qualsivoglia incursione nelterritorio della comicità; le lettere amorose, per dirla con le parole delSansovino che ne curò una fortunata raccolta, sono «piene di sospiri, et diconcetti molto vaghi».138
Come ogni genere, anche quello amoroso funziona come modello con-cettuale e alcune opere canoniche strutturano il paradigma mentale di chivi si cimenta;139 ma ci sono altresí opere «la cui origine è controgenerica»,140
e i Pistolotti amorosi del Doni stanno alla tradizione della lettera amorosacome il Don Chisciotte sta all’Amadigi di Gaula. Non sospiri, concetti vaghi,dolore da disacerbare, ma «inventario delle masseritie d’amore […], nelquale si vede quanto l’huomo si inalberi fuori di proposito».141 Il Doniavverte i lettori di aver preso, per la materia trattata già da tanti autori, «unaltro spolverizzo»; suo scopo non è né fornire un modello di scritturaamorosa da imitare né consolare chi soffre le pene d’amore, ma, con luci-dità erasmiana, far «conoscere apertamente quante son le pazzie che noi
136. G. Parabosco, Lettere amorose (leggo dall’ed. veneziana del 1581 di D. Farri, che racco-glie i quattro libri), libro i c. 1v. Appena necessario rimandare all’utilizzo di precisi luoghipetrarcheschi (cfr. RVF, xxxiii 4).
137. F. Petrarca, RVF, ccxvi 5-6. Citiamo un solo passaggio da una lettera del Parabosco(libro i c. 8v) che ben esemplifica il tenore dell’intera raccolta: «Qui mi potreste veder tuttodí lagrimando et sospirando far per pietà de’ crudi martiri romper le pietre, qui mille volte ilgiorno m’udireste chiamar morte et altamente vinto dal dolore credendomi morir chiedervil’estrema licenza. Ma poi che del mio error avveduto mi sono, di nuovo pure all’usato piantoritorno, il qual con sí larga vena fuor di quest’occhi dolenti piove, che se la lontananza di voinon mi ricordasse ogn’ora me essere quello infelice ch’io sono, io havrei forse tregua talhoracoi miei dolori, porgendovi la speranza d’esser un vivo fonte […]».
138. Delle lettere amorose di diversi huomini illustri libri nove (la prima edizione fu stampata dalveneziano Giorgio De’ Cavalli nel 1565).
139. Cfr. il capitolo dedicato ai generi in C. Guillén, L’uno e il molteplice. Introduzione allaletteratura comparata, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 153-97.
140. Ivi, p. 160.141. A.F. Doni, Tre libri di Pistolotti amorosi, Venezia, Giolito, 1558. La citazione si legge in
apertura del sommario.
la lettera faceta nel cinquecento
243
facciamo et diciamo, quando c’inviluppiamo nell’amore».142 L’intento bef-fardo dell’operazione è sottolineato a chiare lettere:
Tra voi e me, che siamo golpi vecchie, non bisogna tanti colori theorici, né troppiviluppi di frappamenti, o mostrarvi lucciole per lanterne, che Amore m’habbiarinvolto nella sua rete, preso con esca et altre trappole da ridersene. Non è egli dafarsi beffe, la mia piacevol madonna, delle baie che questi innamorati scrivono?non è egli da darsi spasso anchora di questi cervelli d’oche, che se lo credono, et sene tengono le belle e le buone? Chi scrive loro che è diventato come un passero inun tetto, chi dice che voi siete fiere, hermellini, serpenti rivolgendola et rimestandolacon braverie, con parole melate, mostrandosi lione et pecora in un tratto.143
O che amanti capocchi son costoro, ne vero madonna? a dirvi in tanti pistolottibella, nobile, giovane, gratiosa, divina, soave, delicata et dolce. Chi vi paragona allabella Faustina, chi vi dipinge i denti d’avorio et il viso di rose, chi vi forma inparadiso et chi vi tiene per una Dea in terra. O che capocchi amanti; voi, la miacolomba vestita di seta bigia, non vi intenerite alquanto lo stomaco, udendo que-ste, o leggendo simili capocchierie?144
E quando il Doni compone, mostrandosi capace di farlo, una lettera amo-rosa con tutti i crismi del genere, ne rovescia dall’esterno il significatopresentandone l’argomento nel sommario come dimostrazione de «le scioc-chezze che dicono gli amanti per acquistarsi la gratia dell’amato: creden-dosi dir bene».145 E la polemica investe, come sempre nel Cinquecento,insieme contenuti e livello stilistico:
Noi habbiamo certi poeti antichi Madonna nobilissima; i quali s’hebbono a intrin-sicare, o per dir meglio a incorporarsi anchor loro con donne; et ècci openionehoggi, che nessun di noi altri sappi dir nulla da sé, se egli non favella con la bocca diquei dotti et vecchi, cosí cicalando d’amore come ragionando d’ogni altra materia.146
L’intento demistificatorio e faceto di questi pistolotti risulta scoperto se sianalizzano i riferimenti letterari a cui si rifanno: antipetrarchismo, comedetto, e, come si diceva sopra per l’altra produzione faceta degli epistolografidel Cinquecento, legame con la letteratura burlesca che vede capofila ilBerni. Tangibile è l’ispirazione che il Doni trae, ad esempio, dal celebresonetto bernesco, parodistico in contrapposizione all’idealizzazione petrar-
142. Ivi, c. 5r.143. Ivi, c. 27r.144. Ivi, c. 68v.145. Ivi, cc. 13v-14v.146. Ivi, c. 30r.
gianluca genovese
244
chesca assunta dal canone bembiano, Chiome d’argento fino, irte e attorte,147
con in piú, probabilmente, la suggestione proveniente dal tema, di largafortuna in Italia e in Francia, della descrizione anatomica della bellezzamuliebre (anche questa rovesciata nel suo opposto);148 tema già presente inPetrarca, Boccaccio e nei poeti cortigiani ma trasformato da BaldassarreOlimpo da Sassoferrato in Leitmotiv che ispira integralmente la vena poeti-ca. I suoi canzonieri, non a caso spesso intitolati col nome di una donna(Olimpia, Ardelia, Camilla) si propongono, come si legge nel frontespiziodella Gloria (1520), di lodare «una donna dal capo insino alli pedi in ognimembro»; composti tra il 1520 e il 1525, conobbero numerosissime ristam-pe (ne sono state contate 129).149
Col sonetto del Berni sopra citato si confronti quello, in realtà menoincisivo, che il Doni fa seguire a un suo pistolotto, dicendosi desideroso chela destinataria, della quale si dichiara servitore e debitore della propria venapoetica, «legga una scampanata» da lui fatta «in Parnaso» in suo onore:
Cretia con verità posso ben direne l’adocchiarti tutta:mai non vidi a miei dí cosa piú brutta.Portate pinta la disgratia in volto,che pare a tutte proveil ceffo d’un hebreo vecchio sepolto.Il tristo humor, che da vostri occhi piove,faria stomaco a cani;havete poi le maniricamate di crocciole et di rogna.Puzzate tutta come una carogna:onde con verità posso ben direne l’adocchiarti tutta:mai non vidi a miei dí cosa piú brutta.150
147. F. Berni, Rime burlesche, a cura di G. Bàrberi Squarotti, Milano, Rizzoli, 1991, p. 103.148. Sul “canone delle bellezze” (definito come il «procedimento descrittivo che rende in
letteratura la bellezza fisica, principalmente femminile») e sul suo contrario, destinato a ungenere di letteratura bassa, comica, cfr. G. Pozzi, Il ritratto della donna nella poesia d’inizioCinquecento e la pittura di Giorgione e Nota additiva alla “descriptio puellae”, in Id., Sull’orlo delvisibile parlare, Milano, Adelphi, 1993, risp. pp. 145-71 e 173-84. Dello stesso vd. anche, sullastereotipizzazione delle metafore assunte per l’elogio del corpo bello e sul riflesso che que-sta ha sul ritratto della donna brutta, Temi, tovpoi, stereotipi, in Letteratura italiana, cit., iii. Leforme del testo. Teoria e poesia, Torino, Einaudi, 1994, pp. 391-436.
149. Cfr. F. Erspamer, La lirica. Il primo Cinquecento, in Manuale di letteratura italiana. Storiaper generi e problemi, cit., vol. ii pp. 187-88.
150. Doni, Tre libri di pistolotti, cit., c. 64v.
la lettera faceta nel cinquecento
245
Nelle Amorose del Parabosco convivono, all’insegna del discorso amoro-so, componimenti prosastici e poetici, e la parodia del Doni investe en-trambi. Che il sonetto appena riportato sia una risposta alle stucchevolezzedegli epigoni del Petrarca è esplicitamente detto dall’autore nella letterache lo contiene (lettera che è anch’essa un esemplare in prosa di lode delladonna brutta, secondo la tradizione a cui sopra ci riferivamo):
Dilettami sommamente, che tu non habbia huopo d’adoperare unguenti et lisciper il viso, et sveglierti stecco nessuno per la persona con mollette, orpimenti orasoietti. O come mi gusta che non ti sia mestiero impiastrarti le poppe rancide,molli et pendenti, a uso d’una cagna ben ben vecchiotta. Tu inciti pur il desideriomio con quella voce tremante, et sovente ti veggo in compagnia di giovani; in talmaniera ch’io mi raddolcisco di quei bei ragionamenti, incaciandomi tutti i mac-cheroni della fantasia i melati sonettini et le letterine amorose che tu scacazzispesso, talmente che per risposta di quelle mi vien voglia di farti una zufolatad’arpe di piedi, con uno strambotto alla sprofondata, et strangolarmi col ragghiarforte un madrigalino.151
Come nei Tre libri di lettere, il collegamento con la tradizione faceta eburlesca si concretizza col rifarsi da un lato all’eredità lucianea (nei Pistolottidel 1552 Doni inserisce un dialogo pseudolucianeo) e dall’altro al “canone”faceto costituito dall’asse Burchiello – commentato dal Doni, in un’edizio-ne marcoliniana del 1553 – Berni-Aretino, che vuol dire in primo luogosfruttare l’equivocità e la polisemanticità della lingua per costruire testi neiquali ogni parola veicola almeno due significati, il primo “normale”, il se-condo travestito e caricato di valenza fortemente oscena.152
Diamo un esempio, forse il piú facilmente percepibile per un lettoremoderno (mentre in altri casi è piú ardua la decifrazione del codice lingui-stico che anche da un fiorentino del Cinquecento richiedeva «strumentipercettivi molto stratificati»),153 di testo inserito in una lettera e presentatocome «parlar coperto». Si tratta di un lungo indovinello dall’evidente dop-pio senso osceno, di cui riportiamo uno stralcio:
151. Ivi, c. 63v.152. Cfr. l’Introduzione di V. Giri agli Humori in A.F. Doni, Humori e sentenze, a cura di V.
Giri e G. Masi, Presentaz. di R. Bragantini, Roma, Salerno Editrice, 1988, pp. 24-26. NeiPistolotti si ritrovano testi già presenti negli Humori, con le lodi fortemente equivoche delleForbici e del Fuso e della rocca (di quest’ultimo l’autore offre, oltre a un’ampliata riproposizionedel testo in rima, anche una versione in prosa). Per il dettagliato commento storico e lingui-stico a questi tre “humori-pistolotti” si rinvia alle note della Giri.
153. Ivi, p. 24.
gianluca genovese
246
Qual cosa è qui fra voi Donne et Donzelled’entrata senza uscita;larga come sarebbon cinque dita?Non è cosa nessuna che s’usi piú che i guanti, onde ciascuno gli ha quasi di conti-nuo in mano, et non si può dichiarar meglio, né con parole piú appropriate.Di dentro ha molte celle,ove albergarsi ha usanzacosa, che tengo anch’io; senza la qualeil mestier di tal cosa nulla vale.Veramente che il guanto non essendo portato non è buono a cosa d’alcun valore, etsono i guanti, fodrati di pelle, di veluto, son pelosi di fuori anchora, come udirete.Chi l’ha con pel, chi sanza,d’entrata lunga e stretta;ma divien larga et tonda,quanto piú et manco abondala grossezza di quel, che in sé ricetta.Secondo la grossezza della mano s’allarga il guanto, et cosí delle dita, diventandotondi et lunghi come la forma […].154
Pare pertanto difficile da contestare l’appartenenza dei Pistolotti amorosi alsottogenere faceto, con i suoi referenti letterari, i suoi idoli polemici (ilpetrarchismo di maniera, la pedanteria anche qui attaccata con l’arma piúefficace: la messa in ridicolo),155 i suoi espedienti comici (primo tra tutti ilrovescio materiale, carnale, di ciò che i generi alti idealizzano). La naturacompiuta di libro, già attestata per il sottogenere amoroso che è genetica-mente appartenente all’epistolografia fittizia, si dilata nei Pistolotti: e, comegià nelle Lettere, possiamo imbatterci in novelle, dialoghi, sottoinsiemi dilettere che si richiamano; se nel Parabosco la varietà di forme era accomu-nata dal tema amoroso e dal linguaggio ad esso deputato, nel Doni, per con-verso, tali componenti sono accostate dall’intento demistificatorio e antige-nerico rispetto a quella tradizione.
Ci imbatteremo cosí in una novella che smaschera il falso amore degliamici156 (che finché credono morto il loro amico si dicono disposti a paga-re qualsiasi somma pur di rivederlo vivo; quando si rivela vivo ma finge diessere trattenuto in prigione per debiti e richiede il loro aiuto, «questo equell’amico, che si lavava la bocca di favellare a decine di scudi, quandosapeva esser morto, perché era impossibil che risuscitasse», non scuciono
154. Doni, Tre libri di Pistolotti amorosi, cit., cc. 75v-76r.155. Si confronti la Lettera per un pedante innamorato, ivi, c. 50r-v.156. Ivi, cc. 40v-42v.
la lettera faceta nel cinquecento
247
nemmeno un giulio); in un dialogo tra l’Amore e la Pazzia, nel quale, Era-smo docet, la Pazzia si dice madre dell’Amore;157 in prose e versi volutamentegoffi e pedanti ai quali si finge replichi un’amante stomacata, la quale ri-tiene di dover fornire un esempio di come si fanno le lettere, e che si vederispondere di non esser tanto bella «da far tante novelle».158
Di sicuro, a testimonianza dell’intento d’autore nel costruire e presenta-re questo libro di lettere, nulla vale piú di questa dichiarazione tratta dauna delle epistole che lo compongono:
Tuttavia la signoria vostra, la signoria vostra, la signoria vostra vedrete, come io hopoetato a corr’huomo per sghignazzarmi del mondo, et burlare gli scatolini d’amore,i quali non sanno uscire di quinci et quindi, madonna per il cui aspetto et similialtre ciabatterie hoggimai piú fruste che non son le cappe de poeti […].159
«Per sghignazzarmi del mondo»: formula icastica quant’altre mai, che rias-sume appieno lo spirito dell’epistolografia faceta e di uno dei suoi inter-preti piú significativi; dopo il ghigno doniano la storia di questa articola-zione dell’epistolografia cinquecentesca correrà su un binario suo proprio,con gli esiti specialistici e settoriali presi a modello dagli autori successivi,anche in quello che è da considerare il testo piú originale ed esemplare diquesta linea: le Lettere di Andrea Calmo.160
6. Vero best seller all’interno della variegata offerta editoriale veneziana(si contano ventiquattro edizioni del primo libro, ventuno del secondo,venti del terzo e otto del quarto, lungo un arco cronologico che va dal 1547al 1610),161 l’opera del Calmo è poco nota a causa della marginalità derivan-te dalla scelta di usare il veneziano, scelta dettata da precisi moventi cultu-rali e ideologici, che situano la raccolta sul versante della reazione ai detta-mi del Bembo e la collegano al vivace cenacolo letterario gravitante attor-
157. Ivi, cc. 59r-60v.158. Ivi, cc. 46r-50r.159. Ivi, c. 87r.160. A. Calmo, Le lettere riprodotte sulle stampe migliori con introduzione ed illustrazioni di V.
Rossi, Torino, Loescher, 1888. L’originalità della raccolta del Calmo è sottolineata anchenella prefazione di G.G. Ferrero alle Lettere del Cinquecento, Torino, Utet, 1967, p. 21 n. 1:«Una collocazione a parte vogliono le lettere fittizie, in dialetto veneziano, di Andrea Cal-mo, commediografo e attore popolare; che riescono interessanti sopra tutto per chi ricerchila vita e le tradizioni del popolo, per chi raccolga motti, proverbi, riboboli, voci del gergo,faceti travestimenti del linguaggio comune».
161. Per questi dati si rimanda a Le “carte messaggiere”, cit., pp. 291-92.
gianluca genovese
248
no alla famiglia Venier.162 Attore e commediografo di professione, estraneoalla classe dirigente,163 considerato, se non il padre, uno dei maggiori pre-cursori della Commedia dell’Arte, stilisticamente in bilico tra estremo ma-nierismo e fermenti prebarocchi, il Calmo dà vita con la sua opera episto-lografica a un unicum nel panorama letterario del XVI secolo.
Il miscuglio linguistico formato da veneziano antico, latino maccheroni-co, parlata di Burano e inserti di altri dialetti ricorda, mutatis mutandis, la«lingua di Polifilo».164 Se protagonista principale delle sue commedie è ilvecchio borghese, diretto discendente del senex del teatro latino165 e tra iprimi esempi di maschera (c’è chi parla di «proto-Pantalone»),166 figuracentrale nelle Lettere è il pescatore che indirizza, con finzione squisitamen-te letteraria, a destinatari illustri o fittizi, delle «fantastiche fantasie».
Il gioco d’identificazione e sovrapposizione della figura dell’autore conquella dell’immaginario mittente si spinge al punto che il primo si compia-ce di descriversi come appartenente per nascita al mondo umile dei pesca-tori e dei barcaiuoli dell’estuario, mentre indagini documentarie mostranola sua appartenenza a un ceto medio borghese dalle condizioni economi-che e culturali notevolmente diverse.167 Se ciò non bastasse, il carattereprogrammaticamente fittizio delle Lettere si evince dal loro uso (o riuso)teatrale, non solo da parte del Calmo e di altri autori contemporanei o dipoco posteriori, ma anche nella storia del nascente teatro dell’arte, nelquale furono impiegate come opera di repertorio dalla quale attingere mo-nologhi, concetti e battute per gli intrecci comici a soggetto.168 Ma già
162. Cfr. la diffusa analisi di A. De Nichilo, Le lettere di Andrea Calmo e la civiltà venezianadel Rinascimento, in «FM. Annali dell’Ist. di Filologia mod. dell’Univ. di Roma», Roma, Edi-
ter, 1977, pp. 61-83.163. Per l’incerta ricostruzione della biografia del Calmo si rimanda alla “voce” compilata
da L. Zorzi nel Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Ist. della Enciclopedia Italiana, vol.xvi 1973, pp. 775-81.
164. L’espressione «parole di Polifilo», ricorda S.S. Nigro in Le brache di San Griffone.Novellistica e predicazione tra ’400 e ’500, Roma-Bari, Laterza, 19892, p. 88, « si usava nel Cinque-cento per indicare astrusità linguistiche». Il riferimento è, ovviamente, a quello straordinariotesto aldino stampato nel 1499 che è l’Hypnerotomachia Poliphili di F. Colonna, leggibile inrist. an. a cura di G. Pozzi e L.A. Ciapponi, Padova, Antenore, 1964.
165. Cfr. la raccolta di testi curata da A. Traina, Comoedia. Antologia della Palliata, Padova,Cedam, 19974.
166. Cfr. la “voce” cit. di Zorzi, p. 777.167. Ivi, p. 776.168. « In uno dei prologhi di Domenico Bruni, ad esempio, la servetta della commedia,
che finge di essere anche la serva dei suoi compagni di lavoro, enumera una serie di opere
la lettera faceta nel cinquecento
249
basterebbe citare le diciture dei frontespizi delle quattro raccolte per eviden-ziare una consapevolezza, sia sul versante della produzione che su quellodell’offerta sul mercato (e quindi della ricezione), che va ben al di là diquelle sinora citate. Le raccolte dell’Aretino si qualificano semplicementecome Libro de le lettere preceduto dal numero ordinale, Franco preferisce ladicitura, piú marcata ma altrettanto vaga, di Pistole vulgari e lo stesso Doniutilizza un generico Tre libri di lettere.169
Le quattro raccolte del Calmo si presentano, invece, come I piacevoli etingegniosi discorsi in piú lettere composti, Il rimanente de le piacevoli et ingenioselittere, Supplimento delle piacevoli, ingeniose et argutissime lettere, e infine Il residuodelle lettere facete et piacevolissime amorose indirizzate a diverse donne le cui primeedizioni sono rispettivamente del 1547, 1548, 1552, 1566.170 «Piacevoli», « in-gegnose», «argutissime», «facete»: l’uso degli aggettivi non potrebbe esse-re piú indicativo di un genere ai limiti dell’epistolografia tradizionalmenteintesa (non a caso per il primo libro si parla di «discorsi» composti in formadi lettera), che si colloca all’interno di una tradizione ben avviata ma nonancora del tutto autonoma: il debito nei confronti dell’Aretino e del Doni171
è saldato nella «Lettera di chiusa» del terzo libro,172 nella quale entrambivengono citati all’interno di una carrellata di autori estremamente signifi-cativi per la genesi dell’opera calmiana:
e’ son cautissimo che no ve desdegneré de favorirme e dar un pretioso, eternofomento a le mie opere, honorando sempre mai i Dantii, i Verzilii, i Petrarchi, iOvidii, i Boccazzi, i Sanazari, i Bembi, i Tolomei, i Camilli, i Alamanni, i Aretini,i Dolci, i Trissini, i Bevazzani, i Dominichi, i Danieli, i Plauti, i Ariosti, i Terentii,i Machiavelli, i Zanoti, i Molci, i Tibaldei, i Speroni, i Fortunii, i Corsi, i Venieri, equel da la Casa, e con l’armonia dei Paraboschi e d’i piasevoli Intronai, con i Donie cetera quem virtutis.
usate dai comici per le loro improvvisazioni e “tirate” (la Fiammetta del Boccaccio, Le bravuredel Capitano Spavento, la Celestina, finanche Platone), assegnando a Pantalone le Lettere delCalmo» (ivi, p. 777).
169. Spunti interessanti, anche se non orientati sul versante comico d’autore della produ-zione epistolare cinquecentesca, sono nello studio di F.R. De’ Angelis, Per un’analisi delsistema di titolazione delle raccolte antologiche di lettere cinquecentesche, in Le “carte messaggiere”, cit., pp.203-11.
170. Un elenco completo delle stampe è in G. Martucci, Andrea Calmo comico venezianoe le lettere piacevoli e facete, in «La Rassegna nazionale», 16 sett. 1887, pp. 335-44, e nell’ed.Rossi cit.
171. Per l’influenza del Doni sul Calmo, cfr. De Nichilo, Le lettere di Andrea Calmo, cit.,p. 70.
172. Calmo, Le lettere, cit., p. 249.
gianluca genovese
250
Se la figura del pescatore non è in sé comica ma ha la funzione ideologica,comune agli appartenenti del circolo dei Venier, di esaltare l’integrità e lasaggezza della “venezianità” primigenia,173 comico è non solo «lo scopertotravestimento del Calmo, la sua mimesi di un costume sociale “altro”»,174
ma in primo luogo il linguaggio utilizzato per quelli che l’autore stessodefinisce «ingeniosi cheribizzi».
Proviamo a scomporre gli elementi costitutivi di questo linguaggio, co-minciando dall’uso caricaturale del latino maccheronico. Basterebbe ricorda-re la celebre arringa di «Mastro Janotus de Pistolis» nel Gargantua175 (stam-pato solamente quindici anni prima del primo libro delle lettere calmiane),per comprendere come il Leitmotiv dell’antipedantismo trovasse concretarealizzazione non soltanto nella polemica esplicita ma, certamente in mi-sura piú diffusa ed efficace, nella rappresentazione satirica e ironica di unlinguaggio ormai percepito come logoro e frusto. La gustosissima parodiadel latino scolastico operata nel Gargantua ha fisicamente il risultato di farscoppiare a ridere i presenti «cosí convulsamente che ebbero paura di ren-der l’anima a Dio».176 L’uso deformato del latino, specie nel teatro, dove lafigura del “pedante” vive una vita propria nella commedia,177 s’inseriscequindi a buon diritto nell’alveo di una consolidata tradizione comica, per-mettendo inoltre all’autore di inserire quelle «formule proverbiali e popo-lareggianti, ancorate al sano buon senso comune»178 alle quali era moltolegato. L’impiego del veneziano al servizio di un’accesa fantasia linguisticacontribuisce poi a creare un insolito effetto straniante nel lettore catturatoin una fitta rete di periodi che preferiscono l’accumulazione alla logicitàdei nessi, nei quali la parola viene scelta spesso piú per l’immagine cheriesce a evocare e per le sue qualità fonetiche che per la pregnanza seman-tica; periodi ricchi di metafore ardite che fanno pensare a un barocco antelitteram emergente all’interno dello stesso manierismo spinto qui alle sueconseguenze estreme.
Caratteristica piú significativa del linguaggio calmiano è dunque l’origi-nale impasto plurilinguistico. Sul piano dei contenuti ritroviamo ancora
173. Cfr. De Nichilo, Le lettere di Andrea Calmo, cit., pp. 66-67.174. Ivi, p. 67.175. F. Rabelais, Gargantua e Pantagruele, a cura di M. Bonfantini, Torino, Einaudi, 1993,
libro i cap. xix, pp. 60-62.176. Ivi, p. 63.177. Sulla figura del pedante nel teatro cinquecentesco, cfr. A. Stäuble, «Parlar per lettera».
Il pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul teatro rinascimentale, Roma, Bulzoni, 1991.178. De Nichilo, Le lettere di Andrea Calmo, cit., p. 69.
la lettera faceta nel cinquecento
251
una volta, e non solo nel quarto libro, che mima il sottogenere “amoroso”ma lo nega all’istante eleggendo a destinatarie note meretrici veneziane, iltópos del vecchio innamorato: non potrebbe essere diversamente, vista lacommistione lettere-commedie a cui abbiamo già accennato. In virtú diquest’ultima molte sono le epistole che stanno al confine col monologocomico o che fanno riferimento ad altri personaggi tipici dell’universo dellacommedia (il “proto-Pantalone” o anche il plautino miles gloriosus). A que-ste si unisce spesso la degradazione del mito, di sicura presa comica per illettore rinascimentale. Citare direttamente un passo tratto da una lettera ècerto piú indicativo di tanti commenti:
Che credeu, caro cusin, che sia i calighi? non è altro ca i suori che ghe inse da dossoda tanto strucolar quella grama de Venere, Cintia e Titon; e la tempesta è la speranzaconzelà che vien d’alto a basso; Vulcan meschin, che no puol contradir a sti mazorenti,che falo? el sta in la fusina a revetene, e co la ghe vien ben fatta descarga coete perruinarli del mondo; mo la dietae de missier Giove che sa ogni cosa, rebate fa dar inteicampanieli, in le noghere e in qua e in là; nu gofi le chiamemo siete, tamen la xe cove digo mi; inteso per la via de la val de Iosafat, da un che vendeva vuove del cortivode Cerere. Sí che per torner a proposito assae cose se iudica a un muodo che,metandole può in riegola le reinse per aliam viam; mi e’ ve voio ben dire la miaopinion, che cusí co quei savii giera privi de la luse cristiana, cusí anche i s’ha governaoda murloni. Vardè, per vostra fè, che sorte de triangolari, de sferichi e de contempla-tivi giera quei fabricaori del corso celeste, Egiptii, Arabi e Greci a meter a governarcusí bela ombrela da un Giove banchier, Mercurio zaratan, Marte cao de varda,Venere pissota, Saturno herbariol, Luna agiazzà e Febo pastor, con dodese colegamissiai, bestie, porci, puti, strasinai da cavalli infuogai, da serpenti, d’alochi, da paoni,da liocorni, da gali e sora marcao co un feva qualche bela ponta i ’l meteva intelcatalogo d’i Dei, e si giera tal peochioso nassuo infra cento piegore; e tamen nissunda quella volta in qua no gh’è bastà l’anemo da radrezar le cose. Assegneghe le rason:i ve risponde: « l’è tanti anni, che negun no ha dito niente, nianche nu no volemodir», de sorte che l’anderà ad infinito; e ve esorto, e si farò cusí anche mi; za che tantiha tasesto, sofrimo de lassarla passar, sicut placuit ad Dominum; se puol considerarper certo star vigilanti de no aver el zuogo marzo e no se lagar veder le carte alcompagno, viver infina che i dà zoso de la mazza de l’incanto e sotrar i fastidii con ladolcezza de la compagnia segurando i so anni con la borsa de la prudentia; temer itristi e far apiaser a i boni, cusinando la carne in pignate invernicae e sora el tuttovardeve che ’l pandol no ve sequestra el vostro tempo futuro; ita est.179
Questa lettera è firmata «Cavanelo d’i Stringai da Grao, remo de la vostrapescaressa» ed è indirizzata a Domenico Marcello. Oltre a esemplificare
179. Calmo, Lettere, cit., pp. 175-76. Per un’analisi diffusa ed integrale di questa lettera sirinvia a De Nichilo, Le lettere di Andrea Calmo, cit., pp. 80-83.
gianluca genovese
252
le caratteristiche stilistiche e di contenuto sopra esaminate, sarebbe suffi-ciente soffermarsi sulla firma per intuire la portata rivoluzionaria dell’ope-razione del Calmo. Infatti tutti gli autori sinora citati possono sí situarsisul versante della “letterarietà”, si spingono sino a infrangere esplicita-mente il codice di un genere destinato alla comunicazione tra interlocu-tori reali immettendovi destinatari dichiaratamente fittizi (come la « lu-cerna» del Franco), ma non toccano mai il polo comunicativo piú forte eidentificabile: quello del mittente, di colui che assume in prima persona laresponsabilità della produzione del testo e del “patto”180 col lettore. Larispettata coincidenza tra l’autore inteso come persona fisica e l’autore cheproduce il testo firmandolo col proprio nome contribuisce a creare nelfruitore almeno l’illusione di leggere un epistolario che sia testimonianzadocumentaria di episodi biografici, magari frammista a lettere di fantasia,ma comunque all’interno di un ben consolidato schema che prevede quellacoincidenza. Far saltare l’identità autore-mittente significa rompere defi-nitivamente l’apparente coerenza del genere lettera per portarlo a diveni-re qualcosa d’altro; è in questo preciso istante che un genere già contami-nato da esperimenti precedenti lascia il posto a un genere diverso che siserve del primo come di una forma vuota; di qui può partire la consape-volezza (lo ripetiamo, tanto sul versante della produzione che su quellodella ricezione) che giustifica, in epistolari quali quello del Marino, lapresenza di una sezione specifica dedicata a un genere che può non ri-chiedere nessun tipo di appiglio con la realtà fisica dei corrispondenti (la«pupola» può scrivere al «pupolo» e può ricevere risposta), in quanto siconcentra esclusivamente sullo sperimentalismo linguistico e sugli espe-dienti comici.
7. La consacrazione della lettera faceta, che ha in Calmo il suo piú origi-nale esponente “specialistico”, ha riscontro, oltre che in imitazioni di me-diocre fattura (penso in primo luogo alle Lettere facete e chiribizzose in lenguaantiga venitiana di Vincenzo Belando),181 in un testo piú tardo che si presen-ta anch’esso fin dal frontespizio come settoriale: le Argute et facete lettere diCesare Rao.182 Un dato significativo riguarda la diffusione di queste lettere:
180. Intendo qui il termine patto nell’accezione consolidatasi negli studi critici a seguitodello studio sull’autobiografia di Ph. Lejeune, Il patto autobiografico, trad. it. Bologna, Il Mu-lino, 1986.
181. Cfr. Rossi, Introduzione a Calmo, Le lettere, cit., pp. cxxv-cxxvi.182. Una nota biografica e bibliografica, ma con pochi riferimenti al testo in questione, è
di N. Vacca, Cesare Rao da Alessano detto il «Valocerca», in «Archivio storico pugliese», a. i
la lettera faceta nel cinquecento
253
nonostante fossero il prodotto di un letterato ai margini della società cultu-rale ed editoriale del tempo (nato ad Alessano, in terra d’Otranto, viaggiòmolto da un centro all’altro del Nord in cerca di fortuna e pubblicò aBrescia la prima edizione delle lettere nel 1562), e non si distinguesserocerto per originalità, le Argute et facete lettere ebbero ben diciotto edizioni,ultima delle quali nel 1622, in città quali Pavia, Trento, Vicenza e, in ulti-mo, Venezia.
Questo dato ben testimonia la vitalità di un genere dall’ampio favore dipubblico e dalla consolidata presenza, se accostato alle numerose ristampedegli epistolari del Calmo e alla quasi sincrona uscita delle Lettere facete epiacevoli curate dall’Atanagi nel 1561. Ancor piú interessante dell’analisi te-stuale183 è la serie di riferimenti citati dal Rao in una lettera attribuita aMercurio come «scongiuratione per far fuggire tutte le mordaci lingued’una città».184 Nella lunghissima enumerazione di soggetti sui quali Mer-curio “scongiura” si fa strada via via, a mo’ di compendio che legittimiquanto sinora si è tentato di ricostruire, un fitto reticolo di rimandi che aposteriori crea una sorta di canone di autori moderni ed elettivi del generepraticato. Si citano «la statova di Pasquino» e «l’Asino d’oro d’Apuleio», le«novelle del Boccaccio» e «li ghiribizzi del Calmo», «lo cervello accotonatodel Doni», «la facil vena di versificar del Bernia» e «lo spirito e intellettodell’Aretino». Senza contare un vero e proprio catalogo di temi da reper-torio della comicità sfruttati, come abbiamo visto, dalla lettera faceta:«l’ostinatione delle donne», «le robbarie de’ Dottori», «l’avarizia de’ vec-chi», «le simulationi delle cortigiane», «l’insidie», «gli uccellamenti», « lebeffe»; e si potrebbe a lungo continuare.
Proprio la mancanza di originalità spesso imputata al Rao,185 che sac-cheggia, fino al plagio, le opere del Doni,186 riutilizza materiale di chiaraascendenza bernesca, calmiana, aretiniana (non necessariamente occultan-done la provenienza o l’ispirazione: è presente un gruppo di lettere attri-buite a Pasquino e una che si finge essergli stata indirizzata dal Berni), è di
1948, fasc. 1 pp. 1-48. Per il testo delle Argute et facete lettere ci serviamo dell’ed. stampata aVicenza nel 1596 presso gli Heredi di Perin Libraro.
183. Diffusa e relativa agli snodi fondamentali l’analisi della De Nichilo, La lettera e ilcomico, cit., pp. 227-30.
184. L’argomento della lettera si legge nel « sommario di tutta l’opera», posto immediata-mente dopo la dedica «alli discreti lettori».
185. Cfr. De Nichilo, La lettera e il comico, cit., p. 227.186. Il primo a evidenziare i numerosi plagi di Rao dall’opera doniana fu Grendler, op.
cit., pp. 202-4.
gianluca genovese
254
grande utilità per chi voglia avere sotto gli occhi un esemplare frutto del-l’assimilazione, magari pedissequa ma cristallizzata in tutte le sue variecomponenti, di una tradizione ormai consolidata e che anzi è già sulla viadel declino; non tanto per la saturazione di temi e forme, quanto per larigidità della precettistica controriformistica – si ricordi quanto si dicevasopra a proposito del secondo volume delle Lettere facete e piacevoli o dellelettere burlesche del Marino – che contrasta con la licenziosità, la satira,l’arguzia gratuita, tutti gli ingredienti insomma che affollano il calderonecomico dell’autore di lettere facete.
Il Rao, con evidente fiuto commerciale, sintetizza dunque le compo-nenti di un genere molto gradito e, sulla via ormai aperta dal Calmo, offreun testo che non ha nessun’ansia di verosimiglianza sul piano delle codifi-cate convenzioni epistolari. Se il Calmo, pur facendo saltare l’identità auto-re-mittente, offre un campionario tutto sommato omogeneo (chi scrive è,nella finzione, in ogni caso un pescatore della laguna), il Rao sfalda allabase ogni parvenza di organicità, accostando pezzi in sé conclusi e autono-mi che si costituiscono in forma di libro esclusivamente in virtú di unamedesima appartenenza generica.
Proviamo a scorrere il sommario.187 Le lettere si succedono senza alcuncriterio tassonomico. Ci sono lettere che l’autore si attribuisce, ma il cuiargomento dichiara inequivocabilmente il carattere fittizio e costruito, percosí dire, a tavolino, dell’esercizio (quali, ad esempio, le lettere «Al SignorMesser Martino da la Valle, comparationi disuguali e lodi biasimevoli datea lui per farlo scorger matto publico con certi sconsigliati consigli» o «AlSig. Giovan Donato Cittadini giudicio fatto per ischerzo sopra una orazio-ne pedantesca, cosa nuova, rara e fuor dell’ordinario» o, ancora, «Al SignorCesare Aresio, baie severe dette per gratuità»). Altre hanno mittenti e de-stinatari fittizi, con nomi che rimandano ad allusioni oscene («Lettera diMesser Bartolomeo di quella cosa al Sig. Messer Martino Cuglia, la qual fastomacare e ridere chi la legge a tempo»), a personaggi del mito degradati(«Proserpina reina dell’Inferno alle Cortigiane del mondo») o sfruttano,come nel gruppo delle lettere attribuite a Pasquino (una per tutte: «Mali-gna et arguta congratulatione di Pasquino al Sig. Frondola per farlo ricade-re nella medesima o in peggior malatia») la scia di situazioni, autori, perso-naggi già noti.
Ci sono lettere che denunciano un’esercitazione linguistica («Lettera inlingua elegante gratiana»), o rielaborano tópoi burleschi codificati («Oratione
187. L’edizione utilizzata è quella citata alla n. 182.
la lettera faceta nel cinquecento
255
in lode dell’ignoranza», «Al Sig. Cesare Rao, lettera del Lana in lode dellapoltroneria, cosa tanto ingegnosa et bella che per forza tira chiunque lalegge ad amare, abbracciare et riverire essa poltroneria», «Lettera faceta instile burlesco dove si tassa la ignoranza di certi giovani moderni, che pro-cedono nel viver loro spensieratamente», «Lettera capricciosa secondo lostile berniesco, dove sotto metafora di lodar le virtú di costui si riprende esi tassa la costui dotta ignoranza», «Lamento di Giovanni Ganassa […],sopra la morte di un pedocchio», e cosí via).
L’intenzione dell’autore di proporre ai lettori un insieme di testi godibilidal «soave e saporito gusto», come si legge nella dedica iniziale, che richie-dono anche una certa dimestichezza con i testi antesignani del genereburlesco e faceto, perché si possano cogliere e ricostruire i riferimenti con-tinui a essi, si esplica quindi nella giustapposizione di una serie di lettereaccomunate esclusivamente dal loro carattere fittizio e giocoso.
8. Altri autori si richiameranno al genere faceto all’interno dei loro episto-lari per esigenze di varietas, sottraendosi tuttavia «alla specializzazione delgenere “burlesco” e al suo totale distacco dalla lettera familiare».188
Il maggiore tra questi è il Caro.189 Il suo epistolario, edito postumo dopola rinuncia dell’autore, che pur aveva pensato di assemblare una silloge delleproprie lettere,190 solleva interessanti problemi teorici, ben affrontati da An-drea Gareffi, che parla di «epistolario mancato» riferendosi all’assenza del-l’autore e all’assenza di specificità e consapevolezza.191 Ciò che a noi interessarilevare, assumendo il caso del Caro come paradigmatico per una serie diautori che praticano saltuariamente e in maniera non “specialistica” il generefaceto, o, meglio, che scrivono lettere comiche per lo piú «nel senso diun’adesione ad una convenzione ben nota, secondo la quale la lettera si ponecome luogo della chiosa fantastica, fantastica in un senso facile, cinquecente-sco, dell’avvenimento reale»192 (e penserei a Giovio, Tolomei, Contile e allamaggior parte degli autori antologizzati nei due volumi di Lettere facete e
188. Ferroni, Tra lettera familiare e lettera burlesca, cit., p. 53.189. Cfr. G. Ferroni, Lettere e scritti burleschi di Annibal Caro tra il 1532 e il 1542, in «Palatino»,
a. xii 1968, fasc. 4 pp. 374-86, e A. Gareffi, «La lettera uccide, ma lo spirito vivifica» (Paolo, ii Corinzi,3:7). L’epistolario di Annibal Caro: lettere, letteratura, letteralità, in Le “carte messaggiere”, cit., pp. 237-53.
190. Sulle vicende editoriali e sugli interventi dell’autore in merito al progetto di curareun proprio epistolario, vd. l’introduzione di A. Greco ad A. Caro, Lettere familiari, 3 voll.,Firenze, Le Monnier, 1957-1961.
191. Gareffi, «La lettera uccide, ma lo spirito vivifica », cit., p. 252.192. Ivi, p. 248.
gianluca genovese
256
piacevoli), è che anche per questi, che non valicano mai programmaticamentela tipologia “familiare”, le potenzialità del genere epistolare sono ampliateproprio dalla larga presenza e fortuna di sottogeneri autonomi e affermati,dalle caratteristiche tipologiche ben definite e riconoscibili.
Riepilogando quanto sinora è emerso, possiamo tentare di seguire l’evo-luzione della lettera faceta, ricordando che ogni tipo di schematizzazioneha dei limiti e che la semplificazione dei dati in un sistema organico è quasisempre un’astrazione dall’indubbia utilità, ma da prendere cum grano salis.Inizialmente la lettera “piacevole” è priva di una sua autonomia ma sisovrappone e si confonde con la tipologia familiare dalla quale mutua tuttele caratteristiche esterne (è il caso dell’epistolario aretiniano). Successiva-mente alcune di queste caratteristiche possono essere omesse, ad esempioil destinatario può presentarsi non come una persona fisica ma come unsemplice oggetto o una categoria di persone (è quanto avviene nelle Pistolevulgari del Franco). In questo caso, come in quello dei Tre libri di lettere delDoni, la tenuta organica del testo che accosta i vari pezzi fondendoli in unmacrotesto, in un “libro” di lettere, resta comunque garantita dalla onni-presenza, in uno dei poli della comunicazione, dell’autore, che comparesempre o come firmatario delle lettere (vere, verosimili, fittizie) o, moltopiú raramente, come destinatario fittizio (ad esempio nel caso della «Lu-cerna» che risponde al Franco).
Ulteriore passaggio è lo scollamento dell’identità mittente-autore, che sirinviene nelle fortunatissime lettere del Calmo. I due piani sono qui per laprima volta nettamente distinti: da un lato l’autore materiale del testo,dall’altro il personaggio fittizio al quale esso viene attribuito, con le imma-ginabili variazioni che questo comporta sul piano della ricezione. Ancorauna volta però la tenuta organica in forma di “libro” è garantita dall’omo-geneità di temi, linguaggio e classe sociale di appartenenza dei mittentifittizi. Questa tenuta va in frantumi con la raccolta del Rao che preferiscegiustapporre pezzi “arguti e faceti” in sé conclusi e autosufficienti, con pas-so decisivo nella direzione della specializzazione del genere “lettera face-ta”, praticato però sempre meno, perché a causa delle sue componenti nonpuò essere gradito in un clima di generale moralizzazione post-tridentina.193
193. L’etichetta di lettera “faceta”, vista la fortuna del genere, non scompare all’improv-viso, ma viene utilizzata in testi che portano alle estreme conseguenze quella rifunzionaliz-zazione in senso “morale” a cui abbiamo già accennato a proposito del secondo volume diLettere facete raccolte dal Turchi. Nel 1603 Tomaso Buoni pubblicò un volume di Lettere arguteche sono però accompagnate da «molti sali, proverbji, sentenze morali» e che sul frontespiziosi offrono al lettore «per ammaestramento della vita». La definitiva subordinazione del fa-
la lettera faceta nel cinquecento
257
In ogni caso questa raggiunta autonomia formale e tipologica si rinviene inepistolari quali quello mariniano che, suddivisi per “capi”, dedicano unasezione anche alle lettere burlesche o facete, contando sulla consapevolez-za del lettore che sa cosa sta leggendo, perché ormai capace di distinguerele differenze tra i vari sottogeneri ramificatisi all’interno della tradizioneepistolografica volgare.
L’epistolografia come genere avrà ampia fortuna anche in seguito, ma lacommistione romantica di arte e vita non lascerà piú posto a una praticasquisitamente letteraria di sottogeneri dalle caratteristiche dichiaratamentefittizie, e la «lettura ottocentesca degli epistolari d’autore quale materialeausiliario, sorta di para-testo rispetto all’opera della quale costituivano ora uncommento ora una testimonianza genetica»,194 relega la componente lette-raria in secondo piano, per concentrarsi su una lettura che privilegia il «mitodella biografia come racconto o dramma esemplare».195 Il “libro di lettere”come inteso nel Cinquecento non è piú praticato,196 ma lascia un’ereditànella concezione della lettera come genere, di cui l’autore si può impossessareper piegarlo a fini polemici o letterari: è grazie a quest’eredità che possononascere le Lettere provinciali di Pascal e Julie ou la nouvelle Héloïse di Rousseau,vale a dire la lettera aperta di denuncia e il romanzo epistolare. Quanto alleraccolte di lettere “reali”, la consapevolezza del grado estremo di artificiositàdell’epistolario come genere consegnato dalla valanga di testi cinquecente-schi, dai quali ci si vuole distanziare in nome della simbiosi arte-vita, ha lasua piú eloquente testimonianza nella frase topica «questa non è una letterada Epistolario».197 Ed è una frase che si può assumere come epigrafe chesegna irrevocabilmente la fine di un modo di concepire l’epistolografia.
Gianluca Genovese
ceto al morale ha la sua palpabile consacrazione nel volume di Pier Maria Cecchini, stampa-to nel 1618, che si presenta come raccolta, appunto, di Lettere facete e morali. Cfr. Quondam,Dal “formulario” al “formulario”, cit., p. 90.
194. Giammattei, In memoria dello scriver lettere, cit., p. 420.195. Ivi, p. 421.196. Cfr. A. Chemello, Premessa, in Alla lettera, cit., p. x, il quale sottolinea come l’opera-
zione autoriale che nel Cinquecento « fa assumere al “libro di lettere” la fisionomia di vera epropria opera letteraria» si perde in seguito: «Saranno i secoli successivi, soprattutto il Sette-cento e l’Ottocento, a riportare la lettera alla sua funzione di “comunicazione privata”, al suooriginario paradigma di comunicazione in absentia, lontano da occhi indiscreti e restituito aquella intimità e confidenza che ne fa un documento di umanità e il luogo per lo svelamentodi sentimenti reconditi ».
197. Cfr. Giammattei, In memoria dello scriver lettere, cit., p. 419.