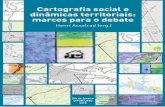Quattrocento morti nel disastro della nave da crociera sovietica
Governo del territorio e cartografia veneta tra Quattrocento e Cinquecento
Transcript of Governo del territorio e cartografia veneta tra Quattrocento e Cinquecento
Verona e il suo territorio nel QuattrocentoStudi sulla carta dell’Almagiàa cura di Stefano Lodi e Gian Maria Varanini
Cierre edizioni
Introduzionedi Marica Milanesi 7
Governo del territorio e cartografia veneta tra Quattrocento e Cinquecentodi Giuliana Mazzi 19
Il territorio veronese, trentino e mantovanodi Gian Maria Varanini, Carlo Andrea Postinger, Isabella Lazzarini 61
Verona: lo spazio urbano e le emergenze ediliziedi Stefano Lodi 111
Raffigurazione e realtà geograficadi Sandra Vantini 143
Alcuni aspetti formalidi Susy Marcon 169
Note linguistichedi Nello Bertoletti 183
Edizione delle didascaliedi Nello Bertoletti 204
Materiali e tecnica esecutiva. Contributi analitici non invasividi Gianluca Poldi 217
Indice
indice6
Nota sui possibili contesti archivisticidi Giovanni Caniato 233
Corrispondenze moderne dei toponimi della carta dell’Almagiàa cura di Stefano Lodi 241
Indice dei nomi di luogoa cura di Stefano Lodi e Gian Maria Varanini 265
Il 27 febbraio 1460 – all’indomani di una definizione dello stato da terra che aveva visto, dopo la pace di Cremona, l’acquisizione di Rovereto, di Ra-venna, di Rimini, di Faenza, di Imola e, dopo la pace di Lodi, la definitiva estensione del dominio fino all’Adda – il Consiglio dei Dieci emanava un decreto1 che imponeva ai rettori della Serenissima la redazione di un corpus
1 Archivio di Stato di Venezia, Consiglio dei Dieci. Misti, reg. 15, c. 198r, 8 (nume-razione a matita), 27 febbraio 1459 (m.v. =1460); proponenti della parte Pietro Moceni-go, Bernardo Giustinian, Marco Donato dottor. «Capta». «Cum de civitatibus castellis et provinciis quae nostro Dominio per Dei gratiam subiectae sunt nemo est in regimine nostro qui, quando de illis locis consulitur, sciat dare particularem informationem de situ eorum, de latitudine et longitudine et de confinis et que domina vicina sunt et qui passus, et si informatio petitur ab aliquibus aliquando et saepe different, quia aut ita putant et ita vellent. Unde pro omni bono respectu providendum est habere in cancellaria nostra aut Camera Consilii nostri Decem in vera pictura formam et esemplum omnium civitatum terrarum castellorum provinciarum et locorum nostrorum, ut quicumque volens consule-re et providere super praedictis habeat veram et particularem noticiam ad oculum et non ad opinionem alicuius.
Vadit pars quod auctoritate huius consilii scribatur et mandetur omnibus Rectoribus civitarum terrarum et castellarum nostrorum quod habito bono et vero consilio a civibus terrae et ab aliis practicis et intelligentibus civitatis aut loci sui, designari faciant terram locum et districtum suum per signa ventorum et orientis et ponentis, castella, flumina, planiciem et distantiam de loco ad locum et loca vicina nobis et distantiam eorum, et illarum designationem ordinate depictam faciant diligenter a doctis et praticis examinari, si bene et recte depicta est; et hoc facto, illam picturam mittere debeant nostro Dominio. De parte 11; de non 2; non sinc 4».
Sul decreto e sui promotori dello stesso, oltre che sulle ricognizioni cartografiche pro-mosse dalla Repubblica nel corso del Quattrocento, cfr. E. Concina, Tempo novo. Venezia e il Quattrocento, Venezia 2006, pp. 35-39 e Id., “In vera pictura”: Venezia, le città del Dominio, il mondo. 1459 “more veneto”, in La vita nei libri. Edizioni illustrate a stampa del Quattro e Cinquecento dalla Fondazione Giorgio Cini, catalogo della mostra, a cura di M. Zorzi, Venezia 2003.
Il documento era già stato pubblicato con imprecisioni e omissioni in Monumenti per
Governo del territorio e cartografia veneta tra Quattrocento e Cinquecento
di Giuliana Mazzi
giuliana mazzi20
cartografico sull’entroterra costituito di carte distinte per singole province, destinato a esser custodito nella «cancellaria nostra [ossia l’archivio dove erano conservati i più importanti documenti amministrativi2] aut Camera Consilii nostri Decem», la sala del Consiglio dei Dieci, sede del massimo organo di governo della Repubblica, deputato alla sicurezza dello Stato.
L’intento sembra esser stato anche quello della possibile esposizione, sia pure riservata ai membri del principale organo di governo. Facile supporre che la registrazione grafica di tutto lo stato da terra sia stata richiesta per poter disporre di un’accurata documentazione («veram et particularem no-ticiam ad oculum et non ad opinionem alicuius») che favorisse la politica in corso volta a impostare controlli articolati sui diversi campi di interesse statale, tra i quali prioritari il problema dei fiumi e il controllo sugli inter-ramenti lagunari e la programmazione della difesa. La pergamena con il “ritratto” del Veronese nota come “carta dell’Almagià”3 sembra la sola po-
servire alla storia del Palazzo Ducale di Venezia, ovvero serie di atti pubblici dal 1253 al 1797, I, Dal 1253 al 1600, a cura di G. Lorenzi, Venezia 1869, doc. 184, p. 82 e in M.L. Scal-vini, G.P. Calza, Bergamo 1516. Città e territorio nella Descriptio di Marcantonio Michiel, Padova 1984, p. 29 nota 21. Ringrazio Elena Svalduz e Stefano Zaggia per aver controllato sugli originali i testi dei documenti del 1460 (m.v. = 1459) e del 1479 (vedi nota 7).
2 Si pensava probabilmente alla Cancelleria Secreta, istituita nel 1402 quando l’uffi-cio fu diviso in Cancelleria propriamente detta (dove erano custoditi gli atti riguardanti l’amministrazione generale ordinaria e la legislazione) e in Cancelleria Secreta, dove erano conservati gli atti ritenuti di carattere riservato. Dall’Indice della Secreta redatto nel 1669 vi risultano del resto conservate le mappe di Cristoforo Sorte (a proposito delle quali si veda più avanti nel testo). Ad entrambe le cancellerie si accedeva dal piano della sala del Consiglio dei Dieci. A. Da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia, I, Roma 1937, pp. 3-4.
3 La pergamena prende il nome da Roberto Almagià (1884-1962), geografo e storico della cartografia, docente presso le Università di Padova e di Roma, che nel 1923 la pub-blica (contemporaneamente ad A. Feuerstein, Ein Kartographisches Denkmal aus dem 15. Jahrhundert, in «Mitteilungen der k.k. Geographischen Gesellschaft in Wien», 66, 1923, pp. 106-122) segnalandola all’attenzione degli studiosi italiani. Per Roberto Almagià vedi almeno Luzzana Caraci I., Almagià Roberto, in Dizionario biografico degli Italiani, 34, Primo supplemento A-C, Roma 1988, pp. 76-78 e Roberto Almagià e la geografia italiana nella prima metà del secolo. Una rassegna scientifica e una antologia degli scritti, a cura di G. Corna Pellegrini, Milano 1988.
Anche Roberto Almagià aveva rilevato lacune e contrazioni nel bacino superiore dell’Adige e a sud del lago di Garda (Un’antica carta topografica del territorio veronese, in «Rendiconti della R. Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche», XXXII, 1923, p. 64). Ezio Filippi ha poi sottolineato le deformazioni da est a ovest e le rotazioni verso est dei territori di Legnago e dei Lessini (La nascita della moderna agrimensura: cartografi, mappe, periti e perizie nel Quattrocento, in Misurare la terra. Agri-mensura e cartografia, catasti e catastici a Verona dall’età romana ai nostri giorni, a cura di P. Brugnoli, Verona 1992, pp. 122-124).
governo del territorio e cartografia veneta 21
tenzialmente riconducibile a quella decisione, per quanto (almeno) sinora si conosce, benché non risponda integralmente ai requisiti richiesti. Il testo grafico sembra peraltro un “non finito”, come si espliciterà più avanti.
La bibliografia degli anni settanta del Novecento suggeriva di collegare a quella delibera, rispettando l’ipotesi avanzata a suo tempo da Roberto Almagià, altri documenti (relativi al Padovano e al Bresciano) che si sono rivelati invece, o sembrano piuttosto rivelarsi, di diversa origine.
Diventa quindi necessario ripercorrere le possibili funzioni di un’ico-nografia (territoriale e urbana) che si sviluppa nel corso del Quattrocento e di una cartografia i cui scopi concreti non sono sempre facilmente indi-viduabili, e non soltanto nel caso di testi quattrocenteschi come la carta dell’Almagià pervenuti decontestualizzati dalle dinamiche che ne hanno causato l’attuazione.
Il nesso con il decreto del 14604, che ne indicava scopi e funzioni, im-plica però un’inevitabile ricognizione sui cicli geografici e/o di iconografia urbana realizzati nei palazzi veneti del potere, frequenti tasselli di un feno-meno che esula dall’ambito strettamente italiano.
Iconografie di dominio
A Venezia, in Palazzo Ducale, già prima del 1442, sembra esistessero due «carte di Cosmografia» (risalenti secondo la tradizione al doge Fran-cesco Dandolo)5 nella sala delle Nappe [= Mappe6], poi dello Scudo. Un mappamondo (e non una rappresentazione del dominio, come era stato frainteso da Roberto Gallo, a sua volta ripreso da parte della bibliografia successiva7) e una rappresentazione dell’Italia (scomparsi con l’incendio del
4 G. Mazzi, Cartografia e organizzazione del sapere tecnico, in Il governo delle acque, Atti del convegno, a cura di M.F. Tiepolo e F. Rossi, Venezia 2008, p. 52. Le prime indicazioni in proposito sono però avanzate in G. Mazzi, La conoscenza per l’organizzazione delle difese, in Il territorio nella cartografia di ieri e di oggi, a cura di P.L. Fantelli, Padova 1994, pp. 118-119.
5 R. Gallo, Le mappe geografiche del palazzo ducale di Venezia, in «Archivio Veneto», 1943, p. 51.
6 «Napa» ha il significato di mappa, tavola cosmografica, geografica: Monumenti, pp. 80-81 nota (a).
7 La rilettura del documento originale (Archivio di Stato di Venezia, Misti. Consiglio dei Dieci 1477-1480, reg. 19, c. 154v, 24 settembre 1479, pubblicato in Monumenti, doc. 193, pp. 89-90) conferma la trascrizione pubblicata. Il termine «cosmographia» ha, come è noto, il significato di descrizione dell’universo, e quindi è riconducibile al termine «map-pamondo», inteso sia come rappresentazione cartografica della superficie terrestre sia come
giuliana mazzi22
14838, mentre la seconda subito replicata è andata perduta definitivamente negli incendi cinquecenteschi)9 saranno dipinti da Antonio de Leonardis (o
rappresentazione del cielo stellato; «nostro dominio» – dativo: quindi complemento di ter-mine che esprime il destinatario – non può essere inteso come specifica del soggetto della «cosmographia», al di là del significato proprio di senso strettamente politico (signoria, dominio). Tutte le fonti, anche secondarie, infine, ricordano il perduto lavoro di Leonardi come mappamondo o come cosmografia universale del mondo.
Del resto, nel Quattrocento il termine «mappamondo» ha come significato prevalente quello di rappresentazione della superficie terreste: la «Camera del Mapamundi» voluta a fine secolo da Francesco Gonzaga per Marmirolo ripropone rappresentazioni della su-perficie terrestre e dell’Italia, come la di poco successiva analoga stanza nel palazzo di San Sebastiano a Mantova: M. Bourne, Francesco II Gonzaga and Maps as Palace Decoration in Renaissance Mantua, in «Imago Mundi», 51, 1999, pp. 61-62, 65-67. Vedi anche: R. Bianchi, Notizie del cartografo veneziano Antonio Leonardi. Con un’appendice su Daniele Emigli (o Emilei) e la sua laurea padovana, in Filologia Umanistica. Per Gianvito Resta, I, Padova 1997, pp. 189-190.
Sembra plausibile l’ipotesi che Gallo (Le mappe geografiche, p. 51) abbia posto in rela-zione i testi dei due documenti del novembre 1459 (relativo al rinnovo del soffitto della sala delle Nappe: Monumenti, doc. 183, pp. 80-81) e del febbraio 1459 m.v. (Monumenti, doc. 184, p. 82: ossia la parte trascritta alla nota 1) con il testo del documento del 1479. Parte della bibliografia successiva ha ripreso il testo di Gallo: per esempio, Florani F., Cycles of Painted Maps in the Renaissance, in The history of cartography, III, Cartography in the European Renaissance, I, ed. by D. Woodward, Chicago and London, 2007, p. 808 (che data la rappresentazione dei territori dell’entroterra attribuita a Leonardi al 1459); p. 830 (identificazione dei luoghi dei cicli in Palazzo Ducale).
8 Romanin S., Storia documentata di Venezia, IV, Venezia, 1855, p. 418. Romanin data l’incendio al 1479, seguendo probabilmente la Cronica di Sansovino che colloca l’evento in quell’anno (cfr. Gallo, Le mappe geografiche, p. 47 nota 1).
9 La redazione della prima Italia fu conclusa entro il 1479 quando sono assegnati a Leonardi benefici vacanti nella diocesi di Brescia per la stesura, appunto, della «cosmogra-phiam nostro dominio» e dell’Italia (Monumenti, doc. 193, pp. 89-90: cfr. nota 7; vedi anche Bianchi, Notizie del cartografo veneziano Antonio Leonardi, pp. 189-190).
La redazione della seconda Italia fu commissionata nel 1485 (Bianchi, ivi, p. 191). Un’Italia di Antonio Leonardi («teller di la Italia», ossia tela applicata direttamente sulla parete) è nel 1505 nell’anticamera della sala dell’Udienza (identificata da Gallo – Le mappe geografiche, p. 53 – nella sala Erizzo), il luogo di attesa per le ambascerie e per le delegazioni che dovevano essere ricevute: cfr. note 10 e 11. In data imprecisata sarà spostata al piano superiore, nell’anticamera del Collegio: ne sarà inviata una copia al cardinale di Ferrara nel 1547: Monumenti, doc. 271, p. 133; doc. 558, p. 259; Gallo, Le mappe geografiche, pp. 51-52.
La sostituzione di affreschi con dipinti su tela, ritenuti più resistenti alle particolari condizioni di umidità della città lagunare, inizia nel Quattrocento. Le tele erano pre-valentemente separate da listelli profilati dorati: Wolters W., Architektur und Ornament. Venezianischer Bauschmuck der Renaissance, Munchen 2000 (trad. it. Architettura e orna-mento. La decorazione nel Rinascimento veneziano, Sommacampagna (Verona) 2007, pp. 159-160).
governo del territorio e cartografia veneta 23
Leonardi) entro il 147910, a testimonianza di un gusto che si moltipliche-rà nel corso del secolo successivo e che porterà allo sviluppo di tematiche volte alla visualizzazione di luoghi collegati a un personaggio politico, che diventa pertanto committente di decorazioni che rappresentino i territori e/o le singole città sottoposte, oppure le città cui la capitale di uno stato è equiparata per importanza politica e/o economica e per ruolo storico11.
Tale prassi nel corso del XVI secolo vede, non soltanto in Italia12, fre-
10 Su Leonardi vedi almeno l’inquadramento della sua attività di cartografo, dei suoi interessi antiquari e sulla cerchia di relazioni personali nel quadro dell’umanesimo non soltanto veneziano della seconda metà del Quattrocento (con i Piccolomini, per esempio): Bianchi, Notizie del cartografo veneziano Antonio Leonardi, pp. 166-211.
Non è chiara l’ubicazione originaria delle mappe: Romanin (Storia documentata di Venezia, p. 418) parla di una «stanza ove erano dipinti tutt’i dogi ciascuno col proprio stemma e con polizzino in mano, e vedevasi il Mappamondo e l’Italia in due gran quadri recentemente fatti da prete Antonio de Leonardi, distinto cosmografo»: si trattava di un ambiente distinto dalle «stanze d’abitazione del doge, [e dal]la sala delle due nappe», di-strutte nel corso dell’incendio del 1483. Altri hanno proposto l’ubicazione delle due carte geografiche nella sala delle Nappe, identificata sia con la sala dello Scudo (riprendendo Monumenti, p. 81 nota a) sia con l’anticamera della sala dell’Udienza: cfr. Fiorani, Cycles of Painted Maps, p. 808 nota 21 con la relativa bibliografia; p. 821 nota 53, p. 830 (identifi-cazione dei luoghi dei cicli in Palazzo Ducale).
Rileggendo Sanudo e la sua cronaca sull’incendio del 1483 (trascritto in Monumenti 1868, p. 92 doc. 198) sembra però più probabile una terza ipotesi che pone le due mappe in una sala prossima alla sala delle Nappe.
Per Sanudo la sala delle Nappe era destinata alle udienze del Collegio, la sala a fianco era riservata alle riunioni dei Savi del Collegio e custodiva il mappamondo e l’Italia di Antonio Leonardi, e la camera con i ritratti dei dogi (ricordata da Romanin) era un terzo ambiente, distinto dalle stanze di abitazione del Doge. La descrizione di Sanudo è confer-mata del documento del 1476 pubblicato da Bianchi, che testimonia la sistemazione del mappamondo in «novam cameram audientiae nostrae», una delle stanze prossime alla sala delle Nappe (Notizie del cartografo veneziano Antonio Leonardi, pp. 187-188). Gallo (Le mappe geografiche, p. 53) la identifica con la sala Grimani.
11 Scrive Jurgen Schulz a proposito delle mappe di Antonio Leonardi: «Là dove gli ospiti con il loro seguito si preparavano all’incontro con il serenissimo principe […] [le mappe] potevano servire solo ad imprimere nella mente dei forestieri la grandezza dei domini della Repubblica e l’immagine dell’intero cosmo di cui quello stato era una parte apparentemente immutabile» (La cartografia, p. 106). Si trattava del resto di un atteggia-mento mentale teso alla visualizzazione del ruolo di Venezia nella compagine europea che, per Burckhart (L’arte italiana del Rinascimento. Pittura: I generi, a cura di M. Ghelardi, Venezia 1992, p. 121), aveva promosso anche l’iconografia trecentesca nella sala del Mag-gior Consiglio.
Sulle opere d’arte nel Palazzo Ducale di Venezia connesse, per iconografia, al dominio veneziano cfr. almeno Wolters W., Storia e politica nei dipinti di palazzo Ducale, Venezia 1987, in particolare pp. 260-265.
12 Cfr. i cicli a soggetto urbano e geografico nell’Alcázar a Madrid, nel Louvre di Luigi
giuliana mazzi24
quenti realizzazioni di mappe e vedute (arazzi, tele, affreschi ecc.), i cui soggetti possono riferirsi a limitati settori di complesse organizzazioni ter-ritoriali. È quanto sembra avvenire negli edifici pubblici di almeno due città della Repubblica, esempi peraltro non unici nel panorama dell’epo-ca, di decorazioni geografiche allocate in palazzi di centri soggetti a città-capitali13.
Forse per quanto riguarda le città sottoposte a Venezia si tratta di sug-gestioni dalla sequenza allusiva allo «stato della Repub[blica]» nella sala delle Quattro Porte che precede sia l’Anticollegio che la sala del Senato in Palazzo Ducale, sala per la quale nel 1578 era stato definito un program-ma iconografico che doveva rappresentare ed esaltare la missione storica dell’aristocrazia veneziana14. In «otto mandole [=ovali]» del soffitto sono ritratte Verona con l’Arena, Padova con i libri, Brescia con le armi (allusive della locale e importante produzione), Istria con in mano una corona evo-cativa dell’indipendenza dalla casa d’Austria cui erano soggetti i territori dell’interno, Treviso con la spada nel fodero (ricordo della precoce dedizio-ne a Venezia), la Patria del Friuli in atto di riporre la spada, Vicenza con frutti, Altino con rovine romane15. Alla fine l’iconografia urbana esce dal campo della curiosità geografica per divenire momento della glorificazione di una classe dirigente.
XIII, nella Kunstkammer della Residenz a Monaco: C. De Seta, La fortuna del «ritratto di prospettiva» e l’immagine delle città italiane nel Rinascimento, in A volo d’uccello. Jacopo de’ Barbari e le rappresentazioni di città nell’Europa del Rinascimento, catalogo della mostra, a cura di G. Romanelli, S. Biadene, C. Tonini, Venezia 1999, p. 35; G. Olmi, Terra e cielo in una stanza: mappe e globi nelle dimore e nelle collezioni dell’età moderna, in Un intellettuale europeo e il suo universo. Vincenzo Coronelli (1650-1718), a cura di M.G. Tavoni, Bologna 1999, pp. 78-79.
13 Sull’uso politico di immagini di città e regioni sono intervenuti recentemente L. Nuti, Ritratti di città. Visione e memoria tra Medioevo e Settecento, Venezia 1996, pp. 30-32; M.B. Bettazzi, Affreschi di città: ricerche per un catalogo ragionato, in La città allo specchio, a cura di C. Conforti, L. Nuti, C.M. Travaglini, in «Città & Storia», I (2006), n. 2, pp. 317-324; L Nuti., Le città di Palazzo Vecchio a Firenze, ivi, pp. 345-358; M. Folin, De l’usage pratico-politique des images des villes (Italie XVe-XVIe siècle) in Villes de Flandre et d’Italie (XIIIe-XVIe siècle). Les enseignements d’une comparaison, sous la direction de É. Crouzet-Pavan et É. Lecuppre-Desjardin, Turnhout 2008, pp. 259-323; E. Svalduz, Non finte, ma «verissime»: le prospettive della sala grande nel palazzo dei Pio a Carpi, in «Some degree of happiness». Studi di storia dell’architettura per Howard Burns, a cura di M. Beltramini e C. Elam, Pisa 2009, pp. 133-154, 693-696; per una recente sintesi del tema, pur con impre-cisioni, cfr. Florani, Cycles of Painted Maps.
14 Wolters, Storia e politica, pp. 59-66.15 F. Sansovino, Venetia citta nobilissima et singolare descritta in 14. Libri, Venetia 1581,
pp. 122r-v.
governo del territorio e cartografia veneta 25
Ne deriva la probabile mimesi anche in edifici privati. Oltre ai map-pamondi collezionati fin dal Quattrocento e testimoni di una crescente diffusione di interessi per la geografia e gli assortimenti di testi di viaggi, di compendi, di raccolte di vedute di città e di raccolte di mappe16, anche affreschi e dipinti risentono dell’attenzione per realtà fisiche individuabili: uno spettro ampio che va dalla visualizzazione di settori urbani specifici (in villa Loredan a Montebelluna, per esempio, con vedute delle piazze di San Marco a Venezia e dei Signori a Treviso17) all’elaborazione di iconogra-fie allusive. Marcantonio Memmo commissiona a Paolo Farinati una serie (realizzata tra il 1597 e il 1599 e inviata subito a Venezia) di «sei pezzi de’ fregi delle città della Repubblica Veneta» sedi delle destinazioni di incari-chi da lui ricoperti per conto della Serenissima (Verona, Padova, Vicenza, Bergamo, Palma, Sacile)18.
Nei palazzi pubblici la rappresentazione può seguire lo schema di al-legorie fatte di monumenti e di personificazioni, come nelle tele dedicate a Verona e a Padova (ora nella Pinacoteca Tadini di Lovere, Bergamo) di-pinte forse ancora da Paolo Farinati (ma comunque di scuola veronese) e impiegate come sovrapporte per una stanza dei Provveditori di Verona nel palazzo del Comune. Per Verona (fig. 1) sono adoperate l’Arena, Ca-stelvecchio con l’arco dei Gavi, Castel San Pietro (e quindi la storia della città attraverso la memoria romana e scaligera e la presenza tutelatrice di Venezia) e le personificazioni della città stessa e dell’Adige; per Padova (fig. 2) le personificazioni della città e del Brenta, libri e strumenti di scienza (l’università), e l’immancabile riferimento alla basilica di Sant’Antonio, riconoscibile per la cupola conica che affianca una cupola estradossata19. L’iconografia delle due tele sembra ispirarsi appunto a quella impiegata negli ovali della sala delle Quattro Porte in Palazzo Ducale.
Nel palazzo allora del Podestà (ora del Comune) a Padova in epoca imprecisata, ma allo scadere del XVI secolo o ai primi anni del XVII, deve
16 Sul tema vedi almeno Olmi, Terra e cielo in una stanza. Per l’impiego di mappe incorniciate e appese al muro, ivi, p. 82; Nuti, Ritratti di città, pp. 203-204; G. Mazzi, Architetture e città, in Un intellettuale europeo e il suo universo, pp. 178-179 (per l’area veronese).
17 Le vedute, affrescate nella prima metà del XVI secolo, sono dipinte nella loggia a pianterreno della villa: A. Lentini, Montebelluna. Villa Loredan, in Gli affreschi nelle ville venete. Il Cinquecento, a cura di G. Pavanello e V. Mancini, Venezia 2009, pp. 367-369.
18 P. Farinati, Giornale (1573-1606), a cura di L. Puppi, Firenze 1968, pp. 153, 156 e 153-154 nota 1.
19 P. Balestrieri, Gli stemmi di Verona e di Padova dipinti da Paolo Farinati, in «Vita Veronese», VIII (1955), maggio, pp. 138-141; Guida alla Galleria Tadini, a cura di G.A. Scalzi, Lovere 1992, p. 48.
giuliana mazzi26
invece essere stata dipinta una teoria di città compresente a figure allegori-che (superstite la Musica) e a elementi architettonici. Sopravvissuti restano i ritratti di Padova (fig. 3) e di Vicenza (fig. 4), che seguono le impostazioni della veduta, come profilo per Padova e a volo d’uccello per Vicenza20.
20 La veduta prospettica di Vicenza è pubblicata in G. Mazzi, Dal simbolo all’immagine: xilografie e incisioni per la Vicenza del Cinquecento, in Andrea Palladio. Il testo, l’immagine, la città, catalogo della mostra, a cura di L. Puppi, Milano 1980, p. 114. Il punto di vista, da nord/nord-ovest, è usato per alcuni profili della città posti sullo sfondo di dipinti da Marcello Fogolino nei primi decenni del Cinquecento (cfr. F. Barbieri, Immagini di Vicen-za cinquecentesca e palladiana, ivi, p. 141). È quello adottato anche nella pianta prospettica conservata presso la romana biblioteca Angelica (da cui prende il nome) e che si diffonde con la pianta da questa ripresa (e con le sue derivazioni) pubblicata da Braun e da Hogen-berg a Colonia nel 1588. L’orientamento cambierà a partire dal secolo seguente, sostituito da riprese da nord-est.
La veduta di Padova (pubblicata in L. Puppi, M. Universo, Le città nella storia d’Ita-lia. Padova, Roma-Bari 1982, p. 121, fig. 142) è sommariamente discussa in G. Mazzi, Iconografia della città di Padova ai tempi del Cornaro, in Alvise Cornaro e il suo tempo, catalogo della mostra, a cura di L. Puppi, Padova 1980, p. 184. Il profilo ritrae la città da ovest, usando una ripresa che tornerà soltanto nelle incisioni settecentesche promosse da Probst e da Werner e che si affianca a quella da est, impiegata nei profili di sfondo alle tele cinquecentesche di Domenico Campagnola, di Palma il Giovane e, forse, di Francesco Apollodoro da Porcia (cfr. Mazzi, Iconografia della città di Padova, pp. 246-251). Sulla genesi della veduta in profilo cfr. almeno L. Nuti, La rappresentazione della città: ricerche, soluzioni, prototipi, in Il Rinascimento italiano e l’Europa, VI, Luoghi, spazi, architetture, a cura di D. Calabi e E. Svalduz, Treviso-Costabissara (Vicenza) 2010, pp. 13-16. È infine opportuno ricordare (per la possibile origine del punto di vista da ovest/sud-ovest per la redazione di profili per la città) che nel 1494 Francesco Gonzaga chiede al suo agente a Venezia di procurargli una veduta di Padova da porta Santa Croce: Bourne, Francesco II Gonzaga, p. 72 nota 58.
Nella sala, situata a est del cortile pensile dell’attuale palazzo del Municipio e in origine a doppia altezza, è affrescata anche una figura allegorica (la Musica). Il motivo architetto-nico sempre ad affresco nella sala ora sovrastante, posto a livello del pavimento, sembra portare la datazione ai primi anni del Seicento per la presenza dello stemma dei Bernardo: R. Lamon, Palazzo Moroni e gli edifici circostanti, [s.l.] 2008, p. 33.
Mancano informazioni sul periodo (anche di committenza) degli affreschi, accostati dubitativamente allora da chi scrive (seguendo L. Grossato, Affreschi del Cinquecento in Padova, Milano 1966, p. 304 nota 27) a Ludovico Toeput detto il Pozzoserrato (1550 cir-ca-1610), che a metà anni degli anni settanta del Cinquecento era impegnato nelle abbazie benedettine di Santa Giustina a Padova e di Santa Maria Assunta di Praglia in provincia di Padova. Le due vedute sono segnalate, e confermate a Pozzoserrato, anche in M. Lucco, Ludovico Pozzoserrato, in I Benedettini a Padova e nel territorio padovano attraverso i secoli, catalogo della mostra, a cura di A. De Nicolò Salmazo e F.G. Tirolese, Treviso 1980, p. 319. Per gli affreschi nell’atrio della sacrestia a Santa Giustina cfr. Lucco, Ludovico Pozzo-serrato, pp. 318-319; per gli affreschi di Praglia nell’appartamento dell’abate cfr. Grossato, Affreschi del Cinquecento, pp. 279-292.
governo del territorio e cartografia veneta 27
Forse l’idea del ciclo risale a qualche decennio prima, se l’invio negli anni trenta del Cinquecento a Padova di un disegno della città berica può essere interpretato come possibile preludio a una raccolta di modelli per la ste-sura di affreschi il cui soggetto poteva essere la teoria delle città confinanti (Rovigo, Vicenza e Venezia) che, nei quattrocenteschi testi grafici di An-nibale Maggi e di Francesco Squarcione (tav. 5) sono rappresentate tutte con macroscopie, ridotte nelle dimensioni rispetto a quella impiegata per la città capoluogo, e con una particolare attenzione formale alla rappresen-tazione di Venezia nella pergamena di Squarcione. Le “camere delle città” erano infatti costruite sulla base di una scelta accurata condotta sui ritratti urbani esistenti, anche a stampa21.
Ovvio che, in questo caso, più che di “geografia”, si tratta di rappresen-tazioni mnemoniche di realtà fisiche dove la visualizzazione di elementi reali inseriti in una compagine urbana “fedele” all’esistente porta all’imme-diato riconoscimento di un luogo e, al di là dell’aiuto offerto dai cartigli, rispondono a quell’attenzione per realtà concrete – e implicitamente poli-tiche – tra loro collegate e/o collegabili.
Sempre nel Cinquecento (1566) risulta collocata nella camera dei Depu-tati di Vicenza una mappa del territorio vicentino, che è “prestata” tempora-neamente a Verona per la redazione di «un retratto del veronese et Vicenti-no et padovano tutto unito» che l’allora capitano di Verona (Marc’Antonio Morosini) intendeva far redigere22, forse per intenti di arredo. Anche la mo-bilità dei rappresentanti del potere centrale favorisce quindi la circolazio-ne di immagini che diventino promemoria visivo dei luoghi dell’esercizio politico, qualora quei disegni siano privi di implicazioni conoscitive volute dallo Stato e/o dalle magistrature al momento della loro commissione.
Documenti e arredi
Torniamo ora ai testi che Roberto Almagià aveva collegato al decreto del 1460. Sono tutti privi di quelle potenzialità informative esplicitamente richieste nel testo della parte.
Non si conoscono, infine, le ragioni della spedizione a Padova, nel 1533, di un disegno di Vicenza smarrito, se non nell’ottica proposta nel testo (G. Fasolo, Notizie di arte e di storia vicentina, in «Archivio Veneto», s. V, XXII (1938), pp. 260-301, 290; F. Barbieri, La pianta prospettica di Vicenza del 1580, Vicenza 1973, pp. 29-30, 46-47).
21 Cfr., per esempio, le ricerche commissionate da Francesco Gonzaga per i cicli (per-duti) di Gonzaga, di Marmirolo e di Mantova: Bourne, Francesco II Gonzaga, pp. 51-82.
22 Fasolo, Notizie di arte, p. 290; vedi anche Schulz, La cartografia, pp. 108-109.
giuliana mazzi28
La pergamena che ritrae il Padovano fu richiesta a Francesco Squarcio-ne nel 1465 per intenti di arredo – seppure per un ambiente di accesso limitato (ne era prevista l’esposizione nell’«offitio Cancellerie Communis» di Padova) – come esplicitano le motivazioni dell’incarico23, e risponde solo in parte a requisiti di informazione dettagliata. Copiata da un dise-gno presente nell’archivio comunale (forse la carta di Annibale Maggi del 1449, pervenuta nella copia cinquecentesca conservata all’Ambrosiana di Milano24), integrato con l’aggiunta di canali nella Bassa padovana e con l’inserimento delle fortificazioni di Oriago25, riflette – come il suo probabi-le archetipo – intenti celebrativi, piuttosto che esigenze di documentazione pratica.
Opportuno escludere dal decreto anche la pergamena relativa al Bre-sciano conservata presso la Biblioteca Estense di Modena (tav. 9), com-posta più o meno negli stessi anni e datata da Almagià al 1469-147026: il
23 Il testo del documento relativo all’incarico è pubblicato in L. Olivato Puppi, L. Pup-pi, Venezia veduta da Francesco Squarcione nel 1465, in Per Maria Cionini Visani. Scritti di amici, [S.l.] 1977, pp. 29-30; sulla pergamena cfr., da ultime, E. Svalduz, [Francesco Squarcione], Padova e il suo territorio, in Andrea Palladio e la villa veneta. Da Petrarca a Carlo Scarpa, catalogo della mostra, a cura di G. Beltramini e H. Burns, Venezia 2005, pp. 366-368, con aggiornamenti sulla bibliografia relativa; M. Zanetti, Il restauro della Mappa di Padova di Francesco Squarcione, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», XCV (2006), pp. 78-93; E. Casti, State, Cartography, and Territory in Renaissance Veneto and Lombardy, in The History of Cartography, pp. 897-898.
24 Cfr. la scheda di G. Mazzi, Iconografia di Padova ai tempi del Cornaro, in Alvise Cor-naro e il suo tempo, p. 233 con bibliografia precedente.
25 R. Almagià, Monumenta Italiae Cartographica, Firenze 1929, p. 12.26 Il volto storico di Brescia, II, Brixia, Le carte del territorio, le piante e le vedute, Brescia
1980, p. 32, A4. Altro è il caso della pergamena datata da Almagià (Monumenta, p. 9b) al quinto decen-
nio del Quattrocento e conservata alla Biblioteca Queriniana di Brescia, inserita nel Codice dei privilegi concessi dalla città alle famiglie e al territorio di Brescia. Il manoscritto, di cui non sembra far parte integrante, è datato al 1472 circa (ivi e Il volto storico di Brescia, p. 39, B5). Il documento grafico effigia Brescia e una parte del territorio come «ritratto» degli stessi attraverso la metafora e la storia (tav. 10). La raffinata rappresentazione del territorio non è totale e non tutti i centri minori raffigurati (in forma di rocca, di recinto fortificato, di una o più case, oppure di chiese) hanno l’indicazione del rispettivo toponimo. La città è invece delineata sulla base del suo assetto fisico, un triangolo delimitato dal perimetro delle mura (scandito dalle torri e dalle porte con i ponti levatoi) e dal circuito dei fossati, con il castello al vertice superiore e il forte della Garzetta a sud. Come ha notato Andrea Bona (Brescia: XV secolo. Acque e mercati nella formazione del nuovo centro urbano, in Fabbriche, piazze, mercati. La città italiana nel Rinascimento, a cura di D. Calabi, Roma 1997, pp. 132-134), il disegno – a prima vista analogo alle rappresentazioni di origine medievale dove le torri e un castello suggeriscono simbolicamente l’identità di una città e non sempre
governo del territorio e cartografia veneta 29
documento non risponde per misure alla carta del Veronese e, per quantità di informazioni, alle richieste contenute nel decreto. Costituisce peraltro un accurato “inventario” di situazioni orografiche (rese in prospettiva), delle valli (indicate da scritte), della rete idrografica, dei laghi, delle rogge per l’irrigazione dei terreni, dei canali artificiali, delle strade e degli inse-diamenti resi attraverso gli ormai consueti simboli graduati sull’estensione e sulla tipologia dei borghi (recinti fortificati, castelli, torri, chiese) dotati nella maggior parte dell’indicazione del toponimo27. Mancano però le in-dicazioni di distanza tra i luoghi e quelle relative ai punti cardinali e alla rosa dei venti, richieste invece dal decreto.
Si accennava alle difformità di misure. Si tratta di un notevole scarto che è opportuno a mio avviso non sottovalutare: 730x615 mm e 1170x1010 mm, rispettivamente, nelle pergamene che disegnano i territori bresciano e padovano contro 2220x2997 mm della pergamena che ritrae il Veronese.
Le carte delle province venete redatte, a partire dal 1578, da Cristoforo Sorte per la sala del Senato veneziano sono tutte di grandi dimensioni (tav. 13) e con misure omogenee in larghezza e con scarti nelle altezze, verisi-milmente determinati dalle diverse estensioni dei territori verso nord28. È difficile non porre in relazione l’eventuale compimento delle pergamene quattrocentesche richieste dalla parte del 1460 con il corpus redatto con intenti pressoché equivalenti nel secolo successivo. L’iter di tale impresa è conosciuto29.
Un primo incarico riguarda una sola mappa relativa a tutto lo stato da terra, pensata come strumento di informazione che divenisse anche ele-mento di arredo30 per la sala dei Pregadi (il Senato) e iniziata, «ne quadroni
si ricollegano a un effettivo urbano – raffigura Brescia divisa nelle tre parti indotte dalla cittadella voluta dai Visconti per separare i ghibellini (a loro favorevoli) dai guelfi con la realizzazione di due cortine murarie, intervallate da torri e collegate alle due rocche, setten-trionale e meridionale. Si tratta di un “ritratto” di città dalle caratteristiche simili a quelle delle immagini di Padova nelle carte di Maggi e di Squarcione.
27 M. Baratta, Sopra un’antica carta del territorio bresciano, in «Bollettino della società geografica italiana», 1913, pp. 514-526, 1025-1031.
28 Carte del Bergamasco e del Bresciano: rispettivamente 3400x1680 e 3400x1690 mm; carta del Veronese e del Vicentino e carta del Padovano e del Trevigiano: rispet-tivamente 2940x1650 e 2950x1600 mm; carta del Friuli: 2160x1660 mm: Schulz, La cartografia, p. 80.
29 Schulz, La cartografia, pp. 66, 69-71, 73-74, 79-89, p. 109; G. Mazzi, La Repubblica e uno strumento per il dominio, in Architettura e utopia nella Venezia del Cinquecento, cata-logo della mostra, a cura di L. Puppi, Milano 1980, pp. 62-63. I prodromi dell’incarico risalgono al 1565: Schulz, La cartografia, p. 69.
30 Cfr. il testo (pubblicato in Schulz, La cartografia, p. 73) della supplica rivolta il 24
giuliana mazzi30
[della sala] compartiti intorno alle mura [teleri?]». Scrive infatti Francesco Sansovino: «si dipinge di continuo tutto lo Stato di Terra Ferma posseduto dalla Rep. di paese in paese, con le distanze, & i siti delle città, delle castel-la, & de territori, co loro confini»31. Nel 158232 è presa invece la decisione di riporre il documento in un armadio a muro che doveva essere costruito nella cappella del Senato allora in funzione, la «Giesola», di cui nel 1586 sarà decisa la trasformazione in Cancelleria (insieme con il locale sovrastan-te), determinando l’adeguamento a cappella della vicina sala delle Teste33. La registrazione dello Stato da terra diventa dunque riservata34. Un nuovo mandato, dei primi di gennaio del 1586 e di poco precedente al cambio di destinazione d’uso della cappella e della sala delle Teste, chiede infine la redazione di sei carte di ugual misura, cinque particolareggiate dell’entro-terra e una generale di sintesi (di formato minore pertanto rispetto a quello prescritto nella commissione del 1578) e redatta nelle misure, estese alle altre carte, suggerite da Sorte stesso nel dicembre immediatamente prece-dente35. La destinazione di tutte le carte doveva essere ancora l’armadio
aprile 1582 ai Provveditori «sopra la restauratione del Palazzo» da Cristoforo Sorte, dove il pittore veronese dichiara che «quando si ha bisogno di qualche informatione del sito & confini de’ loro luoghi, che è materia di molta importantia, è necessario mandar à pigliar istruttioni di fuori, le quali non si possono hauere se no’ con lunghezza di tempo, & molte volte imperfette; di modo che le cose publiche patiscono». La carta murale avrebbe dovuto misurare 4170x12170 mm (ivi, pp. 69-70).
31 Sansovino, Venetia citta nobilissima, p. 123r.32 Schulz, La cartografia, p. 70.33 Monumenti, doc. 956, p. 491: 31 gennaio 1585 (m.v. = 1586); vedi anche doc. 961
p. 495 (28 giugno 1586); doc. 975, pp. 503-504 (21 luglio 1587, in particolare la nota di Antonio da Ponte del 17 aprile dello stesso anno).
La trasformazione della sala delle Teste in cappella del Senato sarà avviata a partire dal 1593 da Vincenzo Scamozzi: C. Davies, Architecture and Light: Vincenzo Scamozzi’s Statua-ry Installation in the Chiesetta of the Palazzo Ducale in Venice, in «Annali di Architettura», 2002, 14, pp. 171-194; e le sintesi: C. Davies, Vincenzo Scamozzi architetto della luce, in Vincenzo Scamozzi 1548-1616, catalogo della mostra, a cura di F. Barbieri e G. Beltramini, Venezia 2003, pp. 38-42, e Cappella del Doge o chiesetta, palazzo Ducale, Venezia (1593 ca.), ivi, p. 346.
34 Oblazione di me Christoforo Sorte sopra la Corografia, 22 dicembre 1585, in Monu-menti, p. 521, dove suggerisce anche la redazione di quattro carte particolari; Schulz, La cartografia, p. 80.
35 Sono però richieste maggiori informazioni rispetto a quelle prospettate da Sorte nell’Oblazione, come la rappresentazione degli stati confinanti e dei porti: cfr. Termina-tione dei Clarissimi Signori Proveditori sopra la Chorografia, 8 gennaio 1585 [m.v. 1586], trascritta in Monumenti, pp. 522-523. Le misure, come si è ricordato nel testo, dovevano essere uguali (dieci piedi di lunghezza per cinque di altezza: 3480x1740 mm) sia per la perduta carta generale che per le carte particolari: ivi, p. 522. Nel 1587 sarà approvata la
governo del territorio e cartografia veneta 31
nella «Gesiola», ossia della nuova Cancelleria, la cosiddetta «secreta, ove prima era la cappella, over Chiesola, nella quale si custodiscono le scritture de i Secreti dello Stato»36. Sembra che la carta generale sia stata esposta, in una limitata pubblicizzazione, nell’Antichiesetta, ossia in un vano inter-medio tra la sala del Senato, la nuova cappella e l’archivio. Scrive infatti Giovanni Stringa: «Nel luogo poi avanti la Secreta vi è un gran quadrone, nel quale è stato fatto un disegno di Corografia di tutto lo stato di Terra ferma, che possedono questi Signori da Christoforo Sorte Veronese, tanto bello, e così giusto, che non può meglio desiderare»37.
Ci sono del resto analogie di massima tra gli eventi storico-politici e l’organizzazione dell’entroterra avviata a metà Quattrocento e la situazione della Repubblica di fine Cinquecento. Negli ultimi decenni del XVI seco-lo Venezia ha ormai definito il sistema delle difese, ha spostato i capitali dalla mercatura alla terra grazie anche alle consistenti bonifiche che hanno aumentato le superfici coltivabili, ed è intervenuta con decisione sui pro-blemi di interramento della laguna. All’indomani di una riorganizzazione dello stato che aveva investito sui temi prioritari della difesa, dell’economia e delle acque (e che era stata avviata nel secolo precedente) particolarmente
proposta di Sorte di aggiungere la rappresentazione dell’Istria per garantire l’omogeneità dei dieci piedi a tutte le carte (Monumenti, p. 523). Tale omogeneità non fu però realizzata differendo le carte nelle dimensioni e nella scala (cfr. nota 28 e Schulz, La cartografia, p. 80). Soltanto le carte del Bergamasco e del Bresciano, come aveva notato Schulz, rispon-dono ai requisiti iniziali.
36 Venetia cità nobilissima et singolare Descritta già in XIIII Libri da M. Francesco San-sovino et hora con molta diligenza corretta, emendata e più d’un terzo di cose nuove ampliata dal M.R.D. Giovanni Stringa, Venezia 1604, p. 231r.
Le cinque «carte grandi» erano ancora conservate negli armadi nel 1676, quando furo-no casualmente rintracciate dopo che se ne era perduta la memoria: Battista Nani (provve-ditore sovrintendente alla Camera dei Confini) propose pertanto «che si potessero sottrare dal pericolo di ricadere di nuovo in oblivione, col riporli nella camera dove tante altre carte minori de siti e luoghi particolari sono esibite». Nani sosteneva l’urgenza di un inventario dei disegni esistenti, che doveva essere provvisto di una rubrica generale e di catastico: Ar-chivio di Stato di Venezia, Senato Terra, filza 941, 23 gennaio 1677 (m.v. = 1676), relazione allegata del 14 gennaio. Il documento è segnalato in Svalduz E., Visti dall’acqua: i disegni del «far la città» e la manutenzione urbana, in Fare la città. Salvaguardia e manutenzione urbana a Venezia in età moderna, a cura di S. Zaggia, Milano 2006, p. 81 nota 30.
37 Venetia cità nobilissima, p. 232r. Nell’edizione curata da Martinioni (Venezia 1663) manca qualsiasi accenno in merito: i vani dell’Antichiesetta e della Cappella ricordati da Stringa sono però esclusi dalle sue integrazioni al testo di Sansovino.
Sorge l’inevitabile dubbio che il «gran quadrone» ricordato da Stringa sia l’esito dell’in-carico iniziale, ossia la registrazione della Terraferma dichiarata in fieri da Francesco Sanso-vino, piuttosto che la redazione della carta di sintesi commissionata nel 1586.
giuliana mazzi32
opportuni potevano infatti risultare materiali aggiornati e di rapida con-sultazione.
Politiche di conoscenza e professionalità
La pratica di indagini preliminari agli interventi previsti sul territorio con l’ausilio di registrazioni grafiche era stata avviata dalla Repubblica fin dall’indomani dell’annessione della Terraferma. Si pensi, per esempio, alla valutazione del Veronese come punto chiave della difesa contro i Visconti attuata a partire dal 1406 (con la collaborazione di un pittore, Martino da Verona, incaricato della redazione di una carta) e concentrata sul castello di San Felice a Verona, su Peschiera, su Valeggio, sul Serraglio, su Nogarole e su Soave, o alle analisi sulla linea del Livenza38. Del resto, fin dalla fine del XIII secolo, Venezia era intervenuta per la tutela dell’assetto idraulico dell’ambiente lagunare minacciato dagli interramenti con operazioni di indagini preliminari condotte da commissioni straordinarie composte da politici, da tecnici e da disegnatori, inseriti tra i funzionari per la redazione dell’indispensabile documentazione grafica39. Ne è probabile testimonian-za la pianta di Venezia pervenuta in più copie (la più nota (tav. 12) è quella inserita nella Chronologia Magna (1346) di fra Paolino Minorita) da un originale del XII secolo eseguito da un perito milanese, che riporta rii e canali e che Schulz suggerisce dovuta alla necessità di registrare e garantire i diritti pubblici di passaggio40.
Venezia, rispetto agli altri stati europei, probabilmente proprio per i particolari problemi connessi alla sua stessa salvaguardia, si pone per tem-po, in un confronto con le altre realtà italiane e europee, all’avanguardia nei campi della produzione cartografica, sia manoscritta che a stampa (una volta che di questa divenne possibile l’attuazione41), anche tenendo conto
38 G. Mazzi, Agli esordi della difesa. I primi interventi della Serenissima nei settori meri-dionali dello stato, in «L’ambiente storico», 1987, Il territorio e la guerra, 10-11, pp. 16-20; M.E. Mallet, The military organisation of a Renaissance State. Venice c. 1400-1617, I, c. 1400-1508, Cambridge U.K. 1984 (trad. it. L’organizzazione militare di Venezia nel Quat-trocento, Roma 1989, pp. 117, 123.)
39 G. Caniato, Introduzione, in G. Rompiasio, Metodo in pratica di sommario o sia compilazione delle leggi, compilazioni & ordini appartenenti agl’Illustrissimi & Eccellentissimi Collegio e Magistrato alle Acque, a cura di G. Caniato, Venezia 1988, p. 16.
40 Schulz, La cartografia, p. 25 e p. 54 nota 60.41 Ci si riferisce non tanto alla pianta prospettica di Venezia delineata da Jacopo de
Barbari o alle edizioni veneziane del Fasciculus temporum di Werner Rolewink (1479) e del Supplementum chronicarum di Jacopo Foresti (stampato a partire dal 1486), quanto alla
governo del territorio e cartografia veneta 33
delle ovvie difformi implicazioni che le hanno determinate. La “pratica” del controllo ha cioè saputo tradursi anche nella capacità di soddisfare le curiosità del collezionismo geografico del XVI secolo. Un’analoga ricchez-za di testi cartografici risalenti al XV secolo sembra riguardare soltanto l’Inghilterra e i Paesi Bassi42. Nel ducato di Savoia, a titolo di esempio, la produzione di documenti sulle particolarità orografiche, sugli insediamen-ti (e la loro tipologia), sui collegamenti stradali sembra iniziare soltanto nell’ultimo decennio del Cinquecento43.
La qualità formale dei documenti redatti nella Repubblica è probabil-mente dovuta all’impiego di pittori per la redazione del disegno finale.
Nel Quattrocento (ma anche nel Cinquecento) alcuni disegnatori sono conosciuti soltanto come pittori44 e pittore, d’altronde, è Jacopo de Bar-bari45.
Si è già accennato a Martino da Verona (un epigono di Altichiero) inca-ricato del rilievo del Serraglio del Mincio. Nicola Giolfino (allievo di Libe-rale da Verona e fortemente influenzato da Lorenzo Lotto) chiede nel 1545 il compenso per una carta del territorio veronese eseguita sulla base di ana-lisi dirette («haver io cavalcato tutto il teritorio predito a parte a parte»)46; nel 1555 registra su richiesta del podestà il settore di Verona compreso tra i portoni della Bra e l’attuale via Scalzi e si tratta probabilmente del «Ni-cola Pictore» incaricato negli anni trenta del secolo dal Consiglio veronese di redigere un disegno informativo sulle acque del Vicentino47. A Paolo
pubblicazione delle raccolte di piante di città edite a Venezia allo scadere del Cinquecento. Vedi in proposito almeno Nuti, Ritratti di città, pp. 62-64 e 193-202.
42 Cfr. P.D.A. Harvey, Local and Regional Cartography in Medieval Europe, in The hi-story of cartography, I, Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean, ed. by J.B. Harley and D. Woodward, Chicago and London, 1987, pp. 464-501.
43 Fortezze «alla moderna» e ingegneri militari del ducato sabaudo, a cura di M. Viglino Davico, Torino 2005.
44 Sul rapporto arte/geografia/corografia vedi almeno L. Nuti, Misura e pittura nella cartografia dei secoli XVI-XVII, in «Storia urbana», 1993, 62, pp. 5-34.
45 Sull’attività di Jacopo de’ Barbari come pittore e come autore di disegni per incisioni in rame e per xilografie cfr. da ultimo S. Ferrari, Jacopo de Barbari: un protagonista del Rinascimento tra Venezia e Durer, Milano 2006 (per la pianta prospettica alle pp. 38-41, 150-154). Sulla pianta vedi anche gli interventi di Romanelli, De Seta, Schulz (soprat-tutto), Falchetta, Masciantonio e Guerra, Balletti, Monti, Livieratos, Boutoura in A volo d’uccello.
46 G.B. Biadego, I Golfino pittori e una scrittura inedita di Michele Sanmicheli, in «Nuo-vo Archivio Veneto», IV (1892), pp. 43-45.
47 Archivio di Stato di Verona, Archivio antico del Comune, Atti del Consiglio, reg. 75, c. 169r. Cfr. Mazzi, Cartografia e organizzazione del sapere tecnico, p. 53 nota 6. Per un’analisi
giuliana mazzi34
Farinati (o alla sua bottega) spetta una pianta di Palmanova preparata tra il 1593 e il 159448. È inoltre nota l’attività di Giovanni Caroto e di Cri-stoforo Sorte. A Vicenza (molto probabilmente episodi analoghi ritornano in tutti i centri del dominio) nei primi decenni del XVI secolo Giovanni Speranza de’ Vaienti (formatosi nella bottega di Bartolomeo Montagna) è incaricato dai rettori di affiancare gli ingegneri per la redazione di una pianta della città da inviare a Venezia e di eseguire una copia di un disegno del Vicentino. A Benedetto Montagna (figlio di Bartolomeo) sono affidati incarichi analoghi, anche di rilevamento diretto. Nel 1575 Girolamo da Ponte (omonimo del figlio di Jacopo Bassano) è pagato per un rilievo di tutto il Vicentino inviato poi a Venezia49. Giambattista Pittoni (conosciu-to soprattutto come autore di vedute di rovine romane date alla stampa) stende a partire dal 1579 il disegno della pianta prospettica da inoltrare a Roma per la Galleria delle Carte Geografiche50.
dell’area di corso Porta Nuova sul foglio di Giolfino in rapporto anche alla documentazio-ne visiva fornita dai disegni di Caroto e di Paolo Ligozzi cfr. E. Svalduz, Venezia, Verona e Palmanova nel secondo Cinquecento: spunti per una comparazione, in I grandi cantieri del rinnovamento urbano: esperienze italiane e europee a confronto (secoli XIV-XVI), a cura di P. Boucheron e M. Folin, Roma 2011, pp. 237-254.
48 E. Svalduz, Architettura per diletto. Alcune considerazioni sui disegni, in Paolo Farinati 1524-1606. Dipinti, incisioni e disegni per l’architettura, catalogo della mostra, a cura di G. Marini, P. Marini, F. Rossi, Venezia 2005, pp. 39-41; E. Svalduz, S. Zaggia, Inventioni di fortezze, ivi, pp. 71-75.
Altri pittori veronesi sono conosciuti per interventi in ambito cartografico: si tratta però della trasposizione nel disegno di presentazione di rilievi eseguiti da altri (Girolamo Andrioli da una registrazione di piazza Erbe a Verona eseguita da Bernardino Marchesi «publico perticatore») e di prove nel genere della veduta (Paolo Ligozzi): per un’informa-zione di massima su quei testi grafici cfr. G. Mazzi, La cartografia: materiali per la storia urbanistica di Verona, in Ritratto di Verona, a cura di L. Puppi, Verona 1978, p. 548 (n. 11) e pp. 571-572. Paolo Ligozzi è autore nei primi decenni del Seicento di una veduta prospettica di Verona conosciuta soltanto nella ristampa settecentesca: si muove quindi nell’ambito di un genere articolato su capacità di resa prospettica (insite nella professione di un pittore) per la realizzazione di schizzi per le facciate di edifici e sulla conoscenza di un territorio che, nel caso di Verona, era garantita dalla documentazione disponibile, sia a stampa che manoscritta, di rilievi planimetrici di massima.
49 Fasolo, Notizie di arte, pp. 288-292.50 Cfr. la scheda di Donata Battilotti in Palladio, catalogo della mostra, a cura di G.
Beltramini e H. Burns, Venezia 2008, pp. 360-361, con bibliografia. La data dei rilievi che hanno portato alla redazione finale è ancora incerta: Ackerman
(Palladio’s Vicenza: a Bird’s Eye Plan of c. 1571, in Studies in Renaissance and Baroque Art Presented to Antony Blunt, London, New York 1967, pp. 53-61) identificava per le opera-zioni di rilevamento gli anni intorno al 1571, confermati da Mazzi, Dal simbolo all’imma-gine, p. 133 (si avverte che nella fase di stampa del catalogo sono cadute alcune righe di
governo del territorio e cartografia veneta 35
Miniatori, infine, sono impiegati ancora nel Seicento, sia pure come figure di secondo piano all’interno dei gruppi di tecnici incaricati di rilievi territoriali e probabili supporti degli stessi per la redazione dei disegni di presentazione51. Nel corso del Cinquecento, infatti, soltanto le magistratu-re locali sembrano rivolgersi con continuità ai pittori, mentre le magistra-ture centrali della Serenissima (Savi ed Esecutori alle Acque, Magistrati ai Beni Inculti, Provveditori alle Fortezze, Provveditori all’Adige ecc.) cercano professionalità più specifiche e mirate, di provata esperienza in problemi di statica, di idraulica e di rilievo52. Ovviamente con eccezioni, come rivelano i casi di Paolo Farinati, impiegato dai Provveditori alle Fortezze, o dello stesso Cristoforo Sorte, la cui carriera all’interno delle magistrature subisce frequenti battute d’arresto.
I pittori, d’altronde, erano in grado di eseguire operazioni di rilievo alla portata di chiunque possedesse quelle cognizioni di geometria che erano illustrate nei testi di matematica e nei trattati militari53 o per lo meno di portare a una complessiva immagine finale (il disegno di presentazione) materiali cartografici redatti da altri. A Venezia è significativa, infatti, l’at-tività editoriale in ambito scientifico: si ricordi la pubblicazione nel 1494 della Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità e nel 1509 di De Divina Proportione, entrambi di Luca Pacioli.
Il linguaggio della pittura applicato alla cartografia, così almeno come lo enuncia Cristoforo Sorte, sottende a Cinquecento avanzato il manteni-mento dei metodi in uso prima delle novità introdotte da Giacomo Gastal-di (per due anni ingegnere presso i Savi ed Esecutori alle Acque54) e da Sil-
testo determinando l’incomprensione di alcuni passaggi); Barbieri (La pianta prospettica di Vicenza del 1580) suggeriva invece il 1579 proponendo misurazioni condotte ex novo da più squadre di perticatori coordinati da Giandomenico Scamozzi, padre di Vincenzo.
51 Cfr. G. Mazzi, L’insegnamento dell’architettura: dalla scuola del Cerato al corso per ingegneri-architetti, in Istituzioni culturali, scienza, insegnamento nel Veneto dall’età delle Ri-forme alla Restaurazione, Atti del convegno di studi (Padova, 28-29 maggio 1998), a cura di L. Sitran Rea, Trieste 2000, pp. 191-192 in particolare nota 3.
52 Cfr. Mazzi, Cartografia e organizzazione del sapere tecnico, pp. 53-58. Sul tema della cartografia impiegata per la salvaguardia e il recupero vedi almeno Fare la città, in partico-lare il saggio di Svalduz.
53 Schulz, La cartografia, pp. 19-20. 54 Giacomo Gastaldi è autore, con Giambattista Ramusio, anche dei disegni per le
mappe relative all’Africa e al Sud America – del 1549, dipinta su tela da Vitruvio Buon-consiglio –, all’Asia e al Nordamerica, del 1553, per la sala dello Scudo (già delle Mappe) in Palazzo Ducale a Venezia. Lo scopo era quello di soddisfare le curiosità geografiche e di sottolineare il merito dei Veneziani nelle scoperte geografiche: ancora una volta autocele-lebrazione, dunque: cfr. Schulz, La cartografia, p. 107. Florani (Cycles of Painted Maps, p.
giuliana mazzi36
vio Belli, nominato proto alle acque subito dopo la pubblicazione del Libro del misurar con la vista, edito nel 1565. Sono infatti metodi che escludono la proiezione di una griglia astratta di misure sul territorio, pur assicuran-do al disegno finale un’alta qualità formale. Non a caso Belli contesta una mappa (perduta) di Sorte con valutazioni negative sul rilevamento riprese da Giovanni Antonio Rusconi, allievo di Tartaglia55.
Corografia e geografia
Tali annotazioni meglio si chiariscono nel confronto tra la pergamena sul Veronese (che testimonia una svolta nei modi della rappresentazione in parte intuibile anche nel pressoché contemporaneo disegno del Cremasco) e alcuni testi quattrocenteschi che hanno per oggetto estese realtà territo-riali e che la storiografia ritiene redatti a scopo militare.
Sembra però opportuno rivedere tale destinazione, che John Hale56 esclude per la pergamena di Istanbul («a generalized decorative comme-moration of the Republic’s amassment of cities and towns on the main-land57») e che – alla luce della sue considerazioni, con cui concordo –, sembra opportuno declinare anche per gli altri documenti. Questi possono aver contribuito a impostare campagne militari suggerendone i parametri strategici. Le informazioni sembrano però insufficienti a organizzare, se non in linea di massima, i percorsi degli eserciti. I dati necessari vertevano infatti sulla padronanza dei dettagli topografici (percorsi e natura delle strade, presenza di ponti, di chiuse e di rapide, esistenza di passi, di disli-velli e di paludi), sulla conoscenza delle distanze, sulle difficoltà o meno di
830) le ritiene ancora esistenti, sia pure pesantemente restaurate da Francesco Grisellini nel 1762. Sembra invece che le mappe siano state completamente rifatte “in stile” dal naturalista, economista e letterato veneziano e da Giustino Menescardi (Milano 1720 ca.-Venezia 1776, pittore di ambito tiepolesco e poi docente all’Accademia di Parma), modi-ficando con aggiornamenti e aggiunte i modelli cinquecenteschi (H. Walter, Un ritratto sconosciuto della “Signorina Clara” in Palazzo Ducale di Venezia: nota sulle mappe geografiche di Giambattista Ramusio e Giacomo Gastaldi, in «Studi umanistici piceni», XIV (1994), pp. 207-208 e Gallo, Le mappe geografiche, pp. 61-113, in particolare pp. 75-76). Su Mene-scardi vedi almeno G. Knox, The Drawings of Giustino Menescardi, in «Arte Documento», X (1995), pp. 208-220 e G. Pavanello, Giustino Menescardi frescante a palazzo Crotta, in «Arte Documento», XIII (1999), pp. 278-283.
55 Schulz, La cartografia, pp. 81-83, p. 93 note 15-16. 56 J. Hale, Warfare and Cartography. Ca. 1450 to ca. 1640, in The history of cartography,
pp. 719-737.57 Ivi, p. 721.
governo del territorio e cartografia veneta 37
accesso ai punti fortificati, sulla loro posizione geografica, sulle tipologie costruttive fino alle caratteristiche delle murature e alla dotazione di armi e, non certo ultime, sulle possibilità di approvvigionamenti. Si tratta di elementi che di solito erano individuati con l’impiego di guide locali e con ricognizioni giornaliere e i cui esiti non sembrano esser stati tradotti, come prassi, in forme grafiche.
Ne consegue che non sembra applicabile la definizione di “carta mi-litare” a documenti grafici che consegnano informazioni multiple anche, inevitabilmente, di carattere militare.
Nel 1440 è redatta da Giovanni Pisato, presumibilmente in ambito veneto, una rappresentazione di parte della Lombardia e del Veronese: i limiti sono Milano, Mantova e Verona (tav. 4). La pergamena restitui-sce numerosi centri abitati (i principali e molti di secondaria importanza, per un totale di oltre duecento toponimi, con l’indicazione delle diverse appartenenze politiche grazie al disegno degli stemmi dei Visconti, della Serenissima e dei Gonzaga58), fiumi (ponendo anche la segnalazione del-le rotte, provocate nel 1438, di Castagnaro in prossimità di Isola della Scala e di Malopera all’altezza di Castebaldo), collegamenti tra i fossati bagnati delle cinte difensive con i corsi d’acqua più prossimi (informazio-ne, questa, di carattere militare), laghi, boschi, ponti (sia in legno che in muratura, altra nota di tono militare), indicazioni stradali (per il cui trac-ciamento Marinelli59 suggeriva un’integrazione posteriore, poi confermata da Baratta), annotazioni in grafie diverse. Questa redazione presenta di fatto un’impostazione analoga a quella degli itinerari su lunghe distanze, dove era posta attenzione sugli “oggetti” più convenienti per l’uso cui era destinato il disegno60 e testimonia una continuità d’uso della pergamena,
58 Il metodo non è ovviamente di invenzione: anche nei portolani medievali i centri del commercio erano indicati con il proprio vessillo. Cfr. Schulz, La cartografia, p. 11. Il procedimento ritorna anche nella pergamena del Cremasco (vedi più avanti nel testo).
59 Saggio di cartografia della regione veneta, a cura di G. Marinelli, Venezia 1881, p. 2 n. 5; sulla pergamena cfr. (oltre, ovviamente e soprattutto, M. Baratta, La carta della Lom-bardia di Giovanni Pesato, in «Rivista Geografica Italiana», 1913, pp. 159-163, 450-459, 577-593), A. Scotti, La cartografia lombarda: criteri di rappresentazione, uso e destinazione in Lombardia. Il territorio, l’ambiente il paesaggio. L’età delle riforme, a cura di C. Pirovano, Milano 1983, p. 37; A. Manno, Giovanni Pisato, Carta del territorio fra Verona e Milano, in Palmanova fortezza d’Europa 1593-1993, catalogo della mostra, a cura di G. Pavan, Ve-nezia 1993, p. 514; E. Turri, Giovanni Pisato, Carta della Lombardia, in Venezia da stato a mito, catalogo della mostra, a cura di A. Bettagno, Venezia 1997, pp. 325-326; e C. Pirova-no, Giovanni Pisato, Carta della Lombardia, in Segni e sogni della terra. Il disegno del mondo dal mito di Atlante alla geografia delle reti, catalogo della mostra, Milano 2001, p. 174.
60 Sul tema vedi almeno M. Milanesi, Il viaggio, la scoperta, la carta, in Segni e sogni
giuliana mazzi38
che va ben oltre la data di redazione, estendendosi almeno fino all’attacco del secolo successivo61. I nomi delle località, non tutti scritti con la stessa grafia, in qualche caso sono stati corretti; una sottile linea nera sormontata da una serie di «m» è stata aggiunta per indicare l’andamento del Serraglio tra Villafranca e Valeggio sul Mincio (la muraglia fortificata che divideva il Veronese dal Mantovano), omesso nella stesura originaria; la mancanza di indicazioni sulla rete stradale è stata risarcita con le indicazioni delle di-stanze parziali tra due centri; la dipendenza politica è stata aggiornata con il ridisegno degli stemmi oppure con didascalie. Tutti elementi (la segnala-zione di ponti e della loro struttura, l’accurata idrografia, le informazioni sulle zone boscose, l’alto numero dei centri abitati, l’indicazione dei fossati bagnati, le distanze tra i centri e il tracciamento delle strade principali, i cambiamenti nelle soggezioni politiche) che sembrano, in effetti, per-mettere una prima definizione dei percorsi di eserciti in zone soggette a mutamenti di confine. Il testo grafico ha però caratteristiche non diverse dalla Carta [definita] militare della Lombardia della Bibliothèque Natio-nale di Parigi (tav. 3) di datazione incerta62, che ritrae i territori compresi tra Milano e il lago di Garda, e il documento, sempre pergamenaceo, che registra i territori della Repubblica conservato al Topkapi Sarayi Museum di Istanbul (tav. 6a e b), di cui Hale esclude appunto una redazione a scopi militari63. La qualità dell’informazione è analoga. I centri sono indicati con simboli riconducibili soprattutto alle loro dimensioni e alle loro po-tenzialità difensive espresse dal risalto assegnato alla struttura fortificata (per qualche città è possibile riconoscere una minima aderenza alla realtà urbana) ed è attenta la resa dell’idrografia; nelle pergamene di Istanbul e di Parigi sono indicate le strade principali ma manca l’indicazione dei boschi; l’orientamento è correttamente con il nord in alto nelle pergamene di Pa-
della terra, pp. 131-132, 138-139 e Schulz, La cartografia, p. 11.61 Baratta (La carta della Lombardia, p. 588) ha notato scritte riferibili ad avvenimenti
degli anni 1499-1500.62 Almagià (Monumenta, p. 90a) la data all’epoca delle guerre veneto-viscontee del
1437-1441, Scotti (La cartografia lombarda, p. 37) la collega alle spedizioni in Italia di Carlo VIII, e quindi agli anni novanta del secolo. Sulla pergamena vedi anche C. Pirovano, Carta Militare della Lombardia, in Segni e sogni della terra, p. 174 con bibliografia.
63 Gallo (A Fifteenth Century Military Map of the Venetian Territory of Terraferma, in «Imago Mundi», 12, 1955, pp. 55-57) la propone antecedente al 1496 e redatta all’epoca delle scorribande turche di fine Quattrocento. Hale, Warfare and Cartography, p. 721.
Vedi anche Concina, Tempo novo, pp. 39-40. La pergamena è stata pubblicata a colori in Concina, La transizione, in E. Concina, E. Molteni, La fabrica della fortezza. L’architet-tura militare di Venezia, Modena 2001, p. 56 e p. 58.
governo del territorio e cartografia veneta 39
rigi e di Istanbul (esito delle conoscenze tolemaiche), con l’ovest in alto64 in quella di Pisato.
Aspetti non dissimili da quelli presenti nelle pergamene or ora ricordate presentano anche le restituzioni del Padovano del 1449 e del 1465, il cui obiettivo era però quello di una rappresentazione celebrativa di luoghi di un territorio il cui fulcro era Padova, la città capoluogo. Non a caso la pergamena più tarda (tav. 5) è affidata per la messa in forma a un pittore, sicuro garante dell’estetica dell’immagine e in ogni caso esonerato dalla responsabilità della registrazione cartografica. Padova è infatti posta al cen-tro (nella mappa di Maggi al centro di una circonferenza che racchiude tutto il territorio) con un’evidente esplicazione del suo volto pubblico (le mura, qualche chiesa, i corsi d’acqua) che rielabora in una forma urbis non compatta ed emblema di se stessa la rappresentazione delle città nei sigilli medievali65.
Caratteristiche abbastanza prossime a quelle notate nella carta dell’Al-magià sono invece leggibili nella mappa del Cremasco conservata al Museo Correr di Venezia (tav. 8a e b), precedente al 146966, che ritrae un’area ai
64 Si tratta di un orientamento anomalo, presente anche nella pergamena che ritrae il lago di Garda (vedi più avanti nel testo) posteriore al 1383: nella tradizione medievale in alto poteva essere posto l’est (la direzione di Gerusalemme), per influenza araba nel corso del Quattrocento il sud: cfr. N. Broc, La géographie de la Renaissance. 1420-1620, Paris 1986 (trad. it. La geografia del Rinascimento. Cosmografi, cartografi, viaggiatori. 1420-1620, Modena 1996, p. 42).
65 Sulla persistenza nelle rappresentazioni di città dell’impostazione iconografica dei sigilli medievali cfr. Schulz, La cartografia, pp. 34-36 e soprattutto Nuti, Ritratti di città, pp. 43-67. Sulla genesi dei ritratti urbani vedi anche la sintesi in Nuti, La rappresentazione della città, pp. 3-5.
66 Il disegno è stato pubblicato e analizzato da C. Verga, Crema città murata, Roma 1966 (riedito, con la medesima numerazione nelle pagine, in Crema e le sue difese, Atti del convegno, a cura di C. Piastrella e L. Roncai, Crema 2000), pp. 14-15, 19; vedi anche G. Caniato, [Mappa del territorio cremasco], in A volo d’uccello, pp. 123-125. Verga lo data ai primi anni della seconda metà del secolo; Bettinelli Spotti e Roncai (Castelli e difese della Provincia di Cremona, Cremona 1992, p. 189) al 1465/1470; Caniato agli anni novanta del secolo. Sul disegno vedi anche Crema e le sue difese, passim.
La pergamena sembra precedente al 1469, anno in cui fu concluso l’ampliamento del castello di porta Serio che portò all’inglobamento nella rocca della porta, ritratta staccata e collegata da un muro merlato alla fortezza (cfr. Verga, Crema città murata, p. 44). È ovvia-mente successiva al rafforzamento in muratura dei rivellini costruiti inizialmente in terra (non ancora attuato nel 1454) e al tracciamento del fossato esterno alla cinta difensiva tra porta Ombriano e porta Ripalta (deciso nel 1453): cfr. C. Piastrella, Le difese di Crema nella documentazione della Comunità, in Crema e le sue difese, pp. 34-37.
Verga (Crema città murata, p. 14) notava l’assenza quasi sistematica degli edifici di culto e la presenza di indicazioni per i luoghi di foraggiamento, di torri isolate di avvista-
giuliana mazzi40
limiti della compagine territoriale, una vera e propria enclave67 «situata nelle visere del Statto di Milano», come ricorderà Francesco Tensini nel 161868. La stesura sembra legata a informazioni di massima su quei ter-ritori (veneziani a partire dal 1449 e delimitati, sulla pergamena, da una sottile linea rossa) e sui confini con il ducato milanese, richiamato dal simbolo – sui centri esterni a quella linea – del “biscione”, il cui signifi-cato è esplicitato nella scritta in calce. La rappresentazione, simbolica, dei centri abitati è connessa alla loro forma/funzione all’interno del territorio: gruppi di case, chiese (nel caso di importanti complessi abbaziali fortificati, come Abbadia Cerreto), torri, centri murati (Lodi, per esempio) e castelli. Il disegno di questi ultimi sembra abbastanza connesso alla situazione re-ale: nelle rese particolari di alcuni episodi e nell’indicazione dei materiali sulla struttura difensiva di Crema (parzialmente rinnovata in quegli anni) i modi sembrano analoghi a quelli impiegati nella carta del territorio vero-nese. La raffigurazione diventa più “dettagliata” nella città-capoluogo per la quale preciso sembra il disegno della cortina medievale, del castello di porta Serio (probabilmente nella struttura avviata da Federico Corner nel 146069, dei torrioni in muratura antistanti alle porte (rivellini) collegati da «repari»70 e del sistema dei fossati bagnati; mancano le indicazioni sulle strade (ma sono rappresentati i ponti) e sulla vegetazione, e sono indicate le distanze da Crema, segnate a fianco dei nomi dei singoli centri71.
mento, di abbazie fortificate (Abbadia Cerreto, con la doppia bastia a difesa del traghetto sull’Adda e fronteggiante Cavenago d’Adda; Barbata).
Il termine bastia (o bastita) indica una fortificazione provvisoria, e spesso improvvisa-ta, di forma quadrata o circolare in legno, in pietra o in terra di un accampamento, oppure situata al di fuori dalle mura di una città o intorno ai castelli.
67 Crema era interamente circondata dal ducato di Milano e collegata ai territori della Repubblica attraverso lo stretto percorso dello Steccato (o strada Cremasca): cfr. G. Villari, Crema nel sistema difensivo dello “stato da terra”. La situazione quattrocentesca, in Crema e le sue difese, p. 54.
68 J. Hale, Post-Renaissance Fortification. Two Reports by Francesco Tensini on the Defence of the Terraferma (1618-1632), in L’architettura militare veneta del Cinquecento, Milano 1988, p. 14. Cfr. per la visualizzazione dell’enclave il Disegno de confini di parte del Brescia-no, intiero Comasco, piano del Bergamasco e stati esteri del 1714 pubblicato in G. Colmuto Zanella, F. Rampinelli, La frontiera bergamasca e l’«isola» di Crema nei rapporti tra Venezia e Milano (secoli XVI-XVII), in La difesa della Lombardia spagnola, Atti del convegno di studi, a cura di G. Colmuto Zanella e L. Roncai, Cremona 2004, p. 172.
69 Itinerario di Marin Sanuto per la terraferma veneziana nell’anno MCCCCLXXXIII, Padova 1847 (rist. anast. Milano 1981), p. 85.
70 Il termine, in lingua veneta, indica un’opera difensiva di terreno generalmente costi-tuita da fosso, argine, palizzata.
71 Per una lettura dettagliata, anche in rapporto alle strutture difensive, cfr. (oltre a
governo del territorio e cartografia veneta 41
Tutti questi disegni territoriali sono la risposta a esigenze anche dis-simili che non possono essere confuse, sovrapposte o interpretate come intercambiabili: per la loro “forma” però rientrano tutti nel campo della corografia, piuttosto che della geografia.
Nel Quattrocento persiste infatti a lungo l’idea di corografia intesa come semplice descrizione di aspetti geografici e pertanto realizzabile con il solo esercizio dell’arte del disegno, e quindi della pittura. Del resto il termine indicava carte in scala ridotta con abbondanti particolari topografici. In essa, come ha ricordato Lucia Nuti a proposito della rigorosa distinzione di Tolomeo, il linguaggio utilizzato è pittorico-qualitativo, mentre nella geo-grafia (che si riferisce alle carte in scala maggiore e persegue altri livelli di conoscenza e altre finalità) è matematico-quantitativo72. La scoperta della prospettiva, il recupero della tradizione tolemaica (e quindi l’impiego delle coordinate a seguito dell’importazione da Costantinopoli del manoscritto illustrato della Geografia), gli scritti di Leon Battista Alberti (che descrive per la prima volta la tecnica della triangolazione), di Piero della France-sca, di Leonardo e di Raffaello spostano progressivamente – in un lungo processo che si inoltra nel Cinquecento – l’esercizio delle registrazioni (sia urbane che territoriali) nella sfera della geografia e dunque della cartografia realizzata sulla base di strumenti di misura, di calcoli precisi, di punti di stazionamento da cui traguardare, di misurazioni sul campo73. Ed è questo l’ambito a cui si accosta la carta dell’Almagià nel riportare dati geografici e topografici in misura più completa di quanto è possibile “leggere” negli altri testi grafici prodotti dalla cultura del rilievo praticata nella Repubblica nel corso del XV secolo.
La carta dell’Almagià
Nelle sue Osservazioni sulla pittura, edite nel 1580, Sorte scriverà:
Ho io adunque essa Corographia [del Veronese, stilata per il giureconsulto Bartolomeo Vitali, cui Cristoforo indirizza lo scritto] situata a i quattro venti maestri, Levante, Ponente, Ostro & Tramontana […]. In oltre ho posta detta
Verga, Crema città murata, p. 19) Caniato, [Mappa del territorio cremasco].72 Nuti, Ritratti di città, pp. 24-25.73 Schulz, La cartografia, pp. 18-20, 31-32; Nuti, Ritratti di città, pp. 23-29; H. Ballon,
D. Friedman, Portraying the City in Early Modern Europe: Measurement, Representation, and Planning, in The History of Cartography, pp. 680-704.
giuliana mazzi42
Corographia con le sue giuste misure & distanze in Pianta ma gli edificii, cioè, le cittadi, castella & ville con le montagne & colline ho poste in mappa & in piedi, ove Tramontana è di sopra, & perpendicolarmente gli è Ostro, & per traverso Levante & Ponente; il che ho stimato necessario per far che si cono-scano i Siti. Percioche havendola à questo modo posta, si ponno vedere tutti i fiumi, le cittadi, le castella, & le ville per tutti i fondi & piani delle valli fra le montagne, dellequali ho alcuni siti disegnati in modo che i prattici de’ loro paesi possono conoscere i luoghi senza leggere le lettere de’ loro nomi74.
Esprime così il concetto di corografia applicato a scala territoriale, ossia il riconoscimento dei luoghi con rappresentazioni identificabili, prossime al ritratto ma di genesi metrica e pertanto affidabili sotto il profilo della misura.
Il sistema (più maturo e rigoroso, ma occorre tener conto dello scarto temporale) sviluppa quello impiegato nella pergamena del Veronese, che indica una svolta nei modi della rappresentazione rispetto ai testi quat-trocenteschi pervenuti: una svolta in parte attuata anche in testi grafici pressoché contemporanei, come la registrazione del Cremasco.
La macroscopia di Verona non pare dettata da motivazioni analoghe a quelle riscontrabili nei disegni per Padova, dove la maggior dimensione della città sottolinea e rimarca il ruolo del capoluogo rispetto al contado seguendo impostazioni orbicolari di matrice neoplatonica75, quanto dalla necessità di tradurre in maniera leggibile il disegno della città. La rappre-sentazione non si limita alle mura e alla scelta delle emergenze architetto-niche viste in prospettiva. Registra la compagine urbana quasi insula per insula, con i prospetti di case, palazzi e chiese (generici e tutt’al più sotto-lineati da una maggior dimensione) ribaltati sul piano della pianta lungo i reticoli viari ed è attenta alla restituzione dei borghi e delle abbazie extra moenia demoliti con il guasto76. Questo modo di registrazione anticipa la
74 Osservationi nella pittura di M. Cristoforo Sorte al Magnif. Et Eccel. Dottore et Cavalie-re il Sig. Bartolomeo Vitali, Venezia 1580, p. 7r-v. Nuti, Misura e pittura, p. 23, p. 27.
75 Cfr. H. Baron, La crisi del primo Rinascimento italiano. Umanesimo civile e libertà repubblicana in un’età di classicismo e di tirannide, Firenze 1970, p. 216 ss.; L. Gambi, La città da immagine simbolica a proiezione urbanistica. Introduzione, in Storia d’Italia, VI, Atlante, Torino 1976, p. 217 ss. Per una lettura in tal senso delle immagini di Padova nelle pergamene del territorio padovano: L. Puppi, Appunti in margine all’immagine di Padova e suo territorio secondo alcuni documenti della cartografia tra ’400 e ’500, in Dopo Mantegna. Arte e Padova e nel territorio nei secoli XV e XVI, catalogo della mostra, Milano 1976, pp. 163-164.
76 Si veda il saggio di Stefano Lodi. Guasto è un termine della lingua veneta impie-
governo del territorio e cartografia veneta 43
rappresentazione, successiva di qualche decennio, che privilegia il disegno delle sole città avulse dai territori di riferimento, redatto soprattutto a par-tire dalla fine del secolo, ma con precedenti negli schemi urbani disegnati a corredo dei trattati, dalla Sforzinda di Filarete agli studi nei codici di Francesco di Giorgio Martini. Esempio a tutti noto è la pianta di Imola del 1502 di Leonardo77 (tav. 12).
Caratteristiche pressoché comuni a tutte le pergamene quattrocente-sche sono le indicazioni dei venti e quelle relative alle distanze (risolte in vari modi): nella carta dell’Almagià la posizione dei venti e l’impiego di tabelle (che, poste intorno alla città capoluogo, permettono una rapida in-dividuazione del dato) rispondono però ai dettami del decreto, che chiede-va appunto ai rettori: «designari faciant terram locum et districtum suum per signa ventorum et orientis et ponentis, castella, flumina, planiciem et distantiam de loco ad locum et loca vicina nobis et distantiam eorum».
Nella pergamena del Veronese78 mutano i segni per gli abitati, che di-ventano ritratti abbastanza realistici (sia pure nel segno della sintesi) nella rappresentazione dei luoghi fortificati (“piccole città” e rocche) e nella tra-smissione degli edificati lungo le strade. Questi sono resi, frequentemente, con la medesima tecnica adottata per la visualizzazione dei fabbricati nel centro capoluogo, ossia prospetti ribaltati sul piano della pianta, e talvolta
gato per indicare l’ampio spazio antistante il sistema difensivo che doveva essere tenuto sgombro da alberi e da costruzioni, sia per individuare l’avvicinarsi del nemico alla cinta muraria sia per non fornire allo stesso ripari contro il fuoco di difesa degli assediati. Nella bibliografia relativa alle fortificazioni promosse dalla Repubblica Veneta è usato come si-nonimo di spianata. Sembra che a Verona la spianata sia stata realizzata esternamente alla città per la profondità di un miglio: cfr. G. Mazzi, Il Cinquecento: i cantieri della difesa, in L’architettura a Verona nell’età della Serenissima, I, a cura di P. Brugnoli e A. Sandrini, Verona 1988, p. 136 nota 7.
77 Vedi almeno Nuti, Ritratti di città, pp. 127-128 e soprattutto D. Friedman, La pianta di Imola di Leonardo. 1502, in Rappresentare la città. Topografie urbane nell’Italia di antico regime, a cura di M. Folin, Reggio Emilia 2010, pp. 121-144. Friedman respinge l’ipotesi che ne vede una prima redazione negli anni settanta del Quattrocento per ragioni militari da parte di un ingegnere lombardo e le rielaborazione da parte di Leonardo, che l’avrebbe ridisegnata con correzioni e aggiornamenti a proiezione rigorosamente ortogonale.
78 La bibliografia di massima consultata a sostegno della lettura della carta è stata: Itine-rario di Marin Sanuto; I centri storici del Veneto, a cura di F. Mancuso e A. Mioni, Milano 1979; I centri storici del Trentino, Milano 1981; Guida d’Italia del Touring Club Italiano. Trentino Alto Adige, Milano 1976; Guida d’Italia del Touring Club Italiano. Veneto, Milano 1992; Guida d’Italia del Touring Club Italiano. Lombardia (esclusa Milano), Milano 1987.
Per approfondimenti bibliografici su singoli settori e una lettura dettagliata che, tra il resto, mette in risalto pentimenti e omissioni si veda il saggio di Varanini, Postinger e Lazzarini in questo volume.
giuliana mazzi44
planimetrie semplificate. Non mancano però rese in prospettiva. I borghi non fortificati sembrano registrati con un maggior o minor numero di case in rapporto alla loro entità fisica: edifici su entrambi i lati delle vie di comunicazione, su un solo ciglio oppure arretrati rispetto al percor-so principale, o raccolti intorno a una piazza. In qualche caso sono rese graficamente le diversità nelle tipologie abitative: come, per esempio, in alta Lessinia, oppure con l’indicazione dell’edificio più significativo di un borgo79. Sono riportati, infine, numerosi agglomerati privi di indicazioni toponomastiche, ma riconducibili alla realtà dei luoghi (le segherie a Ca-vaion, per esempio).
Nella simbologia impiegata nei testi quattrocenteschi in precedenza ricordati è possibile individuare un’aderenza molto di massima alla con-formazione reale soltanto per i centri fortificati più importanti, mentre emblemi omogenei tutt’al più di dimensione maggiore o minore a seconda dell’entità fisica dei centri cui si allude indicano i borghi privi di strutture difensive80. La maggior fedeltà alla forma reale degli insediamenti nella carta dell’Almagià è la probabile risposta all’esigenza di disporre di una «veram et particularem noticiam ad oculum et non ad opinionem alicuius» richiesta dal decreto.
La precisione (per l’epoca) nella rappresentazione delle diverse compo-nenti – vie, fiumi, borghi fortificati e non, ponti, traghetti, montagne, col-line, soprattutto per l’attuale Trentino e per l’area compresa tra la sponda veronese del lago di Garda e la Valpantena – spiega probabilmente anche le dimensioni, che ne escludono una redazione a soli scopi militari (come è stato proposto), al di là delle considerazioni di Hale sulle caratteristiche di strumenti cartografici redatti a quello scopo. Sostengono ulteriormente ta-le esclusione la mancata registrazione, nei settori ritratti in maniera meno dettagliata, di rocche e castelli attestati dalle fonti (nel caso di edifici che più non esistono), oppure attualmente testimoniati da ruderi che permet-tono la riconoscibilità delle funzioni originarie o provati dal loro effettivo esistere.
Sembra probabile che non sia stato portato a termine il disegno (forse affidato, per la qualità dell’immagine, a un pittore) che ricucisse le diverse carte preparatorie, plausibili esiti di rilievi condotti ex novo e di aggiorna-
79 Edifici porticati dotati di una torre: ad esempio a Isola della Scala, a Erbè, a Isola Rizza, a Minerbe o a Cerea ecc.
80 Sui simboli nella cartografia nelle mappe a stampa che ricalcano e sviluppano la tradizione manoscritta, cfr. C. Delano-Smith, Signs and Printed Topographical Maps, ca. 1470-ca. 1640, in The History of Cartography, pp. 528-590.
governo del territorio e cartografia veneta 45
menti di documenti a disposizione risalenti anche al periodo preveneziano oltre che alle prime fasi della dominazione veneta81. La pergamena con il Lacus Garde conservata alla Biblioteca Civica di Verona (tav. 2), posteriore al 1383 e ricca di ragguagli sull’entroterra veronese e trentino, è un esem-pio di precoci registrazioni cartografiche82 che, per quanto non pervenute, potrebbero esser state utilizzate.
La val d’Adige e i settori contermini anche non soggetti alla Dominan-te, ossia quelli dipendenti dal principato di Trento e dai conti del Tirolo sembrano le zone meglio rappresentate per orografia, idrografia, centri abi-tati, rocche e castelli.
Spesso è presentata la condizione fisica dei punti fortificati, anche con un disegno sommario (se dismessi) o in stato di rovina83. Sono indicate chiese, monasteri e abbazie, talvolta col solo segno grafico privo di no-mi84. Lungo l’Adige sono segnati i punti dei traghetti: a Ravazzone, per esempio, con una zattera sul fiume. I borghi sono rappresentati con buona precisione: basti il rimando a Nago dove, alle estremità dell’abitato (non fortificato), paiono disegnate (con la forma di archi) le porte ricordate da Marin Sanudo85.
Sembrano ben rappresentati gli aspetti naturali: per esempio, è regi-strata la distesa di massi e di pietre franate dal monte Zugna ricordata da Dante a Lavini di Marco.
81 Cfr. Mazzi, Agli esordi della difesa, passim. 82 G. Mazzi, Per una storia del territorio gardesano, in Un lago, una civiltà: il Garda, II,
a cura di G. Borelli, Verona 1983, pp. 466-467. Vedi anche V. Fainelli, Il Garda scaligero, in «Il Garda», 1927, n. 1, pp. 7-12 (che la pubblica) e E. Filippi, Carta trecentesca del lago di Garda, in Gli Scaligeri. 1277-1387, catalogo della mostra, a cura di G.M. Varanini, Verona 1988, pp. 324-325.
83 Arco è ritratta come rocca entro un recinto fortificato, priva però delle mura a difesa del borgo sottostante, ritratte nell’acquerello di Albrecht Dürer e nello schizzo nell’Itine-rario in terraferma di Marin Sanudo; Castelbarco ha una forma analoga a quella di Castel Penede, ossia con l’indicazione di un soccorso e probabilmente in una forma che richiama gli interventi della Serenissima della fine del terzo decennio del secolo. Sono anche effigiati le rocche di Chiusole (frazione di Pomarolo, sull’Adige) scomparsa con i lavori per l’au-tostrada del Brennero; di Predaia (la Pradaia che Sanudo – Itinerario, p. 95 – descriverà come «nunc è roto»?); di Nomi, che Sanudo (ibid.) dichiarerà «olim fortissimo castello»; di Castel Corno; di Lizzana (una rocca con mastio in rovina, cui Sanudo riserva la stessa descrizione di Nomi) ecc. Manca il castello di Ala. Non sempre castelli e rocche sono po-sizionati correttamente: cfr. il saggio di Varanini, Postinger, Lazzarini.
84 La chiesa di San Tommaso a sud di Arco; un’abbazia (senza nome, forse San Tom-maso) oltre l’Adige a Rovereto; la chiesa (ricordata anche in Itinerario di Marin Sanuto, p. 93) nell’isolotto nel non più esistente lago di Sant’Andrea, poi di Loppio ecc.
85 Itinerario di Marin Sanuto, p. 93.
giuliana mazzi46
La zona tra il Garda e l’Adige, montuosa nella parte settentrionale e col-linare nell’area meridionale tra l’anfiteatro morenico del Garda e lo sbocco della valle dell’Adige, presenta invece numerose discontinuità. Curata in-vece è la descrizione della riva veronese del lago e dei centri sulle pendici dei monti, mentre meno felice è la registrazione della sponda occidentale, dove manca l’indicazione dei limiti con il Bresciano86.
I punti difensivi posti lungo la riva orientale presentano la struttura di borghi cinti da mura e rinserrati intorno al porto (Garda, Bardolino, Lazise), oppure hanno il castello staccato (possibilmente in altura) con ampliamenti in borghi esterni verso il porto (Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco). Lungo la sponda meridionale sono segnate la rocca di Rivol-tella, sommariamente la struttura di Sirmione, fedelmente l’impianto di Peschiera (fig. 6)87.
Meno felice sembra la registrazione della sponda occidentale, dove non sono indicate alcune strutture fortificate (a Padenghe, a Maderno88 e sulle pendici dei monti, con la sola eccezione di Tignale), mentre i borghi sono resi in rapporto alla loro entità e, nel caso di Salò, con l’indicazione del perimetro murario89.
Nell’area montana il popolamento è distribuito tra costruzioni isolate anche a corte e piccoli borghi (di fatto contrade), indicati dalla chiesa e da gruppi (di diversa entità) di case: Caprino è forse il più consistente. In fondovalle, lungo l’Adige, si susseguono borghi analoghi, centri situati lungo la principale via di comunicazione sulla sinistra del fiume, ma ai piedi di castelli posti in altura (Avio) e rocche sui versanti90 e a sbarramento della strada (la Corvara91: fig. 5). Il sistema di rocche in altura, seguendo la
86 Sono indicati i confini nord-occidentale e settentrionale, dove sono registrati cor-rettamente i territori intorno a Rovereto acquisiti nel 1444; mancano invece gli avvisi dei limiti del Veronese rispetto al Bresciano, al Mantovano, al Vicentino e ai territori di Padova e di Rovigo.
87 Le visualizzazioni di Peschiera e di Sirmione coincidono con le descrizioni e lo schiz-zo della prima in Itinerario di Marin Sanuto, pp. 62-63, 67-68.
88 Mentre Sanudo (Itinerario, p. 88) parla di quest’ultima.89 Nell’Itinerario di Marin Sanuto (pp. 86-87) la descrizione conferma la forma tra-
smessa dalla pergamena, ma avvisa della presenza di una rocca «nunc diruta et vasta».90 Chiusa, con in basso il ponte levatoio e Rivoli (dismessa dopo il 1410), ritratta con
un segno semplificato.91 Sull’importanza, sulle due sponde dell’Adige, dei sistemi di Corvara e di Chiusa,
rispettivamente sulle rive destra e sinistra del fiume, cfr. Verona nel secolo XV: Lettera di Giorgio Sommariva a Federico Cornaro, a cura di O. Perini, Verona 1873, pp. 44-46. La fortezza di Corvara, tra Incanale e Preabocco, fu demolita alla metà dell’Ottocento (ivi, p. 45 nota 15), nell’ambito dell’ammodernamento e del potenziamento del sistema di opere
governo del territorio e cartografia veneta 47
conformazione del territorio, ritorna a Castelnuovo del Garda, dove le abi-tazioni e la chiesa sono poste ai piedi del colle dove fu costruito un castello da Gian Galeazzo Visconti.
Non mancano, oltre a segnalazioni anonime di chiese, le indicazioni sui luoghi di culto, come la S. Corona (all’epoca semplice romitorio), la pieve nei pressi di Caprino, il monastero nell’isola di Garda o la chiesa a San Vigilio.
La fascia meridionale a sud del lago presenta estese aree boschive (la selva Lugana, destinata a scomparire con il XVI secolo) e laghi (tra cui il Lagurselo), oltre i quali sono registrati come borghi murati Castellaro Lagusello e Ponti sul Mincio e, come rocca con ai piedi l’abitato, Monzam-bano. Centri di modeste dimensioni92 si susseguono fino alla linea difen-siva meridionale, il Serraglio (fig. 7) che – dotato di un profondo fossato bagnato (ovviamente artificiale, registrato nella pergamena) e rinforzato dalla rocca intermedia de la Gerla – correva da Borghetto sino ai limiti della «palude dil Grezàn»93, oltre Villafranca e la strada proveniente da Verona (la romana via Postumia) e segnava uno dei punti forti delle difese sul tormentato confine tra Veronese e Mantovano. Al di sotto della linea del Serraglio, un susseguirsi di piccoli centri, in parte sotto ai Gonzaga (tra i quali si distinguono le rocche di Goito e di Marmirolo94), si conclude con il ritratto di Mantova95.
Altri borghi, di maggiori o minori dimensioni, sono situati nella vasta area di origine alluvionale a sud di Verona caratterizzata da presenze di pa-
fisse lungo la strada del Brennero realizzato dagli Asburgo. Sulle due fortezze vedi anche F. Grimaldi, Avanzi delle fortezze venete della Chiusa e della Crovara, in «Archivio Veneto», XXIII (1882), pp. 3-10.
92 Tra questi è inserito un punto fortificato non identificato (Monto Cocolo), fatto di una rocca su di una collina con una limitata espansione esterna. Anche Custoza è ritratta nella forma di castello con mastio.
93 Itinerario di Marin Sanuto, p. 61. Manca, però, nella pergamena la registrazione del-le paludi che dai pressi di Grezzano arrivavano a Nogarole Rocca. Il che fa supporre che per quest’area possano esser stati impiegati disegni databili intorno al 1468. È questo l’anno di una parte che lamenta la conversione ad aree coltivabili delle paludi del Grezzano, tenta di imporne la riconversione a zone acquitrinose e di annullare la parziale regolamentazione del Tartaro e del Tione: Archivio di Stato di Venezia, Senato Terra, reg. 6, c. 39r.
94 La rocca di Marmirolo è circondata da un esteso anello verde, residuo delle foreste padane a latifoglie, che, come riserva di caccia dei Gonzaga, prenderà il nome di bosco della Fontana.
95 Il ritratto di Mantova è stato tratto da una registrazione della città eseguita tra il XIV e il XV secolo: cfr. anche per la lettura dell’immagine: I. Pagliari, Catalogo delle rappresen-tazioni di Mantova, in P. Carpeggiani, I. Pagliari, Mantova. Materiali per la storia urbana dalle origini dall’Ottocento, Mantova 1983, pp. 72-74.
giuliana mazzi48
ludi sempre più marcate scendendo verso sud (ma indicate con una certa sommarietà96) e dalla presenza di boschi.
I centri sono spesso circondati da un giro di alberi, evocativo delle mac-chie documentate nelle fonti e scomparse per la loro graduale trasformazio-ne in terreni agricoli: la raffigurazione risulta sovente troppo generica se la si pone in rapporto con quella impiegata per le zone boscose più settentrio-nali. Ad esempio, ad Angiari non è palese la boscaglia che esisteva a ovest dell’abitato, eliminata nel corso del Cinquecento; inoltre i boschi fluviali che si estendevano da Ronco sino all’Adige sono forse intuibili dalla sequen-za di alberature poste intorno ad alcuni paesi. Nella raffigurazione di Pisato, del resto, i boschi sono segnalati in maniera non dissimile con il disegno di alcuni alberi o di una pianta isolata di dimensioni notevoli: sembra dunque che nella pergamena siano stati ripresi sistemi grafici comunemente in uso per le aree di cui non era probabilmente disponibile una documentazione appropriata. Le imprecisioni che ritornano anche per altri settori (a sud di una ideale linea di prosecuzione del Serraglio o a est verso il Vicentino e il padovano) suggeriscono l’ipotesi che i settori ritratti sommariamente fosse-ro privi di informazioni cartografiche di base, analoghe a quelle che hanno portato alle più accurate registrazioni di altre sezioni del disegno d’insieme, e non l’esito di negligenze di chi ha ricucito i materiali di base.
La mancata indicazione di alcune rocche97 (a Trevenzuolo, a Pontepos-sero, a Bonferraro, a Nogara), insieme alla registrazione di altre (Castel d’Azzano, Vigasio, Salizzole, Sanguinetto98), conferma questa ipotesi. Tut-te, infatti, costituivano potenziali punti di sostegno al sistema del Serraglio e a quello delle Grandi Valli Veronesi, punteggiate di avamposti fortificati e di castelli su un confine (tra il Mantovano e il Veronese) non certo sicuro per le mutevoli politiche dei Gonzaga. La visualizzazione “esatta” di un settore di frontiera avrebbe dovuto essere particolarmente importante, in vista anche della ridefinizione in atto di tutto il sistema difensivo, condotta
96 Manca, come si è accennato in nota 93, quella di Grezzano che estendendosi sino a Nogarole Rocca, dava continuità, attraverso la conformazione del territorio, al blocco costituito dal Serraglio. Il lago nei pressi di Castel d’Azzano è a fatica riconoscibile.
97 Sono invece indicate quelle di Belforto e di Piforto separate da un corso d’acqua – il f. Gardon affluente del Tione – corrispondenti a Castelbelforte un tempo Due Castelli, di Moratica, di Villimpenta e di Governolo, soggette a Mantova.
98 Tutte le rocche suddette sono note come smantellate oppure da dismettere all’epo-ca della redazione del disegno d’insieme: occorre peraltro rilevare che la smilitarizzazio-ne dei sistemi non ha di necessità implicato cambiamenti nelle forme. Sono indicate infine anche strutture che sembrano alludere a torri di difesa (a Magnano, a Gazzo Veronese ecc.)
governo del territorio e cartografia veneta 49
sulla valutazione delle potenzialità militari delle strutture ereditate dalle signorie precedenti in vista di un declassamento o di un potenziamento99, all’interno di un apparato che ponesse in stretta correlazione il Bresciano, il Veronese, il Vicentino e il Padovano. Conferma indirettamente il fatto che l’area fosse conosciuta attraverso resoconti scritti, piuttosto che sulla base di informazioni cartografiche, la relazione di Giorgio Sommariva del 1478100, indirizzata al podestà di Verona Federico Corner e scritta nel ten-tativo di frenare la trasformazione, pericolosa per la difesa dello stato, in terreni coltivabili di quelle aree paludose.
La zona delle Grandi Valli Veronesi (fig. 8), che si chiude a sud con Ostiglia e a est sulla linea di Torretta101 e che conteneva il confine tra Vene-zia e i Gonzaga, sembra tuttavia ritratta con discreta attenzione nonostante l’assenza di indicazioni sui limiti territoriali. Sono documentate in pros-simità della strada che porta a Ostiglia (sul tracciato della romana Clau-dia Augusta) la città murata di Sustinenza tra il Tregnone e il Menago, la fortezza di Correzzo, e in sequenza a sbarramento della strada le rocche di Pontemolino, di Torre di Mezzo e di Torre della Scala, a ovest il punto fortificato dale Zinzale in prossimità della confluenza del Busatello nel Tar-taro, a est quello di San Michele alla confluenza del Tregnone nel Tartaro e la Torre della Croxeta, allo sbocco della fossa Nichesola nel Tartaro102.
99 Per una sintesi in merito cfr. Concina, Tempo novo, il capitolo «Far le città»: Venezia e il Dominio, in particolare pp. 66-81.
100 Verona nel secolo XV e soprattutto C. Cipolla, La relazione di Giorgio Sommariva sullo stato di Verona e del Veronese (1478), in «Nuovo Archivio Veneto», III (1893), pp. 160-214.
101 Il rilievo si conclude a sud sulla linea del corso del Po lasciando in bianco la restante parte della pergamena: sono indicate soltanto una piccola rocca immediatamente a ovest di Ostiglia, sul limite meridionale delle Valli, e Revere al di là del fiume. A est il limite è segnato da una sorta di linea ideale oltre la quale è tracciato il bordo di contorno a nuvole rosse e verdi che delimita tutto il disegno e che corre da poco a sud di Torretta sino a Ca-stelbaldo (rappresentato come sistema fortificato di discrete dimensioni): è di fatto il limite con i territori di Rovigo e di Padova.
102 I punti fortificati delle Zinzale, di Ponte Molino, di San Michele e di Torretta si trovavano lungo il Tartaro, e quindi sulla linea del confine con il mantovano: ai primi del Quattrocento un accordo garantiva tuttavia ai veronesi il diritto di sfruttare i boschi a sud di Pontemolino sino alla Torre di Mezzo. La difesa delle Zinzale (chiamata anche Pontarso) fu edificata da Francesco Gonzaga nei primi anni del Quattrocento; Pontemolino e San Michele, di origine scaligera, e passati ai Gonzaga, costituiscono dunque gli avamposti avanzati di Ostiglia: non a caso Pontemolino fu rinforzato, disattendendo all’accordo del 1406, e furono ulteriormente potenziati, nel 1482, i punti fortificati di Ponte Arso, di Pontemolino, di San Michele e di Torre di Mezzo (G. Rodella, Giovanni da Padova. Un ingegnere gonzaghesco nell’età dell’Umanesimo, Milano 1988, pp. 44, 49, 50). Nel 1451 fu
giuliana mazzi50
La fedeltà nella resa della struttura di quest’ultima103 fa ritenere che anche i disegni degli altri punti fortificati rispondano alla loro realtà fisica per quanto riguarda almeno i rapporti dimensionali. In questo caso, il disegno usato per la registrazione d’insieme dovrebbe essere precedente al 1451, anno della costruzione della bastia veneziana, ossia di un fortilizio opposto a quello di Pontemolino104.
Portano a questa ipotesi le relazioni stese tra il 1451 e il 1452 (che pre-vedono interventi a Valeggio, a Villafranca e a Nogarole105, e che pertanto avrebbero fatto convergere un’eventuale attenzione grafica su quelle zone), la maggior leggibilità del settore nella pergamena del territorio veronese di Cristoforo Cavalcabò (del 1479-1483) (tav. 11a e b) e la preoccupazione di Giorgio Sommariva di documentare la propria relazione con un disegno del territorio veronese106.
Le probabili lacune informative della cartografia disponibile sono sug-gerite anche da altri indizi che interessano le zone comprese tra le Grandi Valli e l’asse che seguiva più o meno il tracciato della romana Postumia verso Vicenza. Vi sono, infatti, riscontrabili semplificazioni e omissioni di centri: ad esempio tra Mazzantica e Salizzole sono eliminati borghi pre-senti nella carta del Veronese compilata da Bernardino Brugnoli nel secolo successivo e incisa da Paolo Forlani. Non mancano imprecisioni ed errori nell’identificazione dei borghi107, nel tracciamento delle strade di accesso ai paesi come diramazioni dalla rete principale108 e nelle indicazioni di pon-
edificata dai veneziani «una bastia molto forte aprexo ponte Molino, la quala era molto chontra a ponte Molin e no pisia andare inanzi ne in dredo li personij». La struttura fu at-taccata e fortemente danneggiata nel corso di un assalto condotto dai mantovani nel 1453 (C. D’Arco, Cronaca di Mantova di Andrea Schivenoglia, in Raccolta di cronisti e documenti storici lombardi inediti, II, Milano 1837, p. 126, 129). Dovrebbe essere la struttura ricor-data da Sommariva nella sua relazione (Cipolla, La relazione, p. 208). La torre di Torretta (la «croxeta») sembra sia stata costruita tra la fine del Trecento e i primi del Quattrocento. Sulla zona cfr. G.M. Varanini, Il bastione della Crosetta di Legnago nel Quattrocento, in Il ritrovamento di Torretta. Per uno studio della ceramica padana, catalogo della mostra, Vene-zia 1986, pp. 40-54.
103 Il disegno trasmette una forma che risponde alla tipologia di fortificazione e pol-veriera a torre con base a scarpa ed è analoga a quella registrata nei documenti grafici successivi: L. Camerlengo, Documenti iconografici per una ricostruzione ideale della torre, in Il ritrovamento di Torretta, p. 33.
104 Cfr. nota 102.105 Archivio di Stato di Venezia, Senato Terra, reg. 2, cc. 204v-205r.106 Cfr. Mazzi, Agli esordi della difesa, passim.107 La ripetizione del toponimo di Aselogna, una frazione di Cerea, impiegato per due
borghi minori prossimi a Cerea.108 Per insediamenti di limitate dimensioni (come Zerpa, Albaredo d’Adige e Tomba-
governo del territorio e cartografia veneta 51
ti109. Caratteristiche analoghe presenta il settore immediatamente a sud del tracciato della strada verso Vicenza, fitto di borghi di diverse dimensioni inframmezzati ai pochi formatisi ai piedi delle rocche (Zevio110), a città for-tificate (Cologna Veneta [fig. 9]; Lonigo) e a case a corte111. Sono segnalate le boscaglie (impiegando il medesimo sistema precedentemente ricordato) che si estendevano nella fascia intorno a San Bonifacio e tra Zevio e Legna-go, ma non i terreni paludosi che saranno sistematicamente regolati per la coltivazione (soprattutto a riso) a partire dallo scadere del secolo successivo. Nell’area spicca piuttosto la visualizzazione del Ponte Zerpan (fig. 10), un ponte fortificato a più arcate (che occupano anche il letto asciutto a proba-bile tutela da esondazioni) che valicava l’Alpone sul tracciato della romana via Porcilana che collegava Verona a Padova. Colpisce anche il disegno del centro di Caldiero (fig. 11), situato ai due lati della strada, con l’indica-zione di un edificio emergente per dimensioni e forma e, poco discosto, la segnalazione delle terme («ibagni»), senza segni di strutture architettoniche ma con la corretta forma circolare delle vasche112. Suscita invece perplessità il ritratto del borgo di Bevilacqua, indicato da due soli edifici (di cui proba-bilmente uno allude alla stazione di posta) e senza il castello, che all’epoca aveva sì funzioni residenziali ma era in condizione di rispondere in caso di conflitti (fig. 27)113. Sembra, questa e ancora, una probabile indicazione di informazioni non complete su estese zone del territorio.
Si riduce inoltre l’attenzione per le abbazie più importanti: ne sono registrate soltanto alcune, come San Pietro in Monastero o San Pietro di Villanova di San Bonifacio114.
zosana), ma anche per San Bonifacio.109 È da notare un probabile pentimento a sud di Villa Bartolomea, dove il tracciato
di un canale che sembra staccarsi dal paese e confluisce (a quanto sembra) nel Naviglio Castagnaro è coperto da macchie di vegetazione.
110 Mancano però a Zevio la visualizzazione della biforcazione dell’Adige (è però intui-bile il fossato bagnato intorno alla rocca) e l’indicazione del porto fluviale, segnalato invece nella pergamena del Veronese del 1478-1483.
111 Desmontà, frazione di Veronella (storicamente Cucca), per esempio.112 Le terme furono riattivate nel 1458, dopo secoli di abbandono: cfr. E. Curi, Storia
delle analisi delle terme di Caldiero dal XV secolo ai giorni nostri, in «Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona», XL (1988-1989), p. 89.
113 Sul castello dei Bevilacqua e sulla sua probabile struttura precedente all’intervento cinquecentesco cfr. G. Mazzi, Un intervento sanmicheliano: il castello dei Bevilacqua, in L’arte nella storia: contributi di critica e storia dell’arte per Gianni Carlo Sciolla, a cura di V. Terraroli, F. Varallo, L. De Fanti, Milano 2000, pp. 262-263 e, sull’intervento sanmiche-liano, P. Davis, D. Hemsoll, Michele Sanmicheli, Milano 2004, pp. 220-223.
114 Memoria del monastero quasi certamente fortificato potrebbe essere la rappresenta-
giuliana mazzi52
Paradossalmente, sembra meglio ritratto (sia pure non nella sua totalità) il difficile territorio montuoso dei Lessini115, compreso tra le valli dell’Adi-ge e del Chiampo, e costituito da piccole gole e da conche che nella fascia pedemontana si allargano in vallate aperte, fitte di centri in fondovalle. Mancano però le indicazioni dei limiti del Veronese verso est, abbastanza coincidenti però con il limite delle visualizzazioni116.
Nelle contrade dell’alta Lessinia, anche quando prive del relativo topo-nimo117, le case allineate118 oppure distribuite intorno a uno slargo spesso centrale119 presentano tutte la facciata rivolta a sud, esposte dunque al sole come nella realtà fisica. Manca invece l’indicazione delle strade di accesso, che sono tracciate soltanto nei fondovalle delle valli principali. Rocche con piccoli borghi esterni di espansione e centri fortificati sono registrati a sbarramento delle vallate: Castelvero e San Giovanni Ilarione sull’alta valle dell’Alpone; Arzignano120 all’imbocco della valle del Chiampo.
Meno conosciuti sembrano i settori più settentrionali delle valli centro-orientali. Nella raffigurazione di quella di Mezzane si intravvedono tracce di un toponimo depennato e un solo nucleo indica le due Mezzane; in quella della val d’Illasi è sommaria la registrazione dei corsi d’acqua (il Progno e i torrenti laterali121) e manca l’abbazia benedettina di Badia Cala-vena; nella dorsale tra le valli di Tramegna e dell’Alpone un primo ritratto di Castelcerino (riproposto nella corretta posizione più a sud) è cancellato ed è indicata come recinto fortificato la Bastia di Montecchia di Crosara122 sulla dorsale tra le due valli. Più documentato sembra invece il settore
zione del ponte provvisto di torri come accesso al sistema abbaziale.115 La selva di Progno, per esempio, è indicata da una macchia d’alberi disegnata con
i fusti in alzato e non con il sistema della massa di chiome in prospettiva che annuncia i boschi nelle aree montane; le valli di Porro e di Squaranto sono ritratte rispettandone l’impervia morfologia.
116 I centri posti più a est sono Gambellara, poco oltre Torri di Confine, e Arzignano, entrambi di pertinenza vicentina anche se incerta.
117 Può anche verificarsi la situazione opposta: il toponimo Velo indica il monte (il Purga?) ma non il borgo o la sequenza di contrade che lo costituiva.
118 Roverè Veronese, San Vitale ecc.119 Azzarino di Velo Veronese, Pezzo, Bosco Chiesanuova, Valdiporro (privo della chie-
sa come Corbiolo), Mezzane ecc.120 Ritratto come rocca di notevoli dimensioni al cui esterno, nella vallata, sono raffi-
gurate una chiesa e poche case.121 Il tracciato del Progno di Illasi compare soltanto a partire dal centro omonimo.
Occorre però ricordare che si trattava di corsi a forte carattere torrentizio, e pertanto in secca per gran parte dell’anno.
122 La bastia è identificata nel saggio di Varanini, Postinger, Lazzarini.
governo del territorio e cartografia veneta 53
compreso tra le valli di Porro e di Squaranto, anche nelle parti più setten-trionali dove è segnalata la rete dei collegamenti stradali123.
Una maggior diligenza (ma con qualche incertezza nella toponomasti-ca124) sembra distinguere il disegno delle zone meridionali delle valli che tagliano la fascia collinare pedemontana, nella successione dei centri e nella rete delle strade: in Valpantena, nella valle di Montorio125 (dove è segnalato l’eremo benedettino di San Fidenzio), nella valle di Illasi.
Più attenti sembrano il posizionamento e gli schizzi dei punti forti allo sbocco delle valli. Montorio Veronese (una rocca con mastio interno di notevoli dimensioni circondata da un fossato asciutto) è ritratto con il nu-cleo minore di espansione all’imbocco della Valpantena e il maggiore allo sbocco di val Squaranto, dove sono evidenziati (sia pure con il solo dise-gno) il laghetto Squarà, il Fiumicello (che portava l’acqua a Verona e di cui è registrato l’andamento sino ai primi quartieri entro le mura), il Fibbio e, tra i due corsi d’acqua, una “macroscopia” in prospettiva, probabilmente allusiva della Loza voluta dagli Scaligeri anche come residenza estiva126 (fig. 13). Tregnago e Illasi, in sequenza per il controllo della valle di Illasi127 nel caso di penetrazioni da nord, sono raffigurati entrambi come rocche massicce e con i borghi di espansione verso valle. Soave, allo sbocco della valle di Tramigna, è effigiato come centro fortificato provvisto di porta
123 Restano tuttavia ancora incertezze sulla posizione delle località: immediatamente al di sopra del borgo di Pigozzo la scritta Mizole [= Mizzole] è coperta dal disegno della vegetazione.
Così come persistono dubbi sull’entità dei centri: Lavagno è indicato con il solo nu-cleo sul colle di San Briccio e non con i borghi sottostanti.
124 Manca per esempio il nome di alcune valli: di Mezzane, di Marcellise, di Illasi ecc. Ritornano le incertezze sull’andamento dei corsi d’acqua: in val Tramigna, al di sopra del nome del fiume entro un riquadro (f. Tramegna), compare la scritta f. Menago, le cui sorgenti (non indicate nella pergamena, come del resto il tracciato del Menago) sono più a sud, a Villafontana.
125 Così è nominata la parte meridionale della valle dove scorre il progno Squaranto, disegnato nella registrazione cartografica.
126 In proposito cfr. G. Sandri, Un disegno di Cristoforo Sorte e l’antica Loza di Montorio, in «Atti dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona», s. V, XIII (1935), pp. 165-175. L’edificio, fatto costruire da Alberto della Scala nel 1273 anche con la funzione di presidiare le acque della zona, fu modificato da Cangrande per farne una residenza estiva, dotata di orti e di giardini.
127 Non è però indicato il nome della vallata. La visualizzazione dei borghi sembra rispondere alla loro entità piuttosto che alla loro forma: per esempio a Cogollo manca l’indicazione del recinto fortificato altomedievale che lo dominava e di cui restano alcuni ruderi; Cellore è rappresentato correttamente come gruppo sparuto di case ma senza l’in-dicazione dell’abbazia altomedievale ecc.
giuliana mazzi54
urbica (la Veronese), di rocca in alto e di una macroscopia civica in testa a un’ampia strada centrale – probabilmente, per l’indicazione di un portico, «’l palazo dove habita el Capit.°» ricordato da Marin Sanudo128 (fig. 29). Roncà, infine, allo sbocco della valle dell’Alpone, è reso come una piccola rocca ai cui piedi si estende il borgo extra moenia.
L’insufficienza di microstorie sul Veronese (non sempre supplita dal-le analisi di singoli insediamenti e/o di singoli manufatti) impedisce di cogliere con buoni margini di sicurezza connessioni cronologiche tra gli episodi rappresentati. Non sempre cioè è possibile far coincidere le diverse visualizzazioni con date di rilievo tra di loro poco discordanti. Il sistema del territorio sembra restituito a una data abbastanza certa per quanto ri-guarda l’epoca della redazione finale (post 1460, ulteriormente slittabile), ma non per le date delle singole registrazioni cartografiche che furono alla base del disegno d’insieme. Emblematica, in tal senso, è la visualizzazione del trasporto via terra della flotta fino al lago di Garda effettuato nel 1439 per soccorrere Brescia all’epoca della guerra veneto-viscontea, forse memo-ria voluta di un’impresa notevole129.
Diventa quindi quanto mai opportuno richiamare alla memoria la pru-denza espressa a suo tempo da Puppi a proposito dei ricorsi alla cartogra-fia storica come possibile documento, ossia che la cartografia altro non è che un «contributo che sarebbe arrischiato, anzi erroneo, considerare e accettare come neutrale, e meccanicamente fedele130». Del resto, come ha ricordato Schulz, neppure una carta odierna restituisce tutte le possibili informazioni in essa implicite131. Saranno quindi sempre cronologie certe dei diversi episodi ritratti l’indispensabile supporto per la valutazione di un’immagine. In mancanza di queste, i disegni possono soltanto costituire uno stimolo per una verifica, per altre vie di ricerca, di condizioni fisiche che possono sembrare anomale.
128 Itinerario di Marin Sanuto, p. 103. Anche il disegno del centro rammenta il succes-sivo schizzo dell’Itinerario.
129 Come è noto, la visualizzazione dell’episodio ha indotto Almagià a datare la perga-mena agli anni compresi tra il 1439 e il 1441.
130 L. Puppi, L’ambiente, il paesaggio e il territorio, in Storia dell’arte italiana, IV, Ricer-che spaziali e tecnologie, Torino 1980, p. 47.
131 Sul ruolo informativo della cartografia anche attuale vedi almeno Schulz, La carto-grafia, pp. 10-11; per una sintesi dei temi e dei problemi connessi allo studio della carto-grafia urbana negli ultimi trent’anni cfr. M. Folin, Introduzione. Piante di città nell’Italia di antico regime: uno strumento di conoscenza analitico-operativa, in Rappresentare la città, pp. 10-36.
governo del territorio e cartografia veneta 55
La presenza di mappamondi e di mappe in Palazzo Ducale e la regi-strazione dettagliata dell’entroterra commissionata nel 1460 per la sala del Consiglio dei Dieci confermano dunque la doppia valenza acquisita dalle decorazioni geografiche: esibizione della potenza dello Stato (e quasi per-corso cerimoniale) nei luoghi aperti agli ospiti del palazzo e documenta-zione per l’esercizio del potere nelle sale dove questo era praticato. Una documentazione che è volutamente realizzata seguendo quella «visione del mondo in pictura132» che poteva renderla anche elemento di arredo, che ne spiega il probabile affido a pittori e che era stata favorita dagli studi geo-grafici dell’umanesimo. Tali studi erano peraltro noti ai principali promo-tori della parte del 1460: Pietro Mocenigo, più volte savio in Terraferma, condottiero e infine doge nel 1474, Bernardo Giustinian, studioso attento di Plinio, di Strabone, di Diodoro Siculo, di Tolomeo, e Marco Donà133. Diventa inevitabile pertanto chiedersi se il mancato compimento134 delle registrazioni provincia per provincia richieste dal decreto e suggerito dal “non finito” riscontrato nella pergamena del territorio veronese, abbia de-terminato un accantonamento del progetto, destinato a essere realizzato soltanto nel secolo successivo con le mappe affidate a Cristoforo Sorte. Ne-gli anni sessanta del Cinquecento la documentazione accessibile presso gli archivi delle diverse magistrature (anche locali) doveva essere di gran lunga maggiore rispetto a quella raccolta entro il 1460 e, di conseguenza, erano necessari soltanto controlli e aggiornamenti su quanto era già disponibile e che doveva ormai coprire tutti i territori della Repubblica. A metà Quat-trocento sistematiche registrazioni cartografiche erano ancora in corso. Di-venta quindi plausibile l’ipotesi che, a fronte di una consapevolezza della complessità dell’impresa riscontrata con la redazione della (probabilmente) prima e unica carta, quella appunto del Veronese, il programma sia stato sospeso. La pergamena superstite diviene così l’espressione di una stagione culturale, ampia e articolata, di cui costituisce una delle più efficaci mani-festazioni.
132 Concina, Tempo novo, p. 39.133 Ivi, pp. 37-39.134 Non si conoscono, per ora, pergamene simili per formato.
giuliana mazzi56
Fig. 1. Scuola veronese (Paolo Farinati?), Allegoria della città di Verona, Lovere, Berga-mo, Galleria dell’Accademia di Belle Arti Tadini.Fig. 2. Scuola veronese (Paolo Farinati?), Allegoria della città di Padova, Lovere, Berga-mo, Galleria dell’Accademia di Belle Arti Tadini.
1.
2.
governo del territorio e cartografia veneta 57
Fig. 3. Ludovico Toeput detto il Poz-zoserrato (?), Padova, Padova, Palazzo del Comune [foto S. Zaggia].Fig. 4. Ludovico Toeput detto il Poz-zoserrato (?), Vicenza, Padova, Palazzo del Comune [foto S. Zaggia].
3.
4.
giuliana mazzi58
Fig. 5. Carta dell’Almagià, fortezza in località Corvara tra Incanale e Preabocco.Fig. 6. Peschiera del Garda.Fig. 7. Il Serraglio da Borghetto a Villafranca.
5.
6.
7.
governo del territorio e cartografia veneta 59
Fig. 8. Le Valli Grandi Veronesi.Fig. 9. Cologna Veneta.Fig. 10. Il Ponte Zerpan sul tracciato della via Porcilana tra Verona e Padova.
9.
8.
10.
Tav. 1. Pianta di Venezia, in Chronologia Magna, Venezia, Biblioteca Nazionale Mar-ciana, Lat. Z. 399 (=1610), f. 7r.
Tav. 2. Lacus Garde, Verona, Biblioteca Civica.Tav. 3: Carta della Lombardia, Parigi, Bibliothèque Nationale.
Tav. 8a e b: Pianta della città di Parma e del suo territorio, Parma, Archivio di Stato, Raccolta Mappe e Disegni, vol. 2, n. 85.
Tav. 11a e b (a fronte): Cristoforo Cavalcabò, Il territorio veronese, Venezia, Archivio di Stato, Scuola Grande della Carità, b. 36, n. 2530.Tav. 12 (qui sopra): Leonardo, Pianta di Imola, Windsor Castle, Royal Collection.Tav. 13 (nella pagina seguente): Cristoforo Sorte, Il Veronese e il Vicentino, Venezia, Museo Correr.




































































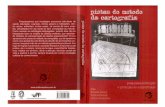

![PRELOŽNIK A., GUŠTIN M.: Cinturoni da parata: esempi di contatti tra l’area veneta e la Dolenjska nell’età del ferro. - Archeologia Veneta 35, 2012 [2013], s./p. 118-127.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63161c373ed465f0570be358/preloznik-a-gustin-m-cinturoni-da-parata-esempi-di-contatti-tra-larea.jpg)


![Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63141b0cfc260b71020f6789/unesperienza-etimologica-veneta-per-la-storia-di-mona-padova-esedra-2011.jpg)