La storiografia patriottica: il corso di storia veneta 1848-1915
Transcript of La storiografia patriottica: il corso di storia veneta 1848-1915
Volume realizzato grazie al contributo straordinario della Regione Veneto, L.R. 16.3.2006 n. 6
© 2012 Ateneo Veneto onlus© 2012 lineadacqua edizioni
Progetto grafico e impaginazioneCamuffo Lab
EditingOmar Favaro Salani
Referenze fotografiche© Archivio fotografico Ateneo Veneto© Archivio fotografico Fondazione Musei Civici di Venezia© Archivio Graziano Arici© Cameraphoto Arte Venezia© KiKo Trivellato Venezia© Giacomo Cosua, Venezia-Berlino
Si ringraziano la Fondazione Musei Civici di Veneziae Graziano Arici per la gentile concessione delle immagini
ISBN 978–88-95598-10-9
Finito di stampare nel novembre 2012 Grafiche Antiga - Crocetta del Montello
ATENEO VENETO
1812-2012
UN’ISTITUZIONE PER LA CITTÀ
a cura di Michele Gottardi
Marina Niero
Camillo Tonini
Venezia 2012
Michele Gottardi Presidente
Silvio Chiari Vicepresidente
Camillo ToniniAlfredo BianchiniGiovanni CastellaniCristiano ChiarotSergio PerosaPhilip RylandsAntonio Alberto SemiNereo LaroniVittorio CenciAndrea Causin
Maria Teresa De Gregorio Segreteria
Luca ZaiaPresidente Regione Veneto
Clodovaldo RuffatoPresidente Consiglio Regionale del Veneto
Roberto CecchiSottosegretario di Stato MiBAC
Giorgio OrsoniSindaco di Venezia
Domenico CuttaiaPrefetto di Venezia
Francesca ZaccariottoPresidente Provincia di Venezia
Marino ZorzatoVicepresidente Regione del Veneto
Carlo CarraroRettore Università Ca’ Foscari, Venezia
Amerigo RestucciRettore IUAV
Massimo ContieroDirettore del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia
Andrea ErriPresidente Università Internazionale dell’Arte
Roberto TurettaPresidente Consiglio Comunale di Venezia
Marina BalleelloPresidente Consiglio Provinciale di Venezia
Vincenzo RocaQuestore di Venezia
Tiziana AgostiniAssessore Attività Culturali Comune di Venezia
Raffaele SperanzonAssessore alla Cultura Provincia di Venezia
Giovanni SammartiniPresidente Cassa di Risparmio di Venezia
COMITATO D’ONORE
COMITATO REGIONALE PER IL BICENTENARIO1812-2012
Michele GottardiPresidente
Silvio ChiariVicepresidente
Camillo ToniniSegretario accademico
Shaul BassiDelegato agli Affari Speciali
Tito FaottoTesoriere
Consiglio accademicoGiovanni Alliata
di MonterealeRoberto CrostaIlaria CrottiGiovanni DiazJohn Leopoldo Fiorilla
di Santa CroceLetizia MichielonFrancesco MiggianiLeopoldo PietragnoliMassimo OngaroMaria Luisa SemiAlberto Toso FeiGuido Zucconi
Revisori dei ContiGiovanni AnfodilloAdriana LottoMario NovariniRoberto Querci
della RovereEdda Serra
Conservatore delle Collezioni d’ArteIleana Chiappini di Sorio
Proto della FabricaAlberto Ongaro
Rivista “Ateneo Veneto”Marino ZorziDirettore scientificoMarina NieroSegreteria redazionale
Referente agli Affari di Etica e StatutoAntonella Magaraggia
Presidente Commissione Premio TortaGuido Zucconi
BibliotecarioDorit Raines
Conservatore dell’ArchivioMichela Dal Borgo
Biblioteca e ArchivioMarina Niero (coordinatrice)Daria AlbaneseSilvia Ferronato
SegreteriaClara BordignonElena Rossetto
Comunicazione e Relazioni EsterneSilva Menettoe la collaborazione diStudio Systema
Servizi tecniciValerio Memo
ATENEO VENETO DI SCIENZE, LETTERE E ARTI
L’ISTITUZIONE
Michele GottardiL’Ateneo e la città. Intersezioni
Filippo Maria PaladiniCivilizzazione europea, storia italiana e rigenerazione di Venezia in Samuele Romanin
Dorit RainesLa storiografia patriottica: il corso di storia veneta 1848-1915
Marina NieroIl “censimento” del 1938 e la discriminazione culturale
Nadia Maria FilippiniLa presenza femminile nell’Ateneo Veneto: un percorso emblematico
LE COLLEZIONI LIBRARIE
Dorit RainesIl fondo antico della biblioteca dell’Ateneo Veneto
Marina NieroGabinetto di lettura
Letizia TombesiLa raccolta libraria di Giovanni Battista Giustinian, primo sindaco di Venezia
Beatrice LuccheseLa biblioteca circolante dell’Ateneo Veneto
Daria AlbaneseI necrologi. La fortuna di un genere e la conservazione della memoria
Daria AlbaneseLe donazioni dei soci
L’ARCHIVIO
Marina NieroL’archivio dell’Ateneo Veneto
Silvia FerronatoUna donazione speciale: il fondo del “Vajont”
LE IMMAGINI
Graziano AriciLe ombre e il futuro
3
39
47
59
67
77
83
89
93
99
111
121
125
129
INDICE
161
167
173
187
211
243
251
261
267
279
291
303
315
LA FABRICA
Thedore K. RabbIl complesso monumentale
Guido ZucconiLa Scuola di San Fantin: l’architettura
Camillo ToniniLa problematica prospettiva: la facciata dell’Ateneo Veneto
LE COLLEZIONI PITTORICHE
Ileana Chiappini di SorioFatti e misfatti all’Ateneo
Meryl Faith BaileyLa devozione delle confraternite, la Riforma cattolica e il ciclo del Purgatorio di San Fantin
Valentina SapienzaNote sulle “Storie della Passione” di Leonardo Corona all’Ateneo Veneto
Pietro ZampettiLe storie della Vergine di Paolo Veronese e aiuti
Pietro ZampettiL’arte a San Fantin tra Manierismo e Barocco
Loredana Luisa PavanelloIl buon uso del denaro e l’esercizio della pietà. Ideologia dell’assistenza nei dipinti di Antonio Zanchi in Ateneo Veneto
Marina MagriniFrancesco Fontebasso: «La Madalena che lava di lacrime e ungie con balssimo presioso li piedi al Salvatore mentre pransava in casa del Fariseo»
IL LOGO DELL’ATENEO E IL MEDAGLIERE
Massimo Favilla, Ruggero RugoloLo «stemma particolare» dell’Ateneo Veneto: Bartolomeo Gamba e Francesco Novelli, con una nota sul monumento a Francesco Aglietti di Bartolomeo e Luigi Ferrari
Leonardo MezzarobaLe medaglie celebrative dell’Ateneo
APPENDICI
Dorit Raines
La storiografia patriottica: il corso di storia veneta 1848-1915
La storia di Venezia non è soltanto la storia di una illustre aristo-
crazia, ma di tutto un gran popolo. Patrizi e cittadini, nobili minori
e popolani, mercanti e navigatori arditissimi, uomini eminenti nelle
lettere e nelle scienze, artisti di fama immortale, tutti concorsero al
maggior lustro di questa loro patria amatissima. I nipoti di coloro
che crearono tanta grandezza non possono permettere che vadano
qui obliate la gesta degli avi loro1.
Così scrisse nel 1897 l’avvocato Marco Diena (già presidente dell’Ateneo Veneto tra il 1886 e il 1888) in un manifesto intitolato «Ai cultori delle patrie memorie»2. Grande sostenitore dell’unificazione italiana all’interno della quale Venezia avreb-be dovuto avere un ruolo importante come riflesso della sua storia passata e più re-cente, Diena espresse in modo sintetico ed efficace il momento paradigmatico del Bildung della nuova coscienza identitaria veneta non più incentrata sull’idea della libertà, bensì fiduciosa nell’azione unificatrice e di legame tra una classe sociale e un’altra, tra una città e un’altra, azione caratterizzata dal tentativo di costruire una nazione, di maturare un’identità inclusiva pur sottolineando la specificità storica locale. È, questo, il momento dello spartiacque individuabile nella storiografia ve-neta divulgativa ottocentesca: da un patriottismo romantico-liberale si passa a toni patriottici di altro tipo. Si ha allora una lettura conflittuale, a volta belligerante, so-cialistico-nazionale, della storia veneziana, lettura nella quale il ruolo di Venezia all’interno di una nascente nazione sembra complesso ma poco definito, mentre l’orgoglio locale ingigantisce le imprese della Repubblica Serenissima garantendo o creando una continuità identitaria tra il passato e un futuro quasi presente.
1. MARCO DIENA, Ai cultori delle patrie memorie, «L’Ateneo Veneto», XX (1897), vol. I, fasc. 1, p. 10, annuncio «Ai cultori delle patrie memorie».
2. Si veda la sua biografia a cura di Loredana Luisa Pavanello sul sito dell’Ate-neo all’indirizzo: www.ateneoveneto.org alla sezione “Storia”, sottosezio-ne “Presidenti”.
48 L’ISTITUZIONE
La storia del corso di Storia Veneta è interessante poiché rappresenta la storia della storiografia divulgativa ma anche raffigura il ruolo propulsore del passato serenissimo, usato come specchio degli avvenimenti storici correnti. Quattro lustri sono corsi dall’insorgere del movimento per la liberazione di Venezia dal dominio asburgico, quando, di fronte alla convinzione che un popolo debba co-noscere la sua storia come parte della costruzione di una forte identità, i due leader del movimento del 1848, Daniele Manin e Nicolò Tommaseo, pensarono di istituire (con decreto del 24 marzo 1848) l’insegnamento della storia patria nelle scuole secondarie con l’intento di portare i giovani a uno scatto di orgoglio tramite la conoscenza del passato glorioso della città. Qualche mese dopo – il 30 novembre – era stata perfino istituita una cattedra a questo proposito ed era stato l’illustre storico Samuele Romanin a occuparla, Romanin che già qualche mese prima aveva iniziato il suo insegnamento all’Ateneo Veneto. Con il ritor-no degli austriaci le lezioni erano state soppresse fino al 1857, quando, sotto la spinta della forte convinzione dell’allora presidente Alvise Francesco Moceni-go, Romanin aveva ripreso le lezioni che erano proseguite fino al 1860 e poi erano cessate con la sua scomparsa nel 18613. La risposta del pubblico a queste lezioni, «il fiore della nostra società cittadina e forestiera; il mondo sapiente, il mondo elegante, cui non mancava il leggiadro decoro di donne gentili», aveva convinto in seguito la Presidenza a re-istituire il corso di Storia patria a partire dal 18664. Ciò avvenne all’interno di un pro-gramma ben articolato (e lungamente dibattuto tra i soci) di lezioni popolari, una novità che sconvolse l’attività della nota accademia, la quale fino ad allora aveva dedicato le proprie energie alla effettuazione, al dibattito e alla pubblica-zione delle conferenze dei propri soci, senza coinvolgere il pubblico esterno. Le lezioni popolari, istituite con l’aiuto finanziario dei fratelli Angelo e Nicolò Papadopoli, dovevano essere a cadenza di una lezione serale settimanale per un numero totale di dodici lezioni all’anno a ingresso gratuito. Lo statuto sta-bilì che le lezioni avrebbero dovuto tenersi in forma orale, sostenendo che «una istruzione di carattere popolare […] non vada disgiunta dal diletto […]. Fra chi parla e chi ascolta si stabilisce quasi a dire una relazione intellettuale, che rende
3. Cronaca dell’Ateneo veneto, p. 6; DIENA, Ai cultori delle patrie memorie, pp. 7-11. A proposito dell’insegnamento di Romanin si veda l’intervento di Fi-lippo Maria Paladini nella presente pubblicazione.
4. TOMASO LOCATELLI, Continuazione dei ricordi storici dell’Ateneo Veneto, «Atti dell’Ateneo Veneto», s. II (1864), vol. I, p. 80.
49LA STORIOGRAFIA PATRIOTTICA
facile il comprendersi». In pratica con queste scelte gli organizzatori si mostra-rono contrari alle consuetudini accademiche5. La questione che si pose, tuttavia, fu quella relativa alla organizzazione delle le-zioni: queste avrebbero dovuto essere collegate all’interno di un tema, ma svolte su argomenti singoli da relatori diversi oppure avrebbero dovuto costituire dei corsi veri e propri? E ancora: corsi monografici o veri e propri corsi istituzionali sulla materia storica? Nel timore da un lato di non poter trovare le persone adat-te per impartire delle lezioni in modo permanente e dall’altro che il pubblico non fosse ancora maturo per cogliere e apprezzare la complessità di corsi me-todici, per attirare un pubblico più numeroso, si era infine deciso di proseguire con i corsi monografici. Il successo fu davvero notevole, al punto che, poiché troppi si presentavano a ritirare i biglietti, e poiché l’aula magna poteva ospitare 400 persone, molti rimasero delusi6. Si propose perfino la costruzione di una galleria che potesse contenere altre 200 persone, ma probabilmente il progetto non ebbe seguito per mancanza di finanziamento7.Nel 1868, dopo la partenza degli austriaci, su iniziativa del conte Luigi Torelli, prefetto della Provincia, ci furono poi i primi tentativi di istituire una Società di Storia Patria e il presidente dell’Ateneo fu chiamato a far parte del comitato promotore8. Ispirato da questa iniziativa, si fece avanti Bartolomeo Cecchetti proponendo una riflessione sull’opportunità di tornare all’idea di Romanin di tenere un corso di storia patria. Egli espose durante l’adunanza 18 febbraio 1869 i suoi appunti di Storia Veneta: in sostanza propose di studiare «lo spirito del governo veneto», in particolare «i grandi esempi del senno e dell’eroismo dei veneziani, che seppero acquistare e difendere la loro indipendenza con ogni maniera di sacrifizj e con vero affetto al proprio paese»9. Ci vollero tuttavia an-
5. Adunanza ordinaria del 6 luglio 1865, «Atti dell’Ateneo Veneto», s. II (1865), vol. II, pp. 389-391.
6. Discipline per le lezioni popolari presso l’Ateneo Veneto, ibid., pp. 392-395.7. Relazione letta dal s.o. cav. Dott. Guglielmo Rerchet in nome della Giunta alle
elezioni popolari, «Atti dell’Ateneo Veneto», s. II (1866), vol. III, pp. 183-184.
8. DIENA, Ai cultori delle patrie memorie, p. 10. Relazione degli studi nelle scienze
morali e nelle lettere dell’Ateneo Veneto dell’anno accademico 1873-4 letta nell’a-
dunanza solenne del 31 agosto 1874 dal professore Antonio Matscheg. Segreta-
rio per la classe di lettere, «Atti dell’Ateneo Veneto», s. II (1873), vol. XI, p. 417.
9. Atto verbale dell’adunanza ordinaria 18 febbraio 1869, ibid., vol. VI (1870), p. 69.
50 L’ISTITUZIONE
cora cinque anni e l’istituzione di un certo numero di premi per lo studio di sto-ria veneta, perché finalmente l’Ateneo Veneto decidesse di affidare, nel 1873, l’incarico di lezioni serali circa i punti principali della storia al socio Domenico Urbani, richiedendogli di strutturare le dodici lezioni previste come larghi qua-dri della storia, indirizzati a coloro che non conoscevano affatto tale storia e, allo stesso tempo, finalizzati a invogliarli a approfondirne lo studio10. Questa prima esperienza destò qualche perplessità, sollevata in particolare da Rinaldo Fulin il quale chiese che dall’anno seguente le lezioni fossero “orali”, intendendo che non dovessero essere basate sulla lettura pubblica di testi scritti. Inoltre egli rispose alla critica di certi giornali che avevano sostenuto che l’am-piezza del programma lo rendeva degno di un corso universitario. Il program-ma, secondo Fulin, era frutto di una lunga riflessione che aveva consentito di selezionare ciò che era stato ritenuto degno di esposizione, stabilendo un nesso tra dati e fatti. Infine venne anche criticato aspramente un compendio di sto-ria patria approvato dal Consiglio scolastico di Venezia chiedendo formalmente un’azione di protesta da parte dell’Ateneo Veneto11. Nel 1875 Urbani fu sostituito dall’abate Giuseppe Nicoletti, diurnista nel 1876, poi primo assistente del Museo Correr nel 1879, del quale divenne vice conser-vatore nel 189812. Tuttavia, il corso faticò a incidere sulla vita dell’Ateneo poiché il continuo cambiamento di direttori e la mancata impostazione del contenitore (numero lezioni annuali, tematiche e desiderata tipologia del pubblico) impedi-vano il suo sviluppo naturale e il suo radicamento come punto di riferimento per la storiografia divulgativa. Nel 1881, a seguito di una riflessione interna sul proprio ruolo, l’Ateneo cam-biò strategia e programma. Anziché pubblicare, dapprima col nome di Sessioni
pubbliche le conferenze dei soci, poi come Esercitazioni e in fine come Atti dell’A-
teneo Veneto, sembrò che fosse giunta l’ora di pensare a dare impulso nuovo alle pubblicazioni dell’Ateneo, fondando una vera e propria rivista. La convinzione
10. Atto verbale dell’adunanza ordinaria del 4 Decembre 1873, prima dell’anno
accademico 1873-74, «Atti dell’Ateneo Veneto», s. II (1873), vol. XI, p. 38; DOMENICO URBANI, Relazione delle conferenze serali preparatorie agli esa-
mi di storia veneta, ibid., pp. 291-312.11. Il nostro programma, ibid., s. III (1881), vol. IV, pp. 5-6.12. Atto verbale dell’adunanza del 10 giugno 1875, ibid., s. II (1875), vol. XII,
p. 337. Su Nicoletti si veda, Introduzione, in Le mariegole della Biblioteca del
Museo Correr, a cura di Barbara Vanin e Paolo Eleuteri, Venezia, Marsilio, 2007, p. XVII, n. 18.
51
che motivava tale radicale cambiamento era che «le Accademie hanno fatto lor tempo» e che agli atti «nessuno o pochi più s’interesserebbero»13. Con la decisio-ne relativa alla nascita della Rivista veniva meno anche la centralità delle confe-renze scientifiche tenute dai soci e per i soci, che venivano affiancate a un’atti-vità multipla, destinata anche a un pubblico più vasto. Il corso di Storia Veneta diventò allora la bandiera dell’impegno dell’istituzione cittadina verso il pubbli-co: a inizio giugno, gli iscritti sostenevano gli esami di fine corso davanti a una commissione costituita dei rappresentanti dell’Ateneo, del regio Ministero della istruzione pubblica, del Municipio di Venezia, della Fondazione Querini Stam-palia, dell’Archivio di Stato, del Museo Civico, per poi il giorno dello statuto concludere con la consegna dei premi e una lectio magistralis tenuta dal direttore del corso14. Il primo a tenere le lezioni per ben due anni è stato il professore Gia-como Cegani15. Lo sostituì nel 1883 il professore Antonio Matscheg. Questi tenne un discorso, «accolto da generosi e ben meritati applausi», intitolato La
Repubblica Veneta. La visione di Matscheg, insegnante al liceo Marco Foscarini e con al suo attivo diversi libri di storia nonché la carica di segretario dell’Ateneo per la classe di lettere e scienze morali dal 1871 al 1875, rivendica il passato glorioso in un tentativo di riscatto e di orgoglio che risente ancora della rivo-luzione del 1848. Secondo Matscheg l’entusiasmo e l’interesse per la storia di Venezia proveniva dal fatto che essa «ci presenta un tipo dell’uomo, della fami-glia, dello Stato, che attrae sempre, non si scolora mai, può dappertutto e le dà l’impronta della vera grandezza». Secondo l’oratore, poi, Venezia era nata come «protesta contro le barbarie» e la sua specificità stava nel fatto che «in altri Stati dell’età di mezzo e moderna troviamo taluni periodi storici splendenti di gloria e grandezza, ma una continuazione, non mai interrotta, di idee, di propositi, di fatti rivolti ad un intento, per virtù propria, senza mescolanza di genti straniere immigrate e di straniere istituzioni, non troviamo in alcuno». Ma il professore osò ben oltre: nel confronto con Roma, Venezia uscì vincente poiché secondo lui Roma era stata per un periodo di 500 anni una Repubblica aristocratica dopo essere stata una monarchia, mentre la Serenissima era subito diventata Repubblica democratica ed era proseguita in tal modo per ben 700 anni «indi si mutò in aristocratica e negli ultimi tre secoli fu oligarchica». Gli ingredienti
13. Il nostro programma, «Atti dell’Ateneo Veneto», s. III (1881), vol. IV, p. 6.14. ANTONIO MATSCHEG, La Repubblica veneta. Discorso storico, «L’Ateneo Ve-
neto», VII (1883), vol. II, p. 3.15. Cronache dell’Ateneo, ibid., 1882, p. 263.
LA STORIOGRAFIA PATRIOTTICA
52 L’ISTITUZIONE
del mito di Venezia erano tutti presenti nel discorso: tutte le classi che si senti-vano unite da «un principio di fratellanza», il popolo «operosissimo» e i patrizi che erano insieme «guerrieri, politici, letterati, scienziati, storici», insomma «il vero tipo della stirpe romana, temprato alla civiltà nuova». Il declino, secondo il ragionamento dell’oratore è arrivato dopo Passarovitz, quando «l’oligarchia ve-neziana era moralmente e politicamente caduta» e non ebbe la lungimiranza di aggregare forze nuove al Maggior Consiglio. Infine, nel 1848 «il popolo aveva avuto la sua riscossa ed aveva lavato l’onta dell’aristocrazia»16. L’anno seguente fu la volta di Rinaldo Fulin, professore al liceo Marco Polo che ebbe nel 1868 l’insegnamento di storia del commercio (e poi di storia politica e diplomatica) alla Scuola superiore di commercio di Ca’ Foscari17. Prese il suo posto il professore Vincenzo Marchesi, studioso e autore del libro, pubblicato nel 1892, Settant’anni della Storia di Venezia (1798-1866). Nel 1890, sotto la presidenza di Paulo Fambri il corso modificò programmi e metodi. L’obiettivo era di «conformarci alle vedute moderne per educare i giovani, non già nel senso dell’erudizione comunque accumulata, ma in quello della critica seria e vediamo con soddisfazione come le lezioni chiamino numerosi uditori nonché allievi, e Venezia cominci oggi essere meglio conosciuta dai Veneziani»18. Ma la fatica di tenere dodici lezioni annuali e la mancanza di finanziamento portarono alla chiusura momentanea del corso durante gli anni 1894-1895. La ripresa, sotto la presidenza di Marco Diena, era dovuta ai sussidi ottenuti e alla speranza di aiuto da parte dei privati19.La ripresa registrava una rivoluzione avvenuta nello stesso concetto di base del cor-so. Innanzitutto l’Ateneo prese in esame l’operato delle altre istituzioni culturali a Venezia e tentò di differenziarsi con il corso di Storia Veneta: «l’operosità di altre istituzioni attuate nella nostra città, allo scopo della diffusione della cultura e degli studii, non deve togliere tuttavia al vecchio Ateneo Veneto, il modo di concorrere anche da parte sua al plausibile intento». Infatti i soci pensarono che viste le gloriose tradizioni si sarebbe potuto «tracciare un campo specialissimo in cui potesse con forze ringiovanite prestare opera utile al nostro paese» e conclusero che il compito dell’istituzione «fosse quello appunto in cui potessero accentrarsi e far capo gli stu-
16. MATSCHEG, La Repubblica veneta, pp. 3-14.17. Cronaca dell’istituto accademico, «L’Ateneo Veneto», VIII (1884), vol. I, p.
208. Si veda il suo profilo a cura di LUCA PES in Dizionario biografico degli
Italiani, vol. 50, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1998, ad vocem.18. Quattro anni di presidenza, ibid., XIV (1890), vol. I, fasc. 1-2, pp. 6-7.19. DIENA, Ai cultori delle patrie memorie, p. 6.
53
dii che si riferiscono specialmente a Venezia» nel passato e nel presente. A questo scopo la presidenza chiamò l’avvocato Antonio Battistella, provveditore agli studi per la provincia di Treviso a «iniziare un corso di lezioni di storia Veneta, riattivan-dosi cosi, sott’altra forma, quella Scuola di storia patria, che fu tenuta per lo passa-to con tanto plauso nel nostro Ateneo». Battistella tenne dieci lezioni che l’Ateneo aveva l’intenzione di pubblicare nei prossimi fascicoli della rivista, cosicché «i let-tori potranno giudicarne l’importanza, non disgiunta da chiarezza e da semplicità». Le lezioni furono pubblicate in seguito dallo Zanichelli (Bologna 1897)20. La proposta fatta al prof. Battistella era stata quella di un corso triennale di qua-ranta lezioni che spaziassero dalle origini alla caduta della Repubblica. Ma il suo trasferimento in una sede più lontana, portò l’Ateneo a proporre a Vincenzo Marchesi «che aveva dato già così splendida prova di conoscenza sicura dell’ar-gomento» di tenere le lezioni. Questo corso, in pratica una scuola, avrebbe do-vuto avere un carattere popolare e gratuito. E poiché ricorreva il centenario della caduta della Repubblica ed erano state dette e pubblicate tante menzogne sul suo conto, accolte non solo da stranieri ma anche da celebri scrittori d’Italia, come sostenne la presidenza,
furono necessarie accurate indagini e studi indefessi, per anni ed
anni continuati, da parecchi valentissimi nostri concittadini, e gli
atti di eroismo, e i patimenti e i sacrifici d’ogni maniera da tutto un
popolo serenamente sopportati, per ben diciotto mesi di lotta contro
un potentissimo Impero, furono pur necessari a detergere il nome Ve-
neziano dagli oltraggi per mezzo secolo contro di lui ripetuti.
Il compito dell’Ateneo era quindi «di provvedere affinché nel popolo nostro, pel lungo volgere del tempo e pel succedersi delle generazioni, non cadano in oblio i grandi fatti ed i grandi ammaestramenti che rifulgono dalla istoria del suo paese»21.Con le lezioni di Marchesi iniziò il ciclo triennale della scuola che vide negli anni una media di 15-20 iscritti di ambedue i sessi, ma con un numero ridottissimo di concorrenti al premio finale (una media di 4-5 persone)22. Marchesi divise
20. ID., Cronaca dell’Ateneo Veneto, ibid., XIX (1896), vol. I., fasc. I, pp. 6-7; DIENA, Ai cultori delle memorie patrie, ibid., XX (1897), vol. I, fasc. I, pp. 6-11.
21. Ibid., p. 7.22. Cronaca dell’Ateneo Veneto, ibid., XX (1897), vol. I, fasc. II, p. 137; ibid.,
fasc. III, pp. 282-283; ibid., XXII (1899), vol. I, fasc. III, p. 261.
LA STORIOGRAFIA PATRIOTTICA
54 L’ISTITUZIONE
la storia di Venezia in tre parti: il primo anno era dedicato al periodo medievale fino alla metà del Trecento; il secondo anno andava dalla guerra di Chioggia nel 1380 fino alla lega di Cognac del 1526 e la fine delle guerre d’Italia; il terzo anno si occupò di Venezia dal 1530 alla caduta nel 179723. Marchesi, di matrice liberale, scelse di fermarsi più sullo splendore veneziano me-dievale e rinascimentale che sui secoli più problematici, quelli che iniziano con la guerra di Cipro (1571) e la cessione dell’isola al Turco, attraverso il Seicento e il secolo “della decadenza”: il Settecento. Il suo successore nel 1900, Pietro Orsi (1863-1943), professore di storia moderna prima all’Università di Bologna, poi di Storia politica e diplomatica all’Istituto superiore di commercio di Venezia, ave-va una visione diversa: sostituì la narrazione cronologica con quella che mise «una volta tanto nella debita luce i trionfi della nostra diplomazia», e quindi passò a un corso tematico incentrato per lo più sul Settecento e sui dispacci degli ambasciatori in Francia negli anni 1780-179024. Nel 1901, con Eugenio Musatti, si tornò a una lettura classica, anche se parziale: le origini di Venezia, il doge, le imprese marittime, Enrico Dandolo, Marco Polo, il Consiglio dei dieci, la conquista della terraferma, la Lega di Cambrai25. Musatti rimase solo un anno come direttore del corso e venne sostituito nel 1902 dallo storico militare e professore a Padova Camillo Manfroni (1863-1935), autore della Storia della marina italiana (3 voll., 1899-1902)26. Manfroni cambiò completamente rotta e diede una lettura politica alla storia di Venezia. Con l’interesse per l’Adriatico e per le terre dalmate che secondo lui costituivano lo sbocco naturale della dinamica imperialistica dell’Italia e con le mire espansionistiche italiane nell’Africa viste come il primo passo per assicu-rarsi il controllo del Mediterraneo, era inevitabile parlare de «Le prime crociate e gli stabilimenti coloniali di Venezia», di «Venezia condominatrice dell’impero d’Oriente» oppure di «Politica coloniale e commerciale di Venezia nel secolo XV»27. Questo linguaggio bellico, che vedeva negli ottomani il nemico principa-
23. Ibid., XX (1897), vol. I, fasc. II, p. 281; ibid., XXI (1898), vol. II, pp. 3-4 e la lezione «La Repubblica di Venezia nel 400 e nella prima metà del 500», ibid., pp. 8-17; Cronaca dell’Ateneo Veneto, ibid., XXII (1899), vol. I, fasc. III, pp. 261-262.
24. Ibid., XXIII (1900), vol. I, fasc. III, p. 256.25. Ibid., XXIV (1901), vol. I, fasc. II, p. 290.26. Si veda il suo profilo a cura di GIUSEPPE MONSAGRATI in Dizionario biografico de-
gli Italiani, vol. 68, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2007, ad vocem. 27. Cronaca dell’Ateneo Veneto, «L’Ateneo Veneto», XXV (1902), vol. I, fasc.
II, p. 154.
55
le di Venezia, che valutava tutta la storia della Serenissima attraverso uno sguar-do conflittuale, si accaniva contro certi storici stranieri che osavano giudicare la politica veneziana come egoistica: Manfroni giustificava l’espansione verso la terraferma e la politica di neutralità nel tentativo di liberare l’oriente mentre tutta l’Europa era «dilaniata da guerre fierissime». Venezia insomma era stata «tutrice dell’Italiana indipendenza»28.Manfroni non era l’unico a sostenere queste opinioni in un clima di crescendo bellico e di espansione coloniale nel corno d’Africa e in Cirenaica e di rinnovate pretese sull’Adriatico. Nella prolusione della cerimonia del premio annuale, tenuta nel 1902, il vice-presidente per la classe delle lettere e scienze morali Giuseppe Occioni Bonaffons sostenne che nel passato dapprima la storiografia di Venezia era stata influenzata da detrattori come Daru che «si favoleggiasse sul despotismo del Consiglio dei dieci, e dell’immaginario Consiglio dei tre, sul terrore delle in-quisizioni ecc. ecc.». Poi, dopo qualche decennio, che in essa cominciò a prevalere «una certa corrente rivolta a tutto giustificare o lodare anche con qualche esagera-zione». «Ora, grazie a Dio, lo studio, forte, costante, illuminato e conscienzioso di tanti documenti […] ci fanno capaci di giudicare e di esporre i fatti più importanti quali essi furono». Concludeva osservando che «non tornerà più la potenza e la grandezza di Venezia, quale fu al tempo di Pietro Orseolo II o di Enrico Dandolo; ma pur qualche cosa si può fare ancora». E qui esce allo scoperto l’impostazione voluta e condivisa delle lezioni di Manfroni, poiché l’oratore aggiungeva: «se il do-minio quasi assoluto ed esclusivo dei mari non sarà più nostro, si potrà per lo meno con perseveranti sforzi ottenere, che Venezia non rimanga l’ultima fra le città e le provincie consorelle, come pure l’Italia non sia l’ultima cioè la meno operosa e quindi prosperosa fra le nazioni europee». Questa visione assoggettava pratica-mente l’insegnamento della storia di Venezia all’ideologia prevalente in quel tempo poiché l’istruzione aveva il compito di procurare «al nostro buon popolo capacità e virtù operosa, e coscienza dei propri doveri oltreché dei diritti»29. Non si disco-stò di molto la visione espressa nel 1904 dal presidente dell’Ateneo Filippo Nani Mocenigo il quale sostenne che fin dai tempi del doge Pietro Orseolo II (che «salpò da Venezia colla sua numerosa flotta ad occupare le coste dell’Istria e della Dalma-zia»), «Venezia poté dire che l’Adriatico fosse suo», e quindi «mare nostro»30.
28. Lezioni di storia veneta, ibid., XXVII (1904), vol. I, fasc. III, pp. 381, 385.29. Cronaca dell’Ateneo Veneto, ibid., XXV (1902), vol. I, fasc. III, pp. 287-
288.30. Lezioni di storia veneta, ibid., XXVII (1904), vol. I, fasc. III, p. 377.
LA STORIOGRAFIA PATRIOTTICA
56 L’ISTITUZIONE
Dopo un triennale trionfante di lezioni, l’Ateneo Veneto chiese allo storico Giu-seppe Pavanello (1871-1933), esperto di storia medievale veneta, di tenere il corso per i successivi tre anni. Era per lui, quindi, molto naturale uno sguardo soprattutto puntato sull’epoca delle origini della città31. Studioso di cronache, Pavanello impostò il corso seguendo il formato della vita dei dogi, attribuendo ad Andrea Dandolo (chiamato «il conte di Virtù») e la sua cronaca, un ruolo be-nefico dove «l’opera di Dandolo, si può affermarlo, fu la Bibbia del suo popolo» poiché «Patria e fede, ecco i due altissimi ideali, ispiratori della grand’opera»32. Pavanello, come Manfroni prima di lui, era convinto che l’espansione venezia-na verso la terraferma fosse stata giusta e non frutto di «egoismo e miopia» come sostenevano Samuele Romanin, Horatio Brown e Ludwig von Pastor: «Venezia nacque anzitutto repubblica italiana, non più destinata per il dominio del mare che per quello della terra: i suoi tribuni erano degli agricoltori e dei marini ad un tempo»33. Salvando quindi capra e cavoli, Pavanello chiuse nel 1908 il terzo anno del corso con un elenco di rivendicazioni34:
All’antica [Venezia] non potrà forse mai più (dall’aspetto del mon-
do non è lecito prevedere la ricostituzione di piccoli stati, nè sarebbe
desiderabile per noi); ma al riacquisto di quel commercio, che dal
trattato di Passarovvitz le fu, di giorno in giorno, sotratto dal go-
verno di Vienna, ella ha diritto e dovere di aspirare. Ed anche a cose
maggiori. Napoleone avea in pensiero di farne il centro del traffico
marittimo del suo regno italico, di ricondurla ad essere il tramite
commerciale con l’Oriente ed un forte cantiere di guerra […]. Or
bene, sia quel grande imitato dai governanti della nova Italia e Ve-
nezia attingerà, senza dubbio, ad altezze maggiori. […] Venezia
non deve e non vuol essere un museo d’arte o un conservatorio di
musica o una villeggiatura per l’Europa oziante, qual fu nel Sette-
cento, ma riprendere la sua posizione commerciale nel mondo, avere
una storia nuova.
31. Ibid., XXIX (1906), vol. II, fasc. I, pp. 145-148.32. Ibid., vol. II, fasc. I, pp. 150-154.33. Ibid., XXX (1907), vol. I, fasc. III, p. 384.34. Della storia in generale e quella di Venezia in particolare, ibid., XXXI (1908),
vol. I, fasc. III, pp. 186-187.
57
Quasi profetico nell’individuare i problemi della città per tutto il corso del No-vecento, Pavanello non esitò nella sua retorica a compiere il massimo sacrilegio: dare del “grande” a Napoleone e invitare i governanti a imitare la sua azione.I tempi mutarono e la vecchia convinzione che il corso di Storia veneta dovesse servire il pubblico e far parte dell’istruzione popolare, portarono anche la Pre-sidenza dell’Ateneo a cercare dei modi nuovi per coniugare profondità con sem-plicità nel tentativo di coinvolgere un vasto pubblico (perfino la Società nazio-nale delle giovani operaie)35. Il ritorno di Manfroni nel 1909 a dirigere un altro corso fu così caratterizzato da uno notevole sforzo di unire l’utile al dilettevole. Lontani dalla storiografia ottocentesca rappresentata da Romanin o da altri studiosi, assidui frequentatori dell’Archivio di Stato, il nuovo approccio, già espresso da Occioni-Bonaffons, si allontanava da un’esposizione cronologica e minuziosa di dati e fatti e adottava sintesi che cercavano di spiegare cause ed effetti: «allora anche la monotona sequela abbandona la propria secca nudità, e diventa espressiva, come una polemica, e concludente come una novella»36. Manfroni fu affiancato nel 1910 da altri insegnanti come Andrea Moschetti, Roberto Cessi, l’archivista Mario Brunetti, Eugenio Musatti e Pier Liberale Rambaldi che si alternavano37. La scommessa di favorire la frequenza del corso fu vinta poiché i frequentatori furono 70 in media38. Negli anni che seguirono fino alla Grande guerra furono innanzitutto Pavanello e Battistella a tenere ciò che ormai veniva chiamata la “Cattedra di Storia di Ve-nezia”, dando una nuova lettura, consona ai tempi, e quindi di matrice “sociali-sta” alla storia della Serenissima39:
Tutto codesto lavoro legislativo, tutta codesta cura continua e vigi-
lante diretta a migliorare le condizioni delle più basse e più povere,
ma non meno utili classi sociali e a fare di esse un elemento d’ordine,
di forza e di ricchezza per lo stato, costituisce per la Repubblica un
35. Cronaca dell’Ateneo Veneto a.a. 1908-9. Inaugurazione delle lezioni di storia
veneta, ibid., XXXII (1909), vol. I, fasc. II, p. 280.36. Lezioni di storia veneta, ibid., XXXI (1908), vol. I, fasc. III, p. 179: discor-
so di Occioni-Bonaffons.37. Ibid., XXXIII (1910), vol. II, fasc. I, pp. 159-160.38. Cronaca dell’Ateneo Veneto a.a. 1908-9. Inaugurazione delle lezioni di storia
veneta, ibid., XXXII (1909), vol. I, fasc. II, p. 280.39. Lezioni di storia veneta, ibid., XXXVI (1913), vol. I, fasc. III, p. 263: Di-
scorso dell’insegnante di Storia Veneta.
LA STORIOGRAFIA PATRIOTTICA
58 L’ISTITUZIONE
titolo di merito di cui comunemente si tien poco conto per l’erroneo
sistema, invalso specialmente nelle scuole, di restringere la storia d’un
popolo suppergiù alle sue imprese di guerra e di conquista. Certo, an-
che in materia di politica economica Venezia fu modello agli altri sta-
ti, e noi stessi, dopo tanto corso di vicende e tanto fiorire di progresso,
sotto alcuni rispetti non abbiamo sinora saputo o potuto fare di più.
I germi del futuro prossimo che attendeva l’Italia sono tutti racchiusi in queste parole. La storiografia divulgativa si soggiogava a una lettura politica usando la Repubblica di Venezia come esempio per dimostrare il tutto e il contrario di tut-to. Passeranno ancora trent’anni fino a un ripristino di un corso più equilibrato nei toni e nei propositi40.
40. Sul corso di Storia Veneta tra le due guerre mondiali si veda GIUSEPPE GUL-
LINO, L’Ateneo Veneto, in Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento, a cura di Mario Isnenghi e Stuart Woolf, vol. III, Il Novecento, a cura di Mario Isnen-ghi, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2002, pp. 1859-1873.


































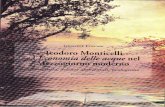





![Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63141b0cfc260b71020f6789/unesperienza-etimologica-veneta-per-la-storia-di-mona-padova-esedra-2011.jpg)


