Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]
Transcript of Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]
Volume pubblicato con il contributo della Scuola Normale Superiore di Pisa
Ricerca “Vocabolario storico dei dialetti veneti” coordinata da Ivano Paccagnella, Vittorio Formentin,
Gino Belloni, Alfredo Stussi
© 2011 by Esedra editrice s.r.l.Via Palestro, 8 - 35138 PadovaTel. e fax 049/723602e-mail: [email protected]
INDICE
1. Questioni preliminari 9 1.1. Bisanzio e Venezia 9 1.1.1. La più antica attestazione di 9 1.1.2. Sull’etimo di (e sul tipo lessicale ‘monte di Venere’) 12 1.1.3. La tesi di Cortelazzo 16 1.2. Schede sulla vitalità di mona in italiano 18
2. Diacronia e semantica di mona ‘sciocco’ e monada ‘sciocchezza’ 25
3. Le attestazioni più antiche dell’accezione sessuale 39 3.1. Alcune assenze e alcuni problemi tipologici 39 3.2. L’attestazione di Benedetto Dei (Milano, anni Settanta del Quattrocento) 42 3.3. Bernardino Zambotti (Ferrara 1496) 44 3.4. Attestazioni veneziane cinquecentesche (con qualche addizione successiva) 46 3.5. Altre due occorrenze cinquecentesche e l’ipotesi metaforica 51
4. Ragioni di una metafora 57 4.1. Considerazioni generali, e qualche avvertenza 57 4.2. Gatti 60 4.3. Scimmie 69 4.3.1. Scimmie rinascimentali I: buffonerie circensi 69 4.3.2. Scimmie rinascimentali II: l’esibizione delle terga 77 4.3.3. Scimmie rinascimentali III: le labbra della scimmia e il bacio alla scimmia. Congetture 83
5. La vitalità della metafora lontano da Venezia 93 5.1. Traslati sessuali in testi fiorentini tre- e quattrocenteschi 93 5.2. La testimonianza di altre lingue 103
6. Osservazioni conclusive 105
Indice dei nomi e delle opere anonime 109
Così il lessicografo imbelle e impotente annota e spiega sulla scorta dei testi parole come: san-gue, guerra, femmina, culo, cunno e membro! Finché la sua vita non verrà sconvolta da un ge-nitale da due soldi, un articolo di fondo patriot-tico, un boccale di birra tiepida e scadente.
Giorgio Manganelli, Hilarotragoedia
Nell’arte del linguaggio si chiama metafora ciò che «non si usa in senso proprio». Perciò le me-tafore sono le perversioni del linguaggio e le perversioni sono le metafore dell’amore.
Karl Kraus, Detti e contraddetti
1. Questioni preliminari *
1.1. Bisanzio e Venezia1.1.1. La più antica attestazione di Sembrerebbe un fatto oramai passato in giudicato che l’eti-
mo della voce mona, diffusa in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino nell’accezione primaria di ‘organo sessuale femmi-nile’, vada riconosciuto nel greco , con lo stesso signifi-cato. La formulazione più solida dell’ipotesi si deve a Manlio Cortelazzo1; ma l’accostamento era già stato prospettato da
* Si impiegano le seguenti sigle: ais = K. Jaberg - J. Jud, Sprach- und Sa-chatlas Italiens und der Südschweiz, Zofingen, Ringier & Co., 1928-1940; deli = M. Cortelazzo - P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana. 2a ed. a c. di M. Cortelazzo e M.A. Cortelazzo, Bologna, Zanichelli, 1999; dle = V. Bog-gione - G. Casalegno, Dizionario del lessico erotico, Torino, UTET, 2004; few = Französiches etymologisches Wörterbuch, a c. di W. von Wartburg, Bonn, Klopp, 1928-2002 (numero di volume e pagina, seguiti da lettera della colonna [a o b]); gdli = Grande dizionario della lingua italiana, a c. di S. Battaglia e di G. Barberi Squarotti, Torino, UTET, 1961-2002; lei = Lessico Etimologico Italiano, a c. di M. Pfister e W. Schweickard, Wiesbaden, Reichert, 1979 e sgg. (numero di volume, colonna e riga); liz = Letteratura italiana Zanichelli, a c. di P. Stoppelli ed E. Picchi, Bologna, Zanichelli, 2001, versione 4.0; rew = W. Meyer Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, Winter, 1935.
Ringrazio di cuore per i loro preziosi suggerimenti Federica Accorsi, Chiara Battistella, Gino Belloni, Alessandro Benassi, Andrea Bocchi, Cosi-mo Burgassi, Marta Cardin, Giuseppe Di Stefano, Ronnie Ferguson, Vittorio Formentin, Lida Maria Gonelli, Lucia Lazzerini, Tommaso Migliorini, Leyla Ozbek, Ivano Paccagnella, Chiara Schiavon, Giancarlo Schizzerotto, Alfredo Stussi, Mario Telò e Lorenzo Tomasin. Questo libretto è per tutti gli amici conosciuti a Pisa negli ultimi dodici anni.
1 M. Cortelazzo, L’influsso linguistico greco a Venezia, Bologna, Pàtron, 1970, pp. 145-147. Tra le recensioni al libro che ho potuto vedere contengo-no osservazioni sull’etimo di mona quella di G.B. Pellegrini («Studi mediola-tini e volgari», XVIII, 1970, pp. 264-267), p. 265: «quanto al rapporto tra
, (fonte del ven. mona) con ‘mons (Veneris?)’ sarebbero necessarie ulteriori ricerche complementari nell’ambito della demologia e
UN’ESPERIENZA ETIMOLOGICA VENETA10
Giuseppe Boerio: «I Greci moderni dicono Munì, il che la-scia in dubbio se questa voce sia venuta dai Greci a noi, o da noi sia passata ai Greci»2. La seconda supposizione – che ha goduto e gode di qualche consenso – è facilmente confuta-bile in forza dei documenti, dato che il greco offre per attestazioni di rispettabile antichità, mentre per raccogliere qualche testimonianza di mona a Venezia bisogna arrivare al Cinquecento inoltrato3. La più antica occorrenza della voce greca s’incontra infatti nell’epilogo della Teogonia di Giovanni Tzetzes (1110 ca.-1180 ca.), che per fornire una virtuosistica riprova delle proprie doti di poliglotta offre un saggio delle numerose lingue parlate a Bisanzio nel XII secolo4. Ogni lin-
dei gerghi»; e quella di V. Pisani («Paideia», XXVI, 1971, pp. 207-210), pp. 208-209: «io suggerisco qui che in veneziano mona possa essere semplicemen-te l’italiano monna ‘madonna, signora’, con un passaggio semantico umori-stico analogo a quello per cui il genitale maschile può essere indicato come “quel signore” o simili» (una rassegna esaustiva delle recensioni a L’influsso linguistico greco a Venezia, cit. si trova in M.A. Cortelazzo, Contatti linguistici. Bibliografia veneta, Battaglia Terme, La Galiverna, 1983, p. 21). Attestazioni veneziane cinquecentesche della parola in M. Cortelazzo, Dizionario vene-ziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo, Limena (PD), La Linea Editrice, 2007, pp. 840 e 842 alle voci mona2 e monina.
2 G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Cecchini, 1856, p. 422 (citerò sempre dalla seconda edizione, ma le voci che c’interessano com-paiono identiche già nella prima, del 1829).
3 La derivazione di da mona è sostenuta da G. Meyer, Neugriechische Studien. IV. Die romanischen Lehnworte im Neugriechischen, in «Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe», 1895, vol. 135, fasc. 6, pp. 1-106, a p. 54, ed è passata a N. Andrio-tes, , Tessalonica, 1967, p. 213 (che la dà come prima ipotesi) e al Dizionario greco moderno – italiano, Roma, GEI, 1993, p. 639; la medesima ipotesi etimologica è enunciata in few XIX, 117b (= Orientalia, Basel, Zbinden Druck und Verlag, 1967 sgg.: l’articolo maimun è stampato alle colonne 115b-118a del fascicolo n° 122, Basel, Zbinden, 1968).
4 H. Hunger, Zum Epilog der Theogonie des Johannes Tzetzes, in «Byzanti-nische Zeitschrift», XLVI, 1953, pp. 302-307, p. 305, v. 21, rist. anast. come diciottesimo saggio in Id., Byzantinische Grundlagenforschung, London, Vario-rum Reprints, 1973. L’unico manoscritto a testimoniare per intero la tra-
QUESTIONI PRELIMINARI 11
gua è rappresentata da una formula di saluto, della quale è of-ferta la traduzione in greco popolare. Ai vv. 18-22 dell’epilogo vengono proposte due formule di saluto degli Alani, di solito identificati con gli antichi abitanti dell’Ossezia5:
18 :19 ;20 20a 21
22 .
In corsivo sono stampati i versi corrispondenti alle glosse in greco popolare, che sono scritte in rosso sul codice sfruttato per l’edizione, e che vanno riferite al testo ossetico immedia-tamente successivo (vale a dire che il v. 19 traduce il v. 20, e il v. 21 traduce il v. 22); il v. 18 introduce la sezione alana, mentre il v. 20a è presente sul solo testimone vindobonense individuato da Hunger, che per non scompaginare la nume-razione di versi acquisita agli studi sigla così il nuovo verso portato dal solo manoscritto V. A parte i vv. 20 e 22, la cui analisi richiede competenze specifiche, per il resto si può pro-porre la seguente traduzione di servizio (crudamente fedele al testo): «Mi rivolgo agli Alani nella loro lingua: / “Buongiorno a te, mio padrone, signora, come stai?” / [...] / E se un’Alana avesse un prete come amante, potresti sentire questo: / “Non ti vergogni, mia signora, che un prete ti fotta la fica?” / [...]».
duzione della formula di saluto alana, compreso l’emistichio che contiene , è il Vind. phil. gr. 118 (XIV sec.), individuato e impiegato per la prima
volta da Hunger anche in ragione della superiorità testuale rispetto all’unico altro testimone integrale dell’epilogo, il Vat. Barb. gr. 30 (XV sec.), nel quale la sezione presenta diversi guasti materiali e risulta di difficile lettura.
5 H. Hunger, Zum Epilog der Theogonie des Johannes Tzetzes, cit., p. 305. Non ho trovato bibliografia specifica sulle reliquie ossetiche dell’epilogo (vd. in generale G. Dragon, Formes et fonctions du pluralisme linguistique à Byzance (IXe-XIIe siècle), in «Travaux et Mémoires», 12, 1994, pp. 219-240, alle pp. 239-240).
UN’ESPERIENZA ETIMOLOGICA VENETA12
Hunger non traduce il testo dell’epilogo, ma nota lo «über-raschend [...] obszöne Ton in dem vulgärgriechischen Vers 21» spiegando che « ist die Volkstümliche Entsprechung von schriftsprachlichen ; bedeutet hier wie in der neugriechischen Volkssprache ‘geschlecht-lich verkehren’. Die Tatsache, dass ein Geistlicher ( ) als Liebhaber der Alanin genannt wird, war vielleicht für den Schreiber von B bzw. von dessen Vorlage Grund genug, Vers 20 überhaupt auszulassen und 21 zu verstümmeln»6.
1.1.2. Sull’etimo di (e sul tipo lessicale ‘monte di Venere’)Caduta l’ipotesi che la voce greca potesse derivare da quel-
la veneziana, la ricostruzione attualmente più accreditata per spiegare muove da , diminutivo di ‘letto nu-ziale’7. Cortelazzo aderisce tuttavia a un’idea diversa, merite-vole di essere discussa, secondo la quale il punto d’avvio sareb-bero ‘monte’ e il suo diminutivo (donde, con spostamento d’accento e mutamento consonantico, ). La prima formulazione di questa ipotesi risale probabilmente a Du Cange, che chiosa così la voce greca: «Cunnus in Corona Pretiosa. Forte pro , quomodo Mottam vulgo dicimus»8.
6 H. Hunger, Zum Epilog der Theogonie des Johannes Tzetzes, cit., p. 307.7 Cfr. G. N. Chatzidakis, , Atene, Sakel-
lariou, 1905, vol. I, p. 395: , pronunciato /vn’ion/, sarebbe stato reso con la grafia omofona * , e da qui, secondo una trafila comune, sareb-be passato a * e quindi a * con anaptissi di tra e consonante successiva. È questo il primo etimo allegato anche nel recente Greco antico, neogreco e italiano. Dizionario dei prestiti e dei parallelismi, a c. di A. Kolonia e M. Peri, Bologna, Zanichelli, 2008, p. 361. Degna di nota anche l’ipotesi di O. Haas (rammentata da G.R. Cardona nella sua recensione a M. Cortelazzo, L’influsso linguistico greco a Venezia, cit., in «Lingua nostra», XXXII, 1971, pp. 96-98), secondo la quale si dovrebbe partire da « ‘fico san-guigno o rosso sangue’, con ellissi di per eufemismo; il passaggio da
a sarebbe regolare» (p. 98).8 C. Du Cange, Glossarium ad scriptores Mediae et Infimae Graecitatis, Paris,
Collège de France, 1943, p. 692 s.v. (rist. anast. dell’ed. Lugduni, 1688; la ristampa anastatica più recente è quella di Bologna, Forni, 2004; tra i les-
QUESTIONI PRELIMINARI 13
La stessa proposta s’incontra a distanza di due secoli abbon-danti nella scheda che Karl Krumbacher dedica a un lavoro di Paul Kretschmer sullo scambio di e : «vielleicht gehört in die besprochene Kategorie auch neugr. (pars mu-liebris) aus (mons Veneris?)»9. A quanto pare, l’idea non è stata più presa in considerazione, e lo stesso lavoro di Kretschmer non si occupa nemmeno di sfuggita del problema posto dalla fonetica e dall’etimologia di ; soprattutto, la soluzione appare problematica dal punto di vista semantico, come ha rilevato Paola Benincà10:
M. Cortelazzo, Infl. greco [...] dimostra almeno, con diversi buoni argomenti, che il greco , non deriva dal venez. mona, ma, al contrario, sarebbe il punto di partenza della parola
sici successivi cfr. anche A. da Somavera, Tesoro della lingua greca – volgare ed italiana, Bologna, Forni, 1977 [rist. anast. dell’ed. Paris, Guignard, 1709], p. 249). La Corona Pretiosa è un manuale più volte ristampato, che cito dall’edi-zione del 1543: Corona Pretiosa La qual insegna la lingua Greca volgare & literale, Et la lingua Latina & il volgar Italico con molta facilità & prestezza, nuovamente emendata, Venezia, Ex Sirenis Officina, 1543 (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, III.h.34). Qui, a c. Fiiir si trovano registrati in corrispondenza di pota il greco volgare mugnì, il latino cunnus e il greco ‘literale’ ædion gynæcos (per tutte e quattro le forme si offrono anche i corrispondenti in caratteri greci). Quanto a mottam, il riferimento di Du Cange è diretto al fr. motte (lett. ‘altura’), che in epoca antica aveva significato sessuale: il Thresor de la langue française (1606) di Jean Nicot registra infatti La Motte d’un homme ou d’une femme, glossato con il latino pecten (‘pube’: i principali dizionari storici del francese sono consultabili in linea all’indirizzo www.lexilogos.com/français_ langue_ dictionnaires.htm). Per il supposto punto di partenza, , e per la sua tardiva diffusione in greco, vd. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire de mots, Paris, Klincksieck, 1990, vol. II, p. 190.
9 Segnalazione firmata K.K., in «Byzantinische Zeitschrift», VII, 1898, p. 628 (le iniziali sono con ogni verosimiglianza quelle di Krumbacher, curatore del volume). L’articolo segnalato è P. Kretschmer, Zur griechischen Lautlehre. 5. Wechsel von und , in «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», n.f. XV, 1899, pp. 603-608.
10 P. Benincà Ferraboschi, Note in margine alle «Etimologie Venete» di Ange-lico Prati, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CXXVIII, 1969/1970, pp. 673-704, p. 694.
UN’ESPERIENZA ETIMOLOGICA VENETA14
venez.. Resterebbe un punto debole per la semantica, cioè l’eti-mo della parola greca, che sarebbe ‘monte (di Venere)’, in quanto pare che il ‘monte’ non costituisca una connotazione di tipo popolare: tuttavia mi sembra piuttosto importante il fat-to che l’immagine compaia nella simbologia onirica e in quella delle fiabe per indicare il sesso femminile.
L’obiezione riceve piena conferma per le lingue classiche: i Thesauri elettronici di latino e greco non offrono neppure un’attestazione per tipi affini (mons o mons Veneris, o
/ , tantomeno con lo specificatore ), e la metafora non è schedata neppure dai lavori di Jeffrey Henderson e James Noel Adams11. Anche l’italiano presenta una situazione analoga, dato che il dle offre un unico esem-pio pertinente, quello di collina in Giambullari (dle 130)12:
11 J. Henderson, The Maculate Muse. Obscene Language in Attic Comedy, New Haven and London, Yale University Press, 1975, pp. 130-148 e J. N. Adams, The latin sexual vocabulary, London, Duckworth, 1982, pp. 82-90. Re-stando a testi molto antichi, mi è capitato d’imbattermi in una sola immagine che assimili il ventre femminile a un oggetto simile a un monte: è quella del Cantico dei Cantici 7, 3 «Il tuo ombelico è una coppa rotonda / che non man-ca mai di vino aromatico. / Il tuo ventre è un covone di grano, / circondato da gigli» (La Bibbia. Nuova versione della Conferenza Episcopale Italiana, Milano, San Paolo, 2009, p. 1371).
12 Non si può usare a cuor leggero l’esempio di monticello ‘organo sessuale femminile’ schedato in dle 363 dal Manganello. Nella porzione di testo in questione la parola potrebbe infatti avere il significato opposto di ‘organo sessuale maschile’: «E cussì fo<r>no a casa al primo trato, / poi la madona disse: “Alexandrina, / sta’ qui su l’uscio e chiama questo matto / e fa’ star l’altre tute ala cucina / sì che nisuna vegna sul castello, / e dirai lor che piglio medicina”. / Poi se ritrasse in ciambra cum el Nello / e dispogliossi fino alla camisa / e cacioli la man al monticello, / riversossi sul leto e quivi strisa, / che parea una porca che rugisse, / e tirosel sul ventre a bella guisa, / e prima che da lei se dipartisse / tre ore il tene lì, discapigliata» (Il Manganel-lo - La reprensione del Cornazano contra Manganello, a c. di D. Zancani, Exeter, Exeter University Printing Unit, 1982, pp. 33-34, cap. X, vv. 61-74; per strisa al v. 70 cfr. a p. 40, cap. XII, v. 82 la dittologia «ruge e strisa» nonché *stridere ‘gridare’ in D. Trolli, Il lessico dell’«Inamoramento de Orlando» di Matteo Maria Boiardo. Studio e glossario, Milano, Unicopli, 2003, p. 283).
QUESTIONI PRELIMINARI 15
Bruno Migliorini ha anzi rilevato che l’associazione più tipica è quella tra monte e seno, tanto che tra i due termini è possibile osservare la cosiddetta metafora reciproca13. Stando al gdli e al dle, il tipo monte di Venere non sarebbe attestato in italiano prima del dizionario edito da Tramater (1829-1840); più tar-di si troverà ad esempio nel Dizionario Moderno di Panzini, a partire dalla prima edizione del 190514. Per di più, in alcuni testi cinquecenteschi d’area settentrionale, il monte di Venere designa senza possibilità di equivoci la zona della mano nella quale il chiromante legge il futuro sentimentale del proprio cliente15. Le poche attestazioni antiche per monte ‘organo ses-suale femminile’ rientrano piuttosto nel novero dei toponimi rianalizzati, tipo al quale appartengono tutti gli esempi repe-ribili nel dle 363: Monte Nero, Montecchio, Monteficale e Montevarchi, cui si può aggiungere «monte peloso» ricavabile da una lettera di Vincenzo Belando16.
13 B. Migliorini, La metafora reciproca (1949), in Id., Saggi linguistici, Fi-renze, Le Monnier, 1957, pp. 23-30, a p. 25.
14 Quasi certamente posteriori anche montagnola e monte registrati senza esempi antichi in G. Lotti, Le parole della gente. Dizionario dell’italiano gerga-le, Milano, Mondadori, 1992, p. 267. Cito il Dizionario Moderno di Alfredo Panzini servendomi dell’edizione storico-critica curata da Marianna Franchi nel 2010 e per ora interrogabile solo su CD-ROM (si tratta della tesi di per-fezionamento discussa presso la Scuola Normale Superiore di Pisa nel 2010, relatore Alfredo Stussi): tale lavoro consente di avere sott’occhio l’intera evo-luzione diacronica del Dizionario dalla prima edizione del 1905 alla settima del 1935, e include anche quelle postume del 1942, 1950, 1963.
15 Cfr. L. Ariosto, Commedie, a c. di A. Casella, G. Ronchi, E. Varasi, Mi-lano, Mondadori, 1974, p. 203 (Suppositi I ii); G.A. Giancarli, Commedie. La Capraria · La Zingana, a c. di L. Lazzerini, Padova, Antenore, 1991, pp. 229 e 233; A. Calmo, Rodiana, a c. di P. Vescovo, Padova, Antenore, 1985, p. 91. Un altro esempio relativamente antico è in G. Marino, L’Adone, a c. di G. Pozzi, Milano, Adelphi, 1988, vol. I, p. 918: «Questa virgula qui che la radice / della linea vital parte a traverso / e su ’l monte di Venere si spande, / scopre un nemico assai possente e grande» (canto XV, ottava 76, vv. 5-8); cfr. anche S. Rapisarda, Lessico tecnico della chiromanzia medievale, in Lo scaffale della biblio-teca scientifica in volgare (secoli XIII-XVI), a c. di R. Librandi e R. Piro, Firenze, Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2006, pp. 405-421, a p. 421.
16 Lettere facete, e chiribizzose in lengua antiga, Venitiana, et una a la Gratiana,
UN’ESPERIENZA ETIMOLOGICA VENETA16
1.1.3. La tesi di CortelazzoSe a Bisanzio la vitalità popolare della parola rimonta al XII
secolo (§ 1.1.1), e occorre dunque esaminarne l’etimo a parte (§ 1.1.2), l’idea che tra e mona dovesse esistere un rap-porto di parentela si è tuttavia imposta come l’unica in grado di spiegare la voce veneziana: secondo Cortelazzo, «se non si vuole tenere staccata la forma venez. (che, però, non si sapreb-be come altrimenti spiegare [...]), dal corrispettivo neogr. [...], sarà più facile che la prima sia derivata dalla seconda»17. A Cor-telazzo è sembrato dunque che una soluzione soddisfacente si potesse ottenere invertendo i termini del problema, e scorgen-do in mona un grecismo di seconda ondata penetrato per via soldatesca a Venezia tra Quattro e Cinquecento. La tesi è stata quasi unanimemente accettata, ammettendosi tutt’al più che all’etimo greco possa essersi sovrapposta l’influenza di altre voci omofone: così, limitandosi ad alcuni importanti lavori re-centi, la Linguistic History of Venice di Ronnie Ferguson ritiene la voce probabilmente connessa alla base greca18; il Dizionario eti-mologico dei dialetti italiani riprende com’è ovvio l’ipotesi di Cor-telazzo, segnalando la possibile influenza di mon(n)a ‘scimmia’ e di mon(n)a ‘signora’ (< m(ad)onna)19; del pari l’ultima ristam-
con Alguni Sonetti, e canzoni piasevoli Venitiani, e toscani e nel fin trenta villanelle a diversi signori e don(n)e lucchesi et altri. El tutto composto e dao in luse da Vincenzo Belando sic. ditto cataldo: al illvstre signor Sebastian Zametti. in Parigi, Appresso Abel l’Angelieri nella prima colonna del palazzo. M. D. LXXXVIII. con privilegio (Mode-na, Biblioteca Estense Universitaria, J 11 22), c. 69r.
17 M. Cortelazzo, L’influsso linguistico greco a Venezia, cit., p. 146. Per at-testazioni di posteriori a quella di Tzetzes vd. Lexikon zur byzantinischen Gräzität, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, fasc. 5, 2005, p. 1047, s.v. . Sul legame esistente tra la voce greca e quella veneziana aveva espresso perplessità G. Rohlfs, Lexicon graecanicum Italiae inferioris. Etymologisches Wörterbuch der unteritalienischen Gräzität, Niemeyer, Tü-bingen, 1964 (I ed. 1930), p. 338, s.v. : «Das Wort wird meist mit venez. mona ‘conno’ verbunden (Andriotis 147), was sehr zweifelhaft ist».
18 R. Ferguson, A linguistic history of Venice, Firenze, Olschki, 2007, p. 274: «of disputed etym. but prob. connected to ‘cunt’».
19 M. Cortelazzo - C. Marcato, Dizionario etimologico dei dialetti italiani,
QUESTIONI PRELIMINARI 17
pa del dle accetta l’etimologia greca e allega come concause il possibile «traslato zoonimo da monna ‘bertuccia scimmia’» e la «connessione secondaria con monna o mona ‘signora’»20. Quanto a quest’ultima ipotesi, avanzata anche da Pisani (vd. nota 1), mi pare non metta conto discuterne, perché l’idea – plausibile dal punto di vista generale – deve fare i conti con il problema cruciale che nei dialetti veneti monna ‘signora’ non ha mai avuto corso (senza contare che mona ha la tonica chiusa mentre monna ha la tonica aperta).
Le pagine seguenti si propongono di illustrare le ragioni che rendono poco persuasiva l’ipotesi d’una provenienza del termine dal greco. In effetti, l’affermazione di Cortelazzo se-condo cui la parola «non si saprebbe altrimenti spiegare» sem-
Torino, UTET, 1998, p. 287; già M. Cortelazzo, L’influsso linguistico greco a Venezia, cit., p. 147 ricordava «l’influsso che possono aver avuto l’omofono mona ‘scimmia’ ed altre voci affini».
20 dle, 360. Allego anche l’etimologia proposta per mona da alcuni dizio-nari dell’italiano. gdli X, 755: dal greco ; A. Duro, Vocabolario della lingua italiana, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1989, vol. III*, p. 281: etimo incerto; F. Sabatini - V. Coletti, Dizionario italiano Sabatini Coletti, Firenze, Giunti, 1997, p. 1582: etimo incerto; T. De Mauro, Grande dizionario italiano dell’uso, Torino, UTET, 2000-2003, vol. IV, p. 273: etimo incerto, forse dal neogreco ; Lo Zingarelli 2006, Bologna, Zanichelli, 2005, p. 1130: «prob. vc. di orig. gr.; 1534»; G. Devoto - G. Oli, Il Devoto - Oli 2008. Vocabola-rio della lingua italiana, a c. di L. Serianni e M. Trifone, Milano, Edumond - Le Monnier, 2007, p. 1722: «Voce veneta, di origine incerta || sec. XV». Va citato qui anche M. Doria, Grande dizionario del dialetto triestino, Trieste, Edizioni de “Il Meridiano”, 1987, pp. 384-385, che dà quattro ipotesi: la derivazione da mona ‘scimmia’, da mona ‘signora’, dal nome proprio Simona, dal greco. Tra gli altri dizionari dialettali, si pronunciano sulla questione D. Durante - G.F. Turato, Dizionario etimologico veneto - italiano, Padova, Erredici, 1975, p. 307 («probabilmente dal greco “mouni” = stesso significato. Secondo altri dall’an-tico “madonna” = signora, accorciato in “monna” e “mona” in veneto»); G. Sparapan, Dizionario della parlata veneta tra Adige e Canalbianco, Rovigo, Euro-print - Banca di Credito Cooperativo, 2005, p. 166 («dal lat. volg. mea domna») e O. Zambon, Glossario del dialetto veneziano di terraferma, Treviso, Vianello, 2008, p. 219, che riporta dubitativamente l’opionione di Cortelazzo. Non prende posizione, con comprensibile cautela, C. Marcato, Ricerche etimolo-giche sul lessico veneto. Rassegna critico bibliografica, Padova, Cleup, 1982, p. 100.
UN’ESPERIENZA ETIMOLOGICA VENETA18
bra un po’ troppo netta21; una spiegazione alternativa c’è, ed è fino a prova contraria quella più economica, affacciata ma mai adeguatamente discussa: mona ‘organo sessuale femminile’ può essere considerato il capolinea di un processo metaforico che ha come punto di partenza mona nel significato animale di ‘scimmia’22.
1.2. Schede sulla vitalità di mona in italianoSarà bene svolgere in via preliminare qualche osservazione
anche sul radicamento di mona in italiano. Il lemma è registra-to come regionalismo da tutti i più importanti dizionari sin-cronici (l’attestazione vocabolaristica più alta sembra datare
21 E dipende forse anche dal responso parimente pessimista di A. Prati, Etimologie venete, a c. di G. Folena e G.B. Pellegrini, Venezia - Roma, Istituto per la Collaborazione Culturale, 1968, p. 106: «Di origine non determinata».
22 Tra quanti hanno avanzato senza approfondirla l’ipotesi di una deriva-zione del significato sessuale da quello animale ricordo A. Panzini, Dizionario moderno, edizione storico-critica a c. di M. Franchi, cit. (a partire dall’edizio-ne del 1908); G. Bonfante, Sull’animismo delle parti del corpo in indoeuropeo, in «Ricerche linguistiche», IV, 1958, pp. 19-28, a p. 23 nota 19; N. Galli de’ Paratesi, Semantica dell’eufemismo. L’eufemismo e la repressione verbale con esempi tratti dall’italiano contemporaneo, Torino, Giappichelli, 1964, p. 89 (e nella ri-stampa Le brutte parole. Semantica dell’eufemismo, Milano, Mondadori, 1969, pp. 106-107); R. Bracchi, Parlate speciali a Bormio, «Atti della Accademia Nazio-nale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», XXX, 1987, pp. 212-213; E. Ferrero, Dizionario storico dei gerghi italiani. Dal Quattrocento a oggi, Milano, Mondadori, 1991, p. 223; e da ultimo R. Bracchi, Nomi e volti della paura nelle valli dell’Adda e della Mera, Tübingen, Niemeyer, 2009, p. 294 nota 271 (tra le pubblicazioni locali vd. E. Scalfi, Duemila parole del mio paese. Tentativi etimologici sul dialetto di Tione, Trento, Panorama, 1983, p. 71; P. Zardetto, Piccolo dizionarietto del dialetto parlato nella zona di Coneglia-no e dintorni, con proverbi, modi di dire e citazioni sull’origine di alcuni vocaboli... ed altre storie tra realtà e leggenda, Treviso, Canova, 2000, 2a ed. aggiornata, p. 103). Il problema era già stato posto da Migliorini: «Quali rapporti abbiano con monello e tra loro i vocaboli mòna, mònna ‘signora’, mona, monna, monnino ‘scimmia’, tosc. mòna, mònna ‘cunnus’, ven. mona ‘cunnus, uomo sciocco’, non saprei dire con certezza» (B. Migliorini, Dal nome proprio al nome comu-ne, Genève, Olschki, 1927, p. 252 nota 2).
QUESTIONI PRELIMINARI 19
al 1908, anno della seconda edizione del Dizionario moderno di Panzini: vd. nota 22), ma non si può non notare che – certo in ragione del significato, della carica espressiva e della preci-sa connotazione geografica – l’impiego della parola è per lo più limitato a contesti ludici. Lo dimostrano alcune attesta-zioni degli ultimi settant’anni, allineate di séguito in ordine cronologico (la ricerca è stata condotta artigianalmente, e la mancanza di esempi significativi è pertanto, più che una pro-babilità, una certezza):
(1) «Era l’aprile del 1918. Le offensive tedesche avevano travol-to l’esercito britannico ad Amiens, aperto un varco pericoloso nelle linee francesi. Si aspettava da un giorno all’altro la terza “spallata” di Ludendorff. Eravamo sul Grappa, quando ci venne l’ordine di scendere a Bassano, di salire in tradotta, e di andare in Francia ad aiutare gli Alleati. Dopo due giorni eravamo a Mo-dane. Appena il treno si fermò, saltammo giù dai vagoni e mo-vemmo incontro a un gruppo di ufficiali francesi che, preceduti da un maggiore, magro, alto, con la sua mosca bianca al vento, venivano verso di noi a darci il benvenuto au nom de la France. In testa a noialtri camminava il capitano Adriano Lami, che ora fa il professore in una scuola media di Milano. Quando ci fu vicino il maggiore francese si fermò, aprì le braccia, ed esclamò con enfasi: “Ah, mon ami!” “Mona mi?” rispose Lami. “Mona ti, ostrega!”. E i due si abbracciarono. Quel “Mona ti, ostrega!” io lo scriverei nelle bandiere di tutti i reggimenti italiani che hanno combattuto a Bligny. Poiché non si potrebbe risponder meglio al tradizionale “mon ami!” dei Francesi» (C. Malaparte, Nota a «I morti di Bligny giocano a carte» [1939], in Id., L’arcitaliano e tutte le altre poesie, a c. di E. Falqui, Firenze, Vallecchi, 1963, pp. 202-211, pp. 202-203)23.
23 La poesia I morti di Bligny giocano a carte – che si legge in L’arcitaliano, cit., pp. 196-201 – reca in calce la data gennaio 1937 e venne stampata per la prima volta nella rivista romana «Circoli», dov’era accompagnata dalla Nota citata qui (vd. E. Falqui, Nota bibliografica, in C. Malaparte, L’arcitaliano, cit., pp. 479-481, a p. 480). L’occorrenza può suggerire che la diffusione extrare-gionale di mona sia da addebitare almeno in parte alla prima guerra mondia-
UN’ESPERIENZA ETIMOLOGICA VENETA20
(2) «Il conigliolo traeva sciabola da dietro e levava gran pernac-chio in sul colba, da parere il re Murat: come s’udì predicare il cannone, gli stivali lustri cantavano cri-cri, le gambe gli face-van giacomo giacometto. “Orsù ragazzi”, badava dire, “andiamo ragazzi”. Manchevole il magliabechiano, illeggibile il parisino, grattato il vaticano, salmistrato dalle acque alte il marciano, tarmato il casanatense, bombardato l’ambrosiano, ammuffito il parisiense, sotterrato il berolinense nel bunker, deportato il vindobonense, pugnalato il malatestiano, inriccardito il riccar-diano, andato in mona il monacense, austerizzato l’oxoniense, restituito il bodleyano agli eredi del buon vescovo cui era stato rubato, adibito a involtar l’affettato per la mensa della Breda il braidense, e mal medicato con l’alloro del poeta Pìspoli il lau-renziano-mediceo, non ci è possibile mettere in chiaro, a distan-za di anni, dove diavolo voleva andare a sbattere» (C. E. Gadda, Il primo libro delle favole [1a ed. 1952], a c. di C. Vela, in Id., Saggi giornali favole e altri scritti, vol. II, Milano, Garzanti, 1992, pp. 11-84, n° 151 a p. 48; quindi in gdli s.v.)24.
(3) «Cosa accade ora a Renzo che fugge verso Bergamo? Il ca-
le, fattore di un robusto rimescolamento linguistico: vd. T. De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita (1963), Roma - Bari, Laterza, 1999, pp. 106-109 e nota 33, e per la diffusione di varie voci soprattutto gergali e dialettali cfr. an-che L. Renzi, Parole di guerra, in «Lingua Nostra», XXVII, 1966, pp. 127-131 (dello stesso vd. anche Parole di caserma, ivi, XXVII, 1966, pp. 87-64; La lingua di caserma, oggi, ivi, XXVIII, 1967, pp. 24-31; «Bocia», «vecio» e legittimi eredi, ivi, XXVIII, 1967, pp. 89-93).
24 Un’altra attestazione di mona si incontra nella favola 180 (pp. 57-58 dell’ed. cit.), dov’è registrato con giocosa perizia glottologica il dialogo tra alcuni volatili in cerca di ricovero sui rami di un olmo. Le prime schermaglie sono bolognesi e veneziane: « – di’ sò, el mi barbazzàgn, fatt bèin in là... – ditt con me? – proppri con te, la mi fazzòta da cul!... – mo fatt in là te, caragna d’un stoppid... – t’avèi da vgnir premma, non siamo mica all’opera qui... – sto toco de porséo... – va’ a remengo ti e i to morti!... – quel beco de to pare... – e po’ taja, se no at mak el grogn,... tel dig me,... a te stiand la fazza... – in mona a to mare» (57). Diversamente da quel che accade nell’apologo del coni-gliolo, qui l’ingiuria, davvero cruda, fa leva sul significato sessuale di andare in mona già attestato in Baffo (vd. nota 31 di pp. 37-38), ed è ancor viva nel veneziano contemporaneo, come mi segnalano tutti i parlanti veneziani che ho potuto interrogare.
QUESTIONI PRELIMINARI 21
lembour contenuto nel nome della città è di per sé evidente: la parola mostra le due radici, una germanica, “berg” (monte) l’altra greca (“gamos” nozze): e Bergamo costituisce appunto l’ultima aspirazione di Renzo che aspira a reintegrare la sua ses-sualità perduta e anela alle nozze simboliche col simbolo stesso di essa (ma così facendo e venendo a desiderare lo stesso sim-bolo della sua potenza, Renzo diverge in una ambigua atmo-sfera omosessuale il suo travaglio, chiara e armonica antistrofe dell’altrettanto ambiguo rapporto che nello stesso tempo Lucia sta intrattenendo con la Monaca di Monza – né è da scordare che Mr. Joyce, che tanto a lungo aveva soggiornato a Trieste, non poteva ignorare il significato sessuale della radice “mona” che ritroviamo, badiamo bene, sia nella Monaca, con cui Lucia ha commercio, sia nei Monatti, che al lazzaretto, ove Renzo poi la trova, circondano Lucia)» (U. Eco, My exagmination round his factification for incamination to reduplication with ridecolation of a por-trait of the artist as Manzoni (1962), in Id., Diario minimo, Milano, Bompiani, 2008, pp. 51-62, pp. 59-60).
(4) «Lo Smilzo (a Ciro, alludendo a Desiderio) – Oh, Johnny, però xè bello! Xè proprio una mona, me par! Mi me vodria cavà una voggia! (A Sisina) Uhé, camarera-caramba, xè veramente una dona, o è solo un reciòn com’a leu?» (E. Moscato, Pièce noire (Canaria), in Dopo Eduardo. Nuova drammaturgia a Napoli, a c. di L. Libero, Napoli, Guida, 1988, pp. 137-216, a p. 179).
(5) «Perché, con buona pace di Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), saremo anche delle monadi, ma non dei “mona”, come si dice in veneziano» (R. Barbolini, Fenomenologia dell’Isola dei fa-mosi, in «Panorama», 24 novembre 2005, pp. 118-121, a p. 121).
(6) «O mona lisa d’una potta logora! Chissà Dio come andrà a finire...» (A. Busi, I Dialoghi del Ruzante, Milano, Mondadori, 2007, p. 89)25.
25 La frase intende tradurre l’originale «O pota del cancaro, Dio sa a che muo’ l’anderà!». Si noti anche la traduzione di «missier Ardòchene... A’ no sè a che muo’: messier Ardo... missier Ardòchene, sì, sì, sì» con «commenda-tor Altroche... Ardonò... Androchemona... Androchecasso... Andromene...
UN’ESPERIENZA ETIMOLOGICA VENETA22
Sia Eco sia Barbolini glossano il lemma rilevandone la pertinenza geografica, e entrambi lo pongono tra virgolette. Busi cala il termine in un calembour, decidendo di farne uso, certo non per caso, in un rifacimento ruzantiano. Malaparte non dà informazioni sulla provenienza del capitano Adriano Lami, ma se si deve credere alla genuinità di mona e ostrega andrà considerato d’origine veneta. Gadda impiega la locu-zione andare in mona entro un’enumerazione i cui addendi risultanto talvolta costruiti sulla base di associazioni foniche: è per l’appunto il nostro caso, dove mona somiglia a monacense (così come quelli del riccardiano inriccardito o del braidense alla mensa della Breda). A parte sta il caso del testo di Mosca-to: qui la parola è calata in un idioma teatrale ibrido dai tratti linguistici confusamente settentrionali, che ha poco a che ve-dere con il veneziano in senso proprio26. Di là dai diversi esiti, non è azzardato concludere che Eco (nato ad Alessandria), Gadda (nato a Milano), Malaparte (nato a Prato), Busi (nato a Montichiari [BS]), Moscato (nato a Napoli) e Barbolini (nato a Formigine [MO]) impiegano mona come blasone regionale, non diversamente da quel che accadeva per certe tessere les-sicali pluriricorrenti nelle parti della Commedia dell’Arte27.
Ardòchene...» (pp. 114-117).26 Su questo e altri testi simili vd. C. Giovanardi, Plurilinguismo e antirea-
lismo nel teatro napoletano dopo Eduardo (2002), in Id., Lingua e dialetto a teatro. Sondaggi otto-novecenteschi, Roma, Editori Riuniti, 2007, pp. 91-124.
27 Il fatto che la parola si presti a impieghi giocosi e a calembour è pro-vato anche da attestazioni ricavabili via Google. Mi accontento di ricordarne qui una risalente all’estate 2009: «L’Italia oggi è una Mona-rchia Mediatica, fondata sull’incoerenza. La Sovranità appartiene al Papi [...]». Si noti che lo stesso gioco di parole si trova probabilmente già ne L’amico tradito di Pier Ma-ria Cecchini (1633), atto III scena xiii, là dove il Dottore esorta il Capitano e Celia – novelli sposi – a ritirarsi in casa per consumare il matrimonio: «Dot-tore: “Andav in casa, ch’ la natura v’insegnarà ’l rest”. Capitano [a Celia]: “Andiamo Monarchessa delle donne, e moglie del Monarca delle milizie”. Dottore: “Da chi a poch la monarchia sarà stracca”» (P.M. Cecchini, L’amico tradito, in La Commedia dell’Arte, a c. di C. Molinari e R. Guardenti, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1999, pp. 525-569, a p. 562).
QUESTIONI PRELIMINARI 23
Molto più numerose sono, com’è ovvio, le attestazioni dovute a scriventi di origine veneta, che adoperano il termine sen-za mediazioni. Oltre al passo di Quarantotti Gambini (nato a Pisino d’Istria nel 1910) schedato in gdli e trasmigrato in altri dizionari (vd. la fine di nota 3 a p. 28), si veda un paio di attestazioni più recenti:
(7) «– E mona da cosa deriva? – disse Giovanni. – Parola santa, forse greca, ma di origine indeterminata, – disse il professore. – O passera! O gnocca! I greci moderni la chiamano muni [sic], il che lascia in dubbio se sia passata dai greci a noi o da noi ai gre-ci» (G. Scabia, Nane Oca, Torino, Einaudi, 1992, pp. 198-199)28.
(8) «la meta – Anche un mona capisce che lì bisogna arrivare, non ci vuole un dizionario. Ma arrivarci, beh, in pratica è com-plicato. Devi superare la montagna degli avversari» (M. Paolini, Dall’antigioco alla touche, dizionario (semiserio) per neofiti, in «Vanity Fair», 6 febbraio 2008, p. 44).
Non c’è dubbio sul fatto che mona – in (8) nel significato insultante, come negli esempi (1) e (5) – appartenga alla lin-gua madre di Scabia (nato a Padova) e di Paolini (nato a Bel-luno), ma va osservato che comparendo su un settimanale di diffusione nazionale come Vanity Fair la parola viene stampata in corsivo. Un sottoparagrafo sull’uso di mona presso parlan-ti veneti sarebbe incrementabile ad libitum e avrebbe del re-sto ben poco interesse: cercando il termine con il motore di ricerca di Google e restringendo l’indagine alle sole pagine italiane ci si rende presto conto senza sorpresa che la gran-dissima maggioranza delle attestazioni provengono da forum, blog e chat scritti da persone che risiedono (e che presumi-bilmente sono nate) tra Veneto, Trentino e Friuli – Venezia Giulia. Per Venezia siamo ben informati anche grazie a un re-cente lavoro di Anna Sullam Calimani, che indica mona tra le
28 Si noti che Scabia ricalca la voce di Boerio, e in particolare il dubbio richiamato qui al primo paragrafo.
UN’ESPERIENZA ETIMOLOGICA VENETA24
parole dialettali di alta vitalità, nota a trentotto intervistati su quarantacinque sia nel significato corporeo sia nel significato insultante29. I pochi esempi proposti sono forse sufficienti a dimostrare che al di fuori dell’area veneta mona è voce impie-gata con chiari intenti espressivi, e che la sua integrazione in italiano è parziale.
29 A.V. Sullam Calimani, Italiano regionale a Venezia, in Italiano, italiani regionali e dialetti, a c. di A. Cardinaletti e N. Munaro, Milano, FrancoAngeli, 2009, pp. 173-191, alle pp. 178 e 182.
![Page 1: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012500/63141b0cfc260b71020f6789/html5/thumbnails/24.jpg)




![[2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313aec8c32ab5e46f0c8758/2007-a-ferrarese-una-economia-dacqua-nella-terraferma-veneta-proprieta.jpg)




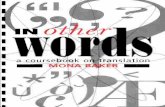
![PRELOŽNIK A., GUŠTIN M.: Cinturoni da parata: esempi di contatti tra l’area veneta e la Dolenjska nell’età del ferro. - Archeologia Veneta 35, 2012 [2013], s./p. 118-127.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63161c373ed465f0570be358/preloznik-a-gustin-m-cinturoni-da-parata-esempi-di-contatti-tra-larea.jpg)










