[2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria,...
ANDREA FERRARESE
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
Proprieta fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonificaa Roverchiara tra ’400 e ’500
Parte prima (*)
Nel tentativo di sondare e di ricomporre gli sviluppi che contraddistinsero ilterritorio veronese tra il basso medioevo e la prima eta moderna, il ruolo dellapianura costituisce un aspetto imprescindibile, su cui la storiografia degli ultimitrent’anni si e ampiamente soffermata, individuando alcune assodate linee di inter-pretazione – con particolare attenzione all’approccio fondiario – poste in essere daiceti urbani in un’area che, nei decenni seguenti la conquista veneziana della Ter-raferma, divenne progressivamente terreno di penetrazione e di ‘conquista’, centrodi marcati intessi ed investimenti agrari, e, in altre parole, uno spazio-economicosempre piu strettamente avvinto alle logiche economico-mercantili del mondourbano. A fronte di dinamiche note, di scansioni cronologiche delineate e dimodelli interpretativi provati e confermati da una generale ‘prosperita’ degli studidi storia agraria veronese che si sono susseguiti (anche e soprattutto grazie ad undiffuso apporto di ‘storie di comunita’ di buon valore euristico), permangonoaspetti e possibilita di ricerca che attendono di essere sondati, prospettando nelcontempo risultati indubbiamente interessanti. La scelta di un case-study centratosulla comunita di Roverchiara e dipesa – oltre che dalla possibilita di fruire di fontiarchivistiche ricche e in parte ancora inesplorate – dalla constatazione che l’evo-luzione del suo spazio-economico tra Quattro- e Cinquecento si prestava a bendefinire alcuni momenti peculiari del «rapporto intercorrente tra mutamento am-bientale e mutamento dell’organizzazione economica» (1). La singolare conforma-
(*) La parte seconda dell’articolo sara pubblicato nel volume LVIII (2008) di ‘‘StudiStorici Luigi Simeoni’’.
Le abbreviazioni usate in seguito corrispondono a: Asvr (Archivio di Stato, Verona);Acvr (Archivio Capitolare, Verona); Apro (Archivio parrocchiale, Roverchiara). Le unita dimisura lineari (campo – vanezza – tavola), di volume per cereali (minale) e monetarie (ducati– lire – soldi) sono quelle veronesi di antico regime, per le cui equivalenze si rinvia ai noticontributi di A. Martini, Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attual-mente e anticamente presso tutti i popoli. Torino 1883 e di G. Beggio, Le antiche misureveronesi rapportate al sistema metrico decimale. In ‘Vita veronese’, XXI (1968), fasc. 9-10,pp. 352-360. Nelle tabelle che seguono sono state adottate le seguenti abbreviazioni: Rover-chiara di Caselle (=RC), Roverchiara di Fonzane (=RF), Roverchiara (=R), Isola Rizza (=IR).
(1) M. Cattini – M.A. Romani, Tendenze e problemi della storiografia agraria europea
‘Studi storici Luigi Simeoni’, LVII (2007), pp. 107-148 (prima parte) [ISSN 2035-8768]
zione dell’ambiente di Roverchiara all’aprirsi dell’evo moderno – i cui tratti, delresto, risultavano comuni a buona parte della pianura veronese – conchiusa ecostretta tra i pericolosi limites del fiume Adige e l’estensione di difformi valli epaludi, costituisce un proficuo parametro di ricerca per la «valutazione dello spazioecologico, del rapporto uomo-comunita-ambiente colto nelle sue variegate e mol-teplici sfumature» (2). Si tratta ovviamente di un rapporto estremamente comples-so, contraddistinto da prospettive differenziate a seconda degli attori e dei prota-gonisti: un rapporto, in altri termini, in cui la «risorsa acqua» (3) e gli eco-sistemiche ne derivavano erano nello stesso tempo un ostacolo e una risorsa, un limiteall’espansione delle possessioni della proprieta urbana e una fonte integrativa im-prescindibile per la sussistenza della comunita rurale. La perdurante precarieta ditale rapporto costituisce invece un tratto comune alle aspirazioni fondiarie dei civesveronesi e alle necessita alimentari delle popolazioni rurali, ma nel contempo ancheuna conferma del fatto che «l’ambiente altro non sia che un insieme di problemimai del tutto risolti, di sfide che gli uomini accettano pur sapendo che non vi sonosoluzioni definitive, che non si possono raggiungere equilibri stabili nel tempo» (4).
All’interno di questo contesto geo-ambientale ‘fluido’, caratterizzato da unperenne sommovimento fatto di inondazioni, arginature precarie e precoci, quantoinfruttuosi tentativi di bonifica, si verificarono tra il secondo Quattrocento e laprima meta del secolo seguente «complessi fenomeni di scomposizione e ricompo-sizione economica e sociale» (5), all’insegna di un fattore ‘terra’ che ne costituı permolti aspetti il denominatore comune, secondo dinamiche ormai ampiamentecondivise dalla storiografia rurale veronese. E anche se la dimensione quantitativacostituisce indubbiamente il primo oggettivo e vistoso parametro del fenomeno dipenetrazione fondiaria dei ceti urbani veronesi nel territorio, va sottolineato comeun criterio «piu significativo [...] per cogliere gli assetti economici che i patrizivanno costruendo nel veronese [sia] il soffermarsi sulle forme giuridiche dellagestione» (6) fondiaria, come pure sulle attenzioni, sull’impegno e sulle profusionidi capitali in occasione delle operazioni di bonifica e riconversione del suolo (7).
Bonifica pero e un termine ambiguo e complesso che necessita di essere
SAGGI108
negli ultimi quaranta anni (1945-1984). In ‘Rivista di storia dell’agricoltura’, XXVII (1987),fasc. 1, p. 36; cfr. anche R. Delort – F. Walter, Storia dell’ambiente europeo. Bari 2002;M. Armiero – S. Barca, Storia dell’ambiente. Una introduzione. Roma 2004; Alla ricercadella storia ambientale. In ‘Contemporanea’, V (2002), fasc. 1, pp. 131-164.
(2) S. Zamperetti, La spazio politico in una comunita rurale d’antico regime: Duevillenell’eta della Repubblica veneta. In: Dueville. Storia e identificazione di una comunita del pas-sato; a cura di C. Povolo; Vicenza 1985, p. 323.
(3) P. Bevilacqua, Demetra e Clio. Uomini e ambiente nella storia. Roma 2001, p. 41.(4) M. Cattini – M.A. Romani, Tendenze e problemi della storiografia agraria euro-
pea, cit., p. 32.(5) G. Borelli, Gli assetti economici di un patriziato urbano nell’Italia settentrionale
del Cinquecento. In ‘Storia economica’, I (1998), fasc. 3, p. 407.(6) Ibid., p. 419.(7) Sulle articolate vicende di Roverchiara tra basso medioevo ed eta moderna si rinvia
al recente volume miscellaneo Roverchiara. Una comunita e il suo territorio; a cura di R. Sco-
109
opportunamente tarato alle specifiche caratteristiche dello spazio-economico diriferimento. Nel caso di Roverchiara, le scelte attuate dai cives che valutaronooculatamente le possibilita offerte dai terreni marginali della comunita, si rivelanoben lontane dalle massicce operazioni attuate spesso sub umbra reipublicae, di cuigli imprescindibili studi di A. Ventura e S. Ciriacono ci hanno dato conto. Lepagine che seguono e i dati desunti da una cospicua documentazione archivisticadescrivono invece processi piu graduali, di lungo respiro, costruiti – nel casoemblematico dalla famiglia Martelli, che di tali dinamiche fu tra gli indiscussiprotagonisti a Roverchiara – attorno ad una lenta composizione fondiaria e inun diuturno confronto con la ‘risorsa acqua’, un confronto che dopo decenni,arrivo alla sua conclusione verso gli anni ’30 del Cinquecento, culminando nelleprecoci e significative esperienze della coltura del riso. La possibilita di seguire taliesperienze su di un arco cronologico di lunga durata – in fieri – ha quindi permessodi approfondire in parallelo quel rapporto uomo-ambiente-territorio, fulcro delle«economie d’acqua» (8), cioe di quel «complesso di attivita umane nelle qualil’acqua e al centro della vita produttiva o costituisce comunque la condizioneimprescindibile del suo svolgimento e della sua stessa esistenza [...] elementoconnotante di un ambito territoriale, componente insostituibile e permanente diun sistema che su di essa fonda la propria peculiarita e il proprio funzionamen-to» (9).
1. Una comunita in un territorio complesso: acque, valli, paludi e du-
gali nella prima eta moderna
L’intrico dei corsi d’acqua minori, le ampie zone umide e paludose, l’Adigestesso, che tra il primo e il secondo Cinquecento costituirono i ‘requisiti’ basilari eindispensabili per i cospicui e redditizi investimenti del patriziato veronese nelleterre di Roverchiara e nell’affare del riso, per secoli avevano profondamente con-dizionato – e continuarono a farlo fino alle soglie dell’eta contemporanea (10) – lospazio-economico delle due comunita, gli insediamenti e gli assetti fondiari, in unperdurante confronto-scontro con un ambiente per molti aspetti ostile e inospita-le (11). La storia delle due Roverchiara, quella di Fonzane e quella di Caselle, e stata
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
la Gagliardi. S. Pietro di Legnago 2006 (il presente saggio riprende, con modifiche e am-pie integrazioni bibliografiche, alcuni dei contributi ivi collocati).
(8) P. Bevilacqua, Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse in Italia. Roma1996, p. 29.
(9) Ibid., p. 29.(10) La struttura pedologica di Roverchiara, «di formazione costituzionale a sedimenti
d’innondazione atesina» e descritta in E. Nicolis, Geologia applicata agli estimi del nuovocatasto (provincia di Verona). In ‘Atti della Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere diVerona’, LXXXII (1906), pp. 74-75 (estratto).
(11) Cfr. R. Scola Gagliardi, Il ruolo delle acque nello sviluppo del territorio. In: Unterritorio e le sue acque. Profilo storico dell’idrografia e del paesaggio agrario tra Adige e Tre-gnon. Verona 1993, pp. 5-15; F. Cazzola, L’incubo delle acque nel Cinquecento. In: Verso la
in parte anche la storia di uno sforzo incessante e di un’attenzione assidua verso unterritorio articolato, delimitato da quelle acque con cui gli uomini della comunitadovettero confrontarsi e lottare, difendendo e recuperando ‘brandelli’ di terreno,ma anche spesso arretrando, cedendo il passo alla forza distruttiva di frequentiinondazioni (12) che non lasciavano scampo ai raccolti e minavano inesorabilmentei fragili meccanismi dell’autoconsumo rurale.
Nella prima eta veneziana, pur a fronte di episodi che denotano una sempremaggiore intraprendenza della proprieta fondiaria nei confronti dei problemi idro-grafici del territorio e su cui torneremo in seguito, non si riscontrano novitasostanziali nelle pratiche di controllo e di manutenzione dei fiumi e dei dugalidella pianura che, a seguito della conferma veneziana della prassi statutaria vero-nese, rimasero affidate alle usuali magistrature urbane, a prescindere dalla possi-bilita del concreto ricorso all’autorita della Dominante per la soluzione delle con-troversie, che nel complesso caso di Roverchiara non tardarono ad impegnare lecorti veneziane (13). La particolare conformazione orografica della comunita (14) –delimitata nella parte settentrionale dal Busse (15), dal dugale Nichesola collettoredell’insieme di scoli minori che ne solcavano il territorio (Polandro, Fossalunga,Bracca, Panego) e dall’Adige – ne faceva un punto nevralgico, oltre che per lamanutenzione dei fiumi maggiori (Adige e relativi argini in primis), anche per unasorta di prima difesa nei confronti delle comunita della bassa pianura veronese.Non e quindi un caso se nel primo Quattrocento – escludendo le interminabili litiper la suddivisione delle spese di manutenzione degli aggeres dell’Adige (16) e del
SAGGI110
santa agricoltura. Alvise Cornaro, Ruzante, il Polesine; a cura di G. Benzoni. Rovigo 2004,pp. 59-65; A. Pozzan, Zosagna. Paesaggio agrario, proprieta e conduzione di un territorio traPiave e Sile nella prima meta del secolo XVI. Treviso 1997, pp. 8-13.
(12) A. Castagnetti, La pianura veronese nel medioevo. La conquista del suolo e la re-golamentazione delle acque. In: Una citta e il suo fiume. Verona e l’Adige; a cura di G. Bo-
relli. Verona 1977, v. I, p. 98; come pure G. Borelli, Citta e campagna in rapporto all’A-dige in epoca veneta. In: Una citta e il suo fiume, cit., v. I, p. 300.
(13) Cfr. A. Castagnetti, La pianura veronese nel medioevo, cit., pp. 88-116; M. Pa-
sa, Il Cinquecento. Venezia ed i fiumi della Terraferma. In: Acqua terra e uomini nella pianuraveneta: dalla Zerpa alla Fratta. La pianificazione idraulico sociale; a cura di M. Pasa. Verona2005, v. I, pp. 233-243.
(14) Cfr. R. Scola Gagliardi, L’evoluzione del sistema idrografico: descrizione anali-tica. In: Un territorio e le sue acque, cit., pp. 36-52.
(15) Fino al 1793 il Busse defluiva nell’Adige tra Roverchiara e Tomba, cfr. A. Casta-
gnetti, La pianura veronese nel medioevo, cit., pp. 77, 80-81, 109.(16) Cfr. B. Chiappa, Dalla prima eta moderna al XVIII secolo. In: Angiari. Il territorio,
la storia, il patrimonio artistico; a cura di B. Chiappa. Verona 1998, pp. 71-72. Tra la docu-mentazione archivistica rimasta permangono ampie testimonianze delle attenzioni rivoltedalla comunita, in genere come obbligo previsto dalla legislazione statutaria veronese, versogli argini dell’Adige, cfr. ad esempio Asvr, Antico archivio del comune, perg. 127(28.VI.1427): visio e laudatio di lavori di riatto per un tratto di 87 pertiche dell’argine del-l’Adige a Roverchiara di Caselle; Ibid., perg. 129 (28.XII.1429): visio e laudatio di alcuni la-borerii effettuati al porto di Roverchiara di Caselle e di Fonzane, alla presenza del iudex du-galiorum e dell’enzignerius Giovanni de Matulino (i lavori consistevano in «colopnis et pal-
111
Busse (17), infinito motivo di disputa tra la citta e il territorio (18) – le controversiepiu aspre riguardarono proprio la funzione di indispensabile ‘filtro’ affidato alcontesto idrico della comunita.
I problemi di una orografia complessa e tale appunto da condizionare pesan-temente la vita delle comunita interessate, trovano riscontro nelle tracce della docu-mentazione compulsata: i toponimi che ad esempio rimandano esplicitamente aldialettico rapporto con le acque, ricorrono con una certa frequenza e testimonianodi una sedimentazione pregressa delle problematiche in questione. Le descrizioni deiconfini e delle ubicazioni delle molte pezze di terra catasticate, transatte, cedute opermutate nei due secoli qui considerati, hanno rivelato interessanti particolari diuna fisionomia ambientale complessa: tra i limites, fanno capolino le tracce piugeneriche, riferite ad esempio alle indeterminate paludes che cingevano la comunita,specialmente nella parte settentrionale, o alle altrettanto indistinte valles (19). Altrovei riferimenti sono invece piu precisi, in particolare quando gli idro-toponimi o i fito-toponimi vengono a coincidere con precise orae, cioe con i nomi ormai sedimentatidi contrade, con zone ben delimitate e precisamente identificate nella memoriacollettiva della comunita (20), come nel caso del palus vetus (‘palu vecchio’), delle‘aquare’, delle ‘rivare’, delle ‘rote’, delle ‘palustrele’, dei ‘stropari’, del ‘boscheto’ (21),dei ‘pra novi’ che avremo modo di incontrare ampiamente in seguito. Altri toponimisuggeriscono bensı particolari conformazioni del terreno, come la contrada della
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
lificatis datis et locatis ad facendum [...] seu figendum» a tale Antonio q. Gratioli di Rover-chiara di Caselle); Ibid., perg. 149 (27.XII.1432): visio loci del iudex dugaliorum Priamo Ca-pella, assieme all’inzignerio Gerardo Marastoni, per esaminare due rotte a Roverchiara diFonzane vicino al ponte «de Sacco» (i lavori erano stati appaltati ad Andrea «raddarollo»della contrada veronese di S. Paolo e vennero laudati perche fatti «secundum provisionemet afictationem»). Sulla figura del magister Giovanni Matolino – a cui si deve la costruzionedella chiesa di S. Anastasia a Verona – si e soffermato G. Da Re, Provvisione fatta da maestroGiovanni Matolino ingegnere e da altri officiali di Verona per la regolazione delle acque del-l’Alpone, della Tramegna, del Chiampo e dell’Aldega il 24 maggio 1429. Verona 1887 eG.M. Varanini, Il cantiere della chiesa dei Santi Giacomo e Lazzaro alla Tomba di Veronanel Quattrocento. In ‘Verona illustrata’, VI (1996), pp. 5-22.
(17) Una interessante testimonianza sulle arginature del Busse, spesso divelte dalle fre-quenti escrescenze e riflussi dell’Adige, e contenuta in una supplica (1460) di Aleardo q. Go-tifredo Aleardi al Consiglio civico di Verona riportata in G.B.C. Giuliari, Documenti del-l’antico dialetto veronese nel secolo XV (1411-1472). Verona 1878, pp. 17-18: nel caso spe-cifico la rotta, che aveva trasformato «la campagna [...] in padulli per una gran parte»,interessava il tratto di argine verso Tomba lungo 1700 pertiche e una spesa preventivatain «forsi de piu de doa milia libre a farli [gli argini] honestamente».
(18) A. Castagnetti, La pianura veronese nel medioevo, cit., pp. 109-110; G. Sancas-
sani, La legislazione fluviale a Verona dal libero Comune all’epoca veneta (secoli XIII-XVIII).In: Una citta e il suo fiume, cit., v. I, p. 471.
(19) Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delle Vergini, reg. 6, c. 244r; comeanche Asvr, Ufficio del Registro, reg. 191, c. 269r (1465).
(20) I riferimenti topografici qui indicati trovano riscontro nelle fonti citate nelle tabel-le del testo.
(21) Asvr, S. Maria della Giara, perg. 894 (1521).
‘vegra’, con un palese richiamo a terreni incolti (22), quella dell’«aggeris» (23) (aridosso dell’Adige), contraddistinta piuttosto da una conformazione in genere sas-sosa e ghiaiosa (24), o gli onnipresenti ‘dossi’, zone rialzate rispetto ai piu bassi terrenicircostanti che «con la loro presenza punteggiavano le aree vallive» (25) e in genereerano utilizzati come pascolo: l’esistenza dei dossi parzialmente coltivati e sfruttati –altrove, ma non troppo lontano, conosciuti con il nome di ‘cuori’ – ci porta aconsiderare e a sottolineare i multiformi aspetti dell’ecosistema della valle, di quelambiente cosı poco omogeneo, che se per molti aspetti costituiva una realta con cuifare i conti nella difficile quotidianita dell’esistenza, per altri fungeva appunto daimportante ed insostituibile integratore per le disponibilita alimentari delle popola-zioni che vi interagivano nella quotidianita dell’esistenza (26).
2. Gli assetti della proprieta fondiaria tra Quattrocento e Cinque-
cento: strutture patrimoniali, penetrazione cittadina, episodi di
bonifica
Pur a fronte di una documentazione fondiaria cronologicamente sfasata e permolti aspetti ‘campionata’ a singole esemplificazioni, il quadro di riferimento re-lativo alle pertinenze di Roverchiara (Roverchiara di Caselle e Roverchiara diFonzane) si conforma bene al contesto progressivamente emerso dagli studi dedi-cati alla pianura veronese negli ultimi decenni. In un’area toccata marginalmentedalle vicende che interessarono le vendite delle proprieta ex-scaligere nel primoQuattrocento – pur in presenza di documentate possessioni della fattoria (27) – un
SAGGI112
(22) P. Mometto, L’azienda agricola Barbarigo a Carpi. Gestione economica ed evolu-zione sociale sulle terre di un villaggio della bassa pianura veronese (1443-1539). Venezia1992, pp. 42-43.
(23) Asvr, Ufficio del Registro, reg. 205, c. 362r (1472).(24) P. Mometto, L’azienda agricola Barbarigo a Carpi, cit., p. 48.(25) Ibid., p. 46; E. Rossini, L’amministrazione del patrimonio fondiario di una pieve
nel secolo XV: Isola della Scala di Verona. In ‘Archivio veneto’, CXXV (1985), p. 101.(26) Cfr. A. Ferrarese, Le valli del comune di Cerea. Note per una storia dell’ambiente
nello spazio-economico delle Valli Grandi Veronesi. In: A. Ferrarese – R. Pollo, La riservanaturale ‘Palude Brusa-Vallette’. Indagine naturalistica e storica sulle valli di Cerea. Verona (S.Pietro di Legnago) 2007, pp. 21-92; B. Chiappa, I ‘laghi’ del Comune e i diritti d’acqua. In:Vigasio. Vicende di una comunita e di un territorio; a cura di P. Brugnoli – B. Chiappa.Vigasio 2005, pp. 118-119; B. Chiappa, La pesca nel lago superiore. In: Vigasio. Vicendedi una comunita e di un territorio; a cura di P. Brugnoli – B. Chiappa. Vigasio 2005,pp. 120-121; F. Bottaro, Pesca di valle e commercio ittico a Padova nel Quattrocento. Pa-dova 2004.
(27) Cfr. G. Sancassani, I beni della ‘fattoria scaligera’ e la loro liquidazione ad operadella repubblica veneta 1406-1417. In ‘Nova historia’, XII (1960), p. 23; ancora negli anni ’30del Quattrocento tra le indicazioni confinarie di alcuni appezzamenti comparivano gli «iuradominationi nostre», ad indicare plausibilmente un residuo di beni gestiti dalla Camera fi-scale di Verona, cfr. ad esempio Asvr, Ospedale di S. Jacopo e Lazzaro alla Tomba, reg.104, c. 274v.
113
elemento che contraddistingue gli assetti della proprieta fondiaria nella comunita, edato dalla presenza continuativa di patrimoni risalenti al secolo precedente che,quasi senza soluzione di continuita, vennero consolidando le loro posizioni, fino adiventare i protagonisti di alcuni di quegli esperimenti di riassetto fondiario checontraddistinsero buona parte del tardo Quattrocento e del Cinquecento. Talipresenze stanziali, ampiamente documentate nel territorio di Roverchiara gia nelcorso del Trecento – l’Ospedale di S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba, i monasterifemminili di S. Domenico e di S. Maria delle Vergini, la prepositura di S. Mariadella Giara, e in misura minore, la pieve di S. Zeno di Roverchiara e l’episcopioveronese – mostrarono nel secolo successivo e in misura sostanzialmente differen-ziata, i segni di una attenzione verso una gestione vigile e in alcuni casi dinamicadella proprieta fondiaria, segni che divennero sempre piu percettibili nel torno diquei decenni che, appunto tra la fine del Quattrocento e il primo Cinquecento,vennero scanditi da una massiccia riallocazione e ristrutturazione degli assettifondiari della pianura ad opera di gruppi di cives veronesi, motivati e spinti dauna rinnovata attenzione verso il bene-terra.
Entro un contesto geo-ambientale contraddistinto, come abbiamo visto, dallaconsiderevole presenza di zone vallive e paludose e, nel contempo, sottoposto all’aleacontinua di rotte e di inondazione ricorrenti, non pare strano che a margine deifrequenti episodi di accorpamento degli appezzamenti, delle permute sempre piuincessanti e di una piu generale riorganizzazione poderale (28), di cui si colgono itratti sempre piu evidenti nella seconda meta del Quattrocento, si siano inseritiepisodi di precoce bonifica e di colonizzazione di aree incolte (29), forieri dei benpiu ampi sviluppi dei decenni immediatamente seguenti (30). La marginalita degliinterventi che interessarono il territorio di Roverchiara nelle prime decadi del secondo
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(28) G.M. Varanini, La ‘curia’ di Nogarole nella pianura veronese tra Tre e Quattrocen-to. Paesaggio, amministrazione, economia e societa. In ‘Studi di storia medievale e diploma-tica’, IV (1979), pp. 206-209; S. Zamperetti, ‘Poveri de’ Christo’ e ‘poveri rustici’. La gestio-ne del patrimonio fondiario di un luogo pio in una comunita rurale veneta in eta moderna. In:Bolzano Vicentino. Dimensioni del sociale e vita economica in un villaggio della pianura vicen-tina (secoli XIV-XIX); a cura di C. Povolo. Bolzano Vicentino 1985, pp. 155-157, 159-162;A.J. Mira Jodar, Terra e proprieta nella Terraferma veneta. La struttura agraria di Monta-gnana nel 1444. In ‘Quaderni medievali’, 56 (2003), pp. 57-58.
(29) Cfr. G.M. Varanini, La ‘curia’ di Nogarole, cit., pp. 234-249 passim; G.M. Va-
ranini, Le campagne veronesi del ’400 fra tradizione e innovazione. In: Uomini e civilta agra-ria in territorio veronese dall’alto medioevo al sec. XX; a cura di G. Borelli. Verona 1982, v.I, Secoli IX-XVII, pp. 219-222; B. Chiappa, Sotto il segno di Venezia. In: Casaleone. Terri-torio e societa rurale nella bassa pianura veronese; a cura di B. Chiappa. Verona 2000, pp. 88-111; B. Chiappa, Ancora sulla proprieta dei cittadini: presenze durature. In: Isola della Scala.Territorio e societa rurale nella media pianura veronese; a cura di B. Chiappa. Verona 2002,pp. 102-104.
(30) Cfr. G.M. Varanini, Le campagne veronesi del ’400, cit., pp. 230-232; P. Mo-
metto, L’azienda agricola Barbarigo a Carpi, cit., pp. 42-48, 70-79; S. Ciriacono, Investi-menti capitalistici e colture irrigue. La congiuntura agricola nella Terraferma veneta (secoli XVIe XVII). In: Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori; a cura di A. Taglia-
ferri. Milano 1981, pp. 129-131.
Quattrocento si coglie dall’immediato paragone con i noti e documentati episodi diRoncanova (monastero di S. Maria in Organo) e di Casaleone (famiglia Dal Bor-go) (31): soprattutto se si considera il mancato intervento diretto degli enti a cui piusopra si e fatto cenno nella pianificazione e nella realizzazione delle opere di bonifica ela preferenza per una cessione dei terreni redimibili a cives disposti ad intervenire inprima persona, in cambio di canoni di locazione del tutto irrisori (32). Un esempiorappresentativo in questo senso e dato dal citato Ospedale di S. Giacomo e Lazzaroalla Tomba che nel 1467 concesse mediante una locatio perpetualis decennale al civisveronese Cristoforo q. Cristato Cristati tre appezzamenti nelle pertinenze tra Rover-chiara e Tomba: si trattava, nello specifico, di una pezza di terra di C. 10 «glariva etpaludiva cum una pischeria» (33), di una seconda pezza prativa e paludosa di C. 7nella contrada ‘Palaverta’ (in prossimita dell’omonimo dugale) e infine di un’ultimapezza di estensione non specificata «quae est palus et circumdata paludibus» (34).L’affitto estremamente mite, computato in L. 7, presupponeva chiaramente la possi-bilita e l’intenzione di «scolare et bonificare [...] et reducere eas prativas» (35), che ilCristati e l’ente veronese si premurarono di indicare nel documento notarile.
Se da un lato quindi si dovette attendere il secolo seguente per rintracciare gliindizi di un coinvolgimento piu maturo e diretto di alcuni enti presenti a Rover-chiara (ad esempio il monastero di S. Maria delle Vergini) in episodi di bonifica –lasciati per ora alla precoce intraprendenza delle sole compagini del patriziatourbano – non mancarono invece le tracce di una marcata attenzione verso laristrutturazione fondiaria e l’appoderamento (36). Anche nel merito di questi pro-cessi, la possibilita di avanzare ipotesi ed esempi si basa su di una documentazionediscontinua, che nel complesso ha comunque permesso di ricostruire alcuni singo-lari case studies. Per alcuni enti, in particolare nei casi di S. Maria della Giara e delgia citato Ospedale di S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba, soprattutto nel secondoQuattrocento si concretizzarono e presero forma piu articolata tendenze versol’appoderamento e l’aumento delle superfici fondiarie delle possessioni, gia comun-que abbastanza evidenti dalla documentazione relativa al secolo precedente: sitratta di una tendenza comune a tutta la pianura veronese quattrocentesca e che,come vedremo in seguito, si lega inscindibilmente, oltre che ad una nuova atten-zione della proprieta veronese per le possibilita offerte dalla terra, ad un lento ecomplementare processo di modificazione della contrattualistica agraria.
SAGGI114
(31) Cfr. G.M. Varanini, Un esempio di ristrutturazione agraria quattrocentesca nella‘bassa’ veronese: il monastero di S. Maria in Organo e le terre di Roncanova. In ‘Studi storiciveronesi Luigi Simeoni’, XXX-XXXI (1980-1981), pp. 58-66.
(32) Ibid., p. 55.(33) Asvr, Ospedale di S. Jacopo e Lazzaro alla Tomba, reg. 104, c. 295r.(34) Ibid., c. 295r.(35) Ibid., c. 295v.(36) Cfr. A. Stella, La proprieta ecclesiastica nella Repubblica di Venezia dal secolo XV
al XVII. (Lineamenti di una ricerca economico-politica). In ‘Nuova rivista storica’, XLII(1958), fasc. 1, pp. 50-77; G. Zarri, La proprieta ecclesiastica a Carpi fra Quattrocento e Cin-quecento. In: Societa, politica e cultura a Carpi ai tempi di Alberto III Pio. Padova 1981, v. II,pp. 530-538.
115
Nel primo Quattrocento, gli esempi studiati qualche anno or sono da G. M.Varanini nelle pertinenze della curia di Nogarole – ma senza dubbio comuni abuona parte della media e bassa pianura – riflettevano una complessiva frammen-tazione che interessava per oltre i due terzi i fondi, caratterizzati da una superficiedi poco superiore ai C. 3, «un vero e proprio reticolato di piccole e piccolissimeparcelle» (37), ancora ben lontano dalle ordinate e ben strutturate possessioni chevennero a formarsi a partire dalla seconda meta del secolo (38): analoghe confermederivavano poi dai beni ex-vermeschi di Roncanova e di Pontepossero, con unamedia leggermente piu alta di circa C. 5 (39). Nel caso di Roverchiara la possibilitadi seguire l’evoluzione della proprieta fondiaria della prepositura della Giara,grosso modo nell’arco di quasi due secoli, ha permesso di confrontare i dati emersidalla situazione gia nota e soprattutto di seguire con precisione le scansioni tem-porali di un lungo processo di ristrutturazione fondiaria, culminato nella sua fasetopica nei primi decenni del Cinquecento. Secondo i dati di una perticazione nondatata, ma riferibile sulla base di una verifica confinaria alla prima meta del Tre-cento (40), gli 82 fondi dell’ente, estesi su di una superficie complessiva di circa C.342, si distinguevano per una estensione media che di poco superava i C. 4, quindiin buona sintonia con quanto gia verificato per situazioni coeve.
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(37) G.M. Varanini, La ‘curia’ di Nogarole, cit., p. 91; E. Rossini, Ceti urbani: terra eproprieta fondiaria nel basso medioevo. In: Uomini e civilta agraria, cit., v. I, Secoli IX-XVII,pp. 112-117; M. Lecce, I beni terrieri del monastero di S. Michele in Campagna. Contributoalla evoluzione storica della proprieta ecclesiastica. Verona 1953, p. 14; M. Lecce, I beni ter-rieri di un antico istituto ospitaliero veronese (secoli XII-XVIII). In: M. Lecce, Ricerche distoria economica medioevale e moderna. Verona 1975, pp. 164-165.
(38) Cfr. A.J. Mira Jodar, Le aziende agricole veneziane nel territorio padovano allameta del XV secolo: struttura e gestione. In ‘Societa e storia’, 97 (2002), pp. 441-456.
(39) Cfr. G.M. Varanini, La ‘curia’ di Nogarole, cit., pp. 89-93; come pure J.S.Grubb, Patrimonio, feudo e giurisdizione: la signoria dei Monza a Dueville nel secolo XV.In: Dueville, cit., p. 268; J.S. Grubb, Il mondo di Lisiera nel Quattrocento. In: Lisiera. Imma-gini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunita veneta. Strutture – congiun-ture – episodi; a cura di C. Povolo. Vicenza 1981, v. I, pp. 82, 88; E. Rossini, Le ‘recogni-tiones’ delle terre della pieve di Isola della Scala di Verona nel secolo XV. (Analisi quantitati-va). In ‘Atti e memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona’, CLXII(1985-1986), pp. 154-156; M. De Martin, Da borghesi a patrizi. I Trivelli di Verona nel Tre-cento e Quattrocento. In ‘Studi storici Luigi Simeoni’, XXXVIII (1988), p. 98; G. Barbieri,Le proprieta fondiarie degli ecclesiastici nel territorio di Legnago agli inizi del secolo XV. In: G.Barbieri, Saggi di storia economica italiana. Bari 1948, p. 50.
(40) Tra i riferimenti confinari presenti nella legittimazione fondiaria, oltre agli imman-cabili «iura dominorum a Scala», compaiono alcuni proprietari identificati attraverso alcuniconfronti incrociati con una documentazione coeva; tra questi, ad esempio Ubicino Zaccari,il cui nome ricorre a Roverchiara in alcune pergamene della prima meta del secolo (Acvr,perg. I, 31, 3v – 1331; Asvr, Istituto Esposti, S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba, reg. 200,cc. 74v-76v – 1344), Caterina uxor di Bernardo a Campanea (Asvr, Istituto Esposti, S. Gia-como e Lazzaro alla Tomba, reg. 200, cc. 74v-76v – 1344; Ibid., cc. 87v-89v – 1345), Fiora-vante de Fracastoriis, i cui eredi sono presenti a S. Pietro di Morubio nel 1362 (Asvr, Con-gregazione del clero intrinseco, reg. 14, c. 51r).
Tabella 1 - Perticazione trecentesca dei possedimenti del monastero di S. Maria della Giara a Roverchiara:tipologia delle colture. Fonte: Asvr, S. Maria della Giara, reg. 67, c. n. n.
Tipologia dei terreni C. V. T. Ha.
Arativo (70,7%)
Arativo 76 21 27 23,09 (22,4%)
Arativo vitato 14 8 5 4,30 (4,2%)
Arativo vitato-arborato 101 7 15 30,41 (29,6%)
Arativo arborato 49 22 8 14,98 (14,5%)
Prativo (29,2%)Prativo 54 4 11 16,26 (15,8%)
Prativo arborato 45 22 11 13,78 (13,4%)
Altro (0,1%) Vegro – 7 12 0,09 (0,1%)
Totale 342 21 29 102,91
Ampiezza media dei fondi (82 appezzamenti): C. 4,1.
La tabella n. 1 riassume le informazioni desunte dal documento in questio-ne: a prima vista, se si considera la ripartizione percentuale della destinazionecolturale dei fondi, emerge nettamente la prevalenza dell’arativo (oltre il 70%),pur in una situazione in cui i terreni prativi arrivavano a sfiorare il 30%, con unvalore elevato e sicuramente legato all’abbondante presenza di paludi, valli ecorsi d’acqua che di certo favorivano il mantenimento delle pradarie. I datirelativi alle viti si rivelano, anche in questo caso, molto vicini a quelli propostida Varanini per la curia di Nogarole (circa il 25% dell’intera superficie coltivata)e denotano sicuramente una importante eccezione nel contesto della pianuraveronese (41). Nel merito invece delle percentuali relative ai terreni arborati, vasottolineata la quasi esclusiva presenza a Roverchiara di piantate di salgarii suterreni arativi, prativi o piu generalmente su terreni vitati, una presenza legataplausibilmente alle peculiari caratteristiche del suolo e alle specifiche caratteri-stiche di rafforzamento del terreno offerte dalle piantate di salici che trovaronouna ulteriore vistosa espansione nei due secoli seguenti (42). Per quanto concernela coltura della vite, le cui caratteristiche specifiche si confondono tra le generi-che indicazioni delle catasticazioni, la documentazione contrattuale quattrocen-tesca relativa al territorio di Roverchiara, mostra abbondanti tracce della pre-senza nelle plantate di sostegni vivi (i pontezarii (43)), quasi sempre costituiti daaceri – gli opii – o da salici (44).
SAGGI116
(41) Cfr. Vite e vino nel medioevo da fonti veronesi e venete; a cura di G. Maroso –G.M. Varanini. Verona 1984, p. 14 e S. Collodo, L’evoluzione delle strutture economichenel Trecento: l’economia delle campagne. In: Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche;a cura di A. Castagnetti – G.M. Varanini. Verona 1995, pp. 285-286.
(42) Cfr. G.M. Varanini, Un esempio di ristrutturazione agraria quattrocentesca, cit.,pp. 69 (nota n. 259), 70-71; M. Bellabarba, Aspetti di vita economica nel feudo: la terrae l’acqua. In: Dueville, cit., p. 891.
(43) Cfr. Vite e vino nel medioevo da fonti veronesi e venete, cit., pp. 20-21; come pureAsvr, Ufficio del Registro, reg. 174, c. 1615v («cum vitibus et pontezis» – 1458); Ibid., reg.182, c. 821r («cum duabus plantatis vitium» – 1461).
(44) Cfr. Asvr, Ufficio del Registro, reg. 136, c. 839v («cum vineis et oppiis» – 1445);
117
Le percentuali relative alla estensione degli appezzamenti (tabella n. 1) – anchein questo caso del tutto conformi ai case studies considerati in precedenza (45) –ribadiscono invece la caratteristica frammentazione della struttura fondiaria, entroun contesto piu generale in cui quasi il 60% dei fondi non superava il limite, certonon univoco ma rappresentativo, dei C. 10 (circa Ha. 3), limite all’autosufficienzaalimentare di una media famiglia contadina. A distanza di oltre un secolo e mezzo,una seconda perticazione fatta predisporre nel 1504 dal praepositus BartolomeoAveroldi ci ragguaglia sui cambiamenti intervenuti nelle scelte colturali e nella strut-turazione dei fondi nel secolo precedente: a fronte di una palese riduzione dell’interocomplesso fondiario che aveva interessato circa C. 30, i dati a disposizione mostranole tracce di una evidente modificazione negli assetti poderali dell’ente. La diminu-zione dei fondi (che passarono da 82 a 67) si accompagno ad un corrispettivoinnalzamento dell’estensione media degli appezzamenti, attestati attorno ai C. 4,5(tabella n. 2): non si tratto certo di un balzo di enormi proporzioni rispetto a quantorilevato oltre un secolo addietro, ma se si presta attenzione alla struttura complessivadei terreni, si colgono i segni di un ‘rimescolamento’ abbastanza consistente cheparve interessare soprattutto le fasce centrali della struttura fondiaria e che preluseagli ulteriori e piu consistenti sviluppi che divennero evidenti dopo gli anni ’30 delCinquecento. Ad una diminuzione di circa il 9% che interesso i fondi marginali eminori, inferiori ai C. 5, si accompagno un discreto rafforzamento e una parallelaridistribuzione di quelli di media estensione, compresi tra i C. 5 e i C. 20, mentre eda rilevare solo un accessorio aumento nei fondi superiori ai C. 20.
Tabella 2 - Distribuzione della proprieta fondiaria del monastero di S. Maria della Giara a Roverchiara (1504).Fonte: Asvr, S. Maria della Giara, reg. 53, c. n. n.
Tipologia dei terreni Ha.
Arativo (92,7%)
Arativo 42,19 (44,9%)
Arativo vitato 8,53 (9,1%)
Arativo vitato-prativo 23,62 (25,1%)
Arativo arborato 5,69 (6,1%)
Arativo prativo 7,10 (7,5%)
Prativo (6,7%)Prativo 5,81 (6,2%)
Prativo vitato 0,45 (0,5%)
Altro (0,6%) Altro 0,60 (0,6%)
Totale 93,99
Ampiezza media dei fondi (67 appezzamenti): C. 4,6.
Come accennato, gli andamenti riferiti da questa seconda perticazione della
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
Ibid., reg. 169, c. 470r («cum vineis et opiis» – 1446); Ibid., reg. 174, c. 1668r («cum vineis etopiis» – 1458); Ibid., reg. 182, c. 821r («cum duabus plantatis opiorum» – 1461); Ibid., reg.205, c. 362r («cum salgariis et vineis et pontezariis» – 1472); Ibid., reg. 208, c. 97r («cumvineis et opiis» – 1476).
(45) G.M. Varanini, La ‘curia’ di Nogarole, cit., p. 89 (tabella n. 1).
prepositura, si situano in una fase di rapida transizione che coinvolse buona partedella media e della bassa pianura veronese: gli ultimi decenni del Quattrocento e iprimi del secolo seguente segnarono infatti una decisa accelerazione nella pene-trazione fondiaria nel contado, che nel contempo presento tratti piu marcati inrelazione alla compagine dei cives, rispetto alle scelte e alle disposizioni forse piucaute di enti laici e monasteri. A prescindere comunque da una precipua differen-ziazione nelle possibilita di successo e nella maggiore o minore dinamicita deidiversi attori e da episodi che vennero a coprire un arco cronologico abbastanzadifferenziato, precoci in taluni casi, piu tardi e lenti in altri, rimangono indubbie lenotevoli dimensioni assunte dal fenomeno, come pure i suoi corollari, tra cui spiccasoprattutto l’intreccio a volte frenetico di emptiones e di permutationes, volte arimodellare la proprieta fondiaria della pianura secondo i nuovi canoni di sfrutta-mento e di gestione che si andavano progressivamente affermando. Non a torto,quindi, nel 1475 – ancora agli inizi del fenomeno – alcuni rappresentanti deldistretto veronese lamentavano davanti al Consiglio civico che «li citadini de Ve-rona hano comprado asai de le soe possessione de li contadini, le quale facea cumlo conta, e mo fa cum la cita: e per quest[o] [...] el conta e impoverido, e la cita einrichida» (46). Ad un confronto con i dati di meta Trecento, alcuni cambiamentisignificativi riguardarono anche le caratteristiche colturali dei fondi della preposi-tura di S. Maria della Giara: la preponderante ‘marcia’ dell’arativo a scapito deiprati costituı forse l’elemento di maggior peso, anche se rimane difficile potervalutare con precisione le caratteristiche degli svegri intervenuti, mettendoli cioein relazione con episodi di valorizzazione di prati stabili in prossimita di terrenimarginali e vallivi, o non piuttosto con esempi di vera e propria riduzione, favoritadalla riorganizzazione complessiva delle possessioni, sotto la spinta preminente diuna domanda cerealicola che dalla fine del Quattrocento tese inesorabilmente acrescere (47). Alla consistente diminuzione dei prati, si accompagno inoltre unalieve progressione dei terreni vitati, soprattutto nel binomio vite-prato che sostituı,rispetto alla precedente perticazione trecentesca, l’abbinamento con le piantatearborate di salgarii.
Elementi di maggiore differenziazione – che supportano l’ulteriore avanza-mento del processo di appoderamento delle possessioni di Roverchiara – si colgonoa distanza di circa un trentennio, dal confronto con una perticazione della prepo-situra riferibile agli anni ’30 del Cinquecento (tabella n. 3): la riduzione nel numerodegli appezzamenti da 67 a 47 e soprattutto il notevole aumento della superficiemedia, testimoniano chiaramente l’accelerazione nelle dinamiche fondiarie, impres-sa nel torno del nuovo secolo, verso la creazione e la razionalizzazione di «blocchicompatti di arativo» (48). A fronte di una sostanziale continuita nelle caratteristiche
SAGGI118
(46) Relazione del proveditore ed oratore del comune Gian Francesco Cipolla contro lepretese accampate da diversi provinciali (1475), riportata in G.B.C. Giuliari, Documenti del-l’antico dialetto veronese (1331-1475). Verona 1879, p. 4.
(47) G.M. Varanini, Le campagne veronesi del ’400, cit., p. 250.(48) Ibid., p. 232; cfr. anche G. Cherubini, La proprieta fondiaria nei secoli XV-XVI
nella storiografia italiana. In ‘Societa e storia’, 1 (1978), p. 29.
119
colturali dei terreni – a prescindere da un ulteriore avanzamento dell’arativo sem-plice e dell’arativo-vitato (49) e da segni di perdurante erosione, ad esempio, nel-l’arativo-prativo (50) – i macroscopici indizi di una ristrutturazione fondiaria sicolgono dal confronto delle percentuali relative alle superfici di terreno superioriai C. 20 che subirono un balzo nell’ordine del 17%, accompagnato nel contempoda un parallelo ridimensionamento dei fondi minori: quelli inferiori ad un camposcomparvero quasi del tutto, mentre quelli compresi tra C. 1 e C. 5 soffrirono unariduzione altrettanto marcata. A margine di tali processi che contraddistinsero lepossessioni della prepositura in tempi abbastanza rapidi, presero corpo – come sievince dalle abbondanti testimonianze archivistiche – anche nuove dinamiche enuovi atteggiamenti nei confronti del mondo rurale e della proprieta fondiaria deldistretto: in altri termini, al pari di quelle tendenze che gia da qualche decennioavevano iniziato a spingere i cives verso le campagne del territorio veronese, ancheper il monastero di S. Maria della Giara la riorganizzazione e il riordino degliassetti fondiari di Roverchiara si concretizzarono in episodi di mirata acquisizionefondiaria, a scapito soprattutto della piccola proprieta locale (51).
Tabella 3 - Distribuzione della proprieta fondiaria del monastero di S. Maria della Giara a Roverchiara (1532).Fonte: Asvr, S. Maria della Giara, reg. 66, c. n. n.
Tipologia dei terreni C. V. T. Ha.
Arativo (87,0%)
Arativo 143 8 – 43,03 (47,7%)
Arativo vitato 37 20 – 11,35 (12,6%)
Arativo vitato-prativo 76 – – 22,81 (25,3%)
Arativo prativo 4 7 – 1,28 (1,4%)
Prativo (6,3%) Prativo 18 21 – 5,66 (6,3%)
Altro (6,7%) Altro 20 4 – 6,05 (6,7%)
Totale 300 12 – 90,18
Ampiezza media dei fondi (47 appezzamenti): C. 6,3.
La documentazione archivistica, come accennato, permette di seguire neldettaglio l’insieme abbastanza frenetico e consistente di passaggi di proprietache segnarono il corso dei primi anni ’30 del Cinquecento. Non va dimenticato,tra l’altro, il fondamentale ruolo svolto in questo stesso torno di tempo dallafamiglia bresciana degli Averoldi, i cui membri si susseguirono o in alcuni casi siaccompagnarono alla guida dell’ente veronese: il vescovo Bartolomeo Averoldi,nunzio pontificio a Venezia, suffraganeo del cardinale Corner nella diocesi di
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(49) Cfr. Vite e vino nel medioevo da fonti veronesi e venete, cit., p. 14.(50) Cfr. G. Borelli, Il paesaggio agrario veronese tra ’500 e ’600. In ‘Atti e memorie
della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona’, CLXV (1988-1989), p. 526; G.Borelli, Problemi di storia rurale veneta. In: Uomini e civilta agraria, cit., v. I, Secoli IX-XVII, p. XXII; S. Ciriacono, Investimenti capitalistici e colture irrigue, cit., pp. 126-127.
(51) Cfr. G. Cherubini, La proprieta fondiaria nei secoli XV-XVI nella storiografia ita-liana, cit., pp. 25-26; come pure G.M. Varanini, Le campagne veronesi del ’400, cit., p. 199.
Tabella 4 - Acquisti fondiari del monastero di S. Maria della Giara a Roverchiara (1531-1536).
Anno Cedente Ubicazione Tipologia Estensione
C. V. T.
1531a Monastero camaldolesedi Murano
RC «in ora rotesive Frassenarie»
Arativa con«salicibus»
4,25 – –
1534bFilippo e Giuseppe
q. Bernardino deBordigaleis di Verona
RC «in ora Quare»Arativa «cum una
bina vitium»2,5 – –
RC «in ora Molarii» Prativa 3 – –
RCPezza «cumterra hortiva
et una nogaria»0,5 – –
RC «in oraCapitis ville ubi dicitur
in ora Boscheti»Arativa vitata 0,75 – –
RC Arativa 1 – –
RC Arativa 1 – –
RC «in ora Frassanarie»Arativa vitata
«cum pontezariis»1,5 – –
RC «in ora di Stafoli» Prativa 6 – –
1535cAntonio q. Paolo
Gambarinodi Roverchiara
RC «in oraBorchole sivedelle Quare»
Arativa garba – 12 –
1535dBaldassarre q. Antonio
de Bonetis diRoverchiara
RC «in ora Pomarii» Arativa garba – 20 –
1535eBenvenuto q. Antonio
de Franchinisdi Roverchiara
RC «in ora Paonore»Arativa «cum
una bina vitium»0,75 – –
1536fAntonio q. Viviano
de Mezaninisdi Roverchiara
RC «in ora Panegi» Arativa garba 0,5 – –
1536g
Francesco e Antonioq. Baldassarre
de Bonetisdi Roverchiara
RC «in ora Borchole» Arativa garba 1 5 –
Totale campi 23, 75 13 –
Totale ha. 7,29
Fonte: a) Asvr, S. Maria della Giara, reg. 28, cc. 76v-77r (emptio al prezzo complessivo di D. 40, in data26.VII.1531); Ibid., cc. 101v-102r (emptio iuris directi al prezzo complessivo di D. 108 in ragione di D. 6 perogni minale, in data 19.I.1534); c) Ibid., cc. 125v-126r (emptio al prezzo complessivo di D. 8 e in ragione di D. 16per campo, in data 8.III.1535); d) Ibid., cc. 133r-v (emptio al prezzo complessivo di D. 12, in data 8.V.1535); e)Asvr, S. Maria della Giara, reg. 29, cc. 2r-v (emptio al prezzo complessivo di D. 13,5 e in ragione di D. 18 percampo, in data 2.VIII.1535); f) Ibid., cc. 15r-v (datio in solutum al prezzo complessivo di D. 6, in data26.IV.1536); g) Ibid., cc. 22r-v (emptio al prezzo complessivo di D. 23 e in ragione di D. 19 per campo, indata 26.VIII.1536).
SAGGI120
121
Verona (52) e commendatario della pieve di Grezzana (53), oltre a comparire confrequenza tra i verbali delle visite pastorali gibertine come esempio di assenteismobeneficiario, agı di frequente in rappresentanza «sui monasterii» (54) di S. Mariadella Giara. Il legame tra la caxada bresciana, la gestione ‘familiare’ dell’ente, quan-to soprattutto l’intreccio tra le operazioni ‘private’ e l’amministrazione del patrimo-nio del monastero, permettono di ipotizzare un collegamento diretto tra il concretostimolo gestionale impresso alla proprieta fondiaria e i significativi episodi di acqui-sizione documentati (tabella n. 4).
L’annoso problema dei debiti costituı anche nel caso della prepositura dellaGiara, il meccanismo consolidato e abitualmente utilizzato per subentrare allaproprieta distrettuale e buona parte dei casi raccolti nella tabella n. 4 sono ricon-ducibili a tali dinamiche: l’acquisto effettuato nel 1531 dal monastero camaldolesedi Murano derivava, ad esempio, da una pregressa datio in solutum effettuata nel1530 da Antonio q. Franchini di Roverchiara di Caselle «pro annua pensione etresiduis» (55), mentre analoghe motivazioni avevano spinto nel 1536 i fratelli Ni-cola e Antonio de Mezaninis, debitori «pro fictis et aliis rebus et bonis» (56) con ilmonastero della Giara e soprattutto con la famiglia Averoldi che ne curava gliinteressi, a cedere il loro piccolo fazzoletto di terra che non raggiungeva nemmenoun campo di estensione. In altri casi, la cessione della proprieta di famiglia eralegata a bisogni piu impellenti, ma sempre all’insegna di una obiettiva difficolta diaccesso al credito minore, che rendeva indubbiamente piu vulnerabili le compa-gini rurali nei confronti dei prestiti garantiti a caro prezzo dai patroni e dai cives:come nel caso di Girolamo q. Domenico de Irrechis di Roverchiara di Caselle(1535), che per liberare un parente «a carceribus comunis Verone» (57) e nellanecessita «inveniendi denarios pro liberatione [...] non habens alium moduminveniendi» (58), non trovo di meglio che dare fondo ad una parte del miseropatrimonio di famiglia.
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(52) G.B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona. Verona 1750, v. III, p.38: secondo l’erudito veronese la nomina a praepositus di S. Maria della Giara risaliva al1499; cfr. anche G.B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona. Verona 1765,v. VI, p. 207.
(53) Cfr. Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G. M.Giberti 1525-1542; a cura di A. Fasani. Vicenza 1989, v. I, pp. LXXX, CVIII, 431, 634.
(54) Asvr, S. Maria della Giara, reg. 28, c. 76v (emptio in data 26.VII.1531). Nel 1535acquisto a nome di Giovanni Francesco q. Giovanni Battista Averoldi (di cui non e indicatoil grado di parentela) una pezza di terra arativa-vitata a Roverchiara «in ora Calmadorii» diC. 1,5, cfr. Ibid., cc. 123v-124r (emptio in data 9.I.1535 al prezzo complessivo di D. 20); neglistessi anni un terzo membro della famiglia, il decretorum doctor Mario Averoldi ricopriva lacarica di praepositus del monastero della Giara [G.B. Biancolini, Notizie storiche delle chie-se di Verona. Verona 1750, v. III, p. 38 (eletto nel 1534)], mentre un tale Zaccaria Averoldirisultava coinvolto nella gestione delle terre del monastero a Roverchiara, cfr. Asvr, S. Mariadella Giara, reg. 29, c. 15r.
(55) Asvr, S. Maria della Giara, reg. 28, c. 77r (emptio in data 26.VII.1531).(56) Asvr, S. Maria della Giara, reg. 29, cc. 15r-v (datio in solutum in data 26.IV.1536).(57) Asvr, S. Maria della Giara, reg. 28, c. 123v (emptio in data 9.I.1535).(58) Ibid., c. 123v (emptio in data 9.I.1535).
Le dinamiche quattro- e cinquecentesche individuate per la preposituradella Giara trovano conferma anche ad un rapido confronto con alcuni deglialtri enti presenti nel territorio di Roverchiara: pur in presenza di una documen-tazione meno completa, che quindi non ha permesso di seguire nel lungo periodol’avanzata del processo di appoderamento, i dati relativi in particolare al Cinque-cento, evidenziano la presenza di affini dinamiche fondiarie, sia in relazione allastrutturazione delle possessioni, sia nei meccanismi di penetrazione, legati prin-cipalmente allo sfruttamento del perenne indebitamento rurale (59). La situazionedella proprieta fondiaria del monastero di S. Domenico nel 1564 – a seguito di undecennio contraddistinto dal frequente ricorso ad una ‘politica’ di permute,soprattutto con proprietari di confine – presentava ad esempio una ampiezzamedia dei fondi di circa C. 6,7, del tutto simile a quella della prepositura dellaGiara rilevata nei primi anni ’30 del Cinquecento: differenze piu sostanzialiriguardavano soprattutto la tipologia colturale, in questo caso contraddistintadalla buona presenza di terreni prativi (quasi il 17% dell’intero) e dalla comparsadi terreni vitati abbinati a morarii, nella forma predominante della piantata (ta-bella n. 5) che proprio nel Cinquecento inizio una vera e propria ‘colonizzazione’delle campagne venete (60).
Se, come accennato, il problema degli affittuari insolventi costituı un volanoimportante nelle dinamiche fondiarie quattro- e soprattutto cinquecentesche –ampiamente documentabile anche nel caso di Roverchiara (61) – non mancaronogli enti che, sulla scorta di similari atteggiamenti della nobilta veronese, non di-sdegnarono di impegnarsi in prima persona in progetti di bonifica e di migliora-mento fondiario. Emblematico risulta ad esempio il caso del monastero di S. Mariadelle Vergini, che dopo aver acquisito nel 1561 da Adamo q. Matteo de Barberaciisdi Roverchiara di Fonzane una pezza prativa e paludosa di C. 25, per la somma
SAGGI122
(59) Cfr. P. Mometto, L’azienda agricola Barbarigo a Carpi, cit., pp. 130-131; G. Bo-
relli, L’agricoltura veronese tra ’500 e ’600: una proposta di lettura. In: Uomini e civilta agra-ria, cit., v. I, Secoli IX-XVII, p. 291; P. Lanaro Sartori, Il mondo contadino nel Cinque-cento: ceti e famiglie nelle campagne veronesi. In: Uomini e civilta agraria, cit., v. I, Secoli IX-XVII, pp. 321-323; G.M. Varanini, Organizzazione aziendale e societa rurale nella pianuraveneta: le terre della famiglia Proti a Bolzano Vicentino nella seconda meta del Trecento. In:Bolzano Vicentino, cit., pp. 111-113; F. Fasulo, Livelli e livellari del monastero di Praglia tra’400 e ’500. Primi risultati di una ricerca. In: S. Benedetto e otto secoli (XII-XIX) di vita mo-nastica nel Padovano. Padova 1980, pp. 147-149.
(60) Cfr. G. Sancassani, La legge e la campagna: gli statuti cittadini, le nuove colture,gli interventi specifici. In: Uomini e civilta agraria, cit., v. I, Secoli IX-XVII, pp. 144-145.
(61) Agli esempi addotti in precedenza, e possibile aggiungere il caso dell’Ospedale diS. Giacomo e Lazzaro: nel 1562 ad esempio, i due fuochi de Gambarinis Paolo e Francescoq. Biagio e Pietro Antonio q. Francesco, si trovavano debitori di L. 140 «pro residuis»[Asvr, Ospedale di S. Jacopo e Lazzaro alla Tomba, reg. 104, c. 45v]: l’ufficio dell’estimariadi Verona dietro richiesta dell’ente mise all’asta una pezza di terra arativa-vitata di loro pro-prieta di C. 2 (valutata D. 50 per campo), ma nonostante «factis tribus subastationibus usquead pretium quo fuit estimata non potuit vendi»[ Ibid., c. 45v], se non dopo una degradatio aD. 36 per campo che vide intervenire il procuratore dell’ente che «levato baculo incantus deterra» [Ibid., c. 45v] se la aggiudico come datio in solutum del credito pregresso.
123
complessiva di D. 229 (D. 9 al campo) (62), decise di intervenire nel riassetto delterreno posto ai confini di Tomba, nella contrada della ‘Pallaverta’. Le monache –che a Roverchiara potevano contare su di un modesto complesso fondiario di circaC. 60 (63) – «fecero fare et cavare molti fossi dal mese d’ottobre dello istesso anno1561 et ne i mesi et anni subsequenti intorno et a traverso [...] et piantare moltisalgari con molta loro spesa» (64). Nel 1567 la bonifica era probabilmente conclusadal momento i terreni vennero concessi ad un lavorente di Roverchiara, con il«galdimento» (65) di una parte dei prati ‘nuovi’ della possessione, ormai ridotta acoltura e rimpinguata dopo poco con altri C. 52 prativi e paludosi acquistati dallafamiglia urbana dei Pescaroli (66).
Tabella 5 - Distribuzione della proprieta fondiaria del monastero di S. Domenico a Roverchiara (1564).Fonte: Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Domenico, reg. 13, cc. 20r-23v.
Tipologia dei terreni Ubicazione C. V. T. Ha.
Arativo(82,4%)
Arativo garbo
RF «in ora dicta le Rivare» trai confini del dugale Nichesola
1 3 14
24,41 (41,4%)
RF «in ora dicta le Rivare» 3 2 22
RF «in ora della Fossa morta» 3 4 11
RF «in ora della Fossa morta» 3 6 3
RF «in ora della Fossa morta» 2 8 29
RF «in ora dicta la Viola» 4 20 14
RF «in ora dicta la Viola» 13 13 18
RF «in ora Morugioli» 3 22 0
RF «in ora Morugioli» 14 3 2
RF «in ora del Pra del rato» 0 21 5
RF 3 16 19
RF «in ora della Cha da l’ora» 9 22 21
RF «in ora della Cha da l’ora» 0 20 22
RF «in ora della Cha da l’ora» 0 22 4
RF «in ora della Cha da l’ora» 3 2 22
RF «in ora della Cha da l’ora» 4 5 20
RF «in ora Molarii» 8 3 14
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(62) Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delle Vergini, proc. n. 537, cc.16r-17r.
(63) Ibid., c. 47r; copia in Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delle Vergini,proc. n. 539, c. 85r.
(64) Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delle Vergini, proc. n. 538, c. n. n.(65) Ibid., c. n. n.(66) Ibid., c. n. n. (emptio in data 21.X.1562).
Arativo(82,4%)
Arativo vitatoRF «in ora Morugioli» 41 10 29
14,83 (25,2%)RF «in ora Morugioli» 7 23 10
Arativovitato-arborato«cum morariis»
RF «in ora Morugioli» 16 13 9 4,96 (8,4%)
Arativo arborato«cum quercubus»
RF «in ora Molarii» 2 20 15 0,85 (1,4%)
Arativo prativo«cum quercubus»
RF «in ora di Pra del molar» 11 17 24 3,52 (6,0%)
Prativo(16,9%)
Prativo
RF «in ora Morugioli» 4 14 20
4,73 (8,0%)RF «in ora Morugioli» 8 20 29
RF «in ora Morugioli» 2 7 5
Prativo arborato«cum quercubus»
RF «in ora Molarii» 5 4 25,24 (8,9%)
RF «in ora Molarii» 12 7 12
Altro(0,7%)
Casa «muratacopata et
solarata cumcortivo furno etfenili et horto»
RF «in ora Morugioli» 1 2 9
0,38 (0,7%)
Strada con servitudi transito
RF «in ora Molarii» 0 4 20
Totale 196 11 4 58,92
Spostando ora l’attenzione ai cives che tra il Quattro- e il primo Cinquecentoscelsero di rafforzare e strutturare le proprie possessioni nel territorio di Rover-chiara, il quadro di riferimento gia tracciato e le dinamiche prese fino a questomomento in considerazione non presentano cambiamenti sostanziali (67). L’ele-mento che pero contraddistinse la massiccia avanzata della nobilta veronese nelcontado e legato ad una piu marcata intraprendenza rispetto agli enti laici e allecompagini ecclesiastiche e soprattutto ad un piu esplicita attenzione alle fluttua-zioni dei prezzi, dettate in parte dal mercato cerealicolo urbano (68) (specialmentenel caso del frumento, cereale ‘mercantesco’ par excellence) e in parte dal mercatoveneziano (69), su cui erano esitate le partite di quel riso, che costituı proprio nelcontesto geo-ambientale di Roverchiara, una forma di investimento altamente re-
SAGGI124
(67) Cfr. P. Lanaro, Un’oligarchia urbana nel Cinquecento veneto. Istituzioni, econo-mia, societa. Torino 1992, pp. 165-166, 227-238; P. Lanaro Sartori, Il mondo contadinonel Cinquecento, cit., pp. 312-313; P. Lanaro Sartori, Gli scrittori veneti d’agraria del Cin-quecento e del primo Seicento tra realta e utopia. In: Venezia e la Terraferma attraverso le re-lazioni dei rettori; a cura di A. Tagliaferri. Milano 1981, pp. 269-270; G. Borelli, Terra epatrizi nel XVI secolo: Marcantonio Serego. In ‘Studi storici veronesi Luigi Simeoni’, XXVI-XXVII (1976-1977), pp. 48-55; B. Chiappa, Un nuovo interesse della borghesia cittadina perla proprieta agraria: verso i latifondi. In: Isola della Scala, cit., pp. 147-148.
(68) Cfr. A. Ventura, Considerazioni sull’agricoltura veneta e sulla accumulazione ori-ginaria del capitale nei secoli XVI e XVII. In: Agricoltura e sviluppo capitalistico. Roma 1970,pp. 528-530.
(69) Cfr. P. Lanaro, Riso veronese e mercato veneziano. Primi appunti sulla produzione
125
munerativo, pur a fronte di ampi impieghi di capitale (70): considerando che «adifferenza del grano, condizionato dall’autoconsumo e da una legislazione anno-naria restrittiva, il riso risultava un prodotto fortemente legato al mercato, in gradodi rimunerare direttamente l’azienda nobiliare, specie grazie ai forti rialzi di prezzoche il prodotto registrava alla fine del Cinquecento» (71). La maggiore estensionemedia delle possessioni dei cives, la loro migliore compattezza e indubbiamente lescelte colturali innovative e in alcuni casi anche ‘avventurose’, testimoniano quindidella continua ricerca di una efficienza agraria (72), in grado di rispondere attiva-mente alle sollecitazioni di una domanda che per tutto il Cinquecento seguı unatendenza in constante rialzo, a fronte di una dinamica demografica che gia dallafine del secolo precedente presentava i segni di una indubbia crescita (73).
La predilezione dei cives e di fasce della media e medio-alta ‘borghesia’urbana per le terre di Roverchiara, trova conferma a partire dal primo Quattro-cento, pur in presenza di una documentazione non omogenea, che ha richiestocampionamenti sparsi ed incompleti, condotti per buona parte nei fondi archivi-stici dell’Ufficio del Registro di Verona. Dalla disamina di numerose locationesperpetuales, emerge la significativa presenza nel territorio dei rappresentanti dellearti cittadine, sia che si tratti di magistri artium piu o meno affermati – spitiarii,sartores, pelliparii, texarii, garzatores (74) ma anche medici, come il «famoso artium
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
e la commercializzazione del riso in Terraferma veneta. In: Saggi di storia economica. Studi inonore di Amelio Tagliaferri; a cura di. T. Fanfani. Pisa 1998, pp. 73-92.
(70) Cfr. M. Berengo, Patriziato e nobilta: il caso veronese. In ‘Rivista storica italiana’,LXXXVII (1975), fasc. 3, pp. 504-507; G. Zalin, Economia agraria e insediamento di villatra Medioevo e Rinascimento. In: La villa nel veronese; a cura di G.F. Viviani. Verona 1975,pp. 76-77; M. Lecce, La coltura del riso in territorio veronese (secoli XVI-XVIII). Verona1958; G. Borelli, Citta e campagna in rapporto all’Adige in epoca veneta, cit., pp. 310-314; G. Borelli, L’agricoltura veronese tra ’500 e ’600, cit., pp. 280-286; G. Borelli, Ilriso in eta preindustriale (secoli XVI-XVIII). In: Prospettive dei consumi di riso in Europa;a cura di P. Berni. Verona 1994, pp. 23-29; S. Ciriacono, Acque e agricoltura. Venezia,l’Olanda e la bonifica europea in eta moderna. Milano 1996, pp. 96-102; B. Chiappa, Sull’o-rigine e diffusione della risicoltura nella bassa pianura veronese: nuovi documenti. In ‘Studistorici Luigi Simeoni’, LV (2005), pp. 79-114.
(71) S. Ciriacono, Investimenti capitalistici e colture irrigue, cit., p. 141; F. Angioli-
ni, Le basi economiche del potere aristocratico nell’Italia centro-settentrionale tra XVI e XVIIIsecolo. In ‘Societa e storia’, 2 (1978), p. 323.
(72) Cfr. B. Chiappa, Ancora sulla proprieta agraria nel Cinquecento. In: Isola della Sca-la, cit., pp. 150-151.
(73) Cfr. G.M. Varanini, Le campagne veronesi del ’400, cit., pp. 249-252; P. Mo-
metto, L’azienda agricola Barbarigo a Carpi, cit., pp. 64-67, 112; J.S. Grubb, Il mondo diLisiera nel Quattrocento, cit., p. 98.
(74) Cfr. Asvr, Ufficio del Registro, reg. 129, cc. 1672v-1673r (locatio del magister Gio-vanni spitiarius q. Bernardino de Caravacio della contrada di S. Sebastiano, in data4.XII.1443; lo stesso aromatarius ricorre tra i confinanti descritti in una locatio del 1479,cfr. Ibid., reg. 214, c. 654r, mentre gli eredi gestivano nel 1523 parte dei beni di Roverchiaradella famiglia Villafranca, cfr. quindi Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delleVergini, proc. n. 15, cc. 1r-7v); Asvr, Ufficio del Registro, reg. 174, cc. 1615r-v (locatiodel sartor Giovanni q. Giacomo de Abbatia, in data 9.IX.1458); Ibid., reg. 182, cc. 819v-
medicine magistro Troiano q. domini Iohannis de Sancto Andrea» (75) –, sia inveceche si tratti dei piu ricorrenti notai (76), la cui frequenza in qualita di locatori dipezze, ci porta alla conclusione che nella primissima eta veneziana anche la pianura– seppur non nella misura degli analoghi atteggiamenti delle compagini urbaneverso le zone collinari e verso la Valpolicella in particolare – godeva di una parti-colare attenzione (77), che nel caso emblematico della famiglia ‘notarile’ dei deTessarolo arrivo fino all’accaparramento di una parte dei diritti di una decimaminore del territorio (78).
Si tratto comunque di una penetrazione fondiaria che rimase abbastanzamarginale se confrontata con le piu vaste possessioni degli enti o con i patrimoniche di lı a pochi decenni alcuni cives iniziarono a strutturare: per gli artigiani e imercatores veronesi – e analoghe considerazioni valgono per il nutrito stuolo dinotai, individuato tra i proprietari fondiari di Roverchiara – le terre di pianuraricoprivano quel «ruolo di semplice supporto» (79) all’autosufficienza alimentare dirilevante importanza all’interno dell’economia familiare (80). Certo non mancaronogli esempi in controtendenza di attenzioni piu consistenti e durature, che comun-
SAGGI126
821r (locatio di Agnese q. Giovanni Stagnoli uxor del civis vicentino Pietro q. Giovanni Ga-spare de Camutiis, in data 4.VIII.1461: tra i confinanti compare tale Mezanotus garzator);Asvr, Ospedale di S. Jacopo e Lazzaro alla Tomba, reg. 104, cc. 257r-v (locatio al magisterpelliparius Nicola q. Francesco della contrada di S. Silvestro, in data 6.IV.1415).
(75) Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Domenico, reg. 6, c. 27r (permutatio indata 16.X.1445).
(76) Cfr. Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Domenico, perg. 1112 (locatio delmonastero in data 28.X.1432: tra i confinanti il notaio Giovanni q. Manfredo della contradadi S. Pietro in Carnario); Asvr, Ufficio del Registro, reg. 106, cc. 1376r-1377r (locatio di Si-gismondo figlio del q. notaio Guarino de Porto della contrada di S. Maria ad Fratam, in data6.II.1436); Ibid., reg. 169, cc. 470r-v (locatio del notaio Facio q. Domenico Foraboschi, indata 16.XII.1446); Ibid., reg. 106, c. 1376v: tra i confinanti di alcune pezze riportate inun atto del 1436, ricorre Facius de Foraboschi de Bodolono, plausibile indicazione di un suc-cessivo inurbamento della famiglia notarile; Ibid., reg. 174, cc. 1614r-1615r (locatio del no-taio Benedetto de Loxella della contrada di S. Maria in Organo, in data 14.V.1458); Ibid.,reg. 205, cc. 361v-362r (locatio di Pellegrino q. Giacomo Pellegrini, in data 22.XI.1472:tra i confinanti il notaio Paganino Della Torre); Asvr, Ospedale di S. Jacopo e Lazzaro allaTomba, reg. 104, cc. 274r-276r (locatio al notaio Michele q. Giacomo Farfusola della contra-da dell’Isolo di Sotto, in data 3.XI.1435).
(77) G.M. Varanini, Le campagne veronesi del ’400, cit., pp. 222, 242-243.(78) La prima investitura rintracciata della decima ‘quartasola’ (su cui torneremo am-
piamente in seguito) ai de Tessarolo risale al 1407, cfr. quindi Asvr, Mensa vescovile, reg. 7,c. 44v: investitura al notaio Giacomo q. Matteo de Tessarolo della contrada di Ponte Pietra(22.XII.1407); Ibid., reg. 10, cc. 121v-122r: investitura al notaio Isidoro q. Matteo de Tessa-rolo della contrada di S. Maria in Organo (20.X.1442), il notaio rogante e Paolo Agostinofiglio di Isidoro de Tessarolo «episcopalis cancellarius», un fatto che ci permette di tararemeglio gli ambiti di influenza raggiunti dalla famiglia nella prima meta del Quattrocento.
(79) G.M. Varanini, Le campagne veronesi del ’400, cit., p. 246.(80) Cfr. G.M. Varanini, La famiglia Pindemonte di Verona: le origini e le prime ge-
nerazioni (secc. XIV-XV). In: Villa Pindemonte a Isola della Scala; a cura di B. Chiappa – A.Sandrini. Verona 1987, p. 45.
127
que rimangono sempre abbastanza difficili da seguire nel lungo periodo: possiamoricordare a questo proposito il sartor e civis Giovanni q. Giacomo de Abbatia, la cuipresenza a Roverchiara e documentata per la prima volta attorno agli anni ’50 delQuattrocento con una serie di interessanti locazioni, vendite, recuperi per crediti,miglioramenti fondiari (81) e i cui eredi continueranno a comparire abbastanza difrequente, almeno fino agli anni ’30 del secolo seguente, nella vita della comuni-ta (82), arrivando a gestire negli stessi anni – secondo modalita attestate altrove nelveronese (83) – la cappella di Roverchiara di Caselle (84). Risaliva invece agli anni’70 del Quattrocento l’esperienza nella pianura dei capellarii de Bordigaleis, ampia-mente impegnati nell’usuale ‘traffico’ della proprieta distrettuale – comprata, per-mutata, locata o ceduta con una velocita a volte sorprendente – e che pure man-tennero con Roverchiara ampi legami nella prima parte del secolo seguente (85).
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(81) Un interessante esempio e dato dalla locazione decennale del 1458 a Giovanni deAbbatia di alcuni fondi: una pezza arativa a Roverchiara di Fonzane di C. 4, una pezza arativavitata di C. 5, una pezza prativa «in ora pratorum novorum» di C. 2, una pezza prativa e pa-ludosa con salici posta ai confini di Tomba a ridosso dell’argine del Busse di C. 16 e una ul-teriore pezza arativa di C. 2; il fitto annuo ammontava a L. 25, con promessa di acquisto perD. 109 al termine della locazione dal notaio Benedetto de Loxella [Asvr, Ufficio del Registro,reg. 174, cc. 1614r-1615r]. Il basso valore di acquisto per i complessivi C. 29 (circa D. 3,7 percampo), lascia intuire come forse di trattasse in parte di terreni marginali – e lo confermano leindicazioni topografiche – ben adatti ad operazioni di miglioramento fondiario.
(82) Cfr. Asvr, Ufficio del Registro, reg. 174, cc. 1614r-1615r (locatio al sartor Giovannide Abbatia, in data 14.V.1458), 1615r-v (locatio del sartor Giovanni de Abbatia, in data9.IX.1458), 1668r-1669v (emptio e locatio del magister Giovanni sartor q. Giacomo de Ab-batia della contrada di S. Cecilia, in data 13.XII.1458); Ibid., reg. 205, cc. 361v-362r (locatiodi Pellegrino q. Giacomo Pellegrini, in data 22.XI.1472: tra i confinanti Giovanni de Abba-tia); Ibid., reg. 214, cc. 653v-655r (locatio di Giovanni q. Giacomo de Abbatia, in data8.II.1479); Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, c. 112v (emptiodi Guglielmo q. Cristoforo Martelli, in data 14.X.1473: tra i confinanti Giovanni de Abbatiadella contrada di S. Cecilia); Apro, b. 18, proc. n. n. Pieve di Roverchiara per decima ‘quar-tasola’, cc. 3v-4v (permutatio di Francesco q. Guglielmo Martelli, in data 12.XII.1486: tra iconfinanti Giovanni de Abbatia). Nel primo Cinquecento un ramo della famiglia si era sta-bilito a Roverchiara, cfr. nel merito Apro, b. 18, proc. n. n. Pieve di Roverchiara per decima‘quartasola’, c. 38r (testimonianza processuale resa da Giacomo q. Pietro de Abbatia di Ro-verchiara, in data 18.I.1533) e Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martel-li, c. 19v (testimonianza processuale resa da Giacomo q. Pietro de Abbatia, in data10.III.1533).
(83) Cfr. A. Ferrarese, Aspetti e problemi economici del diritto di decima in Terrafer-ma veneta in eta moderna. Verona 2004, pp. 383-389 (Cerea); come pure A. Ferrarese,Una causa per la decima novalium nella Valpolicella del Cinquecento: Arbizzano e Novare(1547-1553). In ‘Annuario storico della Valpolicella’, XVII (2001-2002), p. 103.
(84) Riforma pretridentina della diocesi di Verona, cit., v. I, p. 119.(85) Cfr. Asvr, S. Maria della Giara, perg. 894 (rinnovo di alcune «veteres locationes»
stipulate nel 1479, effettuato da Filippo q. Bernardino capellarius de Brodegallis, in data30.IV.1521); Asvr, S. Maria della Giara, reg. 28, cc. 101v-102r (vendita di alcune pezze diterra effettuata da Filippo e Giuseppe q. Bernardino de Bordigaleis di Verona, in data19.I.1534).
Molto differente, ma altrettanto sfuggente per la prima meta del Quattrocen-to, risulta una prospettiva d’insieme sugli atteggiamenti dei cives: se da un lato inomi delle famiglie protagoniste della corsa alla terra iniziarono a comparire nelladocumentazione con una certa regolarita nella seconda meta del secolo, dall’altrobisogna pur sottolineare che a tenere le fila dei notevoli episodi che interessarono ilterritorio di Roverchiara nel primo Cinquecento, furono esponenti che poco onulla avevano da spartire con «il nocciolo duro di famiglie di tradizione pretta-mente, dichiaratamente aristocratica» (86) della citta. I casi emblematici dei Martellie dei Mazzanti testimoniano appunto di esperienze e di approcci fondiari dinamicie precoci che tardarono a fare breccia in patrimoni coevi, come ad esempio nelcaso dei Brenzoni, dei Sagramoso o dei Della Torre che, in un certo senso, ‘indu-giarono’ prima di cogliere le opportunita offerte dal particolare contesto geo-am-bientale, rimandando al Cinquecento inoltrato e al secolo successivo il loro coin-volgimento, che poi comunque si concretizzo nel corso del ‘secondo’ ciclo sei- esettecentesco dell’affare risicolo veronese.
Una veloce ricognizione delle rilevazioni confinarie desunte dalla eterogeneaserie di locazioni appena esaminate e da una documentazione parallela tratta dagliarchivi degli enti presenti a Roverchiara, ci porta quindi a tracciare un quadromolto dinamico, seppur altamente frammentario, delle presenze fondiarie a partiredai primi decenni della dominazione veneta (87). Un quadro che, come accennato,diventa molto piu stabile per la seconda meta del secolo, quando presenze di cives
SAGGI128
(86) G.M. Varanini, Appunti sulla famiglia Turchi di Verona nel Quattrocento. Tramercatura e cultura. In: Studi in memoria di Mario Carrara; a cura di A. Conto. Verona1995, p. 92.
(87) Per il primo Quattrocento ricorrono i nomi dei Lavagnoli [Asvr, Ufficio del Regi-stro, reg. 106, c. 1376v: Giacomo miles de Lavagnolis della contrada di S. Giovanni in Foro(1436)], degli Ormaneto [Ibid., c. 1376v: Battista q. Francesco de Ormanetis della contradadella Pigna (1436)], dei Verita [Ibid., c. 1376v: Gabriele Verita (1436)], dei Caprini [Ibid., c.1376v: Delaydus de Caprino (1436)], dei Fracastoro [Ibid., c. 1376v: Leo Petrus de Fragasto-riis della contrada di S. Andrea (1436); Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delleVergini, reg. 6, c. 244r: Leo Petrus Fracastoro (1428)], questi ultimi gia ampiamente presentia Roverchiara nella prima meta del Trecento e ricorrenti tra i confinanti delle pezze di ragio-ne della prepositura di S. Maria della Giara [Asvr, S. Maria della Giara, reg. 67, c. n. n.:Floravantis Fracastoro (c. 1340)]. Altre presenze individuate sono quelle dei Gavardo [Asvr,Ufficio del Registro, reg. 106, c. 1377r: Giovanni de Gavardo (1436)], dei Broilo [Ibid., c.1377r: Rigo de Broilo (1436)], dei Pavoni [Asvr, Ufficio del Registro, reg. 129, c. 1673r: Lu-chino de Pavonibus (1443); Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delle Vergini, reg.6, c. 244r: Polonius de Pavonibus (1428)], dei Della Torre [Asvr, Monasteri femminili dellacitta, S. Domenico, perg. 1112: Domenico Della Torre (1432); Asvr, Monasteri femminili del-la citta, S. Maria delle Vergini, reg. 6, c. 244r: Giovanni della Torre (1428); Ibid., c. 331r:Paganino Della Torre (1446)], dei Boniventi [Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Mariadelle Vergini, reg. 6, c. 244r: Giovanni Andrea de Boniventis (1428)], dei Lavezzola [Ibid., c.244r: Giovanni Pietro e fratres peliparii de Lavezolis (1428)], dei Maffei [Asvr, Monasterifemminili della citta, S. Domenico, perg. 1139: Antonio q. Enrico Maffei della contrada diS. Vitale (1436); Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delle Vergini, reg. 6, c.121r: heredes di Giovanni Maffei (1436)].
129
ben piu definite, anche e soprattutto in termini quantitativi, presero a dare forma apatrimoni sempre piu consistenti (88): i nomi di riferimento sono quelli a cuiabbiamo appena fatto cenno – soprattutto i Della Torre (89), i Brenzoni (90), iSagramoso (91) per l’ambito della nobilta ‘di spicco’ – anche se non mancaronopartecipazioni meno consistenti, ma comunque costanti, di un patriziato ‘minore’come gli Angiari (92) che innestarono a Roverchiara le appendici dei loro nutriti
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(88) Per il secondo Quattrocento – oltre ai cives ricordati piu oltre, caratterizzati da ri-correnti rapporti con la comunita – tra le presenze piu sporadiche ricorrono i nomi dei Maf-fei [Asvr, Ufficio del Registro, reg. 174, c. 1614r: Antonio q. Enrico Maffei della contrada diS. Vitale (1458)], dei Pellegrini [Ibid., reg. 205, c. 362r: Pellegrino q. Giacomo Pellegrini(1472)], dei da Sesso [Ibid., reg. 208, c. 97r: Ugolino q. Palmerio da Sesso (1476)]; degli Au-ricalco [Asvr, Ospedale di S. Jacopo e Lazzaro alla Tomba, reg. 104, c. 295r: Manfrino Au-ricalco (1467)], dei Lavezzola [Ibid., c. 295r: Giovanni Lavezzola (1467)], dei Capella [Ibid.,c. 295r: Tebaldo q. Priamo Capella (1467)], degli Spolverini [Ibid., c. 295r: Spolverino q.Antonio Spolverini (1467); Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli,c. 112v: «illi de Spolverinis» (1473)]; dei Del Bovo [Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Ro-verchiara contro Martelli, c. 112v: Bartolomeo q. Giovanni Del Bovo della contrada di S. Pie-tro Incarnario (1473)].
(89) Cfr. Asvr, Ufficio del Registro, reg. 174, c. 1615v: Francesco e Giovanni Battistadella Torre (1458); Ibid., reg. 182, c. 821r: Giovanni Battista della Torre (1461); Ibid., reg.191, c. 269r: Giovanni Battista e Francesco della Torre (1465); Ibid., reg. 205, c. 362r: Pa-ganino notaio Della Torre (1472); Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara controMartelli, c. 112v: Stagninus notaio Della Torre e Nicola della Torre (1473); Ibid., c. 112r:Sigismondo q. Nicola della Torre della contrada di S. Fermo (1503); Apro, b. 18, proc.n. n. Pieve di Roverchiara per decima ‘quartasola’, cc. 6r-v: Marco Della Torre (1501), 7r-v: Marco q. Paganino Della Torre della contrada di Ponte Pietra (1504); 13r-v: Bernardinodella Torre (1512); Asvr, S. Maria della Giara, reg. 53, c. n. n.: Luigi, Girolamo, Ludovico eSigismondo Della Torre (1504); Asvr, S. Maria della Giara, perg. 894: Alvise Della Torre(1521); Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delle Vergini, proc. n. 15, cc. 1r-7v:Bernardino Della Torre (1523); Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Domenico, reg.13, cc. 20r-23v: Giovanni q. Sigismondo della Torre, Giovanni Battista q. Raimondo DellaTorre della contrada di S. Pietro Incarnario e Domenico q. Lodovico Della Torre della con-trada di S. Fermo (1564); Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, cc.98r-103r: Giovanni e Agostino Della Torre. Nel corso delle due visite pastorali compiute aRoverchiara da G. M. Giberti, alcuni membri della famiglia Della Torre comparvero tra i«cives habentes predia» a Roverchiara, cfr. quindi Riforma pretridentina della diocesi di Ve-rona, cit., v. II, p. 806 (Roverchiara di Caselle – 1530: Raimondo, Agostino e Francesco DellaTorre) e Ibid., v. III, pp. 1289 (Roverchiara di Caselle – 1541: Giovanni della Torre), 1290(Roverchiara di Fonzane – 1541: Sigismondo Della Torre).
(90) Cfr. Asvr, Ufficio del Registro, reg. 205, c. 362r: Consolatus de Brenzono (1472);Apro, b. 18, proc. n. n. Pieve di Roverchiara per decima ‘quartasola’, cc. 25v-29r: eredi di An-nibale Brenzoni (1530); Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, cc. 98r-103r: tra i confinanti dei fondi della pieve di Roverchiara appaiono «illi de Brenzonis» (1574).
(91) Cfr. Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, c. 112r: Do-nato Sagramoso (1503); Asvr, S. Maria della Giara, reg. 53, c. n. n.: famiglia Sagramoso(1504); Apro, b. 18, proc. n. n. Pieve di Roverchiara per decima ‘quartasola’, cc. 22r-23r: ere-di di Pietro Sagramoso (1529).
(92) Cfr. Asvr, S. Maria della Giara, reg. 53, c. n. n.: Barnaba Angiari (1504); Asvr, S.
possedimenti nell’omonimo comune limitrofo o ancora gli Evangelisti (93), i Capri-ni (94), i Villafranca (95), i Pomedelli (96), i Cristati (97), tutti destinati ad intrecciarerapporti con la comunita di Roverchiara nel corso del Cinquecento. D’altra partepero – e ne abbiamo gia accennato – gli episodi piu significativi e pregnanti dellatrasformazione agraria che interesso parte del territorio di Roverchiara, ci portanonecessariamente a prescindere dalle famiglie appena indicate e a rintracciare, al-meno per le fasi di avvio, altri protagonisti: nel primo caso, quello della famigliaMartelli (98), senza allontanarci di molto da un humus comune con i nomi citati piusopra, legato in particolare alla presenza ‘discriminante’ nel consiglio civico eall’insieme di benefici che ne derivavano. Nel secondo caso, quello dei Mazzanti,
SAGGI130
Maria della Giara, perg. 894: Barnaba Angiari (1521); Asvr, Monasteri femminili della citta,S. Maria delle Vergini, proc. n. 15, cc. 1r-7v: Antonio q. Barnaba Angiari (1523); Asvr, Mo-nasteri femminili della citta, S. Domenico, reg. 13, cc. 20r-23v: Giacomo e Giulio Angiari(1564); Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, cc. 98r-103r: Giulioe Lodovico Angiari (1573). Cfr. anche Riforma pretridentina della diocesi di Verona, cit., v.III, p. 1289 (Roverchiara di Caselle – 1541: Giacomo Angiari).
(93) Cfr. Asvr, Ospedale di S. Jacopo e Lazzaro alla Tomba, reg. 104, c. 295r: Daniele q.Bartolomeo Evangelisti (1467); Asvr, S. Maria della Giara, reg. 53, c. n. n.: famiglia Evan-gelisti (1504); Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Domenico, reg. 13, cc. 20r-23v: Da-niele Evangelisti (1564). Cfr. anche Riforma pretridentina della diocesi di Verona, cit., v.III, p. 1290 (Roverchiara di Fonzane – 1541: Daniele de Evangelistis).
(94) Cfr. Asvr, S. Maria della Giara, reg. 53, c. n. n.: famiglia Caprini (1504); Asvr,Monasteri femminili della citta, S. Domenico, reg. 13, cc. 20r-23v: Gaspare e fratello Caprini(1564).
(95) Cfr. Asvr, Ufficio del Registro, reg. 174, c. 1614r: Giacomo Villafranca (1458);Ibid., reg. 205, c. 362r: Giacomo Villafranca (1472); Asvr, Monasteri femminili della citta,S. Maria delle Vergini, proc. n. 15, cc. 1r-7v: Giovanni Maria, Giacomo e Alessandro Villa-franca (1523). Cfr. anche Riforma pretridentina della diocesi di Verona, cit., v. III, p. 1290(Roverchiara di Fonzane – 1541: Alessandro Villafranca).
(96) Cfr. Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delle Vergini, proc. n. 15, cc.1r-7v: Giovanni Maria e Bonora Pomedelli (1523); Apro, b. 18, proc. n. n. Pieve di Rover-chiara per decima ‘quartasola’, cc. 25v-29r: Antonio Pomedelli (1530); Apro, b. 50, proc. n.n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, cc. 98r-103r: Bonora Pomedelli (1574). Cfr. ancheRiforma pretridentina della diocesi di Verona, cit., v. II, p. 805 (Roverchiara di Fonzane –1530: Giovanni Maria Pomedelli).
(97) Cfr. Asvr, Ospedale di S. Jacopo e Lazzaro alla Tomba, reg. 104, cc. 274v: CristatoCristati (1435), 295r: Cristoforo q. Cristato Cristati (1467); Asvr, Monasteri femminili dellacitta, S. Maria delle Vergini, reg. 6, c. 305r: Cristoforo Cristati (1444); Asvr, Ufficio del Re-gistro, reg. 129, c. 1673r: Cristato de Christatis (1443); Ibid., reg. 136, c. 839v: eredi de Chri-statis (1445); Ibid., reg. 174, c. 1615v: Giovanni Cristati (1458); Ibid., reg. 205, c. 362r: Cri-stoforo Cristati (1472); Ibid., reg. 214, c. 654r: eredi di Cristoforo Cristati (1479); Asvr, Mo-nasteri femminili della citta, S. Maria delle Vergini, proc. n. 15, cc. 1r-7v: Cristato e CristoforoCristati (1523).
(98) Le prime attestazioni dei Martelli nel territorio di Roverchiara risalgono – sulla ba-se della documentazione compulsata – ai primi anni ’70 del Quattrocento; a margine dell’at-tenzione alla media pianura, G.M. Varanini ha rilevato la loro presenza anche in aree colli-nari, cfr. G.M. Varanini, Le campagne veronesi del ’400, cit., p. 204.
131
l’esempio calzante potrebbe essere quello di homines novi, scissi dai legami diconsorteria che avviluppavano i cives impegnati nella gestione del comune e dellemagistrature urbane: mercatores, abilmente e velocemente arricchiti, che dal primoCinquecento ‘fiutarono’ le possibilita offerte dalle terre di Roverchiara e sepperoabilmente sfruttarle anche se per poco, dal momento che gia alla fine del secoloprofonde difficolta finanziarie li costrinsero a cedere una parte consistente deglioltre C. 350 che erano venuti accorpando.
Le scelte della famiglia Martelli a partire dal tardo Quattrocento costitui-rono comunque l’episodio piu interessante per cogliere gli aspetti piu significa-tivi della ‘corsa alla terra’ e dell’affare del riso. Con una serie mirata e costante diacquisti, di permute e di affitti, che presero avvio all’incirca con gli anni ’70 delQuattrocento – anni che contrassegnarono il punto di ‘svolta’ per molte altreesperienze fondiarie della nobilta veronese (99) – divenendo progressivamentesempre piu consistenti tra gli anni ’20 e ’30 del secolo successivo (100), i Martellitrasformarono e compattarono le possessioni ubicate nelle contrade del ‘paluvecchio’ e di ‘pra novi’ di Roverchiara, adattandole altrettanto rapidamentequando la ‘nuova’ coltivazione del riso inizio a diffondersi nella pianura vero-nese (101). Lo sforzo dell’impresa e i capitali investiti si colgono seguendo l’e-lenco delle acquisizioni che e stato possibile ricostruire tramite la documenta-zione d’archivio (tabella n. 6). Colpisce, innanzitutto, la tipologia dei terreni, perlo piu prativi solcati da piantate di salici o paludosi e vallivi, come pure l’ete-rogenea serie dei cedenti in cui i nomi di famiglie del distretto, che incontreremoanche in seguito, si confondono con quelle di cives nel contempo impegnati nellecampagne di Roverchiara. Nel torno di due generazioni, una parte consistentedel palus vetus, posta tra gli argini del Busse in «parte in pertinenza di Rover-chiara et [in] parte in pertinenza di Tomba» (102), cambio volto, trasformandosiin circa C. 300 «soto conditione d’arradori, di prativi con qualche paludosaportione» (103): nei primi anni ’30 del Cinquecento la meta dell’intera possessio-ne era gia stata trasformata in risaia (104).
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(99) Cfr. G.M. Varanini, Le campagne veronesi del ’400, cit., pp. 249-252; G.M. Va-
ranini – D. Zumiani, Ricerche su Gerardo Boldieri di Verona (1405c.-1485), docente di me-dicina a Padova. La famiglia, l’inventario dei libri e dei beni, la cappella. In ‘Quaderni per lastoria dell’Universita di Padova’, 26-27 (1993-1994), pp. 61-62.
(100) Cfr. M. Pasa, Veneziani, oligarchia di Terraferma e borghesia locale nel sud est ve-ronese. Investimenti e prime bonifiche. In: Acqua terra e uomini nella pianura veneta: dallaZerpa alla Fratta. La pianificazione idraulico sociale; a cura di M. Pasa. Verona 2005, v. II,pp. 80-125.
(101) Cfr. B. Chiappa, Sull’origine e diffusione della risicoltura, cit., pp. 79-86; B.Chiappa, La corsa all’acqua e l’introduzione della risicoltura. In: Isola della Scala, cit., pp.157-159.
(102) Apro, b. 19, proc. n. n. Summarium pro quarta parte decimae ‘quartasolae’, c. n. n.(103) Ibid., c. n. n.(104) Ibid., c. n. n.
Tabella 6 - Acquisti della famiglia Martelli nelle pertinenze dei ‘pra novi’ di Roverchiara (1473-1592).
Anno Acquirente Martelli Cedente Tipologia dei terreni C. V. T.
1473a Guglielmo q. CristoforoAngelo q. Ognibene
de MelegariisPrativo 3 – –
1478b Francesco q. GuglielmoBerton q. Francesco
de Bertolinis di Isola RizzaArativo 1 – –
1478c Francesco q. GuglielmoPietro q. Bartolomeo
de Peronis di Isola RizzaArativo vitato-prativo – 23 –
1486d Francesco q. Guglielmo Andrea Boldieri Prativo 7 – –
1487e Cristoforo - Prativo paludoso 6 – –
1501f Francesco q. GuglielmoZeno e fratelli dell’Antigo
di RoverchiaraPrativo paludoso«cum salicibus»
17 – –
1501g Francesco q. GuglielmoGiacoma q. Pietro
Giovanni olim Dominicide Leniago di Roverchiara
Prativo paludoso 6 – –
1504h
Mauro q. Francescoe fratelli (Giovanni,Gregorio, GiovanniMaria e Guglielmo)
Marco q. Paganinodella Torre
Prativo «cum salgariset ruperibus»
6 4 –
1512i Cristoforo q. GuglielmoMauro e fratelli
q. Francesco MartelliArativo 10 – –
1513l Gregorio q. Francesco –Arativo garbo «valliv[o] etin parte ridott[o] a’ risi»
62 – –
1515mMarco, Gregorio,
Giovanni eGiovanni Maria
Girolamo CalzataleaPrativo «cum salicibus
et ruperibus»6 4
1525n Gregorio q. FrancescoBernardino q. Marco
della TorrePrativo paludoso«cum salicibus»
40 – –
1529o Marco q. FrancescoDomenico q. Giovanni
de BarberacisPrativo «cum salicibus» 3,5
-––
1559p Gragorio q. FrancescoOspedale di S. Giacomo
e LazzaroPrativo paludoso 27 27 26
1559q Gragorio q. FrancescoOspedale di S. Giacomo
e LazzaroPrativo 1 – –
1592r Gregorio q. FrancescoFrancesco q. Domenico
RambaldoArativo «cum salicibus» 3 15 4
Fonte: a) Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, c. 112v (emptio in data 14.X.1473);copia in Apro, b. 18, proc. n. n. Pieve di Roverchiara per decima ‘quartasola’, c. 1r; b) Apro, b. 18, proc. n. n.Pieve di Roverchiara per decima ‘quartasola’, cc. 1v-2r (emptio al prezzo di D. 8 per campo, in data 18.VIII.1478);c) Ibid., cc. 2r-3v (emptio al prezzo di D. 2 per campo, in data 26.VIII.1478); d) Ibid., cc. 3v-4v (permutatio indata 12.XII.1486); e) Apro, b. 19, proc. n. n. Summarium pro quarta parte decimae ‘quartasolae’, c. n. n.; f)Apro, b. 18, proc. n. n. Pieve di Roverchiara per decima ‘quartasola’, cc. 5r-v (emptio in data 31.VIII.1501); g)Ibid., cc. 6r-v (emptio al prezzo di circa D. 2,5 per campo, in data 29.XI.1501); h) Ibid., cc. 7r-v (emptio al prezzodi circa D. 9 per campo, in data 22.VII.1504); i) Ibid., cc. 13r-v (emptio al prezzo di D. 10 per campo, in data8.VI.1512); l) Apro, b. 19, proc. n. n. Summarium pro quarta parte decimae ‘quartasolae’, c. n. n.; m) Apro, b.26, proc. n. n. Pro archipresbitero Rupeclarie contra archipresbiterum Tumbe Sozane, cc. 8r-v (emptio al prezzo dicirca D. 8 per campo, in data 2.X.1515); n) Apro, b. 18, proc. n. n. Pieve di Roverchiara per decima ‘quartasola’,cc. 17r-19v (emptio al prezzo di D. 5 per campo, in data 13.V.1525); o) Ibid., cc. 22r-23r (emptio in data5.IV.1529); p) Ibid., c. 214r (permutatio in data 16.XII.1559); q) Ibid., c. 214r (permutatio in data 16.XII.1559);r) Apro, b. 26, proc. n. n. Pro archipresbitero Rupeclarie contra archipresbiterum Tumbe Sozane, cc. 13r-14v(emptio al prezzo di D. 64 per campo, in data 25.IV.1592).
SAGGI132
133
Le testimonianze processuali raccolte in occasione di una lite per la decimadel riso che vide contrapposti la pieve di Roverchiara e i Martelli nei primi anni ’30del Cinquecento – un processo su cui torneremo ampiamente in seguito – si sonorivelate di estrema importanza per integrare i dati gia disponibili sulle acquisizionie sulle bonifiche intraprese ai ‘pra novi’; tutti i testes citati ed interrogati dai giudicidelegati dai rettori veronesi, confermarono lo scarso valore dei terreni che i Mar-telli erano venuti progressivamente acquisendo. I pochi ducati con cui si eranoconcluse le contrattazioni precedenti l’inizio delle operazioni di bonifica – all’in-circa D. 4 per ciascun campo (105) – rendevano conto di pezze di terra assoluta-mente improduttive, a causa delle «nebias quibus erant subiecte» (106) che neimpedivano la semina regolare di frumento o granata (107), terre «basse [...][con] alcuni pochi pradi cattivi [...] ma erano piu gli palludi che gli pradi» (108),valli che producevano solamente «caretta et fen cativo» (109).
Le operazioni di bonifica iniziarono plausibilmente attorno agli anni ’20 delCinquecento e si susseguirono per circa un decennio (110), rese molto piu difficilidalle continue inondazioni dell’Adige: nel 1533 un testis ricordava ancora di avervisto in alcune occasioni «l’aqua alta fino alle zoche di salgari» (111). Per sgrondare iterreni e porli al riparo dalle acque «facti fuerint plures conducti et fossata reme-diantia» (112) alle inondazioni, con un notevole impiego di manodopera locale –«essendoghe da quaranta in cinquanta persone a zaponarci ziuchi di palludi, sta-gando in fina alli zenochii intel fango» (113) – ma anche con il ricorso a personeesperte, in grado di far preparare i terreni per le delicate operazioni che dovevanoaccogliere la coltura del riso, come ricordava sempre nel 1533 un altro testis: moltepezze infatti «fuerunt reducte [...] per risarios ad instantiam de Martellis» (114). Il‘ciclo’ della bonifica era stato quindi scandito da precise tappe obbligate – «de
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(105) Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, c. 17v (testimo-nianza di Simone q. Manfredo de Melchioribus, in data 10.III.1533).
(106) Ibid., c. 18r (testimonianza di Simone q. Manfredo de Melchioribus, in data10.III.1533).
(107) Cfr. G. Da Re, Che cosa era la ‘granata’ dei documenti veronesi. In ‘Atti e memo-rie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona’, XCIX (1922), pp. 227-234.
(108) Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, c. 27v (testimo-nianza di Benedetto q. Domenico de Lugis originario di Vigasio, in data 4.IV.1533).
(109) Ibid., c. 28v (testimonianza di Vincenzo q. Giorgio Cerdonis di Bardolino, in data5.IV.1533).
(110) Ibid., c. 26v (testimonianza di Domenico q. Giovanni dell’Antigo, in data10.III.1533).
(111) Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, c. 29v (testimo-nianza di Vincenzo q. Giorgio Cerdonis di Bardolino, in data 5.IV.1533).
(112) Ibid., c. 25v (testimonianza di Domenico q. Giovanni Dell’Antigo, in data10.III.1533).
(113) Ibid., c. 28r (testimonianza di Benedetto q. Domenico de Lugis originario di Vi-gasio, in data 4.IV.1533).
(114) Ibid., c. 28r (testimonianza di Benedetto q. Domenico de Lugis originario di Vi-gasio, in data 4.IV.1533). Cfr. G. Borelli, Tra citta e campagna in Terraferma veneta in etamoderna. In ‘Studi storici Luigi Simeoni’, XXXVIII (1988), pp. 159-160; M. Lecce, La col-
vallibus et palludibus ad pascua et postmodum de pascuis ad prata» (115) – con-trassegnate dal fatto che, nel frattempo, le terre erano venute costantemente «sem-pre moltiplicando» (116) in valore, fino a diventare quei «bona prata» (117), in unprimo tempo affittati per l’allevamento e per il pascolo a «certis vachariis» (118) epoi in seguito acconciati a risaia, dopo aver completato il fondamentale sistema dicanali per rifornirli dell’acqua necessaria alla messa a coltura.
Le caratteristiche geologiche dei terreni e soprattutto l’incombente rischiorappresentato dagli argini dell’Adige e del Busse, non garantivano d’altra parterisultati certi, tali da ripagare in ogni caso i consistenti sforzi economici riversatinella bonifica e non mancarono a tale proposito gli esempi di un rapporto tral’uomo e l’ambiente contraddistinto, oltre che da una attenzione continua – comedimostrano ad esempio le spese sostenute annualmente dalla prepositura dellaGiara «pro cavatione dugalis Nichisole» (119) e «pro cavatione dugalis Pane-gi» (120) – anche dai rischi di una reversibilita sempre in agguato (121). I testesdel processo appena citato, ricordarono nei loro costituti che proprio non lontanodai terreni redenti, un altro Martelli, il civis Marco q. Francesco, il cui nomecompare tra gli acquirenti dei ‘pra novi’, aveva piu volte cercato inutilmente diseminare del frumento e «de aliis granis videlicet silligine, fasolis et fabiis» (122) inalcuni «prata disvigrata» (123): gli sforzi, in questo caso, non avevano dato frutto eil raccolto «el non ghe vegneva troppo ben, [et] el lasse star de somenarghe inparte» (124).
Le fatiche dei Martelli vennero comunque ampiamente ripagate, dal mo-mento che sul lungo periodo l’esperimento dei ‘pra novi’ si rivelo ampiamentesolido e redditizio, venendo implementato nel corso dei decenni seguenti daglieredi di Gregorio, che si impegnarono a consolidare il patrimonio di famiglia e aproseguire nel redditizio affare del riso, nonostante i perduranti problemi di‘buon vicinato’ che la gestione delle risorse idriche continuava a creare. Ad
SAGGI134
tura del riso in territorio veronese, cit., pp. 11-12; B. Chiappa, Sull’origine e diffusione dellarisicoltura nella bassa pianura veronese, cit., pp. 85-86, 92-96.
(115) Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, c. 24v (testimo-nianza di Domenico q. Giovanni Dell’Antigo, in data 10.III.1533).
(116) Ibid., c. 25r (testimonianza di Domenico q. Giovanni Dell’Antigo, in data10.III.1533).
(117) Ibid., c. 29r (testimonianza di Vincenzo q. Giorgio Cerdonis di Bardolino, in data5.IV.1533).
(118) Ibid., c. 18v (testimonianza di Simone q. Manfredo de Melchioribus, in data10.III.1533).
(119) Asvr, S. Maria della Giara, reg. 75, c. n. n.(120) Ibid., c. n. n.(121) Cfr. P. Mometto, L’azienda agricola Barbarigo a Carpi, cit., pp. 33-38.(122) Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, c. 19r (testimo-
nianza di Simone q. Manfredo de Melchioribus, in data 10.III.1533).(123) Ibid., c. 24r (testimonianza di Silvestro q. Domenico Dell’Antigo, in data
10.III.1533).(124) Ibid., c. 24r (testimonianza di Silvestro q. Domenico Dell’Antigo, in data
10.III.1533).
135
esempio, nel 1567 la comunita di Legnago si oppose con veemenza ad unarichiesta di investitura d’acqua perorata da Giovanni Battista Martelli per «leacque del canal di molini» (125) di Isola Rizza, che dopo aver irrigato le proprierisaie sarebbero state fatte defluire nella Nichesola: il timore dei consorti legna-ghesi era legato al rischio di sovraccaricare il dugale con gravissimo danno per ilterritorio di Legnago. Secondo i rappresentanti della fortezza, la supplica deiMartelli era in realta «una cosa mascherata sotto scena di voler adaquar suoiluochi» (126): paventando il «bisogno d’esser essicati per le acque del Busse etAdice desidera introdur nuova acqua [...] mettendo li suoi campi a risara comealtre volte erano l’anno 1558» (127). In altri termini al Martelli, «parendoli pocoacque sortive a far risi vuol introdur fintamente d’adaquar li suoi luoghi bassi chepatiscono acqua per valerse a far mercanzia de risi» (128). Un ulteriore graveproblema era poi rappresentato dal tragitto dello scolo, che avrebbe dovutopassare attraverso le possessioni gia bonificate dei Mazzanti e dei Sagramoso, iquali negli anni precedenti, «stante la remozione dell’acque e lontananza derisi» (129), erano riusciti nella difficile operazione di riassetto fondiario. I Prov-veditori – nonostante le rimostranze – valutarono positivamente le intenzioni delMartelli e concessero l’acqua che avrebbe irrigato circa C. 25, con il divietoesplicito pero di far risi: nel marzo 1567 la comunita di Legnago interposeappello. La causa venne comunque risolta l’anno seguente con un accordo ‘ami-chevole’ tra le parti, a garanzia del quale il Martelli si sarebbe impegnato a nonfar scolare l’acqua ricevuta (mezzo quadretto) nella Nichesola, lasciando «che lamora sopra li suoi luoghi» (130).
Il problema dell’approvvigionamento idrico per le risaie venne comunqueaffrontato a piu riprese anche nei decenni seguenti: ad esempio, nel 1572 Giaco-mo e Vincenzo Martelli richiesero ai Provveditori sopra Beni Inculti una nuovainvestitura di tre quadretti d’acqua del Busse (prelevata ad Isola Rizza nellevicinanze del mulino del nobile Girolamo Recalco) «per irrigar et far risi» (131)(con costruzione della relativa pila) in circa C. 300 «in contra di pre novi» (132)nelle pertinenze di Roverchiara, «a quella maggior fertilita che sia possibile, senzadanno di alcuno, per beneficio de la casa nostra et ancho in consequentia delpublico [bene]» (133). Nel 1588, Giovanni Battista Martelli domando e successi-vamente ottenne dai Provveditori un altro mezzo quadretto d’acqua, che si ag-giungeva a quello concesso nel 1567 e soprattutto la possibilita di trasformare in
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(125) Asvr, Dionisi-Piomarta, reg. 507, c. n. n. (sentenza dei Provveditori sopra BeniInculti, in data 8.III.1567).
(126) Ibid., c. n. n. (sentenza dei Provveditori sopra Beni Inculti, in data 8.III.1567).(127) Ibid., c. n. n. (sentenza dei Provveditori sopra Beni Inculti, in data 8.III.1567).(128) Ibid., c. n. n. (sentenza dei Provveditori sopra Beni Inculti, in data 8.III.1567).(129) Ibid., c. n. n. (sentenza dei Provveditori sopra Beni Inculti, in data 8.III.1567).(130) Ibid., c. n. n. (sentenza dei Provveditori sopra Beni Inculti, in data 17.III.1568).(131) Asvr, Monasteri maschili della citta, S. Anastasia, proc. n. 508, c. 8r.(132) Ibid., c. 8r.(133) Ibid., c. 8r.
risaia i C. 25 legati alla concessione che era stato tanto avversata dalla comunita diLegnago (134).
Per valutare invece la consistenza fondiaria della famiglia, una divisioneriferibile al 1565 tra i discendenti di Gregorio Martelli – che fu indubbiamentel’artefice principale dell’esperienza di bonifica del primo Cinquecento – ci per-mette di sondare con piu precisione la struttura di un patrimonio sparso tra lecomunita di Roverchiara e di Isola Rizza, ottenendo ulteriori informazioni suiprocessi della sua strutturazione. La tabella n. 7 raccoglie le informazioni relative
Tabella 7 - Divisione della proprieta fondiaria di Roverchiara-Isola Rizza della famiglia Martelli (1565).Fonte: Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, cc. 70r-82v.
Martelli Tipologia dei terreni Localita Estensione
Bartolomeo
Casa «murata, copata et solarata [cum] curtivo et broilo» IR 3
Casa «murata, coppata cum fenile et curtivo dita la casa dilavorenti [...] cum terra broliva et arrativa garba» divisa «in
septem corporibus»RF (pra novi) 159
Totale C. 162
Totale Ha. 48,6
Vincenzo
Casa «murata, copata et solarata cum stabulis, fenilis,barchessa, curtivo, horto, ara, broylo» con terra arativa
e prativa, divisa «in septem corporibus»R –
– R 18
– R 23
– R 4
– R 7
– R 46
– R 10
– R 7
Arativo IR [2,5]
Arativo garbo
IR 4
IR 2,5
IR 3
Arativo vitatoIR 10
IR 7
Totale C. 150
Totale Ha. 45,0
Ampiezza media dei fondi (7 corpi di Bartolomeo – Roverchiara): C. 22,7.Ampiezza media dei fondi (7 corpi di Vincenzo – Roverchiara): C. 16,4.
SAGGI136
(134) Asvr, Dionisi-Piomarta, reg. 507, c. n. n. (supplica ai Provveditori sopra Beni In-culti, in data 10.XII.1588). L’investitura venne concessa pochi giorni dopo, in data19.XII.1588, cfr. Asvr, Dionisi-Piomarta, reg. 507, c. n. n.
137
ai beni divisi tra i fratelli Bartolomeo, Vincenzo e Giovanni Battista q. GregorioMartelli. A prescindere dalla mancanza dei dati relativi alla parte di Giovanni Bat-tista, l’ampia e definita struttura delle possessioni, suddivise in diversi corpora dicompatte dimensioni affidate a lavorenti, rende conto di un processo di appodera-mento gia ampiamente avanzato, anche in considerazione della presenza di alcunicomplessi di strutture abitative, funzionali alla gestione di aziende agrarie sviluppa-te. Interpolando, grazie a fonti archivistiche di poco successive, il valore della partedi Giovanni Battista che all’incirca doveva raggiungere i C. 140 (135) nello stessotorno di anni, ci troviamo di fronte ad un patrimonio complessivo che alla mortedi Gregorio Martelli arrivava a sfiorare i C. 450, un patrimonio senza dubbio in-gente, abilmente ‘costruito’ in una progressione secolare.
Nel merito di tale processo di graduale accorpamento, proprio i dati relativiagli aggravi annuali a cui i tre eredi di Gregorio erano sottoposti, lasciano intra-vedere alcuni dei percorsi di composizione fondiaria intrapresi nei decenni pre-cedenti e che nello specifico si riferiscono ad una serie di locazioni livellariepregresse, in cui i Martelli erano subentrati rilevando il dominio utile (136). L’in-sieme eterogeneo dei censi – tra cui ad esempio D. 12 ad Andria Saibante conpatto di affranco per D. 200, D. 6 agli eredi di Alessandro Villafranca con pattodi affranco per D. 100, L. 19 all’aromatarius Giovanni Battista de Moris con pattodi affranco per D. 75, L. 36 a Vincenzo Lando con patto di affranco per D. 125,D. 7 allo «strenuo capitaneo» Cesare Colleoni con patto di affranco per D. 100,L. 25 agli eredi di Girolamo Lavezzola con patto di affranco per D. 90, L. 8 almonastero di S. Lucia con patto di affranco per D. 25, L. 15 a Giacomo Maffeicon patto di affranco di D. 30, D. 12 agli eredi di Giovanni Maria Auricalco,successi alla famiglia Angiari, con patto di affranco per D. 200, D. 19 a CesareMandelli con patto di affranco di D. 300 – denotava appunto la successivasostituzione degli utilisti operata dai Martelli, per terreni di cui non sarebbe dicerto azzardato presupporre una ovvia contiguita con le altre possessioni dellafamiglia.
Una rapida rassegna sulla consistenza di altri patrimoni di cives di cui sonodisponibili informazioni per gli anni centrali del Cinquecento, conferma la de-finitiva sedimentazione di estesi nuclei fondiari, irrobustiti nel corso del seco-lo (137): nel caso dei Mazzanti, il quadro dei possedimenti di Roverchiara che sidesume da un processo causato dalle divisioni tra due rami della famiglia, risa-lente agli anni ’30 del Cinquecento, denota – oltre ad un interesse specifico perle potenzialita offerte dalle stesse aree dei ‘pra novi’ e del ‘palu vecchio’ cheerano stati al centro dei progetti dei Martelli – una struttura fondiaria in cui ipoderi di ampie dimensioni costituivano la parte preponderante delle possessio-ni, con un ampiezza media attestata attorno ai C. 15 (tabella n. 8) e con rapportitra le differenti tipologie colturali abbastanza in sintonia con i case studies
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(135) Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, cc. 108r-111v.(136) Ibid., c. 78r.(137) Cfr. B. Chiappa, I Pindemonte di S. Egidio. La famiglia e il patrimonio fra XVI e
XVIII secolo. In: Villa Pindemonte a Isola della Scala, cit., pp. 60-61.
riferibili ad altri beni del patriziato veronese. Come ad esempio quello deiPomedelli (tabella n. 9) – ricostruito grazie alla divisione tra i fratelli Antonioe Bonora q. Giovanni Maria avvenuta nel 1563 (138) – dove a margine di unaminore estensione complessiva dei fondi e di una loro conseguente inferioreampiezza media (circa C. 11), permaneva il medesimo interesse per l’area del‘palu vecchio’, che si dimostrava zona ‘nevralgica’ per gli interessi fondiari ditutto il Cinquecento.
Tabella 8 - Distribuzione della proprieta fondiaria della famiglia Mazzanti a Roverchiara (1530).Fonte: Apro, b. 18, proc. n. n. Pieve di Roverchiara per decima ‘quartasola’, cc. 25v-29r.
Tipologia colturale Ubicazione C. V. T. Ha.
Arativo(89,2%)
Arativo
R 4 – -
39,92 (39,8%)
R 9 – –
R 6 – –
R 16 – –
R 16 – –
R 3 – –
R 3 – –
R 4 – –
R 4 – –
R 2 – –
R 3 – –
R 2 – –
R (‘pra novi’) 52 – –
R 8 – –
R 1 – –
Srativo vitatoR 50 – –
17,41 (17,4%)R 8 – –
Arativo prativoR 57 – –
32,12 (32,0%)R (‘palu vecchio’) 50 – –
Prativo(7,8%)
Prativo vitato R 26 – – 7,80 (7,8%)
Altro(3,0%)
Casa «copa, solaracon portico et brolo»
R 10 – – 3,00 (3,0%)
Totale 334 – – 100,25
Ampiezza media dei fondi (21 appezzamenti): C. 15,9.
SAGGI138
(138) Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, cc. 65r-69v.
139
Tabella 9 - Divisione della proprieta fondiaria di Roverchiara della famiglia Pomedelli (1563).Fonte: Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, cc. 65r-69v.
Tipologia colturale Ubicazione dei terreni C. V. T. Ha.
Arativo(51,1%)
Arativo garboR in contrada di ‘pra novi’ 5 15 –
2,28 (7,2%)R «in ora del Mezon» 2 – –
Arativo vitato «cumordinibus quinque
vitium»R «in ora del Mezon» 34 12 –
13,96 (43,9%)
Arativo vitato R «in ora del Mezon» 12 – –
Prativo(29,2%)
PrativoR «in ora del Mezon» 26 18 6
9,27 (29,2%)R «in ora del Mezon» 4 3 –
Altro(19,7%)
Palude R 10 – –
6,26 (19,7%)– R «in ora del Mezon» 7 21 –
– R 3 – –
Totale C. 105 21 6 31,77
Totale Ha. 63,54
Ampiezza media dei fondi (9 appezzamenti): C. 11,6.
Anche per i Mazzanti, la scelta di sfruttare le possibilita offerte dalla diffusarisicoltura implicarono i noti problemi di rifornimento idrico, gestiti tramite l’or-mai collaudato sistema delle investiture d’acqua concesse da Venezia, foriere nellostesso tempo di una litigiosita, in alcuni casi esasperata proprio dalla ‘corsa’ fre-netica alle risorse idriche del territorio (139). Di tale conflittualita latente – checomunque non tardava a sfociare in episodi ben piu gravi – rimane come esempiointeressante la supplica rivolta nel 1580 da Paolo Mazzanti ai Provveditori sopraBeni Inculti, per opporsi ad una precedente richiesta avanzata dal civis LeonardoRecalco nel settembre 1577. Il Recalco aveva perorato «una concessione di potterscollar nella Cappa Freda dugale un quadreto de acqua de alcune sue risare oltra ilfiume Bussedo» (140): secondo il Mazzanti «tal acqua scoladicia [...] apportarebbeinestimabil danno ad un mio luogo chiamato il palu vecchio et altri miei palustrellicircumvicini bassi piu di tutti li altri campi» (141), posti nelle pertinenze di Rover-chiara di Fonzane per una estensione circa C. 100.
I ‘lacrimevoli’ cenni al danno subito mascheravano pero un disegno piucomplesso e per certi aspetti ‘sibillino’: difatti, dal momento che non sarebbebastata «tal aqua scolladiza per far a risi li sudetti miei campi» (142), il Mazzantichiedeva in contropartita la possibilita di usufruire oltre a «tutte le scolladice dellequali nella supplica predita delli Recalchi» (143), anche delle «sortive del fiumeBussedo et tutte le acque scolladice de dugali condotti che infrutuosamente pas-
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(139) Cfr. G. Borelli, Citta e campagna in rapporto all’Adige in epoca veneta, cit.,p. 317.
(140) Asvr, Monasteri maschili della citta, S. Anastasia, proc. n. 508, c. 16r.(141) Ibid., c. 16r.(142) Ibid., c. 16v.(143) Ibid., c. 16v.
sano per le campagne de Isola Porcarizza et de Roverchiara de Fonzane et scollanoda diverse bande nel detto dugale della Cappa Freda» (144). L’intenzione era quelladi condurre e regolare tali acque, «sı come a periti parera star bene per farrisi» (145) nei C. 100 di proprieta, «con dar essito poi a tutte queste acque nelproprio lor dugale della Cappa Freda insieme con le sudette scoladice del Recal-chi» (146). E non ancora ‘soddisfatto’ per i danni che aveva elencato alla magistra-tura veneziana, il Mazzanti chiudeva la supplica con l’ulteriore richiesta di poterutilizzare gli scoli di un ponte canale, di cui aveva gia chiesto e ottenuto l’inve-stitura nel 1579: altrimenti «tutte queste acque insieme non basteran al maturardelli risi al tempo del luglio et agosto» (147).
Di tale ponte canale si trova appunto traccia in una precedente investituradell’ottobre 1579: Paolo Mazzanti si dichiarava in possesso di circa C. 300 «valliviet inutili» (148) tra Tomba e Roverchiara di Fonzane, «confinanti con i fiumi Adeseet Bussedo, i quai campi con molta spesa ho ridotti arzerrandoli in un serraglio conopinion di ritrarli a qualche fertilita» (149). La mancanza di un «conveniente schol-ladore» (150) non aveva permesso di portare a buon fine l’impresa: ai Provveditoriveniva quindi chiesta licenza di «potter traversare il fondo del Bussedo con unponte canale [...] non solamente per dar esitto et schollador a questo mio serragliodi quelle acque che per il schollador del Adese non possono schollare al tempo delestate, sı come schollano al tempo dell’inverno, ma ancho per irrigare con lemedesme acque» (151) i circa C. 100 di cui si e gia fatto cenno, «i quali al tempodel caldo per l’ordinario han bisogno de acqua, sı come ancho ha il proprio dugaledella Cappa Fredda che entra poi nella Nichesuola» (152). Nelle intenzioni delMazzanti, l’uso del ponte canale sarebbe stato limitato tra i mesi di luglio e disettembre, chiudendolo nel restante periodo, per evitare il rischio di sovracaricarela Cappafredda e la Nichesola: negli altri mesi si sarebbe invece servito dello scolo«che cascha nel Adese» (153), dopo averlo «fatto piu libero et ispeditto che non e alpresente» (154) e di una chiusa da realizzare «nel arzer del Adese fra le due chiavi-che che sono nel arzer istesso al diritto de miei campi» (155).
Gli episodi appena citati, oltre a rendere conto di quell’intraprendenza checontraddistinse due tra le famiglie piu impegnate nella ristrutturazione e nello sfrut-tamento del territorio di Roverchiara, testimoniano – come gia accennato – di fre-quenti frizioni e di continue difficolta per far collimare gli interessi dei singoli pro-
SAGGI140
(144) Ibid., cc. 16v-17r.(145) Ibid., c. 17r.(146) Ibid., c. 17r.(147) Ibid., c. 17r.(148) Ibid., c. 18r.(149) Ibid., c. 18r.(150) Ibid., c. 18r.(151) Ibid., c. 18r.(152) Ibid., cc. 18r-v.(153) Ibid., c. 18v.(154) Ibid., c. 18v.(155) Ibid., c. 18v.
141
prietari, entro un reticolo fondiario fatto di dugali, scoli, diritti pregressi, investituregia ottenute e incessantemente implementate, per far fronte ai continui miglioramentia cui le possessioni erano sottoposte. Non e quindi un caso che gli interessi deiprotagonisti principali di tali esperienze innovative, vennero a scontrarsi in piu occa-sioni, in anni contigui con le vicende di cui abbiamo appena dato conto. D’altraparte, nella frenesia dei cambiamenti, i motivi e le occasioni del contendere cresce-vano proporzionalmente alla profusione dei cospicui investimenti impegnati nelleterre di Roverchiara: i casus che contrapposero i Martelli e i Mazzanti a partire daiprimi anni ’80 del Cinquecento, presentavano una articolazione abbastanza ampia. Suvertenze marginali e secondarie – alcuni campi dei Mazzanti ai ‘pra novi’ di cui iproprietari si erano rifiutati di pagare la decima spettante ai Martelli, oppure la stradache girava intorno al ‘palu vecchio’ che i Mazzanti avevano «occupata et incorporatain sue pezze di terra convertendola in suo uso» (156) – si inserivano i problemi piuconsistenti, che nello specifico derivavano inevitabilmente da affari d’acque. Unafossetta che fungeva da «scolador di tutte le sortive dil Busse et le portava ad unscolador chiamata la Capa Fredda scolando le nostre [dei Martelli] possessione etd’altri cosorti» (157), era stata usurpata dai Mazzanti, che nel contempo si erano purepermessi di abbattere «un ponte di preda sulla via visinevole che passa tra IsolaPorcarizza et Tomba, percio che essi Mazzanti hanno fatto scavezzar la ditta stradaet fatto cavar suso il ponte che menazzava ruina anci era cascato, et cio per scolar lasua possessione di Polandro con suo gran benefficio» (158). La lite e gli strascichi chene erano derivati – secondo un cliche abbastanza comune tra le famiglie del patriziatourbano – erano proseguiti scanditi dagli infruttuosi tentativi di compromesso arbi-trale tra Paolo Mazzanti e Giovanni Battista Martelli e le immancabili riacutizzazionidel contendere. Nel 1588, lo stesso Paolo Mazzanti richiedeva una concessioned’acqua per «tutte le soprabbondanze delle aque del canaleto esistente sotto il molinde Recalchi per far risara campi cento incirca nelle pertinenze d’Isola Porcarizza eRovergiara di Fonzane et insieme le scoladizze di campi venticinque di messer Batti-sta Martelli» (l’acqua era quella concessa ai Martelli nel 1567 dopo la lite con ilcomune di Legnago) (159): a margine della richiesta, il supplicante sottolineava peroche tali campi erano «redoti quasi inutili per causa d’una risara ivi contigua» (160) deiMartelli, che oltre a danneggiare gli arativi, aveva rovinato i prati che non si eranopotuti far «segar se non per far letto e per netar il codego» (161).
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(156) Ibid., c. 24v.(157) Ibid., c. 24v.(158) Ibid., c. 25r.(159) Apro, b. 18, proc. n. n. Pieve di Roverchiara per decima ‘quartasola’, c. 136r (sup-
plica in data 5.VII.1588). In una seconda supplica di poco posteriore, il Mazzanti chiedevaanche la possibilita di estrarre acqua dal Busse «per li suoi campi piu bassi» [Asvr, Dionisi-Piomarta, reg. 507, c. n. n. (supplica ai Provveditori sopra Beni Inculti, in data30.VIII.1588)].
(160) Asvr, Dionisi-Piomarta, reg. 507, c. n. n. (supplica ai Provveditori sopra Beni In-culti, in data 5.VII.1588).
(161) Apro, b. 18, proc. n. n. Pieve di Roverchiara per decima ‘quartasola’, c. 138r (do-cumento in data 11.IX.1589).
Per completare il complesso quadro appena delineato, non resta che unabreve disamina della proprieta distrettuale: un compito arduo, in considerazionesoprattutto delle caratteristiche sfuggenti dei fondi appartenenti ai proprietari deldistretto, sottoposti dopo il secondo Quattrocento ad una massiccia erosione e aduna conseguente rapida e continua ristrutturazione, entro il novero di quelle fami-glie in grado di emergere nella schiera eterogenea dei brazenti e dei piccoli livellaridella comunita. Come vedremo meglio nell’analisi di alcuni episodi significativi, unelemento caratteristico della proprieta distrettuale e dato indubbiamente dallabreve durata delle ‘fortune’ di famiglia, sottoposte da piu parti alle sollecitazionidi una congiuntura agraria secolare non facile ed intermittente: un fatto in grado diagevolare rapide aggregazioni fondiarie – in genere legate a rapporti di patronage edi dipendenza diretta dai cives piu influenti o da alcuni dei ricchi enti presenti aRoverchiara – ma nello stesso tempo causa principale di altrettanto rapide disgre-gazioni e ‘retrocessioni’ sociali (162).
La terra, la conduzione oculata di affitti redditizi, l’impegno diretto nell’ap-palto e nella riscossione dei pingui raccolti decimali, le peculiari strutture familiariallargate a molte ‘braccia’ su cui contare o ancora la gestione diretta dei gangli delpotere comunitario, rappresentarono alcuni dei percorsi che delineano le ‘storie’personali di famiglie del distretto: l’aleatoria durata di tali esperienze e l’impossi-bilita di stabilizzare nel tempo le conquiste effettuate, paiono tratteggiare invece,oltre che una aspetto difficile da sondare, il destino comune di molti distrettuali. Aprescindere dagli evidenti limiti della documentazione a disposizione, tra i nomiche infarcirono le decine di locationes con cui la proprieta della comunita vennevorticosamente livellata o affittata nella Roverchiara del secondo Quattrocento,sono due le famiglie che forse ricorrono con maggiore frequenza, quella dei deIrechis e quella dei de Barberaciis. Quanto ai primi, la loro presenza e attestata dadiversi episodi intorno agli anni ’60 del Quattrocento: nel 1465, ad esempio,Francesco q. Bartolomeo de Irechis di Roverchiara di Caselle e lo zio Martino q.Andrea de Irechis, stipularono una locazione decennale con un proprietario vero-nese – Raffaele q. Bartolomeo de Piscibus della contrada cittadina di S. Maria adFratam – impegnandosi a coltivare una pezza prativa «in ora vallis» (163), unaseconda pezza arativa vitata e una terza pezza arativa «in ora del aquara» (164) diestensione indeterminata, versando annualmente un canone stabilito in 6 minali«frumenti boni sici mercadareschi pulcri» (165) e in una balantia di lino «bonipulcri bene spatulati» (166). Dopo qualche decennio, agli inizi del Cinquecento inomi di Francesco e Bernardino de Irechis e dei loro eredi, menzionati tra i confinidei fondi della prepositura di S. Maria della Giara, indicano la presenza di unmodesto patrimonio fondiario, destinato comunque a sparire di lı a poco, come
SAGGI142
(162) Cfr. A. Ferrarese, Aspetti e problemi economici del diritto di decima, cit., pp.365-398.
(163) Asvr, Ufficio del Registro, reg. 191, c. 269r.(164) Ibid., c. 269r.(165) Ibid., c. 268r.(166) Ibid., c. 268r.
143
lasciano presupporre gli indizi rintracciati. Nel 1521, infatti, il capellarius Filippo q.Bernardino de Bordigaleis, rinnovava una serie di vecchie locazioni stipulate nel1479 con Francesco e fratelli de Irechis: il cambio degli affittuari, che avveniva ingenere con una certa ritrosia da parte dei locatori, sostituiti dal fabbro Pietro q.Giovanni di Roverchiara, presuppone che probabilmente la situazione economicadella famiglia fosse nel frattempo mutata, anche in considerazione degli anni con-trastati e difficili seguiti al 1509 e delle cessioni fondiarie gia documentate inprecedenza a favore della prepositura della Giara.
Il problema dei debiti, a cui e gia stato fatto riferimento, costituı d’altra partel’elemento che piu incise nei rapidi rivolgimenti che caratterizzarono la proprietadel distretto e spesso provoco quelle rapide disgregazioni fondiarie di cui abilmen-te seppero approfittare le compagini urbane: un esempio interessante e riferibile aicitati de Barberaciis. Nel 1499 il civis veronese Cristato q. Cristoforo de Christatisdella contrada S. Sebastiano, creditore di Domenico q. Matteo de Barberaciis diRoverchiara di Fonzane, aveva preso in tenuta una pezza di terra «cum duabustegetibus a paleis cum quadam parte broili» (167) di C. 1,5, poi ‘passata’ «adofficium estimarie» (168) per la vendita e la successiva datio in solutum allo stessoCristati: il debito ammontava a 440 denari veronesi, mentre una parte della pezzarientrava in un precedente livello di 21 minali di frumento che i de Barberaciispagavano a Sachomanus de Realdono. Dopo un compromesso arbitrale che stabilıl’unicita del credito (stimato in D. 55) a favore del solo Cristati, il civis decise laconvenienza di mantenere i vecchi locatori ancora indebitati per circa D. 40 e peraltri D. 10 per spese effettuate «de concordio» (169). Le due parti, «volentes secomponere» (170), arrivarono ad un ulteriore accordo, mediante il quale il Cristatistabilı che la pezza ricevuta come datio in solutum avrebbe coperto il debito per lasomma di D. 45 «et non ultra» (171); in seguito, ne avrebbe investito i fratelli deBarberaciis con una locatio perpetualis decennale (fitto di 11 minali frumento), conla possibilita di un eventuale affranco dietro la corresponsione di D. 45. La con-venienza di mantenere gli affittuari indebitati era in genere parte di quel perversoingranaggio che erodeva, con sempre maggior frequenza nel primo Cinquecento, leproprieta distrettuali: l’accumulo di debiti, saldato di volta in volta con la cessionedi terre, se da una parte favoriva il lento processo di appoderamento e di aggre-gazione della proprieta urbana, dall’altra garantiva il perpetuarsi della dipendenza,legando in modo sempre piu indissolubile il creditore al suo patronus. E proprio levicende successive dei de Barberaciis, costellate da una successione di cessioni –prima ai Martelli (nel 1529) impegnati a dare forma ai ‘pra novi’ e poi al monasterodi S. Maria delle Vergini (1561) di un ampio complesso fondiario in cui le monacheprofusero in seguito le loro migliorie – confermano e documentano, oltre all’ine-
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(167) Asvr, Ufficio del Registro, reg. 236, c. 95v.(168) Ibid., c. 94v.(169) Ibid., c. 94v.(170) Ibid., c. 94v.(171) Ibid., c. 94v.
vitabile declino della famiglia, la fattiva impossibilita di sfuggire alla pressione deldebito.
A margine degli insuccessi tracciati brevemente nei casi considerati, nonmancarono gli esempi – pochi a dire il vero – di patrimoni distrettuali piu solidi,capaci di resistere per un torno di tempo piu lungo alle forti sollecitazioni dellapenetrazione urbana, come nel caso della famiglia Dell’Antigo: un ceppo distret-tuale in grado di mantenere una sostanza e una fisionomia gestionale della pro-prieta comune ai diversi rami della famiglia, che gli permise di superare indenne –o almeno di limitare i danni – la difficile congiuntura cinquecentesca. Attestati aRoverchiara a partire dalla seconda meta del Quattrocento (172), le ‘fortune’ deiDell’Antigo parvero consolidarsi nei decenni seguenti, soprattutto grazie alla ge-stione livellaria o ad affitto di ampie proprieta di cives o di enti veronesi (mensavescovile di Verona): un primo importante contratto fu quello stipulato nel 1472con Pellegrino q. Giacomo Pellegrini per un insieme di pezze di C. 26 (173), cedutecon una locatio decennale a Giovanni q. Domenico dell’Antigo e ai fratelli Zeno,Pietro, Santo e Silvestro «in fraterna habitantium» (174), per un canone annuo diminali 23,5 di frumento, L. 7 e S. 10 piu tre capponi di regalıa.
La scelta della fraterna, cioe della gestione comune del patrimonio e dellelocazioni tra tutti i componenti della famiglia, facilmente rintracciabile in episodicoevi riferibili al contesto della pianura veronese (175), costituı, oltre che un ele-mento di stabilita in grado di evitare pericolose divisioni ereditarie e conseguentideleterie frammentazioni fondiarie, anche una importante garanzia di quella coe-sione e di quella disponibilita di braccia, indispensabile nell’addossarsi contrattiimpegnativi e rischiosi, affrontabili solo grazie alla presenza di nuclei familiaricompatti, dotati di scorte animali proprie e magari di un modesto patrimoniofondiario di supporto, che nel caso della copula Dell’ Antigo e facile da individuareproprio ai confini delle pezze locate nel 1472. Al livello acceso con i Pellegrini –che tra l’altro venne rinnovato almeno fino alla meta del secolo successivo (176) –
SAGGI144
(172) Asvr, Ufficio del Registro, reg. 174, c. 1614r: Domenico Dell’Antigo compare trai confinanti di alcune pezze locate dal notaio Benedetto de Loxella (1458).
(173) Asvr, Ufficio del Registro, reg. 205, c. 362r: una pezza vitata arborata «cum dua-bus domibus paleatis» a Roverchiara di Fonzane di C. 2,5; una pezza arativa «cum salgariis etvineis et pontezariis» di C. 6; una pezza arativa vitata «in ora aggeris» (confinante, come altredelle pezze in questione, con gli iura dell’episcopio di Verona) di C. 2; una pezza arativa vi-tata «in ora Sablonarie» di C. 2; una pezza arativa di C. 1; una pezza arativa con salici di C.1,5; una arativa con salici di C. 2; una pezza arativa di C. 2; una pezza arativa e prativa consalici nelle vicinanze del dugale Cappafredda di C. 7.
(174) Ibid., c. 361v.(175) Cfr. P. Mometto, L’azienda agricola Barbarigo a Carpi, cit., p. 114; G. Delille,
La famiglia contadina nell’Italia moderna. In: Storia dell’agricoltura italiana in eta contempo-ranea, v. II, Uomini e classi; a cura di P. Bevilacqua. Venezia 1990, p. 514.
(176) Nel 1501 Pellegrino Pellegrini cedette il dominio diretto di una parte dei C. 26precedentemente locati ai Dell’Antigo ad Elena Maffei (moglie di Girolamo Dalla Riva):la nuova proprietaria mantenne le precedenti locazioni e le rinnovo ai medesimi possessorinel 1523 [Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delle Vergini, proc. n. 13, cc. 1r-4r].La parte di fondi rimasta invece ai Pellegrini venne ceduta in dote a Camilla, figlia di Gio-
145
seguirono altre interessanti operazioni fondiarie, indici evidenti delle discrete con-dizioni economiche della famiglia e della costante attenzione per le possibilitaofferte dalle conduzioni. Risale ad esempio al 1501 la vendita di circa C. 17 «interpascua, valles et prata pro ducatis quatuor quoque campo sotto sora» (177), aiMartelli impegnati nel noto affare dei ‘pra novi’ – ricordata tra l’altro tra le depo-sizioni rese da Silvestro q. Domenico Dell’Antigo al processo per la decima del risonel 1533 – mentre non mancarono i nuovi affitti, come quelli stipulati con Sigi-smondo della Torre per alcune terre prative nel 1503 (178), con i canonici dellacattedrale di Verona per le possessioni di Roverchiara negli anni ’30 del Cinque-cento (179) e con l’episcopato di Verona nel 1536.
Vari indizi, riferibili appunto ai primi decenni del secolo, attestano nel con-tempo la progressiva presenza della famiglia in ruoli di preminenza nella comunita,quasi a ‘naturale’ conclusione – e anche in questo caso gli esempi relativi ad altrecomunita cinquecentesche della pianura risultano alquanto cospicui (180) – di unlento e graduale processo di ascesa sociale, che trovava nella gestione dei gangliamministrativi e fiscali del comune un punto di arrivo significativo ed imprescin-dibile, dato che proprio «attraverso la gestione delle cariche pubbliche si control-lavano le finanze, si determinavano gli ambiti di azione del proprio villaggio, sioccupavano le posizioni fondamentali del rapporto intermediario tra la comunita eil mondo esterno [...] mediante tali incarichi era in definitiva possibile sancireanche socialmente la propria preponderanza economica» (181). Di indubbio valore,
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
vanni Girolamo q. Tommaso Pellegrini della contrada cittadina di Mercato Nuovo, al mo-mento della monacazione nel monastero di S. Maria delle Vergini (1558) e anche in questocaso livellata nuovamente ai Dell’Antigo.
(177) Apro, b. 50, proc. n. n. Chierici di Roverchiara contro Martelli, c. 22r (testimo-nianza di Silvestro q. Domenico dell’Antigo, in data 10.III.1533).
(178) Ibid., c. 112r (emptio di Cristoforo q. Guglielmo Martelli, in data 3.X.1503).(179) Ibid., c. 27r (testimonianza di Domenico q. Giovanni dell’Antigo, in data
10.III.1533).(180) Cfr. A. Ferrarese, Aspetti e problemi economici del diritto di decima, cit., pp.
382-385.(181) S. Zamperetti, La spazio politico in una comunita rurale d’antico regime, cit., pp.
370-371; S. Zamperetti, Lo spiegare e il comprendere. Ipotesi per uno studio socio-istituzio-nale delle comunita rurali d’antico regime. In ‘Annali veneti. Societa, cultura, istituzioni’, I(1984), fasc. 1, p. 90; S. Zamperetti, Aspetti e problemi delle comunita del territorio vicen-
a questo proposito, furono anche le testimonianze rese da alcuni membri dellafamiglia nel corso della citata causa che vide contrapposti i Martelli e la pieve nel1533; l’essere annoverati tra i testes principali di entrambe le parti risentiva certo diuna considerazione nell’elite comunitaria di Roverchiara, a cui si accompagnaval’appellativo di ser che in questi stessi anni inizio a contraddistinguere nella docu-mentazione archivistica i nomi dei Dell’Antigo. Non e quindi per caso che nellevisite pastorali gibertine del primo Cinquecento comparvero tra gli homines loci,spesso in posizioni chiave: nel 1526 il massarius del comune Domenico dell’Antigovenne ad esempio interrogato dagli inviati del vescovo, assieme al figlio Silvestro,sulle condizioni della pieve e del cappellano che la reggeva (182) e lo stesso avvennequalche anno dopo con il figlio Giovanni Domenico q. Domenico nel corso dellavisita personale del Giberti (1530) (183).
A margine della evidente progressione sociale, gli anni ’20 del Cinquecentosegnarono per i Dell’Antigo anche l’affacciarsi di importanti cambiamenti nellescelte gestionali della famiglia, tra cui spiccano soprattutto i segnali di una lentacrisi della fraterna: nel 1523, al momento del rinnovo del livello sottoscritto con iPellegrini alla fine del secolo precedente, la conduzione comune appariva gia incrisi, come si evince dalle precise indicazioni riferite alle divisioni che avevano nelfrattempo interessato i vari rami della famiglia (tabella n. 10). Il ruolo aggregatoredella fraterna aveva progressivamente lasciato spazio alle individualita dei singolicontraenti, che subentrarono nell’eredita di specifiche porzioni di un dominio utilefino ad allora tenuto assieme dalla forza della copula. E anche in questo caso,occorre ripeterlo, non si tratta certo di un fenomeno nuovo per la pianura vero-nese, quanto piuttosto di una conferma a tendenze note (184), scandite dai ritmi diuna congiuntura cinquecentesca complessa e difficile per il mondo rurale, i cuicontraccolpi vennero ad interessare anche le strutture stesse delle famiglie che nelcorso del secolo modificarono profondamente i tratti pregressi, caratterizzati an-cora da nuclei compatti – raggruppati emblematicamente attorno alle famiglieallargate di fratelli o di cugini – per lasciare il posto a famiglie piu ‘semplici’ diun solo nucleo. Le evidenti ripercussioni economiche di tale fenomeno trovaronoriscontro nella parallela disaggregazione di quei patrimoni comuni, che tra il Quat-tro- e il primo Cinquecento avevano costituito un elemento di notevole incidenzanelle comunita della pianura veronese: nel caso dei Dell’Antigo, l’abbandono dellafraterna non diede pero luogo a particolari rivolgimenti negli assetti patrimonialidella famiglia che rimasero abbastanza stabili per buona parte del secolo, anche senel contempo alcuni rami parvero muoversi in condizioni piu favorevoli, concen-trando lentamente nelle loro mani il patrimonio di quelli invece piu deboli edesposti.
SAGGI146
tino durante il XVI secolo nell’ambito dei rapporti citta-contado nello stato regionale veneto.In: Lisiera, cit., v. I, pp. 519-528.
(182) Riforma pretridentina della diocesi di Verona, cit., v. I, p. 120.(183) Ibid., v. II, p. 805.(184) P. Mometto, L’azienda agricola Barbarigo a Carpi, cit., pp. 114-116.
147
Tabella 10 - Beni livellari della famiglia dell’Antigo a Roverchiara (1523).Fonte: Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delle Vergini, proc. n. 15, cc. 1r-7v.
Tipologia dei terreni Estensione in C. Possessore
Arativo «olim cum salgariis et vineis» 6 Giovanni Domenico q. Zeno
Arativo «olim cum salgariis» 1,5 Domenico e Antonio q. Giovanni
Arativo «cum salicibus [...] cum duabusdomibus paleatis et una domo a muro
et una columbaria super pillastris»2,5 Silvestro q. Domenico
Arativo «olim cum duabus domibuspaleatis et cum vineis»
2,5Pietro Antonio q. Santo (in parte) e Simone
q. Manfredo de Melchioribus (in parte)
Arativo vitato 2 Domenico q. Santo
Arativo vitato 2 Andrea q. Zeno
Arativo prativo «cum salgariis» 7Domenico e Antonio q. Giovanni (in parte)e Giovanni Domenico q. Zeno (in parte)
Prativo 1 Domenico q. Santo
– 2,5 Andrea q. Zeno
Totale C. 27
Totale Ha. 8,10
Come per il recente passato, gli affitti, soprattutto dagli enti ecclesiasticipresenti a Roverchiara – plausibilmente in ragione della maggiore flessibilita e dellemaglie contrattuali forse piu larghe che distinguevano la gestione del patrimonioecclesiastico – continuarono ancora ad interessare la terza generazione della fami-glia. Particolarmente attivo si dimostro il ramo discendente da Giovanni: nel 1536,Antonio q. Giovanni aveva in affitto i fondi di Roverchiara appartenenti all’epi-scopio veronese (tabella n. 11), mentre il fratello Domenico q. Giovanni nel 1533risultava affictualis del capitolo della cattedrale di Verona. La scelta delle terre diproprieta della mensa vescovile era probabilmente legata alla contiguita con lepezze di terra di cui la seconda generazione della famiglia era stata investita nel1472 (e poi ancora nel 1523), in un tentativo di strutturazione fondiaria che,seppur basata su frammenti di dominio utile, poteva indubbiamente avere un pesodeterminante secondo quelli che erano i parametri di riferimento della proprietadistrettuale. Tra i confini delle terre dell’episcopato compaiono anche i nomi dialtri cugini, tra cui Pietro Antonio q. Santo, Andrea q. Zeno e ancora quel Do-menico q. Giovanni di cui abbiamo appena dato conto: i loro eredi, nella secondameta del Cinquecento, riuscirono a recuperare il dominio diretto di alcuni di queiterreni, affrancando parte del livello acceso dalla prepositura di S. Maria dellaGiara (subentrata ai Pellegrini per ragioni dotali) attraverso alcune permute, «se-guite col mezo di assegno di tanta parte di terreno» (185). Si trattava certo di piccolequantita di affitto – 7 quarte e S. 2 nel dicembre 1559, altre 6 quarte e S. 2 nelgennaio 1560 da parte di Giovanni Andrea Dell’Antigo, 2 minali da parte di Zenoe fratelli sempre nel gennaio 1560, una affrancazione per 1 quarta nel dicembre1570 da parte di Fiore q. Santo Dell’Antigo – che comunque denotano ancora una
UNA «ECONOMIA D’ACQUA» NELLA TERRAFERMA VENETA
(185) Asvr, Monasteri femminili della citta, S. Maria delle Vergini, proc. n. 13, c. 50r.
Tabella 11 - Locazione della proprieta fondiaria della mensa vescovile di Verona ad Antonio dell’Antigo (1536).Fonte: Asvr, Mensa vescovile, reg. 15, c. 271r.
Tipologia dei terreni Ubicazione dei terreni Estensione
Arativo RF 2
Arativo RF 2
Arativo vitato RF 6
Arativo vitato-prativo RF 24
Totale C. 34
Totale Ha. 10,20
certa tenuta economica e ‘politica’ – Domenico q. Antonio e tra i consiliarii chia-mati a redigere il ‘campion delle strade’ nel 1589, come incaricato dugaliorum (186)– dei rami ‘forti’ della famiglia, entro un contesto rurale da cui emergevano segnalidi tutt’altro genere.
SAGGI148
(186) Apro, Stampa della pieve di Roverchiara al laudo, s. l., s. d., p. 13 (copia del ‘cam-pion delle strade’ di Roverchiara di Fonzane, in data 25.IV.1589).
![Page 1: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: [2007] A. FERRARESE, Una ‘economia d’acqua’ nella Terraferma veneta. Proprietà fondiaria, forme di conduzione ed episodi di bonifica a Roverchiara tra ’400 e ’500. In ‘Studi](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aec8c32ab5e46f0c8758/html5/thumbnails/42.jpg)





![[2002] A. FERRARESE, La popolazione di Soave in età moderna. Strutture familiari, evoluzione demografica, congiunture. In: Soave ‘terra amenissima, villa suavissima’; a cura di](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313aecfb033aaa8b2103155/2002-a-ferrarese-la-popolazione-di-soave-in-eta-moderna-strutture-familiari.jpg)



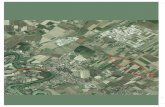
![[2000] A. FERRARESE, L’evoluzione demografica di una comunità veneta in età moderna. Cerea tra XVI e XIX secolo [ISBN 978-88-87082-72-2]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313ad945cba183dbf0734d8/2000-a-ferrarese-levoluzione-demografica-di-una-comunita-veneta-in-eta.jpg)
![[2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313aecbc32ab5e46f0c8759/2004-a-ferrarese-quia-ubi-non-est-ordo-ibi-est-confusio-gian-matteo-giberti.jpg)


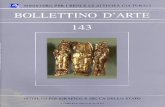

![Un'esperienza etimologica veneta. Per la storia di 'mona', Padova, Esedra, 2011 [pp. 116]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63141b0cfc260b71020f6789/unesperienza-etimologica-veneta-per-la-storia-di-mona-padova-esedra-2011.jpg)

![PRELOŽNIK A., GUŠTIN M.: Cinturoni da parata: esempi di contatti tra l’area veneta e la Dolenjska nell’età del ferro. - Archeologia Veneta 35, 2012 [2013], s./p. 118-127.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63161c373ed465f0570be358/preloznik-a-gustin-m-cinturoni-da-parata-esempi-di-contatti-tra-larea.jpg)
![[2004] A. FERRARESE, Il ‘Ricovero’. Un secolo di assistenza nella storia della ‘Casa De Battisti’ di Cerea [ISBN 978-88-96930-20-5]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313adb7b033aaa8b21030f0/2004-a-ferrarese-il-ricovero-un-secolo-di-assistenza-nella-storia-della.jpg)

