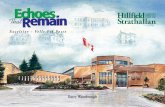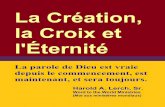[2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la...
Benché di recente e da più parti sia stata sottolineata l’imprescindibile im-portanza di una conoscenza maggiormente approfondita della «amministrazio-ne economica delle curie vescovili, su cui sappiamo ancora molto poco»1, lapossibilità di tracciare un quadro di riferimento di ampio «respiro» rimanepurtroppo ancora di là da venire, quanto legata a contributi che affrontano talenodale problema solo a margine di più ampie indagini sulle vicende delle dio-cesi della penisola pre- e post-tridentine. In altri termini – come scriveva Pro-speri qualche anno addietro – del vescovo quattro e cinquecentesco non cono-
«QUIA UBI NON EST ORDO, IBI EST CONFUSIO».GIAN MATTEO GIBERTI E LA RISTRUTTURAZIONE
DELLA PROPRIETÀ ECCLESIASTICA NELLA DIOCESI DI VERONA(1524-1543)
di Andrea Ferrarese
Società e storia n. 103, 2004
Abbreviazioni: ASVr (Archivio di Stato di Verona); ASCVVr (Archivio storico dellaCuria vescovile di Verona); BCVr (Biblioteca Civica di Verona); MV (Fondo Mensa ve-scovile in ASCVVr); BCAVr (Biblioteca Capitolare di Verona); CV (Fondo Cancelleriavescovile in ASCVVr); VP I-III (Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pa-storali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, Vicenza 1989); GO (Jo.Matthaei Giberti Episcopi Veronensis Ecclesiasticae Disciplinae ante Tridentinam Syno-dum instauratoris Opera, Ostiglia 1740); CO (Le Costituzioni per il clero (1542) di GianMatteo Giberti, vescovo di Verona, a cura di R. Pasquali, Vicenza 2000). L’autore ringraziaG. Borelli, M. Knapton, A. Prosperi, E. Stumpo e G.M. Varanini che con estrema cortesiahanno accettato di leggere il dattiloscritto di questo contributo.
1. C. Donati, Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell’etàmoderna: percorsi di ricerca, in Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d’Eu-ropa: XV-XVIII secolo, a cura di C. Nubola e A. Turchini, Bologna, 1999, p. 228. Per l’areaveneta un recente contributo in questo senso è stato dato da G. Silvano, Appunti sulla men-sa vescovile di Padova al tempo di Gregorio Barbarigo, in Gregorio Barbarigo patrizio ve-neto, vescovo e cardinale nella tarda controriforma (1625-1697), a cura di L. Billanovich eP. Gios, v. I, Padova, 1999, p. 797-814; come pure A. Masetti Zannini, L’archivio dellamensa vescovile di Brescia fonte per la storia dell’agricoltura bresciana nel tempo dellaRepubblica veneta, in Atti del convegno su Camillo Tarello e la storia dell’agricoltura bre-sciana al tempo della Repubblica veneta, Brescia, 1980, p. 111-115; mentre per il veronese,prescindendo da alcune frammentate informazioni desumibili dai saggi che verremo di se-guito citando, l’unico studio a cui si rinvia è quello di R. Scola Gagliardi, La mensa vesco-vile di Verona con particolare riferimento al territorio di Bovolone dal XV al XVIII secolo,Verona, 1987.
‘Società e storia’, 103 (2004), pp. 1-50 [ISSN 0391-6987]
sciamo «le sue disponibilità finanziarie e il suo modo di gestire i propri beni»2
se non in modo molto approssimativo. Se si escludono infatti le magistrali ecapillari indagini di Prodi in merito alla organizzazione diocesana bolognesedurante l’episcopato del Paleotti – comprensive di una dettagliata ricostruzionedei compiti, dei ruoli e dei funzionari legati alla gestione amministrativa dellamensa episcopale – solo per qualche altra diocesi è stata tentata una sintesi ba-sata su analoghi criteri, come pure su di una loro più approfondita contestua-lizzazione3.
Non va poi dimenticato che nell’arco cronologico appena delimitato, il pro-blema della amministrazione economica del patrimonio vescovile, unitamenteai suoi «riflessi» più o meno ampi sulla proprietà ecclesiastica della diocesi,può essere agevolmente posto in relazione con una serie alquanto ampia diquestioni correlate: tra queste, a nostro giudizio, le due che forse ne intreccia-no maggiormente le vicende riguardano, da un lato, i presuli più direttamentecoinvolti nella lenta riaffermazione dell’autorità vescovile a partire dal bassomedioevo, dall’altro i molti episodi che stanno a testimonianza di quel pro-gressivo consolidamento della proprietà ecclesiastica, spintosi ben oltre i tem-pi del Concilio di Trento. Per il periodo pre-tridentino, non mancano infatti letestimonianze sulla «debolezza dell’autorità del vescovo»4 – a conferma di unadiffusa e «perdurante incapacità dell’istituzione vescovile di porsi come veraautorità di governo della diocesi, come elemento centrale della sua vita eccle-siastica e pastorale»5 –, come pure gli innumerevoli esempi di quella progres-siva «reazione» in cui si sono voluti spesso cogliere alcuni dei riflessi precorri-tori di quanto avvenne in seguito. Del pari, entro un contesto alquanto frasta-gliato e disomogeneo, percorso da latenti germi di riforma quanto «appesanti-to» il più delle volte da inveterate pratiche di abbandono e trascuratezza delleres ecclesiae, le puntuali sintesi di Stumpo hanno invece evidenziato comegrazie ad un «vero e proprio rinnovamento dei criteri di gestione e di condu-zione dei beni fondiari»6, il patrimonio regolare e secolare si sia giovato, nellostesso torno di tempo, di verificati e puntuali rafforzamenti: «dopo Trento … sisuccedono le iniziative tese a reintegrare i beni usurpati, a riscattare i censipassivi, a incrementare le entrate»7.
2 A. Ferrarese
2. A. Prosperi, La figura del vescovo fra quattro e cinquecento: persistenze, disagi e no-vità, in Storia d’Italia, Annali 9, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età con-temporanea, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino, 1986, p. 257.
3. Si citano ad esempio i lavori di D. Zardin, La struttura della curia arcivescovile altempo di Carlo Borromeo, in «Studia borromaica», VIII, 1994, p. 123-152 e D. Zardin, Tracontinuità delle strutture e nuovi ideali di «riforma»: la riorganizzazione borromaica dellaCuria arcivescovile, in Lombardia borromaica, Lombardia spagnola 1554-1659, a cura diP. Pissavino e G. Signorotto, Roma, 1995, p. 695-764.
4. G. Chittolini, Note sui benefici rurali nell’Italia padana alla fine del Medioevo, inPievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV), Roma, 1984, v. I, p. 435.
5. Ibid., p. 436.6. E. Stumpo, Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell’età della
Controriforma, in Storia d’Italia, Annali 9, cit., p. 274.7. Ibid., p. 286. Cfr. in merito anche E. Stumpo, Problema di ricerca: per la storia del-
A loro volta, i corollari di entrambe le questioni a cui abbiamo appena accen-nato sarebbero esemplificabili attraverso una fitta serie di episodi; i dati desumi-bili dal contesto delle visite pastorali quattro e cinquecentesche, come pure le nu-merose elaborazioni del pensiero ecclesiologico nello stesso arco di tempo8, po-trebbero confermare appieno, pur nella loro frammentazione, le tendenze a cuiabbiamo fatto cenno. Se da un lato l’interesse della trattatistica ecclesiastica pre-tridentina in merito alla «questione dell’amministrazione dei beni diocesani edella loro destinazione come parte della ‘episcopalis gubernatio’»9 si mosse am-piamente nel solco della corretta destinazione morale dei redditi, senza spingersifino alla redazione di regole «pratiche» per la corretta gestione del patrimonio ec-clesiastico, dall’altro l’approfondito contatto con la realtà delle diocesi, attraver-so la mediazione visitale, non mancò di spunti, di interventi, di norme, atti a di-sciplinare, forse ancora in modo approssimativo ma nondimeno spesso efficace,la corretta amministrazione dei bona. Abbiamo già accennato al fatto che i casestudies da addurre sarebbero molti, mentre disparati e disomogenei sarebbero imodelli di riferimento; come non citare, ad esempio, il questionario visitale inter-diocesano elaborato da S. Antonino e i suoi frequenti rimandi alla puntuale veri-fica degli assetti gestionali del patrimonio ecclesiastico10, come pure le innume-revoli attestazioni delle precise ricognizioni episcopali delle dotazioni economi-che dei benefici curati che ricorrono con una frequenza, in alcuni casi sorpren-dente, in molti interventi vescovili pre-tridentini11. Al riguardo, due casi regiona-li ben documentati, come quello relativo alla Romagna12 e al Veneto tre-quattro-centeschi (e la scelta, lo ribadiamo, non è la sola possibile), sono oltremodo ric-chi di testimonianze dei concreti interventi dei presuli, legati alla «preoccupazio-ne di assicurare il buon andamento economico delle chiese visitate»13 (istituzione
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 3
la crisi della proprietà ecclesiastica fra quattrocento e cinquecento, in «Critica storica»,XIII, 1976, fasc. 1, p. 62-80.
8. M. Fois, Vescovo e chiesa locale nel pensiero ecclesiologico, in Vescovi e diocesi inItalia dal XIV alla metà del XVI secolo, a cura di G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Tro-lese, G.M. Varanini, Roma, 1990, v. I, p. 68.
9. Ibid., p. 70.10. M. Miele, Concili provinciali e rapporti interdiocesani tra quattrocento e cinque-
cento, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, cit., v. I, p. 288.11. A. Turchini, Vescovi e governo delle diocesi in Romagna dal trecento al primo cin-
quecento, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, cit., v. I, p. 422-423, 424-425, 427; F. Molinari, Visite e sinodi pretridentini a Piacenza, in Problemi di vitareligiosa in Italia nel cinquecento, Padova, 1960, p. 247, 250-251 (usurpazione dei beni ec-clesiastici), 253, 258 (esame dei titoli beneficiali e ingiunzioni contro gli insolventi al tribu-to decimale), 260 (obbligo alla redazione dell’inventario dei beni), 277, 279.
12. Turchini, Vescovi e governo delle diocesi in Romagna dal trecento al primo cinque-cento, cit., p. 403, 413.
13. G. De Sandre Gasparini, Vescovi e vicari nelle visite pastorali del tre-quattrocentoveneto, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, cit., v. I, p. 579, 580-582; Ead., Governo della diocesi e «cura animarum» nei primi anni di episcopato di Ermo-lao Barbaro vescovo di Verona (1453-1471): prime note, in Il primo dominio veneziano aVerona (1405-1509), Verona, 1991, p. 73-92; M. Cipriani, Per lo studio della visita pasto-rale alla diocesi di Verona (1454-1460): note su alcune fonti integrative, in Visite pastora-
dei massari14, confezione e aggiornamento degli inventari15, censimento dei cre-diti, dei legati e dei testamenti16, accertamento di eventuali usurpi)17. Come nondimenticare, poi, accanto a tali forme di verifica gestionale ed amministrativa,plausibilmente ancora «spurie» ed episodiche, la progressiva affermazione, nel-l’ambito del personale della curia e della familia episcopale, di quelle specifichefigure che tanta fortuna avranno nella propulsione riformista del secolo seguente,tra cui in primis quella del vicario, uomo «simbolo» della crescente articolazionee mobilitazione dell’ambito curiale18: «il fatto che lo sviluppo nel tardo medioevo di un tipo di vescovo che è, in un certo modo, nuovo, con responsabilità pa-storali realizzate in modo insolitamente ampio e con un nuovo tipo di libertà pa-storale, è saldamente collegato con lo sviluppo di una burocrazia diocesana …organizzata in modo più sofisticato, e che il livello di questo sviluppo è compro-vato dalla presenza della carica di vicario generale»19. Dal caso emblematico del-la diocesi di Ferrara, studiata qualche anno or sono dal Peverada, si è delineata,ad esempio, la importantissima figura del factor episcopale, «il personaggio più
4 A. Ferrarese
li ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, a cura di C. Nubola e A. Turchini, Bolo-gna, 1993, p. 340; P. Gios, L’attività pastorale del vescovo Pietro Barozzi a Padova (1487-1507), Padova, 1977, p. 73; L. Pesce, Ludovico Barbo vescovo di Treviso (1437-1443), Pa-dova, 1969, v. I, p. 56 (situazione della mensa vescovile).
14. De Sandre Gasparini, Vescovi e vicari nelle visite pastorali del tre-quattrocento ve-neto, cit., p. 594: l’autrice parla di una «graduale affermazione dei massari, i quali divengo-no per il visitatore, oltre che economi e amministratori, le principali fonti di informazionesulla condotta di preti e laici». Anche P. Gios, Tra l’Astico e il Brenta. L’azione di discipli-namento dei vicari e dei vescovi padovani (1448-1507), Trento, 1997, p. 20; Id., Il gratico-lato romano nel quattrocento. La visita pastorale di Diotisalvi da Foligno a nord-est di Pa-dova (1454), Padova 1995, p. 31, 54; Id., L’inquisitore della bassa padovana e dei colli eu-ganei 1448-1449, Padova, 1990, p. 49-50; Id., Vita religiosa e sociale a Padova. La visitapastorale di Diotisalvi da Foligno alle parrocchie cittadine (1452-1458), Padova, 1997, p.33; Id., L’attività pastorale del vescovo Pietro Barozzi a Padova, cit., p. 148.
15. Gios, Tra l’Astico e il Brenta, cit., p. 27-28, 44, 54, 84; Id., Il graticolato romanonel quattrocento, cit., p. 22-24, 32, 34; Id., L’inquisitore della bassa padovana, cit., p. 50;Id., Vita religiosa e sociale a Padova, cit., p. 32, 45; Id., L’attività pastorale del vescovoPietro Barozzi a Padova, cit. p. 96, 121, 130, 343 (e nota n. 20); Pesce, Ludovico Barbo ve-scovo di Treviso, cit., v. I, p. 181, 281.
16. Gios, L’inquisitore della bassa padovana, cit., p. 30; Id., Vita religiosa e sociale aPadova, cit., p. 31.
17. Gios, Tra l’Astico e il Brenta, cit., p. 20, 22, 27; Id., Il graticolato romano nel quat-trocento, cit., p. 53-54.
18. Turchini, Vescovi e governo delle diocesi in Romagna dal trecento al primo cinque-cento, cit., p. 420; Gios, L’attività pastorale del vescovo Pietro Barozzi a Padova, cit., p.74.
19. R. Brentano, Vescovi e vicari generali nel basso medioevo, in Vescovi e diocesi inItalia dal XIV alla metà del XVI secolo, cit., v. I, p. 555. Sulla figura vicariale v. anche i re-centi contributi di B. Mariani, L’attività della curia arcivescovile milanese e l’amministra-zione diocesana attraverso l’operato del vicario generale Romano Barni (1474-1477), in«Società e storia», 54, 1991, p. 769-811 e di M.C. Ferrari, Il vicario arcivescovile GiovanBattista Ferri e la curia milanese alla fine del quattrocento, in «Nuova rivista storica»,LXXX, 1996, fasc. II, p. 339-364.
ragguardevole nella cerchia laica della casa del vescovo, con ampi – se non pro-prio assoluti – poteri in ordine alla amministrazione patrimoniale»20, coadiuvatoin una sorta di rapporto simbiotico dai notai della curia, sui cui compiti e sullacui affermazione nello stesso tempo, sono stati fatti recenti sondaggi21: «al notaiosotto la supervisione del vicario, tocca stendere, registrare, autenticare, dispensa-re, ingiungere, formulare, compiere tutti gli atti che permettono l’ordinata condu-zione della diocesi, a prescindere dal numero e dalla natura dei benefici, dal mec-canismo della provvista, dalla fisionomia dei titolari. Al notaio, mero esecutore,spetta utilizzare la formula e la forma giusta per fornire validità ad un atto decisoaltrove; la sua figura svolge un ruolo di filtro istituzionale importantissimo, conun profilo ed una configurazione nettamente delineati»22.
Sulla scorta delle linee di tendenza a cui abbiamo velocemente fatto appe-na riferimento, questo breve contributo si propone di sondare e tracciare preli-minarmente un quadro d’insieme della organizzazione amministrativa delladiocesi di Verona, posta in essere negli anni dell’episcopato di Gian MatteoGiberti; occorrerà fin da subito, in un certo senso, porre le mani «avanti» inmerito al delicato problema della documentazione. A prescindere infatti dal-l’eccezionale corpus visitale gibertino, la situazione degli atti della cancelleriaepiscopale, quanto soprattutto quella della mensa (suddivisa a sua volta in tredistinte «fattorie», corrispondenti alla dislocazione dei possedimenti dell’epi-scopato) è apparsa, dove non compromessa del tutto, ampiamente lacunosa.Per quanto riguarda il patrimonio infeudato, i volumi delle investiture sono leuniche testimonianze, ancorché fondamentali, superstiti; in merito invece alpatrimonio afferente direttamente alla mensa, la incompleta documentazionescampata alle acque dell’Adige (1882), riferibile prevalentemente ai due gros-si feudi di Bovolone e di Monteforte, permette nondimeno di seguire a grandilinee, per i quasi due decenni di governo diocesano del presule, le scelte ge-stionali, gli uomini preposti al controllo, come pure gli sprazzi di una continuaemanazione normativa ad hoc. E d’altra parte, il problema delle regole costi-tuisce senza ombra di dubbio una delle caratteristiche univoche dell’opera gi-bertina: la gestione del patrimonio ecclesiastico, da quello della mensa finoalle marginali rationes dei piccoli e sperduti ospedali della diocesi, si giovò di
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 5
20. E. Peverada, La «famiglia» del vescovo e la curia a Ferrara nel sec. XV, in Vesco-vi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, cit., v. II, p. 619, 621. Su tale figuracfr. anche Pesce, Ludovico Barbo vescovo di Treviso, cit., v. I, p. 98, 112.
21. Si rinvia a G. Chittolini, «Episcopalis curiae notarius». Cenni sui notai di curie ve-scovili nell’Italia centro-settentrionale alla fine del medioevo, in Società, istituzioni e spiri-tualità. Studi in onore di Cinzio Violante, Spoleto, 1994, p. 221-232; M. Lunari, «De man-dato domini archiepiscopi in hanc publicam formam redigi, tradidi et scripsi». Notai di cu-ria e organizzazione notarile nella diocesi di Milano (sec. XV), in «Rivista di storia dellaChiesa in Italia», XLIX, 1995, fasc. 2, p. 486-508; mentre recentemente per l’area veronesev. M.C. Rossi, I notai di curia e la nascita di una «burocrazia» vescovile: il caso veronese,in «Società e storia», 95, 2002, p. 1-33.
22. Turchini, Vescovi e governo delle diocesi in Romagna dal trecento al primo cinque-cento, cit., p. 422.
una incessante promulgazione, seppure affidata il più delle volte ad una seriealquanto molteplice di «strumenti» (editti della cancelleria episcopale, decretie ordinata visitali, costituzioni sinodali). Il poter rintracciare in tale mare ma-gnum normativo – come giustamente proponeva Prosperi – «in che misural’attività episcopale di Giberti a Verona si limita a eliminare abusi da un orga-nismo la cui struttura è lasciata intatta e in che misura invece si riesce a trova-re nella sua azione le linee di un programma personale di riforma»23, significa,in parte, dover fare i conti con il dibattuto problema della «fortuna» gibertinain periodo conciliare24. Già gli eruditi settecenteschi Ballerini, autori di una trale prime biografie «esemplari» del Giberti, non avevano mancato di sottolinea-re ampiamente, nella ricostruzione degli anni veronesi, l’insieme degli inter-venti di regolamentazione della proprietà ecclesiastica diocesana, ponendoli inrelazione con note «tesi», più volte ribadite dal pensiero ecclesiologico pre-tri-dentino e con la successiva esperienza borromaica: «tandem ecclesiasticos red-ditus recte a parochis administrari voluit. Cur ergo illos bonorum ecclesiae nondominos sed procuratores esse crederet, ut omnes patres uno ore affirmant; illanon in suprefluis ac vanis sumtibus, in conviviis, in deliciis consumenda cen-suit. Honestam quidem sustentationem primum inde parochos sumere aequumduxit: si quid autem superesset, in haec conferri voluit»25.
A prescindere, comunque, dagli evidenti limiti di tale approccio «apologe-tico», rimane indubbio che il «modello» veronese (nel complesso o in partedei suoi diversificati corollari) costituì a lungo una sorta di «parametro» di ri-ferimento, quantunque pure difficilmente esportabile, in ragione direttamenteproporzionale all’eccezionale potere di cui il presule genovese si trovò investi-to26. Consideriamo, ad esempio, il noto e documentato caso dell’episcopatobolognese studiato da Prodi: la gestione del patrimonio episcopale e il control-lo amministrativo sulle res ecclesiae della diocesi venne dispiegata con lacreazione di una struttura piramidale e con la istituzione di un corpo di «uffi-ciali» preposto, di cui non sfuggono, ancorché approssimativamente, gli echi ele particolarità dell’esperienza veronese di cui diremo a breve, senza comun-
6 A. Ferrarese
23. A. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma. G.M. Giberti (1495-1543), Roma,1969, p. XXIII.
24. G.-G. Meersseman, Il tipo ideale di parroco secondo la riforma tridentina nelle suefonti letterarie, in Il concilio di Trento e la riforma tridentina, Roma, 1965, v. I, p. 41; an-che H. Jedin Il tipo ideale di vescovo secondo la riforma cattolica, Brescia, 1958, p. 36-37.Una importante disamina sulle tendenze della «fortuna» gibertina si ha in A. Prosperi, Notein margine a un opuscolo di Gian Matteo Giberti, in «Critica storica», IV, 1965, fasc. III, p.374 come nel più recente Id., Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari,Torino, 1996, p. 302; Id., Le Costituzioni tra evangelismo e controriforma, in CO, p. XXVe A. Turchini, Giberti, Gian Matteo, in Dizionario Biografico degli Italiani, v. LIV, Roma,2000, p. 623-629.
25. De restituta ante tridentinam synodum per Jo. Matthaeum Gibertum episcopum ve-ronensem ecclesiastica disciplina dissertatio, in GO, p. LXXXIV.
26. Prosperi, La figura del vescovo fra quattro e cinquecento, cit., p. 233-234; Id., Traevangelismo e controriforma, cit., p. XVIII, 133, 141, 151.
que sottovalutare il fatto che, per alcuni aspetti, le visite pastorali gibertine co-stituirono «lo sviluppo massimo di tendenze disegnate»27 ampiamente nel se-colo precedente. A Bologna ogni compito risultava conseguentemente stabilitocon estrema precisione28: al vescovo29 (revoca dei sequestri), al vicario genera-le30 (materia beneficiale in genere), al vescovo suffraganeo31 (controllo deiconti dei monti di pietà, degli ospedali e delle confraternite della città), all’au-ditore generale32 (cause della mensa vescovile e controllo dei frutti dei benefi-ci vacanti), al vicario delle monache33 (controllo di beni, inventari e rendite deimonasteri), al provvisore ai legati pii34, al sotto auditore35 (controllo sulla ge-stione della mensa vescovile), al sindico della mensa vescovile36 (la discussio-ne delle cause inerenti la mensa, il controllo delle locazioni). La conduzione«diretta» della mensa era invece affidata a quattro economi37 (ai quali era de-mandato il controllo di tutte le entrate e la situazione patrimoniale della stessa,la redazione delle investiture e delle locazioni, il mantenimento della familia,la gestione del patrimonio fondiario38, la cura dell’archivio39). E volendo poiallargare l’orizzonte preso in considerazione ad altre diocesi dell’area setten-trionale della penisola, nell’ambito dei decenni immediatamente successivi al
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 7
27. De Sandre Gasparini, Vescovi e vicari nelle visite pastorali del tre-quattrocento ve-neto, cit., p. 598. Più recentemente sulle visitationes gibertine si vedano gli atti del Semina-rio sulle visite pastorali del vescovo G.M. Giberti (1525-1542), in «Ricerche di storia so-ciale e religiosa», XX, 39, 1991, p. 171-195.
28. P. Prodi, Lineamenti dell’organizzazione diocesana in Bologna durante l’episcopa-to del cardinale G. Paleotti (1566-1597), in Problemi di vita religiosa in Italia nel cinque-cento, cit., p. 335-336, 338-340, 377-384; come pure Id., Il cardinale Gabriele Paleotti(1522-1597), v. II, Roma, 1967, p. 269-322.
29. Prodi, Lineamenti dell’organizzazione diocesana in Bologna, cit., p. 386.30. Ibid., p. 377. Assai più ampie erano invece le attribuzioni in materia di amministra-
zione delle res ecclesiae che il cardinale Gasparo Contarini attribuì al proprio vicario Giro-lamo Negri nel decreto di nomina (settembre 1538), cfr. quindi V. De Boni, Il cardinaleGasparo Contarini vescovo di Belluno (1536-1542), in «Rivista di storia della Chiesa inItalia», LI, 1997, fasc. II, p. 483-484: al vicario episcopale competevano i rinnovi delle in-vestiture («obediaentiae ac alia consueta iuramenta ac servitia») e delle nuove infeudazioni(«de bonis pheudalibus eiusdem ecclesie de iure et consuetudine quoscumque inpheudarisolitos inpheudandi»), le «concessiones in emphyteosim» ai livellari dell’episcopio e i ri-spettivi rinnovi, come pure le «permutationes» dei bona ecclesiae.
31. Prodi, Lineamenti dell’organizzazione diocesana in Bologna, cit., p. 378.32. Ibid., p. 379.33. Ibid., p. 381.34. Ibid., p. 384.35. Ibid., p. 384.36. Ibid., p. 385.37. Ibid., p. 386-387.38. Ibid., p. 390-391.39. Ibid., p. 392. Alcuni aspetti del rafforzamento post-tridentino dell’archivio episco-
pale sono analizzati da A. Turchini, La visita come strumento di governo del territorio, in Ilconcilio di Trento e il moderno, a cura di P. Prodi e W. Reinhard, Bologna, 1996, p. 353-354.
Concilio, gli esempi da addurre non sarebbero pochi: i casi di Trento40, di Ri-mini41, di Padova42, di Imola43, di Brescia44 e di Milano45 stanno a testimo-nianza della diffusione, «mediata» nella maggior parte dei casi attraverso l’al-trettanto eccezionale esperienza borromaica e paleottiana46 (che si giovò ripe-tutamente – occorre ribadirlo – dell’eredità e degli «uomini» del Giberti)47, ditendenze gestionali ed amministrative ampiamente consolidate quanto organi-camente già costituite nel progetto veronese.
1. La mensa vescovile
Per affrontare in modo lineare la lenta strutturazione degli interventi giber-tini in merito alla proprietà ecclesiastica della diocesi e della mensa vescovile,
8 A. Ferrarese
40. I. Rogger, Il governo spirituale della diocesi di Trento sotto i vescovi Cristoforo(1539-1567) e Ludovico Madruzzo (1567-1600), in Il concilio di Trento e la riforma triden-tina, cit., v. I, p. 199 (tra le attribuzioni ai decani rurali, comparabili ai vicari foranei, il con-trollo sulla redazione degli inventari, il controllo sull’operato dei sindici delle pievi, la se-gnalazione di eventuali alienazioni patrimoniali effettuate senza il consenso episcopale).Più recentemente gli aspetti del controllo amministrativo della diocesi emergono in C. Nu-bola, Applicazioni informatiche alla visita pastorale del cardinale Ludovico Madruzzo alladiocesi di Trento (1579-1581), in Visite pastorali ed elaborazione dei dati, cit., p. 49-50,52, 58-59; Ead., Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Lu-dovico Madruzzo (1579-1581), Bologna, 1993, p. 117-155, 187-198, 412-413 (casi riserva-ti), 455-511 (organizzazioni laicali).
41. A. Turchini, Clero e fedeli a Rimini in età post-tridentina, Roma, 1978, p. 17 (com-piti di controllo amministrativo affidati ai vicari foranei), 54 (lotta contro gli usurpi del pa-trimonio ecclesiastico), 55 (obbligo di redazione di inventari), 142 (controllo amministrati-vo delle confraternite); 175-178 (questionario visitale del 1574, con diverse indicazioni delcontrollo sulla prassi amministrativa di chiese, benefici, monti di pietà).
42. L. Billanovich, Fra centro e periferia. Vicari foranei e governo diocesano di Gre-gorio Barbarigo vescovo di Padova (1664-1697), Padova, 1993, p. 27, 73 (nota n. 114),141, 146, 174 (nota n. 249: creazione di una commissione economica a cui era affidata lagestione patrimoniale dell’episcopato); L. F. Maschietto, «Ut grex dominicus salubriter re-gatur, conservetur et custodiatur». Visite pastorali degli abati di S. Giustina in Padova alleparrocchie dipendenti (1534-1791), Padova, 1998, p. 138 (ruolo e funzioni dei massari del-le confraternite), 145, 160.
43. M. Marocchi, La visita pastorale di mons. Alessandro Musotti alla diocesi di Imola(1599). Una esperienza di elaborazione dei dati, in Visite pastorali ed elaborazione deidati, cit., p. 148-149, 162.
44. G. Gamba – D. Montanari, Le visite pastorali della diocesi di Brescia nel secolo XVI,in Visite pastorali ed elaborazione dei dati, cit., p. 179, 181, 183, 186, 188, 194, 199-200,202-203, 206-207, 213-214, 217-218, 220, 225, 228-229, 233, 236-237, 240-242, 245-246.
45. G. Coppola, Fisco, finanza e religione: lo Stato di Milano da Carlo a Federigo, inFisco, religione, Stato nell’età confessionale, a cura di H. Kellenbenz e P. Prodi, Bologna,1989, p. 309-310, 337.
46. Cfr. P. Prodi, San Carlo Borromeo e il cardinale Gabriele Paleotti due vescovi del-la riforma cattolica, in «Critica storica», III, 1964, fasc. 2, p. 135-151.
47. A. Prosperi, Di alcuni testi per il clero nell’Italia del primo cinquecento, in «Criticastorica», VII, 1968, fasc. II, p. 152 (con rinvio all’ulteriore bibliografia di Prodi e Cattaneo).
diventa imprescindibile seguire la periodizzazione di riferimento scandita asuo tempo da Prosperi. Dopo la contrastata nomina alla sede veronese, nel tor-no di anni successivo, seguì per il presule genovese un periodo di non residen-za tra l’agosto del 1524 e il febbraio del 152848. Fino agli inizi del 1528 (nelgennaio si portò a Venezia per le ultime formalità49, prima di stabilirsi definiti-vamente nella diocesi)50 l’impegno politico, funestato dai disastrosi eventi del«sacco» di Roma e dalla successiva temporanea prigionia, rallentarono e con-dizionarono la effettiva possibilità di prendere visione della situazione delladiocesi; in questo contesto di spesso difficile gestione, la scelta dei collabora-tori e la costituzione di un primo nucleo della familia ebbero indubbiamenteun’importanza di tutto rilievo. Va da sé che per certi aspetti siamo di fronte adinterventi ed a scelte legati il più delle volte alla contingenza delle circostanze:la aggregazione dei primi familiares veronesi è ben lungi dall’essere la conse-guenza dell’attuazione di un progetto definito e coordinato – «creare una élite,intorno al vescovo, capace di svolgere un’opera complessa, di educazione e diesempio, sul resto del clero»51 – che si dispiegò invece negli anni a venire. Ilcommissario Giovanni Battista Mentebona52 prese formalmente possesso delladiocesi il 17 ottobre del 152453 – «ut suo nomine veronensis episcopatus pos-sessionem iniret, ac ea pararet, quae ad suum adventum opportuna videntur»54
–, seguito entro i primi mesi dell’anno successivo dall’arrivo del vescovo vica-rio Antonio Beccari55, del vicario generale Callisto Amadei56 e del commissa-rio addetto alla gestione dei bona episcopali, il vescovo pisano Giovanni Batti-sta Galetti57. Nel pieno rispetto delle formalità della successione episcopale,uno tra i primi interventi del Mentebona, «commissarius, gubernator, locumte-nens»58, riguardò il rinnovo di tutte le investiture feudali dell’episcopio (edittodel 17 dicembre 1524): ai detentori dei numerosi iura di pertinenza episcopa-le, nella maggior parte dei casi inerenti alla fittissima rete di iura decimationisdell’intera diocesi, veniva richiesto di riconoscere «episcopum prefatum in do-minum et possessorem»59, con l’intimazione di provvedere al pagamento delrelativo teloneo «infra tempus a iure statutum»60. Nel merito di questi primi in-
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 9
48. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 130.49. Ibid., p. 84.50. Ibid., p. 80.51. Ibid., p. 94.52. Ibid., p. 125.53. Ibid., p. 133.54. Joannis Matthaei Giberti episcopi veronensis vita, in GO, p. VIII.55. Sul Beccari cfr. la scheda di A. Fasani, Verona durante l’episcopato di G. M. Gi-
berti, in VP I, p. XCIII.56. Cfr. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 134 e Fasani, Verona du-
rante l’episcopato di G. M. Giberti, cit., p. XCIII.57. A. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 135 e Fasani, Verona durante
l’episcopato di G. M. Giberti, cit., p. XCVIII-XCIX.58. CV, b. 3, fasc. II (1524-1527), c. 5r-v (17 dicembre 1524).59. Ibid., c. 5r-v (17 dicembre 1524).60. Ibid., c. 5r-v (17 dicembre 1524). Sul teloneo, cfr. ad esempio quanto scrive A. Ca-
terventi, la scarsissima documentazione superstite permette comunque di indi-viduare, nel novero delle amplissime competenze affidate dal Giberti ai più di-retti collaboratori, alcune specifiche «aree» di intervento: a prescindere dallemansioni del commissarius generale Mentebona, di cui pare evidente l’azionedi coordinamento degli affari generali della diocesi a diretto contatto con le at-tribuzioni proprie del vicario Amadei, nella gestione amministrativa dellamensa, già dagli ultimi mesi del 1524, iniziarono a delinearsi compiti più pre-cisi. Abbiamo appena sopra accennato al Galetti la cui presenza nella diocesideve essere fatta risalire all’arrivo del Mentebona: in previsione dello svolgi-mento delle operazioni di rinnovo dei feudi episcopali che avevano preso av-vio nel dicembre del 1524, il commissario generale affidò infatti al sacerdotepisano (4 novembre 1525) il controllo delle nuove investiture61.
In rapida successione, dopo la verifica delle proprietà e dei diritti solo for-malmente dipendenti dall’episcopio, fu la volta dell’eterogeneo patrimoniodella mensa vescovile, la cui parte più consistente era riunita nelle possessionidei feudi di Bovolone e di Monteforte, con ulteriori appendici fondiarie a S.Bonifacio, a Pol di Pescantina, a Buttapietra, a Roverchiara e nell’area urba-na62. Le testimonianze di un primo intervento ricognitivo sulla consistenza esulla situazione gestionale della mensa risalgono al 1526: per quanto riguardale competenze specifiche della mensa, la figura e le funzioni del «gubernatorepiscopatus Veronae»63, affidate al decretorum doctor Panfilo Rasmino64, ap-paiono a questa data già ben delineate. Quest’ultimo riscontro permette dun-que di anticipare plausibilmente all’anno precedente la precisa delimitazionedei criteri e dei compiti inerenti all’amministrazione del patrimonio vescovile:se infatti, nello specifico, mancano testimonianze precise al riguardo, pare
10 A. Ferrarese
stagnetti, Aspetti politici, economici, e sociali di chiese e monasteri dall’epoca carolingiaalle soglie dell’età moderna, in Chiese e monasteri a Verona, a cura di G. Borelli, Verona,1980, p. 80. Nel quattrocento il suo valore corrispondeva al 10% del valore del bene ven-duto o infeudato, come si desume ad esempio da una ducale veneta del 16 marzo 1469[BCVr, ms. 946, c. 402]: «toloneum in ratione decem pro centenario exigendum per eccle-siasticos pro bonis sibi obligatis et venditis». Durante l’episcopato del Giberti l’importo delteloneo venne ridotto al 4%, dopo un accordo intervenuto tra l’episcopato e i rappresentan-ti della città di Verona: di tale riduzione ne danno notizia frammentaria due processi [MV93 e MV 909bis] del 1538. Il 2 aprile del 1538 un decreto del factor Matteo Bardolino san-zionò l’entrata in vigore della riduzione («non sabi da scoder se non a rason di quatro procentenario») [MV 909bis, c. n. n.], anche se l’accordo viene fatto risalire al 5 marzo del1535 [Ibid., c. n. n.].
61. CV, b. 3, fasc. II (1524-1527), c. 19v-20r (4 novembre 1525).62. Cfr. per qualche cenno Scola Gagliardi, La mensa vescovile di Verona, cit., p. 39-
44, 143. Per le comunità di Bovolone, Monteforte e S. Lucia di Pol (Pescantina) l’episcopiodeteneva lo ius eligendi del locale vicario, nonché la giurisdizione sulle cause civili e cri-minali, cfr. in merito Comuni, giurisdizioni, e vicariati della provincia veronese, Verona1785, p. XXVI (Bovolone), XLIII (Monteforte), LII (S. Lucia di Pol).
63. MV 47, c. n. n.64. Sul Rasmino cfr. la breve scheda in Fasani, Verona durante l’episcopato di G.M.
Giberti, cit., p. XCIV.
poco plausibile scindere la nomina del commissarius alle investiture da quelladel gubernator della mensa. E pur in presenza di una cronologia di azione trale due cariche non sempre convergente – almeno fino all’arrivo del Giberti,coincidente con una ulteriore razionalizzazione dei compiti e delle figure pre-poste alle proprietà episcopali – nei campi di azione del Galetti e del Rasminosi concentrarono complessivamente le linee di un intervento sommario e rico-gnitivo, atto a sondare il terreno, a verificare situazioni, a salvaguardare il piùdelle volte bona e possessioni dal rischio, tutt’altro che sporadico, di usurpa-zioni.
Tra le proprietà della mensa, il Rasmino – nello stesso torno di tempo im-pegnato anche nella funzione di «commissarius Bodoloni»65 (il feudo più am-pio dell’episcopato, situato nella fertile pianura veronese) – procedette soprat-tutto «renovando locationes veteres et antiquas»66, per lo più locazioni decen-nali67 che però da troppo tempo sfuggivano ad una ricognizione capillare econtinuata. Come abbiamo accennato, l’intervento del gubernator si limitònella grande maggioranza dei casi ad un controllo di massima, ricognitivo ab-biamo detto, affidato in genere al lavoro di un nutrito gruppo di notai: si tra-scrivevano i nomi dei livellari, si controllavano situazioni pregresse, si interve-niva d’urgenza rinnovando locazioni «bloccate» da decenni o infeudando e li-vellando terreni rimasti senza conduttore68. Si tentava, in altri termini, di veri-ficare le corrispondenze tra la documentazione rintracciata nell’archivio dell’e-piscopato, in genere tardo quattrocentesca o al più risalente ai primi anni delCinquecento, e la reale situazione di un patrimonio di cui non si conoscevanofino in fondo la consistenza e la effettiva disponibilità. Non sorprende, di con-seguenza, che il termine di questa prima e veloce verifica del patrimonio epi-scopale coincise, qualche anno dopo, con una serie di minuziose legitimatio-nes (in alcuni casi ripetute più volte a distanza di anni) di ognuna delle fattorieche componevano la mensa.
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 11
65. MV 47, c. n. n. Cfr. anche Scola Gagliardi, La mensa vescovile di Verona, cit., p. 49.66. MV 47, c. n. n.67. Ibid., c. n. n. e MV 54, c. n. n. (locazioni perpetue «singulo decennio renovandae»).
Su tali modalità di affitto dei beni della mensa nello stesso torno di tempo si sofferma ancheScola Gagliardi, La mensa vescovile di Verona, cit., p. 57 passim.
68. Di tale materiale ricognitivo rimangono testimonianze nel frammentario e purtropporovinato fondo della mensa vescovile, cfr. quindi MV 11: descrizione dei livellari di Mon-teforte (1533-1534), atti di notaio locale non identificato; MV 47: investiture livellarie perBovolone (1526-1542); atti dei notai Alessandro q. Matteo ab Agnusdei (1526-1534), Mat-teo Bardolino, fattore generale dell’episcopato (1538-1539: all’inizio delle investiture auto-grafe sono riportati i capitoli che i conduttori erano tenuti a rispettare nella durata della lo-cazione), Paride q. Iotini de Noris (1541) e Nicola q. Alessandro ab Agnusdei (1542); MV48 (copia del registro precedente); MV 51: investiture livellarie per Monteforte e S. Bonifa-cio (relative agli anni trenta del cinquecento); MV 53: investiture livellarie per Monteforte(1538), atti del notaio Matteo q. Pietro Bardolino, factor generale dell’episcopio, trascrittiin copia dal figlio Bonifacio; MV 54 (copia del registro precedente); MV 98: poche legitti-mazioni livellarie per Monteforte eseguite dal gubernator Panfilo Rasmino nel 1526, il no-taio redattore è Giovanni Battista q. Matteo de Notariis.
Prima però di affrontare tali nodali iniziative, occorrerà accennare breve-mente agli importanti cambiamenti nelle cariche afferenti alla mensa che,come abbiamo detto, coincisero con la stabile presenza del Giberti nella dioce-si; tra il 1528 e il 1529 venne ultimata quella che abbiamo definito come «fasericognitiva», sia nell’ambito della proprietà episcopale, sia in quello delle visi-te vicariali, effettuate a più riprese nella diocesi fino a questa data. In relazionealla gestione amministrativa della mensa, il momento sicuramente più signifi-cativo in questo torno di tempo coincise con la comparsa nella familia giberti-na (o con la definitiva strutturazione, se consideriamo anche le pregresse com-petenze affidate al gubernator) del factor generale dell’episcopato. Nella figu-ra del factor si fusero le mansioni che provvisoriamente negli anni precedentierano state affidate al Galetti e al Rasmino: al factor venne infatti affidata l’in-tera gestione del patrimonio della mensa, il controllo delle investiture e deiloro rinnovi ancora in corso69, l’azione diretta nella amministrazione dei feudi,come pure la tutela e la preservazione dell’importante documentazione dell’ar-chivio episcopale. La delicatezza degli incarichi, quanto soprattutto la indub-bia specializzazione delle competenze ne giustificarono la coincidenza con l’e-sercizio della professione notarile; investito formalmente dell’incarico nel set-tembre del 1531, il primo factor generale Matteo q. Petri notarii de Bardoli-nis70 pur continuando nell’azione di ricognizione patrimoniale abbozzata eportata avanti dai predecessori, impresse negli anni immediatamente seguentiuna svolta importante nei criteri di gestione della mensa, culminata nella reda-zione di nuove legitimationes per i grandi feudi di Bovolone e Monteforte e
12 A. Ferrarese
69. Il materiale relativo ai rinnovi si trova in ASVr, Mensa vescovile, reg. 15, 16, 17.Nel registro n. 15 le investiture vennero rogate dal notaio Bartolomeo de Novaleis e com-prendono atti dal 1526 al 1528; i rinnovi furono effettuati davanti all’arcivescovo pisanoGaletti «commissarius et locumtenens generalis cum plena et libera facultate» [Ibid., Men-sa vescovile, reg. 15, c. 3r], di cui viene pure ricordato il «mandatum amplissimum» [Ibid.,c. 45v] e la «facultate amplissima» [Ibid., c. 64r] a lui delegata dal presule. Nello stessovolume è anche contenuta una legitimatio per le terre di Bovolone del maggio 1533 ese-guita alla presenza di Matteo Bardolino che agisce in loco di Panfilo Rasmino: l’atto inquestione è rogato dal notaio Alessandro ab Agnusdei [Ibid., c. 306r-314r]. Nel registro n.16 gli atti di investitura si riferiscono al periodo 1528-1540: alcuni rinnovi del 1529 sonorogati alla diretta presenza del presule, come pure (nella maggior parte) del noto Galetti odi Matteo Bardolino (di cui viene ricordato l’editto di nomina del 19 dicembre 1531); inaltri atti compare invece Francesco Mazzanti, arciprete della chiesa veronese (su conces-sione del factor Matteo Bardolino). Infine, il registro n. 17 contiene le prime investituredel biennio 1525-1526, eseguite alla presenza del commissarius Mentebona o di PanfiloRasmino, ma anche del Galetti (a cui si riferiscono, anche in questo caso, la maggioranzadegli atti).
70. MV 53, c. n. n. (atti del cancelliere episcopale Ludovico Camisani, 19 settembre1531). A lui successe (non è dato conoscere quando) Giovanni Pietro Armarolo, ancora incarica nel 1542 [MV 47, c. n. n. (investiture di Nicola q. Alessandro ab Agnusdei]; nellostesso anno la documentazione della mensa vescovile segnala nella carica di «factor et je-conomus» Francesco Magno [MV 882, c. n. n.], rendendo comunque difficile ipotizzare unasostituzione dell’Armarolo o un avvenuto «sdoppiamento» nelle cariche.
nel conseguente rinnovo delle locazioni perpetuali in ragione delle catastica-zioni appena ultimate71.
Il primo intervento venne stabilito e successivamente attuato a Montefortenel maggio del 153772: alla presenza del «discreto iuvene» Bonifacio, notaio,figlio di Matteo Bardolino e dello stesso «factor generalis» dell’episcopato –«exequendo mandata» del Giberti, «volens et intendens procedere ad legitima-tionem affictualium omnium generis, et condictionis cuiuscumque tam carigio-rum quam frumenti, denariorum, et aliarum rerum qui respondentur et solvun-tur in dicta villa Montisfortis»73 e nella vicina villa di S. Bonifacio – venne ra-dunata la vicinia delle due comunità per la designazione degli esperti «legiti-matores qui habeant legitimare, iustificare, et verificare affictuales predictosiuxta continentiam et modum librorum antiquorum et modernorum»74.
Le operazioni di catasticazione presero le mosse dal materiale che era statorintracciato nell’archivio vescovile, in particolare i redattori si avvalsero di duecatastici coevi del 1488 e del 1500: sulla base di tali indicazioni, i legitimato-res tentarono con estrema fatica di ricostruire, oltre alle caratteristiche preci-pue dei vari terreni, i nominativi dei vecchi livellari, come pure i «percorsi» ei «passaggi» seguiti dagli appezzamenti nei quantant’anni successivi. Non sitrattò d’altro canto di una operazione agevole e a testimonianza delle difficoltàincontrate sta il fatto che nel corso degli anni seguenti vennero di continuo ap-portate ulteriori modifiche alla prima redazione del catastico del 153775: comeera prevedibile le comunità, timorose di vedere lese le concessioni strappate oper lo più usurpate in decenni di scarso controllo dell’episcopato, si trinceraro-no dietro posizioni di manifesta reticenza, rifiutando di collaborare alle verifi-che in corso. L’episodio certamente più significativo fu il tentativo di occulta-mento delle vecchie redazioni estimali della comunità di S. Bonifacio, cheavrebbero permesso agli uomini dell’episcopato una maggiore precisione nellaredazione della legitimatio: l’espediente venne comunque ben presto scoperto.Nel 1538 il factor generale, dopo essere venuto a conoscenza («ad suas aures… pervenisse»), che gli uomini del comune di S. Bonifacio possedevano «pe-nes se unum librum nuncupatum librum aestimi veteris, in quo quidem libroinveniuntur descriptae omnes possessiones sustinentes onera et factiones cumsuo communi, cum honoribus et oneribus, seu gravaminibus eis spectantibus,et quod etiam sunt omnes possessiones obnoxiate ad varias pensiones episco-patui», ne fece esplicita richiesta, minacciando di scomunicare chiunque aves-se partecipato all’occultamento dell’importante documento. In segno di conci-liante apertura, venne quindi deciso di condonare ai numerosi usurpatori deiterreni una parte degli affitti residui – «cum promissione donandi omnia resi-
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 13
71. In generale su tali iniziative (con particolare attenzione per la situazione di Bovolo-ne), cfr. Scola Gagliardi, La mensa vescovile di Verona, cit., p. 73-80.
72. Cfr. Scola Gagliardi, La mensa vescovile di Verona, cit., p. 74-75.73. MV 99, c. n. n. (1 maggio 1537, copia seicentesca); ne esiste una seconda copia,
sempre seicentesca, volgarizzata in MV 100, c. n. n.74. MV 99, c. n. n. (1 maggio 1537, copia seicentesca).75. Cfr. Scola Gagliardi, La mensa vescovile di Verona, cit., p. 75.
dua cursa per totum annum 1531 ad hoc ut homines detinentes ab excomuni-cationibus praedictis absolvantur, et animae e manibus inimici eruantur» – nel-la speranza di far così capitolare i reggenti della comunità, i quali, allettati in-dubbiamente più dalle proposte del factor che non intimiditi dalla paventatascomunica, decisero alla fine di collaborare, non senza tentare di salvaguarda-re in extremis le proprie posizioni, consegnando una copia dell’estimo ampia-mente manipolata.
La cosa non sfuggì all’occhio attento ed esercitato dalla pratica notarile delfactor: «habito maturo et optimo consilio super dicta exemplificatione sic ex-tracta a sapientibus et iuris peritis in civitate Veronae et praecipue ab excellen-tissimo illustre doctore domino Gabriele de Peregrinis, asseruit idem dominusMatheus [Bardolino] quod pro consilio habito dicta copia, seu exemplificatioin futurum esse nullius valoris, et momenti, ex eo quia in eo non fuerunt ser-vata servanda, et a jure requisita, quia in simili et tali re requiritur, in primis»l’autorizzazione del podestà o di un giudice da esso delegato, mediante unalettera indirizzata al vicario della comunità. Quest’ultimo, in esecuzione degliordini ricevuti, avrebbe poi dovuto eleggere «quatuor homines de antiquiori-bus et melius informatis ad legitimandum dictas petias terrarum hypothecatasdicto episcopatui»76. Per risolvere la controversia l’episcopato nominò il nobi-le Sebastiano Banda nelle veci di suo procuratore nell’intricata vicenda che ar-rivò ad una definitiva soluzione solo dopo qualche anno (1541), quando unodei tribunali della città (in rappresentanza del rettore veneziano TommasoContarini) intimò al vicario e agli homines di S. Bonifacio di trascrivere fedel-mente le partite dell’estimo in cui si faceva menzione dei vecchi fitti dell’epi-scopato, così da poter ricostruire le vicende di tali livelli negli ultimi anni, insostituzione delle investiture originali di cui si erano perse completamente letracce77.
Nel momento in cui quest’ultima lunga vertenza si stava avviando ad unarisolutiva definizione, le operazioni di legittimazione del primo (per estensionefondiaria) feudo vescovile erano state invece da poco ultimate78: la catastica-zione, decretata alla fine del 1540 (proclama del 28 dicembre) dal vicario ve-scovile di Bovolone Agostino Nuvolina79 e dal factor generale Matteo Bardo-lino – per «far legitimar, perticar, et mesurar tutte le terre et luochi pertinenti alditto suo vescovato in la pertinentia et jurisdictione de Bovolon, quale sono te-nute et riconosciute per qualunque persona dal ditto vescovato a pagar il terzoo quinto et ogni altra pensione che si rispondano al ditto luocho de Bovolon et
14 A. Ferrarese
76. MV 102, c. n. n. (copia seicentesca): anche per le citazioni precedenti.77. Ibid., c. n. n. (mandato dell’11 giugno 1541).78. Su tale episodio cfr. anche Scola Gagliardi, La mensa vescovile di Verona, cit., p.
81-83, 111-115.79. Sulla figura del vicario vescovile per il feudo di Bovolone si sofferma brevemente
Scola Gagliardi, La mensa vescovile di Verona, cit., p. 47-49. Nel fondo MV dell’archiviodella Curia vescovile di Verona si conserva un unico volume originale di atti del notaio (Pa-ride q. Iotini de Nores) del vicario vescovile di Bovolone per l’anno 1540, cfr. in meritoMV 52.
fare la nova descrittione de ditti luochi et rasone con le sue novi confini qualitàet quantità»80 – seguì una procedura analoga a quella messa in atto a Mon-teforte e a S. Bonifacio. Il giorno seguente alla proclamazione pubblica dellalegitimatio – con cui si intimava a chiunque avesse avuto beni confinanti conquelli dell’episcopato a «demostrar quanto si aspetta et dedur tutte le sue raso-ne»81 – il vescovo trasmise al vicario e al factor il mandato di elezione per iquattro «homines loci praticos et expertos»82 nella procedura da seguire nei la-vori che si sarebbero basati, anche in questo caso, su di un precedente catasti-co risalente al 148683. Alla fine del febbraio seguente (27 febbraio 1541) leperticazioni vennero concluse84: i risultati della legitimatio vennero quindi let-ti pubblicamente alla vicinia nella piazza di Bovolone, riservando i dieci gior-ni successivi per chiunque avesse rilievi contrari e reclami da esporre85.
Il completamento delle catasticazioni delle proprietà della mensa costituìsenza ombra di dubbio uno dei successi più importanti e duraturi degli anni gi-bertini: di ciò ne sono testimonianza le vicende della mensa nei decenni se-guenti ed in primo luogo il fatto che le legitimationes approntate costituironola base su cui si innestarono molti degli interventi dei presuli successivi86; nonvanno tuttavia sottovalutate le difficoltà incontrate che, in fin dei conti, permi-sero di arrivare a dei risultati definitivi solo quasi alla fine dell’esperienza ve-ronese. La ritrosia delle comunità, la confusione delle carte e degli archivi,quanto soprattutto i decenni di scarso e intermittente controllo da parte deiprecedenti reggenti, non giovarono di certo ai compiti che il presule genoveseconcentrò ed organizzo attorno alla figura del factor. Un ventennio di interven-
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 15
80. MV 101, 2r-v (28 dicembre 1540, il notaio redattore è Paride q. Iotini de Nores). Ilterzo e il quinto corrispondevano ai canoni pagati usualmente dai conduttori delle posses-sioni vescovili, in merito cfr. Scola Gagliardi, La mensa vescovile di Verona, cit., p. 120-122.
81. MV 101, c. 2r-v (28 dicembre 1540).82. MV 19, p. 19 (processo a stampa sei-settecentesco: riporta il decreto di elezione in
data 29 dicembre 1540).83. Il fatto si evince dai continui rimandi, nella descrizione delle singole pezze di terra
catasticate in MV 101, ai numeri di riferimento della coeva legitimatio del 1486.84. MV 19, p. 24 (a stampa).85. Ibid., p. 24.86. Cfr. ad esempio la legitimatio successiva (1564) fatta redigere dal commissario del
vescovo Bernardo Navagero, Andrea Marcello, basata interamente sul confronto redaziona-le con la documentazione del 1540 [MV 104]; in merito ai successivi interventi di catasti-cazione delle proprietà della mensa cfr. anche Scola Gagliardi, La mensa vescovile di Vero-na, cit., p. 76-80, 112. Copie settecentesche dei proclami e di parte delle legittimazioni suc-cessive a quelle gibertine per il feudo di Bovolone sono in ASVr, Archivio privato Gianfi-lippi-Campostrini, proc. a stampa n. 114, p. 22-25 (proclama per la legitimatio del 15 luglio1564), 32 (proclama per la legitimatio del 1 aprile 1581: Alvise Valier e Giorgio Martellocommissari del vescovo Agostino Valier), 33-36 (proclama per la legitimatio del 18 gen-naio 1618: Marco Valier commissario del vescovo Alberto Valier), 55-57 (proclama per lalegitimatio del 21 giugno 1698: Giacomo Peccana commissario del vescovo GianfrancescoBarbarigo), 59-62 (proclami per la elezione del commissario e per la legitimatio del 17-19aprile 1750: Giacomo Riva commissario del vescovo Giovanni Bragadin).
ti mirati e continui portò a risultati per molti aspetti importanti; si arrivò aduna definitiva riorganizzazione delle proprietà, alla creazione, in altri termini,di una serie di aggregati fondiari gestiti attraverso un sistema di fattorie, allarealizzazione di precisi strumenti di verifica e di controllo quali le catasticazio-ni, al rinnovo pressoché completo delle locazioni, effettuato dapprima sullabase della continuità con il passato e in seguito perfezionato alla luce dei risul-tati emersi dalle nuove misurazioni. Furono risultati che segnarono profonda-mente, come dicevamo, la struttura anche successiva della mensa ma, ancor dipiù, furono soluzioni e risposte a problemi che filtrarono nella parallela azionedi assestamento della proprietà ecclesiastica e della sua gestione in corso nelladiocesi di quegli stessi anni.
2. L’azione di riforma nella diocesi
L’ispezione e la verifica della situazione patrimoniale di pievi, parrocchie,cappelle ed ospedali della diocesi interessò, del pari alla promulgazione di unaeterogenea serie di editti87, l’insieme degli ordini «straordinari» che contraddi-stinsero i primi anni della gestione vicariale; si trattò di provvedimenti ad hoc,di ampie e spesso generiche disposizioni, innestate a margine delle più impor-tanti linee di intervento dei vicari, impegnati soprattutto ad estirpare l’ardua esorda resistenza di buona parte del clero diocesano alla residenza. A partire dalbiennio 1524-1525 i tentativi di sondare la consistenza della massa beneficialedella diocesi vanno di conseguenza calati nel più ampio e frastagliato contestodel problema residenziale88: la nomina del Giberti, più volte confermata anchein seguito, a giudice ordinario sugli esenti (23 maggio 1525)89, costituì indub-biamente uno strumento ricognitivo di fondamentale importanza, la cui utiliz-zazione rimase tuttavia strettamente connessa agli interventi d’urgenza in fieri.Se da un lato, quindi, il controllo della imprescindibile connessione tra resi-denza, legittima ordinazione e godimento beneficiale costituì l’impegno e l’o-biettivo peculiare degli anni di gestione vicariale90 – tale, forse, da far passare
16 A. Ferrarese
87. Fasani, Verona durante l’episcopato di Gian Matteo Giberti, cit., p. LXXVI.88. Joannis Matthaei Giberti episcopi veronensis vita, in GO, p. IX. Altri editti su tale
materia vennero ripetuti ad esempio anche nel febbraio 1529 [Ibid., p. XVI] e nel 1532[Ibid., p. XXIV-XXV].
89. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 134-135; Joannis Matthaei Gi-berti episcopi veronensis vita, cit., p. XI-XII.
90. Joannis Matthaei Giberti episcopi veronensis vita, cit., p. IX: «ne auderent [i sa-cerdoti beneficiati della diocesi] dicta eorum beneficia alicui affictare, seu locare, nec ali-quem capellanum ibi conducere, et deputare sine expressa licentia nostra» (questo editto –«quo pluribus cleri corruptelis provisum fuit» – è collocato dai Ballerini tra la fine del1524 e gli inizi del 1525). Due ulteriori editti contro il clero non residente vennero pro-mulgati nel febbraio del 1529 [Ibid.,, p. XVI] «in quo etiam multis cavit, nequis plura be-neficia sine legitima dispensationem teneret: jussit enim ostendi a quolibet beneficiorumtitulos, ne quispiam forte non ordinatus, vel non rite electus aliquod beneficium posside-ret» e il 22 dicembre 1536 (ma edito nel gennaio dell’anno seguente) [Ibid., p. XXVII-
in secondo piano altri pur pressanti problemi che si concretizzavano nel men-tre veniva approfondiva la conoscenza dell’intera realtà diocesana –, non van-no d’altra parte tralasciati alcuni importanti «corollari» che vennero comunqueampiamente sviluppati dal Giberti dopo la personale ricognizione del 1530.
Tra questi, prescindendo da alcuni cenni negli editti di cui abbiamo dettopiù sopra al problema dei legati pii e dei testamenti su cui torneremo ampia-mente, la questione della amministrazione patrimoniale dei monasteri femmi-nili91 assorbì in questo torno di tempo molte delle energie del presule e deisuoi vicari, senza poi dimenticare che le soluzioni proposte ed elaborate per ilcaso veronese rimasero a lungo tra gli aspetti più apprezzati dell’opera giberti-na92. Il controllo patrimoniale dei monasteri femminili si inserì nella più com-plessa vicenda che riguardava il difficile riconoscimento dell’autorità vescovi-le, una diatriba che, come è noto, contrappose a lungo il Giberti ad ampi stratidell’élite nobiliare veronese93: tralasciando di ricostruire le complicate fasidell’intera vicenda, peraltro ampiamente analizzate, interessa qui focalizzarel’attenzione sugli interventi di controllo e di promulgazione normativa che eb-bero attinenza con la prassi amministrativa e gestionale dei monasteri femmi-nili, nel tentativo di «assicurare le basi materiali per un ordinato svolgersi del-la vita dei monasteri»94.
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 17
XXVIII]: «Ibidem etiam cavetur de ostendendis beneficiorum titulis litterisque ordinatio-num, ne quis forte, ut ferebat temporum iniquitas, sine ordine ac legitimo titulo in eccle-siam aliquam irrepsisset».
91. P. Paschini, I monasteri femminili in Italia nel cinquecento, in Problemi di vita reli-giosa in Italia nel cinquecento, cit., p. 38; G. Zarri, Monasteri femminili e città (secoli XV-XVIII), in Storia d’Italia, Annali 9, cit., p. 372, 382, 393, 396. Da non tralasciare i cenniagli interventi amministrativi in tale materia del vescovo di Padova Barozzi, in Gios, L’atti-vità pastorale del vescovo Pietro Barozzi a Padova, cit., p. 181-185.
92. Nella Milano borromaica Alberto Lino – già membro di spicco della familia giber-tina [cfr. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 276] – visitò e riformò i mona-steri, redigendo delle regole (entrate poi nella redazione del primo concilio provinciale)ispirate a quelle gibertine, cfr. dunque E. Cattaneo, Influenze veronesi nella legislazione disan Carlo Borromeo, in Problemi di vita religiosa in Italia nel cinquecento, cit., p. 135 (v.l’Appendice per altre citazioni). In generale sul problema della riforma dei monasteri nelperiodo tridentino cfr. R. Creytens, La Riforma dei monasteri femminili dopo i Decreti Tri-dentini, in Il concilio di Trento e la riforma tridentina, cit., v. I, p. 45-84 (con un solo cen-no a p. 50 in merito al problema della amministrazione temporale) e G. Zarri, Ordini reli-giosi e autorità episcopale: le visite pastorali a chiese esenti e monasteri, in Fonti ecclesia-stiche per la storia sociale e religiosa d’Europa, cit., p. 352, 356-357. Per il periodo triden-tino cfr. ad esempio Paschini, I monasteri femminili in Italia nel cinquecento, cit., p. 56; al-cune esemplificazioni degli interventi di riordino amministrativo in alcune diocesi sono inF. Molinari, Visite Pastorali dei Monasteri Femminili di Piacenza nel sec. XVI, in Il conci-lio di Trento e la riforma tridentina, cit., v. II, p. 693, 709, 725; Zarri, Monasteri femminilie città (secoli XV-XVIII), cit., p. 405-406, 408.
93. Cfr. in merito O. Viviani, Il vescovo di Verona G.M. Giberti e il riordinamento deimonasteri femminili, in «Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura, Scienze e Letteredi Verona», serie VI, v. VIII, 1956-1957, p. 135-166.
94. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 185.
Una prima visita generale venne effettuata dal vicario vescovile nell’apriledel 152695, seguita da una seconda nell’ottobre del 1528: in entrambi i casi, ipochi lacerti delle verbalizzazioni superstiti, conservano ampie tracce di unacapillare regestazione delle rendite patrimoniali dei singoli enti96. Come ac-cennato, la mancanza pressoché totale dei dati ricavati nel corso delle due visi-te, impedisce di avanzare ipotesi di riferimento; la specifica e puntuale consi-derazione che emerge nei pochi excerpta superstiti per la situazione degli as-setti amministrativi, induce solo ad ipotizzare quanto divenne molto più evi-dente nel corpus normativo specificamente dedicato, nelle Costituzioni per lemonache97, alla gestione dei patrimoni e dato alle stampe qualche anno dopo(1539). La visita, momento di ricognizione e di ispezione ma pure, nelle inten-zioni del presule, momento di approfondimento e di indispensabile conoscen-za della realtà diocesana, costituì spesso nell’esperienza gibertina – e lo vedre-mo meglio nel rapporto dialettico tra le visite pastorali e le fondamentali Co-stituzioni per il clero del 1542 – una sorta di banco di prova, un primo «can-tiere» in cui abbozzare soluzioni e prospettare regole, in seguito omogeneizza-te ed organizzate nella definitiva redazione. Anche in questo caso risulta quin-di abbastanza agevole interpretare le disposizioni gestionali ed amministrativeaffidate al testo a stampa del 1539, facendole derivare dalla diretta esperienzadelle due visite ai monasteri femminili della città: nello specifico, non si trattòper nulla di regole «astratte» o fatte forzatamente discendere dalla precettisticacanonica coeva98, quanto piuttosto di prescrizioni in cui non è punto difficile
18 A. Ferrarese
95. Ibid., p. 154, 184.96. Alcuni verbali delle visite vicariali (1526) e personali (1528) ai monasteri si trova-
no trascritti tra le miscellanee dell’erudito veronese Perini; in relazione alla verifica della si-tuazione patrimoniale dei monasteri è possibile ricordare il caso del convento di S. Mariadegli Angeli presso la Cittadella di Verona, in cui già al momento della prima visita vica-riale il computo delle entrate è descritto in modo dettagliato [BCVr, Carte Perini, b. 25,fasc. IV, n. 2]. Analoghe verifiche vennero effettuate anche nel monastero di S. Maria degliAngeli di Quinzano; nello specifico, i vicari Amadei e Beccari redassero particolareggiatiinventari dei beni dotali delle monache presenti al momento della ricognizione, segnalandoil loro valore, come pure l’ubicazione delle possessioni e l’ammontare degli affitti, dei li-velli e delle rendite [BCVr, Carte Perini, b. 25, fasc. IV, n. 3I]; e in quello delle benedetti-ne di S. Massimo, in cui, come nel caso precedente, venne compiuto dai vicari un sistema-tico scorporo della dotazione personale delle monache dall’insieme dei bona temporalia delmonastero (inventariati con precisione assieme alle entrate e alle spese annue) [BCVr, Car-te Perini, b. 25, fasc. IV, n. 21]. Ulteriori trascrizioni dai verbali di queste due visite sonosparsi anche negli otto volumi di G.B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona,Verona, 1749-1771.
97. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 191.98. Vale la pena di sottolineare le analogie esistenti tra l’esperienza di riforma gibertina
dei monasteri femminili veronesi con quanto era auspicato nei contemporanei CanonesConcilii Provincialis Coloniensis del vescovo tedesco Gropper, di cui sono note e ampia-mente verificate le influenze dirette sul Giberti [cfr. ad esempio Prosperi, Tra evangelismo econtroriforma, cit., p. 254, 311; Id., Di alcuni testi per il clero nell’Italia del primo cinque-cento, cit., p. 164]. Nel testo dei Canones – citiamo dall’edizione veronese del 1541,espressamente approntata nella stamperia gibertina – si faceva più volte riferimento alla ne-
cogliere una competenza ed una conoscenza dettagliata e sicura di meccani-smi, di funzioni, di mansioni.
E se il prologo rimaneva nella genericità delle intenzioni – «provvederetiam, che l’entrate, ed altre cose del monasterio siano fedelmente conservate,amministrate, e dispensate a comune utile di tutto il convento, ordiniamo cheper l’avvenire l’abbadessa, e le discrete sieno obbligate a riveder li conti, e farche si facciano le ragioni del monasterio dal fattore, ed altre persone, che am-ministrassero, d’anno in anno talmente, che di continuo si sappia chiaro l’en-trata ed uscita del monasterio, e specialmente procurino remoto ogni umanoaffetto, che d’anno in anno proceda alli debitori del monasterio, etiam che fos-sero di sangue congiuntissimi ad alcuna delle sorelle, fin alla compita soluzio-ne»99 –, le regole che seguivano entravano nello specifico, affrontavano il det-taglio, attribuivano competenze ed ordini che lasciavano ben poca autonomiagestionale alle monache preposte. Tutte le entrate «si scrivano in un libro perla borsiera, o sia scrittora, e si ripongano in una cassa tutti a uno, cioè senzadistinzione, che tutti sieno di comune, la qual cassa abbia tre chiavi differenti… la detta borsiera a partita per partita nel medesimo libro descriva l’uscita didette entrate, e noti bene a cui le darà … Il simile si faccia del granaro, che glisia una preposita, la quale riceva il frumento, … detta preposita abbia un libro,nel qual scriva come sopra è detto … Ed ogni una tenga inventario del suoesercizio di tutte le robbe, ed in capo dell’anno lo consegni alla madre abba-dessa: e similmente ella tenga l’inventario di tutti li beni del monasterio e mo-bili e immobili»100. Non sarà poi difficile, come vedremo meglio in seguito, in-dividuare in questa sorta di schema organizzativo della gestione amministrati-va un embrionale «nocciolo» di quanto venne esteso di lì a qualche anno allacontabilità delle pievi, delle parrocchie, degli ospedali e delle confraternite lai-cali della diocesi.
Tra il 1525 e il 1529, contemporaneamente quindi alle ricognizioni dei mo-nasteri femminili e a quelle in corso tra le proprietà della mensa, prese avvio laprima serie di visite pastorali nella diocesi, visite vicariali abbiamo detto, manon per questo meno efficaci nell’affrontare le precise direttive impartite dalpresule; in parte, ancora una volta, l’urgenza dei provvedimenti, quanto soprat-
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 19
cessità di «sumptuosi monialium praepositi abrogandi, et frugales oeconomi constituendi»[§XI, c. 42r], sostituendoli con «probi oeconomi a nobis [i. e. dal vescovo] comprobandi(quorum victus sit monastico similis) … qui etiam obligati erunt singulis annis rationem dereceptis ac erogatis integram redere» [Ibid., c. 42r].
99. Constituzioni e ordinazioni generalmente da osservarsi in tutti li monasterij dellacittà e diocese di Verona, in GO, p. 202-203 (§XXVIII).
100. Ibid., p. 203 (§XXIX). Altre importanti indicazioni in merito alla gestione patri-moniale dei monasteri sono contenute nelle Monitiones generales Jo. Matthaei Giberti epi-sc. Veronensis exhibitae in visitationibus [in GO], una sorta di sommario elaborato sullabase degli interventi visitali degli anni successivi; nel merito le Monitiones ricordavano peri monasteri che «sint curae bona temporalia, ac reditus, ne superiores monasteriorum sintsuspecti de dilapidatione» [Ibid., §IV, cap. 4, p. 222], come pure «curent, ut bene expen-dantur bona, eleemosynae, et oblationes fraternitatum, et scholarum, quae erectae sunt inipsorum [dei monasteri] ecclesiis» [Ibid., §IV, cap. 6, p. 222].
tutto la necessità di ottenere nel breve periodo un quadro di riferimento dimassima della situazione complessiva, sveltirono le ricognizioni rispetto, adesempio, ai tempi molto più lunghi che caratterizzarono le visite condotte per-sonalmente dal Giberti nel 1530 e nel 1541. Le necessità contingenti non infi-ciarono comunque la «raccolta» delle informazioni che, come testimonianoampiamente le dettagliate verbalizzazioni rimaste, permisero effettivamente alpresule e ai collaboratori tutta una prima serie di interventi mirati, di cui è ri-masta traccia nei numerosi editti promulgati al termine di ogni tornata visita-le101. Come dicevamo, quantunque appaia indubbio che in queste prime verba-lizzazioni l’interesse del vescovo fosse concentrato alle problematiche struttu-ralmente più scottanti nella corretta cura animarum, non di meno l’attenzioneper i tratti prettamente economici della parrocchia pare testimoniata da una no-tevole abbondanza di riferimenti; già ad esempio nello schema visitale elabo-rato dal Giberti (anche se una sua datazione precipua non è del tutto certa) i ri-chiami, nella scansione del percorso di visita, alla raccolta di informazioni re-lativa al de valore, al de aestimo, come pure al de inventariis bonorum eccle-siae e al de legatis102, confermano una considerazione non accessoria per taliproblemi.
Nel corso della prima visita-ricognizione dei vicari Beccari e Amadei(1525) non mancarono dunque implicite attenzioni alla situazione della pro-prietà ecclesiastica103, anche se spesso la sensazione è tale da far rientrare iprovvedimenti presi, nel segno dell’azione personale dei due vicari piuttostoche entro il limite di un più ampio progetto di ristrutturazione, come quello di-spiegato negli anni a venire: in generale – come scrisse Prosperi – «il quadrodella situazione veronese che risulta dalle visite del Beccari e dell’Amadei èpiuttosto incolore»104; si trattò ancora, nella sostanza, di «frettolose ricognizio-ni»105, quantunque destinate ad un rapido perfezionamento. Così, esemplifi-cando alcune tipologie tra gli interventi del 1525, a Puegnano vennero citati al-cuni «extimatores electi et assumpti per reverendum dominum Callistum deAmadeis», al fine di valutare alcune pezze di terreno106; a Polpenazze, il vica-rio intervenne in una permutatio che riguardava alcuni terreni della pieve, nelqual caso, «nullam de praedictis habens notitiam, elegit cum instrumento in-frascriptos [homines] ad videnda et extimanda bona praedicta et referendumvicario»107. Non mancarono episodi per certi aspetti particolari, come a Moni-
20 A. Ferrarese
101. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 202.102. Ibid., p. 205-206 (che propende per una datazione redazionale al 1530); Prosperi,
Le visite pastorali del Giberti tra documento e monumento, in VP I, p. XLVIII; anche Fa-sani, Verona durante l’episcopato di Gian Matteo Giberti, cit., p. LXXXV.
103. Turchini, La visita come strumento di governo del territorio, cit., p. 369.104. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 204.105. Ibid., p. 204.106. VP I, p. 10. Sulle modalità visitali adottate dall’Amadei e sui loro legami con la
prassi del giudizio sinodale cfr. quanto scrive Turchini, La visita come strumento di gover-no del territorio, cit., p. 362, 365.
107. VP I, p. 15. Un altro intervento in una permutazione di beni ecclesiastici è segna-
ca, quando gli homines del comune si rivolsero al vicario per sollecitare la re-dazione dell’estimo della comunità: e, al di là della commistione tra gli ambitidi competenza, l’Amadei incaricò due cappellani «ad videndum et exstiman-dum tot bona stabilia dicti comunis Monice in pertinentia eiusdem loci»108. Siha comunque la sensazione, come abbiamo appena ribadito, che si tratti diprovvedimenti d’occasione: le cose parvero invece mutare nella visita dell’an-no successivo, quando appunto l’intervento dei visitatori seguì direttive piùprecise e una maggiore considerazione per il problema della proprietà eccle-siastica.
La seconda visita vicariale prese avvio nell’agosto del 1526. I redditi dellechiese iniziarono ad essere stimati con attenta circospezione e verbalizzati109,allo stesso modo dei terreni concessi a livello, di cui vennero sempre più spes-so annotati i canoni corrisposti110; per la prima volta cominciarono a compari-re le richieste per la presentazione dell’inventario: «imposuit dicto fratri archi-presbyteri quod ostendat introitum ecclesie infra mensem et rationes si nonostenderit, ne cadat in penam edicti»111. Simili disposizioni vennero prese neiconfronti dei massari delle pievi e delle parrocchie, anche se spesso le intro-missioni nella proprietà ecclesiastica o in quella degli enti parvero confondersie mescolarsi: così a Minerbe il vicario, venuto a conoscenza del continuo de-pauperamento dei bona della fabrica, «quia non reperitur registrum sive catha-strum instrumentorum diversorum bonorum», ordinò che ne venisse redattouno nuovo, come pure che le «possessiones ipsius fabrice affictentur ad publi-cum incantum, plus offerenti, quia melius affictabuntur»112. Scrupolose atten-zioni vennero pure rivolte al frastagliato problema dei legati pii: nella quasi to-talità dei casi non rimaneva che una flebile memoria di quanto testato a favoredella chiesa, quando non erano poi gli eredi che si rifiutavano di contribuire ildovuto113. Ai frequenti debitori insolventi, segnalati con abbondanti allusioni
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 21
lato a Padenghe sempre nell’ottobre del 1525; in questo caso il vicario «visis videndis etconsideratis considerandis» dichiarò che la «permutationem inter ipsas partes factas rite etlegaliter processisse et cedere in evidentem utilitatem dicte ecclesie et per consequens suaratamfecit auctoritate per iudiciale decretum» [VP I, p. 21].
108. VP I, p. 20.109. Per qualche esempio cfr. VP I, p. 65 (Belfiore d’Adige), 88, 94-95 (Minerbe), 175
(S. Pietro in Cariano), 176 (Mazurega), 188 (Sommacampagna), 196 (S. Giovanni Lupato-to), 198 (Villafontana).
110. VP I, p. 94 (Minerbe), 122-123 (Tombazosana: si tratta delle entrate livellarie diun «quoddam hospitale vocatum ‘Sottornia’»), 167-168 (Lazise: si tratta anche in questocaso di una ricognizione dettagliata delle entrate livellarie del locale ospedale), 206 (Butta-pietra).
111. VP I, p. 73 (Zevio). Per altri casi cfr. VP I, p. 129 (Malavicina), 141 (Bovolone:vengono richiesti i redditi del locale ospedale), 163 (Peschiera: il vicario Amadei impone«ad videndum et calculandum rationes administrationis» del locale ospedale); Fasani, Vero-na durante l’episcopato di Gian Matteo Giberti, cit., p. CXXXII.
112. VP I, p. 97.113. Per qualche esempio cfr. VP I, p. 74 (Zevio), 87 (Albaredo), 93 (Miega), 140
(Bionde di Visegna), 166 (Lazise). Sul problema cfr. G. De Rosa, Presentazione, in VP I, p.
dagli stessi ecclesiastici114, i vicari imposero in molti casi un terminus adquem per la restituzione: «mandavitque eidem don Bartholomeo quod moneatquoscumque occupantes bona ecclesie, spectantia dicte plebi et capellis ac ho-spitali, haec sub excommunicationis pena restituant per totum mensem novem-bris»115; altre volte intervennero invece più drasticamente, operando sequestri«cautelativi» «ne dicta ecclesia debitis ossequiis defraudetur»116, nel caso incui i parroci o i pievani non si fossero dimostrati all’altezza dei compiti di tu-tela a loro affidati.
Il panorama abbastanza disomogeneo fino ad ora messo in luce, di cui valela pena ribadire il carattere di precipua straordinarietà, non presentò tratti dis-simili nel prosieguo delle due successive visite vicariali che precedettero laprima capillare ricognizione compiuta personalmente dal presule; terminatanel novembre del 1526 la seconda visita del vicario Amadei, la terza prese av-vio nel gennaio del 1527. I temi e i problemi su cui i visitatori concentraronoancora una volta la loro attenzione non si discostarono da quanto abbiamo finoad ora indicato117: nel merito invece della gestione patrimoniale (anche se inmodo più netto a partire dalla visita successiva del 1529, con il vicario Mar-cello Martini) la figura del massarius delle pievi e i compiti che ad esso eranostati destinati parvero delinearsi con maggiore precisione118. In particolare, aprescindere dalle usuali mansioni ricognitive affidate ai massarii (stesura degliinventari119 e dei computa amministrativi120) iniziò a prospettarsi e parve pren-
22 A. Ferrarese
XXVII. Anche per quanto riguarda i testamenti e i legati pii vanno sottolineate le importan-ti convergenze tra le direttive emerse nelle prime ricognizioni vicariali e l’esperienza delGropper, cfr. nel merito i Canones Concilii Provincialis Coloniensis, cit., §X, c. 46r (De te-stamentis insinuandis, approbantis ac exequendis): «procuratores nostri fiscales in dioecesinostra coloniensi … advigilabunt, ut testamenta, maxime ecclesiasticarum personarum, pri-vilegiis ecclesiae nostrae maioris salvis, intra anni spatium exequutioni mandentur, utqueintra idem tempus exequutores testamentorum legitimum calculum reddant. Quorum etiamtestamentorum insinuationem approbationemque intra triginta dies a morte sacerdotis, petivolumus atque obtineri, nisi rationabilis causa longiorem dilationem exposcat in praemis-sis».
114. Cfr. ad esempio VP I, p. 117 (Cerea), 154 (Villafranca), 168 (Lazise), 200 (Maz-zantica). Non mancano le segnalazioni di situazioni sui generis, come nel caso della pievedi Zevio che «pro maiori parte usurpat» i redditi e i proventi spettanti ad una cappella dellapieve di S. Giovanni Lupatoto [Ibid., p. 196].
115. VP I, p. 98 (Minerbe). 116. VP I, p. 90 (Bonavigo). Altri casi di sequestro sono segnalati in Ibid., p. 165 (Pa-
cengo), 179 (Castelnuovo); mentre per la visita del 1529 si rinvia ad Ibid., p. 300 (Lazise:sequestro dei beni dell’ospedale locale), 367 (Mazzantica), 442 (Moruri).
117. Per la serie di editti e provvedimenti seguiti alle prime ricognizioni vicariali cfr. A.Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 142-143.
118. Fasani, Verona durante l’episcopato di Gian Matteo Giberti, cit., p. LXXXIII,LXXXVII, CXXXI.
119. VP I, p. 219 (Montorio).120. VP I, p. 249 (Roverè di Velo: tra i compiti del massarius «quod reddat rationem
massario anni et capellano, sumptibus secum duobus hominibus dicti communis sive consi-liariis et quod singulo anno sic fiat per alios massarios futuros»).
dere corpo sullo sfondo dei verbali visitali, la strutturazione di quel legame di-retto tra laicato ed episcopio che costituì indubbiamente uno dei tratti peculia-ri della pre-riforma gibertina121. Nel complesso dell’azione visitale non man-carono anche in questa terza ricognizione i continui cenni agli usurpatori checonvertivano il patrimonio delle chiese «in suum disponibilem usum … contraeorum animarum salutem»122, come pure l’attenzione nei confronti dei legatiad pias causas123 e alla quantificazione precisa delle rendite parrocchiali124
(assieme a quelle di ospedali e di confraternite laicali)125. È invece da considerare come un elemento di fondamentale rilievo, nell’in-
sieme delle disposizioni incontrate nella successiva visita vicariale del 1529, ilruolo primario che l’episcopato venne progressivamente ad assolvere nel con-trollo dei redditi ecclesiastici; l’attuazione di questo provvedimento presuppo-se innanzitutto la presenza di una raxoneria di curia ben funzionante, di un ar-chivio altrettanto ordinato126, quanto soprattutto la esistenza di personale ingrado di gestire ed intervenire nel complesso beneficiale della diocesi. Ricor-dando quanto abbiamo precedentemente detto in merito alle vicende dellamensa, va certamente sottolineata la stretta concomitanza cronologica tra la
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 23
121. Cfr. a proposito M. Knapton, Istituzioni ecclesiastiche, culto, religiosità nella Val-policella di età pretridentina e tridentina, in La Valpolicella nella prima età moderna(1500c.-1630), a cura di G.M. Varanini, Verona, 1987, p. 369 e Prosperi, Note in margine aun opuscolo di Gian Matteo Giberti, cit., p. 372. In generale sul legame tra laici ed ammi-nistrazione ecclesiastica si veda anche il recente saggio di C. Nubola, Chiese delle comu-nità. Diritti consuetudinari e pratiche religiose nella prima età moderna, in Fonti ecclesia-stiche per la storia sociale e religiosa d’Europa, cit., p. 441-464.
122. VP I, p. 253 (Vestenavecchia); come pure ibid., p. 228 (S. Mauro in Saline), 249(Cerro), 254 (Cogollo), 300-301 (Incanale: «introitus massarius et homines loci contra iuset iustitiam retinent et usurpant, in suum usum damnabilem convertunt pro sua voluntate»),319 (Manerba), 358 (Sanguinetto), 372 (Bovolone: il pievano, in questo caso, «usurpatoblationes et elemosinas», spettanti all’altare della confraternita della Concezione di Ma-ria), 373 (Nichesola).
123. VP I, p. 242 (Grezzana), 321-322 (Portese), 324 (Soiano), 330 (Valeggio), 341(Fagnano), 360 (Casaleone).
124. VP I, p. 236 (S. Briccio di Lavagno: elenco dettagliato dei livelli della parrocchia),305 (Bardolino), 335 (Villafranca), 369 (Isola della Scala), 385 (Albaredo), 404 (Centro).
125. VP I, p. 284 (Porto di Legnago: i massarii del locale ospedale «habent librumcomputorum et reddunt rationem omni anno sindicis comunitatis»), 286 (Vangadizza).
126. Sul rapporto tra il Giberti e la documentazione scritta cfr. quanto scrive M. Knap-ton, Istituzioni ecclesiastiche, culto, religiosità nella Valpolicella, cit., p. 341: «nella …prospettiva di tensioni, di un’efficacia conquistata faticosamente, si colloca un altro aspettodei rapporti fra vertice e base: la compilazione e conservazione di documentazione scritta, eil suo impegno come mezzo di controllo e comunicazione, su scala molto più vasta che inepoche precedenti»; anche G. De Rosa, Presentazione, cit., p. XXX e A. Ferrarese, «Agno-sce vultum pecoris tui». Aspetti della «cura animarum» nella legislazione anagrafica eccle-siastica della diocesi di Verona (secc. XVI-XVIII), in «Studi storici Luigi Simeoni», XLIX,1999, p. 189-237 (in particolare p. 196-210). Per un confronto con gli interventi borromaicicfr. A. Palestra, La legislazione del cardinale C. Borromeo per gli archivi ecclesiastici del-la provincia metropolita milanese, in Palaeographica diplomatica et archivistica. Studi inonore di G. Battelli, Roma, 1979, v. I, p. 593-616.
creazione del factor generale nel 1531 e questi primi abbozzi (o che almenonel 1529 apparivano ancora tali) per la strutturazione di un organismo in gradodi provvedere alla raccolta e al controllo dei dati contabili e «fiscali» della fra-stagliata proprietà ecclesiastica diocesana127: «omnia praeterea sacerdotia, be-neficia, ecclesias, monasteria, et oratoria, tam urbis, quam ruris, cum capelliset ecclesialis cuique subjectis pulcherrimo ordine in libro separatim praescrip-ta sunt»128.
Dopo anni di «apprendistato» e di ricognizioni fin tra le più sperdute cap-pelle della diocesi, i tempi erano plausibilmente maturi per quella svolta «ge-stionale» che impegnò il presule e i membri della familia per tutto il decennioseguente: come dicevamo, fu la visita personale del 1530 che fornì gli ultimi
24 A. Ferrarese
127. Una precisa puntualizzazione a riguardo degli sfuggenti problemi della contabilitàecclesiastica, di cui vale la pena tener conto, si ha in F. Landi, Per una storia dei falsi in bi-lancio: le contabilità pubbliche dei conventi e dei luoghi pii, in L’uso del denaro. Patrimo-ni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV-XVIII), acura di M. Garbellotti e A. Pastore, Bologna, 2001, p. 41-62.
128. Con tali parole il familiaris Pier Francesco Zini ricordava a distanza di qualcheanno il «punto di arrivo» del progetto gibertino di controllo della proprietà ecclesiastica del-la diocesi, la realizzazione, in altri termini, di un archivio ordinato e costantemente aggior-nato; per la citazione cfr. P.F. Zini, Boni pastoris exemplum, in GO, p. 294. Di tale volume– menzionato pure nelle Costituzioni per il clero del 1542 (tit. VIII, cap. 1) – non è rimastatraccia nel fondo archivistico della MV, come pure tra le carte degli eruditi Ballerini checurarono la stampa delle due edizioni delle Opera gibertine; un processo a stampa della se-conda metà del settecento, relativo ad una controversia tra la pieve di Colognola ai Colli e idetentori laici della locale decima [ASVr, Archivio privato Nichesola-Zennari, proc. n. 7]contiene un ampio estratto dal volume gibertino, eseguito nel dicembre del 1766. Il cancel-liere settecentesco che eseguì la trascrizione ebbe cura di riportare nell’incipit del docu-mento alcune importanti indicazioni che consentono di identificare senza ombra di dubbiol’importante volume: «fides per offitium canc. episc. Veronae sicuti in libro inscripto Catta-logo da un libro antico della canc. di Verona, che contiene i benefizj della stessa città … visegue l’aggiunta dell’antiche Constituzioni, e divisioni delle pievi copiata parimente dallostesso libro etc.» [ibid., p. 12]. L’indicazione relativa al testo delle inedite Costituzioni perle pievi, ci permette qualche ulteriore considerazione: è del tutto plausibile che il volumecollazionato per la copia sia lo stesso da cui i Ballerini esemplarono il testo delle Costitu-zioni preparato per la terza edizione delle Opera che non riuscirono a dare alle stampe [eche viene qui riprodotto in Appendice]: nella loro trascrizione i Ballerini accennarono alfatto che la loro copia proveniva da un exemplum dell’archivio episcopale, senza comunquedare altre indicazioni in merito alle caratteristiche del documento. A conferma di tale corri-spondenza vi è anche un ulteriore elemento; la copia del 1766 prosegue infatti in questomodo: «inter cetera sequentia formalia verba leguntur, vid. in fol. 12t. die 23 mensis aprilis1540 in sala episcopatus. Pro plebibus omnibus dioecesis veronensis rev. d. episcopus vero-nen. ad benefitium omnium plebium veron. dioecesis stabili decreto constituit, et ordinavit»[Ibid., p. 12]. Il decreto, di cui il trascrittore del 1766 fornì solo l’intestazione venne invececompletamente trascritto dai Ballerini che indicarono, a margine della loro copia, come taleimportante documento gibertino «legitur autem in ms. episcopatus, nec non in alio antiquoexemplo»: una attestazione che dovrebbe fugare ogni ulteriore dubbio a riguardo della cor-rispondenza tra i due documenti. Un dettagliato catastico della intera proprietà ecclesiasticadiocesana venne previsto anche dal Paleotti come ricorda Prodi, Lineamenti dell’organizza-zione diocesana in Bologna, cit., p. 375.
riscontri ad un progetto che si era gradualmente venuto formando negli anniprecedenti e che comunque nel 1529 – come dimostrano i puntuali riscontridei verbali visitali – era già ampiamente delineato. Gli episodi, nel 1529, in cuiè fatto esplicito riferimento ad un controllo diretto delle entrate, delle spese edell’intera gestione dei bona ecclesiae non sono di per sé molti, anche se in-dubbiamente significativi: ad esempio nella ricca pieve di Cerea venne ordina-to al massarius del locale ospedale «quod reddat rationem omni anno de admi-nistratis communitati ipsius ville seu quod fidem faciat reverendissimo dominoepiscopo»129, mentre analoghe richieste vennero avanzate in altre «grandi»complessi plebani come a Valeggio130, a Isola della Scala131 e a Minerbe (ilmassarius «comparere debeat … cum libro computorum et rationum suarumde gestis et administratis»)132.
Un ulteriore e fondamentale elemento di novità, introdotto al termine diquest’ultima ricognizione vicariale fu la stampa del noto Breve ricordo, unopuscolo di poche pagine destinato ad una rapida fortuna non solo nella dio-cesi133, impresso nell’aprile del 1530 e distribuito nel corso della visita perso-nale a partire dal giugno dello stesso anno134: «raccogliendo le esperienze del-la visita del 1529»135 il Giberti racchiuse in una sorta di conciso memorandumi «lineamenti originali»136 del programma che, non senza difficoltà, da tempoveniva portato avanti tra il clero della diocesi. L’importanza del documento, ilprimo di quella lunga serie che testimonia ampiamente del felice e riuscitoconnubio tra il presule e l’arte tipografica137, è stata individuata soprattutto
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 25
129. VP I, p. 293.130. VP I, p. 330-331: «praeceptum factum eiusdem quatenus hinc ad Septimanam
sanctam exclusive debeant [il massarius e gli homines comunis] portasse et ostendisse li-bros et rationes illorum qui gubernant dictum hospitale et fabricam reverendo domino vica-rio episcopatus Verone sub pena excomunicationis».
131. VP I, p. 369: «factum fuit praeceptum dicto massario quatenus praeparet libros etrationes suas, ut illas videre possit reverendus dominus vicarius generalis episcopatus Vero-ne, finitis festis paschalibus proxime futuris».
132. VP I, p. 379.133. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 236.134. Prosperi, Note in margine a un opuscolo di Gian Matteo Giberti, cit., p. 381-382;
Id., Di alcuni testi per il clero nell’Italia del primo cinquecento, cit., p. 152. Nel febbraiodel 1529 il vicario vescovile nel corso della visita alla parrocchia di Cerea rilevava che il«capellanus plebis habet copiam instructionis capellanorum ed presbyteriorum habentiumcuram animarum» [VP I, p. 292]: nella concreta impossibilità di identificazione con il Bre-ve ricordo (o con alcuno dei noti testi per il clero in cura d’anime), stampato e distribuito apartire dal giugno dell’anno successivo, può essere forse ipotizzata una sua precedente dif-fusione manoscritta?
135. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 236; Id., Note in margine a unopuscolo di Gian Matteo Giberti, cit., p. 370, 388-389; Id., Di alcuni testi per il clero nel-l’Italia del primo cinquecento, cit., p. 141.
136. Prosperi, Note in margine a un opuscolo di Gian Matteo Giberti, cit., p. 372.137. Cfr. in merito anche Knapton, Istituzioni ecclesiastiche, culto, religiosità nella
Valpolicella, cit., p. 360 e P. Simoni, Appunti sulle opere a stampa del vescovo veronese G.M. Giberti, in «Studi storici Luigi Simeoni», XLIII, 1993, p. 147-167.
nella sua particolare struttura, scevra «dal condizionamento di formulazionitradizionali»138 che invece saranno oltremodo evidenti nella summa gibertinadelle Costituzioni per il clero, edite nel 1542; d’altra parte, l’essere appuntouna sorta di «manifesto» sintetico ed essenziale, plasmato sulle prime espe-rienze visitali da poco concluse, quanto soprattutto sui problemi che ne aveva-no costituito il leit-motiv, non consente di gettare molta luce su quanto stiamotentando di ricostruire. Non mancano, e non potrebbe essere altrimenti, i cen-ni alla proprietà ecclesiastica e alle problematiche inerenti la sua complessagestione – si rammenta, ad esempio, ai pievani e ai parroci che «faccino in-ventario de tutti beni mobili et immobili, et scritture et catasti che appartengo-no a la chiesa»139 – anche se tali accenni rimangono ben lontani dal poter es-sere considerati i tasselli di quel progetto definito di cui abbiamo scorto letracce nell’esperienza della mensa vescovile e nella visita del 1529. A pre-scindere infatti da una ulteriore breve puntualizzazione sul problema dei lega-ti pii e dei testamenti, un tema tra l’altro già affrontato nella serie editale suc-cessiva alle prime visite vicariali e più sporadicamente tra gli ordinata diqualche parrocchia – «admonisca in chiesa che si exeguiscano i testamenti,maxime ad pias causas, et in quanto peccato et pericolo sono quelli che ciònon fanno, et che non ponno essere assoluti; et in tutte le feste al men solenniadmonisca et richieda che chi sa de tali testamenti non exeguiti li manifesti alprete, et esso li facci intendere al superiore secondo che intende»140 – tra le ri-ghe del Breve ricordo non compaiono nuove indicazioni che possano essereagevolmente collegate all’intenso coinvolgimento del presule sul fronte delleres ecclesiae che di lì a breve venne messo in atto. In parte, questo costituisceuna ulteriore conferma di quanto abbiamo anticipato poco sopra, sul fatto chela visita personale del 1530 costituì un evidente spartiacque nell’azione del
26 A. Ferrarese
138. Prosperi, Note in margine a un opuscolo di Gian Matteo Giberti, cit., p. 372.139. Breve ricordo, edito in Prosperi, Note in margine a un opuscolo di Gian Matteo
Giberti, cit., p. 395. Nella parrocchia urbana di S. Paolo in Campo Marzio (1529) – «quiadatum fuit inventarium, ut ante registratum, intricatum et imprefectum» – venne imposto distenderne una nuova versione «in quo describantur singula bona de per se separatim tam ec-clesiae quam cappellarum» [VP III, p. 1562]. Le norme «definitive» per la stesura degli in-ventari di pievi e parrocchie – in cui sono facilmente riscontrabili molte delle «pratiche» giàutilizzate nelle legittimazioni dei feudi vescovili di Monteforte e Bovolone – vennero stabi-lite solo nelle Costituzioni per il clero del 1542: queste prevedevano che «assumptis secumduobus antiquioribus de populo (in quo sita est dicta ecclesia vel locus pius), una cum rec-tore seu sindico populi praedicti, faciant inventarium de omnibus bonis, mobilibus et im-mobilibus, ecclesiarum et locorum praedictorum, annotando in uno vel pluribus foliis om-nia vasa sacra vestes supellectilia fundos agros domos cum qualitatibus et confinibus suis,scribendo per se vel per alium, cum subscriptione assumptorum praedictorum, si sciant scri-bere, alias cum subscriptione notarii, qui de eorum praesentia ac diligentia fidem faciat.Quo inventario facto, illiusque apud se uno exemplari autentico, altero vero in manibus sin-dici seu consiliariorum relicto, infra quindecim dies praesentare teneantur tertium officionostro» [CO, p. 560-562].
140. Breve ricordo, edito in Prosperi, Note in margine a un opuscolo di Gian MatteoGiberti, cit., p. 399-400.
Giberti, nelle modalità «investigative» e indubbiamente nelle soluzioni propo-ste.
Il primo problema ad essere affrontato nel 1530, che in parte si riallaccia-va ad alcune sporadiche anticipazioni già emerse nella visita dell’anno prece-dente, fu quello attinente alla quantificazione delle entrate di ogni pieve, par-rocchia o cappella. I numerosi ordinata in merito alla esibizione di «omnes etsingulos introitus et tam ecclesie quam clericorum pro conficiendo estimo»141
non dovrebbero lasciare dubbi sulle effettive intenzioni del presule. La que-stione appare però leggermente più complessa, dal momento che le indicazio-ni dei verbali non lasciarono semplicemente trasparire la volontà dell’episco-pato di conoscere l’esatto ammontare delle rendite delle chiese soggette allapropria giurisdizione, bensì anche precisi cenni al fatto che la questione si ri-ferisse alla contorta faccenda del rinnovo dell’estimo del clero (i. e. all’estimoattraverso il quale il corpo clericale delle città e del territorio contribuiva allatassazione statuale veneziana): «ad dandum computum introituum eiusdemplebis pro reficiendo estimo dominis deputatis ad hoc in civitate Veronae»142.Il problema non era di poco conto, anche perché nel merito dell’estimo e delsuo rinnovo (l’ultimo risaliva addirittura alla fine del quattrocento) era in cor-so da decenni una annosa diatriba che opponeva al clero, desideroso di rinno-vare i suoi coefficienti estimali, indubbiamente calati dall’ultima redazione, lacittà per motivi che dovrebbero apparire altrettanto ovvi143. Pare forse possibi-le ipotizzare una azione congiunta tra episcopato e città per risolvere le anno-se questioni estimali e aggiornare l’estimo fermo ad almeno cinquanta anni
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 27
141. VP II, p. 448 (Sommacampagna), 455 (Palazzolo: «dedisse cedulam intrituum dic-tae plebis ad hoc ut extimum refici possit»), 504 (Brenzone), 607 (S. Floriano), 661 (BadiaCalavena), 669 (Cazzano), 697 (Moruri), 701 (Albisano), 709 (Zevio: «pro reficiendo esti-mo generali»), 714 (Albaro),
142. VP II, p. 544 (Sirmione), ma pure ibid., p. 501 (Pai: «mittat cedulam introituumdominis deputatis Veronam pro reficiendo estimo), 562 (Peschiera), 619 (Breonio: «quo adestimum dixit [il rettore] […] se cedulam exhibuisse introituum dominis deputatis sive revi-soribus»), 718 (Belfiore d’Adige: «cedulam introituum illius pro reficiendo estimo in mani-bus reverendi domini commissarii praefati reverendissimi domini in civitate Veronae»), 721(Ronco), 729 (Tombazosana), 736 (Oppeano), 738 (S. Giovanni Lupatoto), 740 (Cadida-vid), 743 (Vigasio), 747 (Povegliano), 751 (Bagnolo), 753 (Roncolevà), 758 (Fagnano),766-767 (Bonferraro), 769 (S. Pietro in Valle), 771 (Nogara), 776 (Roncanova), 779 (Cor-rezzo), 781 (Campalano), 784 (Engazzà), 785 (Bionde di Visegna), 789 (Concamarise), 794(Casaleone), 798 (Cerea), 803 (S. Pietro di Morubio), 804 (Roverchiara), 808-809 (Angia-ri), 817 (Legnago), 820 (S. Pietro di Legnago), 822 (Vangadizza), 829 (Canove), 834 (Ca-stagnaro), 836 (Nichesola), 839 (Terrazzo), 848 (Minerbe), 862 (Albaredo), 871 (Isola del-la Scala), 879 (Grezzano), 887 (Villafranca).
143. Tali importanti questioni sono state ampiamente trattate da G. Borelli, Aspetti eforme della ricchezza negli enti ecclesiastici e monastici di Verona tra sec. XVI e XVIII, inChiese e monasteri a Verona, cit., p. 124, passim, 136-138. Nell’ipotesi che gli interventigibertini de aestimo siano riferibili al problema del rinnovo dell’estimo del clero, non va di-menticato che già qualche decennio prima la stessa questione aveva sollecitato l’interventodel presule «riformatore» Ermolao Barbaro, come ricorda De Sandre Gasparini, Vescovi evicari nelle visite pastorali del tre-quattrocento veneto, cit., p. 597.
prima? Perché, ad esempio a Montorio si segnalava che la presentazione dellacedula dei redditi sarebbe servita «ad hoc ut estimum refici possit pro omniumbono comuni»144? Le scarse informazioni che sono desumibili dalla visita nonpermettono purtroppo di sciogliere le riserve nel merito della questione: po-trebbe non essere illogico presupporre che la raccolta dettagliata delle infor-mazioni inerenti ai redditi ecclesiastici che, a partire da questa visita, divenneoltremodo capillare, abbia fatto balenare al presule e al commissarius Galetti,il cui nome compare spesso legato al problema de estimo reficiendo, la possi-bilità di revisionare uno strumento fiscale che andava a tutto danno della com-pagine ecclesiastica. La effettiva disponibilità di dati fiscali aggiornati e di pri-ma mano avrebbe sicuramente garantito una ricognizione esaustiva ed unanuova divisione dei carichi: ma nonostante i cenni, come dicevamo, tutto ri-mane alla stregua di una ipotesi da verificare, anche considerando l’ulteriore enon remota possibilità che le operazioni di ricognizione fiscale messe in attonel 1530, potessero servire ad una più precisa ripartizione della tassazioneepiscopale.
Alla verifica complessiva delle rendite ecclesiastiche della diocesi si ac-compagnò una specifica considerazione per gli instrumenta con cui potevanoessere tutelati i diritti delle chiese: non mancarono, tra gli ordinata, ammoni-zioni ad alcuni parroci affinché si preoccupassero di recuperare quanto primale carte della dotazione beneficiale145. A Pacengo, ad esempio, nel maggio del1530 venne intimato al rettore «quod studeat et curet diligenter invenire scrip-turas ad rem huiusmodi facientes, quae de facili inveniri poterunt penes domi-num Leonellum de Leonibus, notarium episcopalis Curiae»146, un episodio ingrado inoltre di confermare che la riorganizzazione dell’archivio episcopalepoteva dirsi conclusa. Analoga cura venne riposta nel controllo della redazionedegli inventari di beni, a cui già da tempo erano stati obbligati i pievani e i ret-tori delle cappelle minori, assieme ai gestori laici dei loca pia. Anche in que-sto caso gli esempi potrebbero essere molti: ad esempio, al massarius dell’o-spedale di Lazise si ordina «quod faciat bonum librum affictualium»147, mentreinvece ad Albaredo il presule, dopo aver creato alcuni «procuratores, actores,revisores et dictarum [della fabrica] rationum et computorum calcolatores», liobbligò nel contempo «quod, factis calculatis rationibus, faciant librum, quempraesentare teneantur eidem reverendissimo domino cum nominibus affictua-lium distinctis et separatis, ad hoc ut videri possit summa dictorum introi-tuum»148.
Precise disposizioni vennero prese anche per l’annoso problema dei testa-menti e dei legati pii, presenti quasi ovunque nelle parrocchie visitate, così
28 A. Ferrarese
144. VP II, p. 704.145. L’ordine venne esteso anche alle cappelle di dotazione laica, cfr. ad esempio le
Monitiones generale, cit., §V, cap. 8, p. 224: «si in ecclesiis sunt capellae dotatae, dicant [iparroci] nomina patronorum, valorem, et gravamina».
146. VP II, p. 469.147. VP II, p. 472.148. VP II, p. 860.
come ovunque disattesi dagli eredi o dagli esecutori che, nei casi più eclatanti,arrivarono addirittura a rubare le prove del loro debitum («furto ablata sunt in-strumenta sive libri in quibus huiusmodi legata descripta erant»)149. I richiamidel vescovo150 e gli ordinata ai parroci (e ai notai per la regestazione obbliga-toria dei lasciti testamentari nell’archivio della curia vescovile)151 si infrange-vano spesso contro un’astiosa volontà di non pagare: tra i verbali si sprecava-no gli ordinata «quod illi ad quos huiusmodi tanguerat quaerant et in lucemproducant sive instrumentum sive testes sive quaecumque possunt habereiura»152, oppure gli appelli ai pievani e ai parroci «quod studeant et invigilentquod legata quaecumque ad pias causas adimpleantur»153. Ovunque pareva ri-
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 29
149. VP II, p. 517 (Manerba).150. Cfr. ad esempio quelli contenuti nelle citate Monitiones generales, cit., §III, cap.
14, p. 221: «anniversaria, eleemosynae, legata solita, et alia onera debitae executioni man-dentur»; oppure quelli rivolti ai membri del clero diocesano perché «advertant et referant delegatis piis» [Ibid., §III, cap. 20, p. 222] e perché «curent, ut legata ad pias caussas adim-pleantur» [Ibid., §V, cap. 48, p. 227]; l’inadempienza era contemplata invece tra i Casus re-servati, in CO, p. 731 («de his qui pro legatis ad pias causas infra tempus a iure vel ab ho-mine statutum non satisfecerunt, vel Ordinario non denuntiaverunt». Tali disposizioni tro-varono poi ampio risalto nella citata compilazione apologetica del familiaris Zini, Boni pa-storis exemplum, cit., p. 280 («legata, et pias defunctorum voluntates exeguantur»). Tutte ledisposizioni sulla materia, unitamente ad un edictum pro legatis piis del 3 marzo 1540, ven-nero infine raccolte nelle CO, p. 578-586 (tit. VIII, cap. 11-12: De relictis ad pias causasexequendis e De fideicommissariis).
151. Una prima disposizione in tal senso si trova nell’editto «miscellaneo» emanato trala fine del 1524 e gli inizi del 1525, cfr. quindi Joannis Matthaei Giberti episcopi veronen-sis vita, cit., p. IX: «executores relictorum ad pias caussas infra tempora deputata, seu a jurestatuta illa exegui; notarii ipsa legata exhibere»; in seguito meglio definito dalle Costituzio-ni per il clero del 1542: «teneantur, postquam testamenta ipsa morte confirmata fuerint, siin civitate nobis vel vicario nostro, si vero in diocesi fuerint et ad civitatem venire vel mit-tere noluerint rectori parochialis ecclesiae, sub qua conditum est testamentum, dictorum le-gatorum exemplum exhibere infra tempus duorum mensium» [CO, p. 588]. Le stesse Costi-tuzioni prevedevano inoltre la sistematica e ordinata raccolta di tale materiale: «et ut horumlegatorum memoria facilius conservari possit, statuimus et ordinamus ut in nostra curia epi-scopali teneatur unus liber, in quo illa specialiter describantur per notarium ad id deputan-dum» [CO, p. 588-590]; una conferma della esistenza nell’archivio vescovile di tali raccol-te si evince invece da un passo di Zini, Boni pastoris exemplum, cit., p. 294: «omnia legataex privatis et legitimis testamentis, quae vel superioribus annis facta sunt, vel quotidie fiunt,in codices magnos referenda curavit». Cfr. anche. Fasani, Verona durante l’episcopato diGian Matteo Giberti, cit., p. CXXXI; mentre alcuni esempi di ricezione post-tridentina ditale prassi si hanno in E. Petrucci, Vescovi e cura d’anime nel Lazio (sec. XIII-XV), in Ve-scovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, cit., v. I, p. 458 e in E. Cattaneo,Il primo Concilio provinciale milanese (A. 1565), in Il concilio di Trento e la riforma tri-dentina, cit., v. I, p. 268.
152. VP II, p. 467 (Castelnuovo).153. VP II, p. 527 (Padenghe). Anche ibid., p. 523 (Soiano: «legata relicta dictae eccle-
siae mandavit eisdem presbytero et consulibus loci ut pro illis adimplendis sollicitent illos,qui ad illa admplenda tenentur»), 595 (S. Giorgio di Valpolicella: «fiat diligentia de inve-niendo instrumenta huiusmodi legatorum et videatur an sint in manibus domini syndici velmassarii dominorum clericorum eiusdem plebis»).
petersi un medesimo «rituale»: dove non erano scomparse del tutto le carte egli instrumenta, le minacce di scomunica non erano minimamente in grado diirretire gli inobbedienti154. Più dettagliate furono anche le disposizioni suimassarii e sulla loro nomina (sia che si trattasse di beni pievani che di confra-ternite laicali e loca pia): per la prima volta venne fissato il terminum annualedella carica155, mentre divenne sempre più stretto il legame con la chiesa gra-zie al controllo che i referenti ecclesiastici locali vennero chiamati a svolgeresul loro operato156.
Accanto agli interventi che in certo qual modo sono riconducibili al mo-mento ispettivo della visita, oltre agli ordinata specifici emanati a sanare di-sordini e frodi evidenti, tra i verbali della prima visita personale comparvero,anche se in modo discontinuo, alcune tracce di quello che possiamo ritenere innuce il «blocco» normativo espressamente dedicato dal vescovo alla gestionedei beni ecclesiastici e che appunto trovò la sua codificazione massima oltreche nelle Costituzioni del 1542, in quelle specifiche per le pievi rurali e nellaserie di testi a stampa che iniziarono a circolare negli anni seguenti. Come ac-cennato, si tratta di scarsi indizi che non possono nemmeno essere integrati da-gli atti della Cancelleria, per questo torno d’anni assai lacunosi, quando non ir-
30 A. Ferrarese
154. In merito al problema della difficile esazione dei legati ad pias causas le testimo-nianze della visita del 1530 sono alquanto numerose, cfr. ad esempio VP II, p. 453 (Valeg-gio), 456 (Palazzolo), 462 (Sandrà), 477 (Cisano), 482 (Garda), 510 (Portese), 516-518(Manerba), 532 (Lonato), 539 (Rivoltella), 544 (Sirmione), 546-547 (Pozzolengo), 555(Monzambano), 578 (Brentonico), 585 (Peri), 586 (Dolcè), 605-606 (Settimo di Pescanti-na), 621 (Prun), 667 (Cellore d’Illasi), 669-670 (Cazzano), 688 (Marcellise), 728 (Tomba-zosana), 757-758 (Fagnano), 794 (Casaleone), 797 (Cerea), 821 (S. Pietro di Legnago), 847(Minerbe), 869-870 (Isola della Scala), 886 (Villafranca), 889 (Quaderni).
155. VP II, p. 448 (Sommacampagna: «mandatum fuit quod de cetero singulis annisunus novus massarius fiat pro gubernatione dictae ecclesiae), 621 (Prun: «mandavit … quodille sive alius de novo creandus massarius de anno in annum reddant rationem de exactis etadministratis dicto capellano vel alii pro tempore existenti et duobus vel tribus per dictumcomune et homines deputatis»), 629 (Poiano).
156. Prosperi, Di alcuni testi per il clero nell’Italia del primo cinquecento, cit., p. 154.Cfr. quanto previsto dalla raccolta delle Monitiones generales: «videant [i parroci] rationessocietatum, ut redditus bene expendantur» [Ibid., §III, cap. 12, p. 221]; «quod manuteneatursocietates … et quod procuret rector, sive pro tempore existens capellanus, quod omni annofiant rationes per illarum massarios, et rasonerios» [Ibid., §V, cap. 1, p. 223]; in merito allepene per gli inadempienti cfr. quanto disposto dai Casus reservati, cit., p. 732 («Item prae-cipit [il vescovo] pari modo moneri omnes regentes aliqua hospitalia consortia charitatesvel alia pia loca, quod sub poena excommunicationis bona et redditus dictorum locorum fi-deliter dispensare procurent ad usus destinatos et de talibus administratoribus rationem red-dant singulis annis, quibus de iure reddenda est; alias publicabuntur excommunicati in Oc-tava Resurrectionis»). Cfr. anche P.F. Zini, Boni pastoris exemplum, cit., p. 283 («idem [i.e. le pratiche di una corretta amministrazione] in societatum, et disciplinarum proventibusservatur»), 289 («a procuratoribus ratio proventuum, fabricarum, disciplinarum, et societa-tum exigitur; ac si quid in rem suam converterint, coguntur restituere»); le ultime disposi-zioni in merito sono quelle delle CO, p. 572-578 (tit. VIII, cap. 9-10: De reddendo compu-to administrationum locorum piorum singulis annis coram nobis seu aliis per nos deputatise De sindicis remanentibus debitoribus).
rimediabilmente perduti: tra gli innumerevoli interventi del presule si delineò,in altri termini, il primo abbozzo di un insieme di disposizioni che avrebberoaiutato e difeso il clero in cura d’anime nella non facile gestione del patrimo-nio loro affidato. In parallelo con il Breve ricordo, espressamente dedicato allacura animarum e alle caratteristiche di disciplina e di moralità che il clero erachiamato a rispettare e fare proprie, tra gli ordinata e i decreti emanati in visi-ta parve prendere forma un corpus di istruzioni sempre più dettagliato, seppu-re ancora legato il più delle volte alla eventualità della situazione.
Il problema più grave per la proprietà delle pievi e delle parrocchie deriva-va da una prassi costante di abusi, di usurpazioni e di debiti di cui queste sitrovavano spesso gravate: e ancora una volta gli esempi da proporre sarebberomolti. Non si contavano le chiese che vantavano spesso «aliqua credita et inbona quantitate contra quosdam, qui negligunt illa satisfacere»157, chiese fro-date dai debitori, come pure dagli amministratori a cui invano il vescovo si ri-volgeva ricordando «quod non differant tantum quantum soliti sunt differre infaciendis computis et rationibus»158. Al di là dei richiami verbali e delle fre-quenti ammonizioni159, fu con questa prima visita che si concretizzarono e pre-sero forma specifiche norme di gestione ed amministrazione: così ad esempioad Albaro, nel settembre del 1530, venne fatta per la prima volta menzione diun decreto «superioribus diebus emanati ab eodem reverendissimo dominocontra debitores ecclesiarum et presertim illarum quae reparatione indigent»,subito applicato al «conductor introituum eiusdem ecclesie»160. Nel contempoapparve, seppure ancora sporadicamente, una precisa considerazione alle tipo-logie dei contratti con cui i fondi delle pievi e delle parrocchie erano stati affit-tati161; quando le usurpazioni erano patenti, il presule ordinava, come a Casta-
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 31
157. VP II, p. 488 (Pesina).158. VP II, p. 763 (Pontepossero).159. Cfr. ad esempio quelle contenute nei Casus reservati, cit., p. 728: «de occupanti-
bus res sacras aut bona et iura episcopatus et aliarum ecclesiarum vel piorum locorum, eo-rumque (si sciunt) occupatores non revelantibus»; o nelle CO, p. 568-570 (tit. VIII, cap. 6-7: Contra occupatores decimarum et aliorum ecclesiasticorum bonorum e De investigandishuiusmodi occupatoribus et miserabilium presonarum oppressoribus).
160. VP II, p. 714. Lo stesso decreto è plausibilmente applicato anche nella pieve diSanguinetto, in cui vengono sequestrate le decime per le necessità della chiesa; le entratedel pievano vennero «liberate» solo dopo che il nobile Antonio Verità garantì personalmen-te mediante una fideiussione «et obligavit se in ampliori formae camerae de exequendoquaecumque imposita fuerint per dictum reverendissimum facienda in dicta ecclesia San-guinedi» [Ibid., p. 795].
161. A prescindere dalla durata decennale dei contratti di locazione fondiaria applicatinelle possessioni della mensa vescovile e di cui abbiamo detto in precedenza, mancano pre-cise disposizioni nel merito tra i testi a stampa della normativa gibertina; un generico cennoa tale proposito è contenuto in un capitolo inedito nel manoscritto delle Costituzioni per ilclero del 1542 (cassato nell’edizione a stampa) che così disponeva: «inhibemus … ne de re-bus suarum ecclesiarum … immobilibus sive preciosis mobilibus perpetuas sive ad longumtempus (et praesertim forma constitutionis super hoc a felicis recordationis Paulo papa IIeditae non servata) alienationes faciant (alienationis etiam largissimo sumpto vocabulo),sine licentia a nobis seu vicario nostro petita et obtenta» [CO, p. 720]. Il redattore del testo
gnaro, «quod de cetero non locentur, nec alicui concedantur in affictum nequeperpetuo, neque ad tempus»162 senza la azione congiunta del pievano e deglihomines loci; altrove, come nella ricca pieve di Isola della Scala, si controlla-va, davanti al rischio evidente che l’enfiteuta potesse «solvere minus eo quodin veritate posset et debere solvere»163, che l’ammontare del fitto corrispondes-se esattamente al valore dei terreni. Non mancarono poi le attenzioni all’onni-presente usura: a Manerba il Giberti davanti ad un contratto notevolmente sfa-vorevole al comune del luogo, costretto ad impegnare un proprio mulino, «re-scindit dictum contractum et illum nullum et invalidum sententiando declara-vit» – «attenta … contractus praedicti inhonestate» – concedendo alla comu-nità di restituire il debito «nisi ducatos 8 pro centenario»164. Mentre un altronotevole episodio che testimonia l’impegno del vescovo verso il problema deidebiti si verificò invece a Terrazzo, nella bassa pianura: in questo caso il ve-scovo autorizzò il massarius del luogo a «retrovendendi quosdam campos,alias minori precio satis quam valent» a quegli stessi che li avevano chiara-mente impegnati per contrarre un mutuo («illis tantum a quibus dicti campiempti fuerant»), recuperando in questo modo la somma prestata «sine dilatio-ne et continuo reinvestiantur ne pereant»165.
3. Gli anni delle «codificazioni»
Un primo accertamento sull’applicazione delle disposizioni e degli ordina-ta emanati nel corso della visita personale del 1530 venne effettuato dal vica-rio Filippo Stridonio a partire dall’aprile del 1532: e ovviamente gli inadem-pienti non si erano del tutto dileguati. In non pochi casi venne strenuamente ri-badita l’imprescindibile volontà di quantificazione della proprietà ecclesiasti-ca, da effettuarsi attraverso la presentazione delle polizze in vescovado166 e at-
32 A. Ferrarese
aggiunse al margine un richiamo ad un edictum vescovile «de innovandis locationibus inve-stituris plebium vel ecclesiarum et aliorum quorumcunque piorum locorum» [Ibid., p. 720,nota editoriale n. 17], di cui non viene indicata la data di emanazione e di cui non è statopossibile rinvenire traccia alcuna nella documentazione compulsata, ad eccezione del ri-chiamo nel §XVIII delle Costituzioni per le pievi riportate in Appendice (Documento 2). Inmerito invece all’estravagante Ambitiosae cupiditati di Paolo II (1468) – ripresa anche nelcapitolo 1 del titolo VIII delle Costituzioni per il clero [cfr. CO, p. 560] – v. ad esempio G.Chittolini, Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica fra quattro e cinque-cento. Locazioni novennali, spese di migliorie ed investiture perpetue nella pianura lom-barda, in «Rivista storica italiana», LXXXV, 1973, fasc. II, p. 362 (e rinvio in nota ad ulte-riore bibliografia).
162. VP II, p. 833.163. VP II, p. 870.164. VP II, p. 528.165. VP II, p. 838.166. VP II, p. 897 (S. Giovanni Lupatoto), 902 (Zevio), 905 (Palù), 1204 (S. Massimo
«extra muros Veronnae»: «faciat inventarium bonorum dictae ecclesiae, quod factum defe-rat Veronam inferius registrandum»), 1224 (Villafranca).
traverso la redazione di precisi inventari167, a cui appunto venne richiamato chiancora non si era adeguato. Con una certa insistenza ricorsero anche i proble-mi relativi alle confraternite168: in più occasioni il vicario ne controllò i com-puta annuali o addirittura mensili169, redatti alla presenza del parroco; inter-venne a recuperare alcuni bona ablata170, come pure a ricordare a quei massa-ri renitenti i loro compiti già ampiamente codificati dal presule171. Non manca-rono, poi, le incessanti esortazioni contro i «negligentes ad exigenda debi-ta»172, gli interventi per verificare la congruenza delle locazioni173 e la legitti-mità delle permute e delle vendite effettuate da chiese e cappelle174: nihil novi,nella sostanza, rispetto a quell’insieme di norme e di verifiche a cui il clero e ilaici coinvolti nella gestione del patrimonio ecclesiastico, erano stati chiamati
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 33
167. VP II, p. 896 (S. Giovanni Lupatoto: «praecepit [il vescovo al pievano] ei quodfieri faciat de novo inventarium bonorum ecclesiae manu notarii, per quem sibi fiat consi-gnatio in praesentia duorum vel trium hominum dicti loci»), 910-911 (Tombazosana), 914(Legnago: «decrevit … fieri facere unum cathastrum ad perpetuam rei memoriam»).
168. Utili indicazioni su tale «spinosa» questione per molti dei presuli pre- e post-tri-dentini si ricavano dalle note sommarie di G.-G. Meersseman, La riforma delle confraterni-te laicali in Italia prima del Concilio di Trento, in Problemi di vita religiosa in Italia nelcinquecento, cit., p. 17-30; mentre un esempio di interventi precedente il Concilio in unadiocesi contigua a quella veronese (e nello stesso torno di anni dell’operato gibertino) si hain M. Bendiscioli, Finalità tradizionali e motivi nuovi in una confraternita a Mantova delterzo decennio del cinquecento, in Problemi di vita religiosa in Italia nel cinquecento, cit.,p. 95 (obbligo di amministrare i bona tramite due massarii e rinnovo biennale delle cari-che).
169. VP II, p. 897 (S. Giovanni Lupatoto), 898 (S. Maria di Zevio), 916 (Legnago), 927(Terrazzo), 960 (Isola della Scala), 992-994 (Monteforte), 995 (Soave), 1001 (Colognola aiColli), 1010 (Vestenavecchia), 1049 (S. Anna d’Alfaedo), 1051 (Cavalo), 1052 (Monte),1054 (S. Ambrogio di Valpolicella), 1058 (Fumane), 1069 (Negrar: «mandavit etiam dictocapellano quod in termino unius mensis curet quod videantur computa massariorum socie-tatis beatae Mariae Virginis»), 1092 (Cavaion), 1123 (Costermano), 1131 (Torri del Bena-co), 1133 (Brenzone), 1143 (Bardolino), 1145 (Cisano), 1147 (Lazise), 1156 (Sirmione),1175 (Polpenazze), 1182 (Padenghe), 1187 (Lonato), 1192 (Pozzolengo), 1196-1197 (Mon-zambano), 1199 (Ponti sul Mincio), 1202 (Sandrà), 1213 (Valeggio sul Mincio), 1220 (Ba-gnolo), 1221 (Nogarole Rocca).
170. VP II, p. 921 (S. Pietro di Legnago).171. VP II, p. 975 (Nogara: «massarius dominorum clericorum dictae plebis male ver-
satur et parum est sollicitus in dicta sua massaria, quam facit per interpositas personas etpropterea pecuniae male expenduntuur»), 1035 (Marzana: «massari confraternitatis beataeMariae … non reddunt computum temporibus debitis de exactis per eos, prout tenentur sal-tem omni anno ex decreto reverendissimi domini episcopi»).
172. VP II, p. 914 (Legnago).173. VP II, p. 1075 (Pescantina: «renoventur locationes affictualium dictae ecclesiae,
quorum nomina descripta sunt in missali»).174. VP II, 1106 (Crusano: «revocavit [il vicario] contractum permutationis factae de
certis petiis terrarum dictae ecclesiae permutatis sine auctoritate superioribus, praesentibusdon Francisco, capellano plebis Brentonici et Stephano Billa, nuntio iurato episcopatus Ve-ronae et quod de tali revocatione idem don Franciscus notificare debeat populo infra missaesolemnia»), 1190 (Lonato: «in praedicto loco constito de evidenti utilitate ecclesiae, con-cessa fuit licentia … facendi duas permutationes»).
lentamente ma inesorabilmente a conformarsi, anche e soprattutto attraverso ladiffusione capillare di direttive e opuscoli a stampa175. Da questa prima verifi-ca è ancora molto difficile valutare la effettiva penetrazione e il «successo» delprogramma gibertino; a distanza di un decennio, la seconda visita personalesembrò tuttavia confermare appieno una quasi integra ricezione delle regole:certo, gli inadempienti non scomparvero, anche se d’altra parte tutta una seriedi significativi indizi rafforzano la sensazione di un ampio adeguamento nelladiocesi alle disposizioni del presule. Nel corso degli anni trenta l’attuazionedel progetto di controllo e di «riassetto» della proprietà ecclesiastica venneprogressivamente consolidandosi, pur ancora attraverso innumerevoli reticenzee difficoltà176. L’ultima visita pastorale compiuta personalmente dal presule nel1541 fornisce infatti un quadro della situazione molto più lusinghiero rispettoa quanto emerso nel decennio precedente: quasi per ogni pieve e parrocchia177
(ma anche per i loca pia178 e per i monti di pietà)179 i verbali visitali indicanocon scrupolosa esattezza i resti annuali compilati dai massari delle chiese e
34 A. Ferrarese
175. Su cui v. le note di Prosperi, Di alcuni testi per il clero nell’Italia del primo cin-quecento, cit., p. 147-155.
176. Nello stesso torno di tempo (1538) tra i pochi verbali superstiti della visita pastora-le alla diocesi di Belluno, compiuta dal cardinale Gasparo Contarini, vennero registrate pa-recchie disposizioni inerenti la gestione della proprietà ecclesiastica, «in sintonia» con quan-to emerso dal caso veronese. Si ordinarono, ad esempio, gli inventari dei bona: «fiat manda-tum ut veniant ad denuntiandum bona et iura» [De Boni, Il cardinale Gasparo Contarini ve-scovo di Belluno, cit., p. 476] ; ma anche la verifica delle cessioni: «videantur permutationesfactae de bonis ecclesiae» [Ibid., p. 476]. Le norme inerenti la redazione degli inventari ven-nero infine codificate tra i capitoli delle Costituzioni emanate dal vicario del Contarini nelnovembre del 1542 [Ibid., p. 488]: «volentes insuper ecclesiarum et benefitiorum providereincolumitati, volumus et mandamus quod omnes et singuli benefitiati teneantur et debeantconfecisse sive confici fecisse inventarium bonorum et rerum ac iurium omnium ad sua be-nefitia spectantium sub scribendum per cancellarium nostrum et hoc in termino unius anni adie publicationis praesentium, sub poena ducatorum quinque auri et supra applicanda et subpoena suspensionis a divinis pro quolibet contrafactore» [Ibid., p. 491].
177. Cfr. per alcuni esempi (in un elenco che sarebbe comunque molto più lungo) VPIII, p. 1233 (Buttapietra), 1237 (Isola della Scala), 1239 (Pellegrina di Isola della Scala),1240 (Engazzà), 1242 (Tarmassia), 1244 (Salizzole), 1245 (Bionde di Visegna), 1248 (Ca-saleone), 1259 (Pontepossero), 1288 (Roverchiaretta), 1289 (Roverchiara), 1303 (Porto diLegnago), 1319 (Minerbe), 1347 (Moruri), 1351 (Montorio), 1353 (Quinto), 1374 (Ca-vaion), 1380 (Pesina).
178. Interessanti spunti, con riferimento alle legislazioni vescovili e alle disposizionivarate dopo il tridentino in A. Turchini, I «loca pia» degli antichi stati italiani fra societàcivile e poteri ecclesiastici, in Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d’Euro-pa, cit., p. 369-409 (con rimandi alla normativa elaborata a Trento); M. Garbellotti, Visitepastorali e «loca pia» tra legislazione e prassi: il caso di Trento (secc. XVI-XVIII), in Fon-ti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d’Europa, cit., p. 411-440; A. Pastore,Strutture assistenziali fra Chiesa e Stati nell’Italia della Controriforma, in Storia d’Italia,Annali 9, cit., p. 439, 453, 456, 463; Id., Usi ed abusi nella gestione delle risorse (secoliXVI-XVII), in L’uso del denaro, cit., p. 38-39.
179. VP III, p. 1237 (Monte di pietà di Isola della Scala), 1288 (Monte di pietà di Ro-verchiaretta).
delle confraternite al termine della loro carica180. Come dicevamo, anche inquesto caso gli inadempienti non sparirono: qua e là il presule dovette ancoraordinare alcune catasticazioni dei beni della fabrica parrocchiale181, imporre ilrinnovo dei fitti e delle locazioni182, imbattendosi non raramente in legati ine-satti183 e in amministratori poco solerti, come ad esempio nella pieve di Mon-zambano, dove nella locale confraternita della Vergine, «cuius visa fuere com-puta et calculatis quae calculare potuerunt ex angustia temporis, reperti fueredebitores, gubernatores eiusdem de anno 1540 tantum de libris 185 veronensi-bus, salvis etiam nonnullis praestitis ambiguis, prout in quadam poliza»184. Manonostante tutto, rimane indubbio che si trattò di episodi accessori, di sacchedi «resistenza» per certi aspetti isolate e marginali – soprattutto per numero eper diffusione – che non inficiarono il quadro di concreto adeguamento dellarealtà diocesana al «progetto» gibertino di cui abbiamo dato conto.
Valutando di conseguenza tali premesse, non pare del tutto fuori luogo po-ter affermare che la promulgazione delle Costituzioni per le pievi si inserì in uncontesto diocesano che da tempo ne aveva già ampiamente recepite le norme,avvezzo a buona parte delle regole e delle pratiche di amministrazione e di ge-stione che in esse vennero codificate nel 1540185; plausibilmente, le Costituzio-ni per le pievi, a differenza di quelle per il clero, non vennero mai stampate186:
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 35
180. Va ricordato che nel 1540 erano stati editi i Capitoli ordinati per Monsignor il Ve-scovo di Verona per governo delle Compagnie, et confraternite in tutta la diocesi sua [Ve-rona 1540]; la diffusione dell’opuscolo nella diocesi è ad esempio confermato da alcune in-dicazioni nella visita pastorale personale compiuta nel 1541: a Mozzecane il presule ricordòal massarius della locale Societas Corporis Christi di redigere i «computa et serventur ca-pitula, nuper a me tradita» [VP III, p. 1267]. Su questo importante documento – rimastoignoto ai Ballerini – v. la Joannis Matthaei Giberti episcopi veronensis vita, cit., p. XL:«Petrus Franciscus Zinus meminit quarumdam regularum, quae ad confraternitatum socie-tatumque moderationem compositae et impressae fuere; ex his quoque nihil modo reliquumest». Cfr. infine Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 272 (e note corrispon-denti) e R. Rusconi, Confraternite, compagnie e devozioni, in Storia d’Italia, Annali 9, cit.,p. 483-484, 485-486 che inquadra gli interventi sulle confraternite del Giberti nel panoramadelle esperienze pre- e post-tridentine.
181. VP III, p. 1293 (Cerea: «mandavit preterea fieri diligentem requisitionem de terriset bonis, ad dictam ecclesiam spectantibus, prout ad eius aures perlatum est, nonnulla bonaa quibusdam occupantur, spectantia ad dictam ecclesiam, quae forent recuperanda et exnunc concessit monitorium in forma et significavit contra detenentes et occupatores etscientes et non revelantes in forma»).
182. VP III, p. 1337 (Cazzano di Tramigna).183. VP III, p. 1306 (Vangadizza), 1325 (Albaredo), 1332 (Colognola ai Colli), 1370
(Bardolino), 1375 (Cavaion), 1382 (S. Zeno di Montagna), 1405 (Monica).184. VP III, p. 1423.185. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 210 (nota n. 80); Prosperi, Di
alcuni testi per il clero nell’Italia del primo cinquecento, cit., p. 148.186. Le Costituzioni per le pievi sono pervenute in due diversi manoscritti: la redazione
più antica è contenuta in una miscellanea capitolare di mano del familiaris gibertino AdamoFumano [BCAVr, ms. n. DCCLXXXIX, c. 113r-120v]; quella più recente è dovuta aglieruditi Ballerini che collazionarono il manoscritto capitolare con un exemplum delle Costi-tuzioni tratto dall’Archivio dell’episcopio, ora disperso [BCVr, Carteggi, b. 810 (=Carte
un fatto questo che rende quindi difficile una valutazione complessiva delle dueredazioni manoscritte rimaste, di cui non è neppure possibile determinare ade-guatamente il grado di perfezionamento. Le ultime visite pastorali del presule –che pure non mancano di abbondanti cenni sui decreti e sugli editti emanatinello stesso torno di tempo – non recano traccia di una loro diffusione tra ilclero della diocesi: l’unica testimonianza certa della loro entrata in vigore ri-mane un decreto del 23 aprile 1540 con cui il vescovo «constituit et ordinavit,quod massarii et syndici teneantur omnimode exequi decreta suarum constitu-tionum, praecipue in legitimandis iuribus et affictibus ipsarum plebium et pos-sessionum suarum, et in faciendo novas investituras cum sindicis contra con-ductores iuxta constitutiones sub poena in constitutionibus contenta, et procu-rent etiam exequi omnia alia, ad quae tenentur per formam suprascriptam»187.
È pure difficile stabilire con certezza i tempi redazionali delle Costituzioniper le pievi, anche se va da sé che tale fondamentale raccolta normativa dell’a-zione gibertina, non può non essere posta in stretta relazione con le più noteCostituzioni per il clero, abbozzate – secondo le ipotesi avanzate a suo tempoda Prosperi – nel periodo tra il 1536-1537 e il 1540 ed edite infine nel 1542188.Per quanto concerne il problema della proprietà ecclesiastica, tra i due docu-menti non mancano stretti punti di contatto, anche se appare evidente che ledisposizioni contenute nelle Costituzioni per il clero sui bona ecclesiastica esulla loro corretta amministrazione presentano tratti meno «tecnici» di quantoè invece raccolto in quelle per le pievi: i paragrafi delle Costituzioni per il cle-ro sono per molti aspetti assimilabili a monitiones – pur rappresentando il «do-cumento più organico e considerevole dell’opera del Giberti»189 – più che avere e proprie regole gestionali da osservare alla lettera e da applicare conscrupolosa attenzione, nell’attesa della annuale verifica dei rasonerii dell’epi-scopato. Questo non significa, d’altra parte, che le disposizioni «de rebus …ecclesiasticis conservandis», contenute nelle Costituzioni del 1542, sianomeno dettagliate delle norme raccolte in quelle per le pievi: le regole per laconfezione degli inventari come pure quelle destinate alla corretta gestione deilegati pii, mostrano chiaramente una grande attenzione alle modalità, ai tempie agli specifici compiti assegnati agli ecclesiastici, come ai laici della parroc-chia. D’altra parte, va però ribadito che all’interno dell’eterogenea strutturadella raccolta normativa del 1542, i paragrafi che riguardano la gestione deibona ecclesiae non presentano quell’organica completezza delle Costituzioniper le pievi, assimilabili concretamente, evidentemente anche nelle intenzioni
36 A. Ferrarese
Ballerini, b. XIX)]. L’esemplare capitolare è descritto in I manoscritti della Biblioteca Ca-pitolare di Verona. Catalogo descrittivo redatto da don Antonio Spagnolo, a cura di S.Marchi, Verona, 1996, p. 577-579.
187. Cfr. il Documento 2 in Appendice.188. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 257; più recentemente cfr. an-
che R. Pasquali, Le tre redazioni delle Constitutiones, in CO, p. LXXV-LXXXI e Id., LeConstitutiones per il clero di Gian Matteo Giberti, in «Ricerche di storia sociale e religio-sa», XX, 40, 1991, p. 231-237.
189. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 260.
dei redattori, ad una sorta di ordinato e sistematico «compendio» della ammi-nistrazione economica pievanale. Se dunque – parafrasando Prosperi – le Co-stituzioni per il clero rappresentarono «la codificazione estrema della riformadel clero»190, quelle dettate per le pievi furono senza alcun dubbio la massimaespressione dei progetti e delle aspirazioni gibertine per il «buon governo»delle res ecclesiae. Trattandosi, d’altra parte, di una raccolta normativa percerti aspetti «ideale», rimane complessivamente da verificare la loro ricezionenella diocesi, come pure la «fortuna» del testo191 – indubbiamente assai blandase paragonata ad esempio alle Costituzioni per il clero, riedite in diocesi anco-ra in pieno settecento192 –, anche in considerazione della prematura scomparsadel Giberti che seguì dopo qualche anno (1543).
Schematizzandone la struttura redazionale, i «blocchi» normativi delle Co-stituzioni per le pievi possono essere riassunti come segue:
- modalità per l’elezione annuale del sindicus e del massarius della pieve (§I-III): le norme dettate in questo senso dal presule evidenziavano la netta pre-ferenza per la scelta di personale «interno» alla collegiata dei chierici dellapieve, mentre la possibilità di affidare a laici tali delicati incarichi ammini-strativi poteva venire considerata solo come ultima istanza e non prima del-la presentazione di certe e confermate garanzie fideiussorie193, in mancanzadi candidati in gremio194. Il tassativo divieto per i pievani di accedere a talicariche garantiva, per certi aspetti, una sorta di controllo «incrociato» sulla
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 37
190. Ibid., p. 255.191. Una breve disamina della normativa emanata dall’episcopio veronese per le pievi
rurali della diocesi, tra XVI e XVIII secolo si ha in G. Forchielli, La pieve rurale. Ricerchesulla storia della costituzione della Chiesa in Italia e particolarmente nel veronese, Bolo-gna, 1938, p. 226-233 (che ricostruisce anche le successive elaborazioni ed integrazioni acui il testo delle Costituzioni per le pievi del Giberti venne sottoposto dai presuli veronesisei-settecenteschi).
192. Cfr. in merito Pasquali, Fortuna storiografica delle Constitutiones, in CO, p.XCVI-CI.
193. Nel veronese, di tale prassi è dato riscontro tra alcune disposizioni del vescovoquattrocentesco Ermolao Barbaro, cfr. quindi Cipriani, Per lo studio della visita pastoralealla diocesi di Verona (1454-1460), cit., p. 341. Ma pure nella diocesi bellunese durantel’episcopato di Gasparo Contarini, cfr. quindi De Boni, Il cardinale Gasparo Contarini ve-scovo di Belluno, cit., p. 476: «quilibet massarius teneatur praestare fideiussorem de suamassaria, et hoc observetur continuato tempore, tam in ipsa plebe quam in aliis plebibusBellunensis diocesis» (1538).
194. Una conferma della diffidenza, del timore e del conseguente controllo circospettonei confronti degli amministratori laici delle res ecclesiae si coglie, ad esempio, in unoscritto del 1540 di Tullio Crispolti, uno tra i membri più influenti e rappresentativi della fa-milia gibertina [su cui v. la scheda di Fasani, Verona durante l’episcopato di G. M. Giber-ti, cit., p. XCIV-XCVI]: nell’opuscolo dialogico Alcune interogationi delle cose della fede[Verona 1540] il Crispolti faceva rispondere in questo modo alla domanda provocatoria senon fosse stato meglio affidare ai laici la gestione dei beni ecclesiastici: «bisogna guardarea questi laici homini da bene, che voi dicete che havessero cura di queste intrate, et vederequel che hanno fatto delli hospitali, et di altri tali manegi, che hanno havuti, et come hannoridutto ogni cosa in niente [Ibid., §41, c. n. n.]. Su questo testo cfr. quanto scrive Prosperi,Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 279-280.
gestione economica della pieve: l’accumulo di tutte le cariche amministrati-ve nelle mani di una sola persona avrebbe di certo favorito quei noti episodidi conduzione «privata» delle entrate plebane, di cui pullulavano le verba-lizzazioni delle stesse visite pastorali gibertine. Va inoltre ricordato che lemodalità di revisione della gestione dei redditi pievanali, emerse dai primiparagrafi delle Costituzioni, confermano il consolidato funzionamento dellaraxoneria episcopale in cui ogni anno, al termine del mandato (cfr. anche il§XI), il massarius di ogni pieve doveva presentare il rendiconto consuntivodella sua attività195 («ad omne beneplacitum dominorum rasoneriorum ple-bium veronensis dioecesis», cfr. anche il §VI);
- modalità di divisione delle porzioni clericali (§IV-V): ogni anno, al momen-to della divisione delle entrate comuni, ogni massarius era obbligato a ri-chiedere l’elenco aggiornato dei chierici porzionati della propria pieve,esemplato ed autenticato dal notaio della fattoria episcopale, prima di pro-cedere nella spartizione delle entrate. L’attenzione per la collazione clerica-lium portionum costituì, d’altra parte, uno dei primissimi interventi già postiin atto durante l’amministrazione vicariale, di cui rimangono purtroppo po-che tracce negli elenchi di chierici negli atti della cancelleria episcopale196:il momento della pubblicazione delle Costituzioni per le pievi fu inoltre pre-scelto come terminus per una ulteriore verifica delle lettere di provvisionedei componenti delle collegiate clericali della diocesi (§V);
- controllo diretto della rasoneria episcopale sulla divisione delle entrate pieva-nali (§VI-VII): al termine dei raccolti (che in genere, come vedremo, deriva-vano prevalentemente per le pievi dall’affitto dei propri iura decimationis), trai mesi di ottobre e novembre, i massarii avrebbero dovuto consegnare le ce-dulae degli introiti delle pievi di loro competenza, assieme alle minute notari-li degli incanti decimali e ai capitoli che ne regolavano l’affitto. I rasoneriiepiscopali, sulla base della documentazione prodotta ogni anno, avrebberoquindi proceduto nelle divisioni dei redditi e delle spese, secondo lo schemadi ripartizione relativo a ciascuna pieve della diocesi (esemplificato, per lapieve di Colognola ai Colli, nel Documento 1 in Appendice);
- modalità di affitto delle decime (§VIII-X): le entrate decimali, almeno nelcaso delle pievi veronesi, costituivano di sicuro la quota più consistente del-le entrate197. Gli iura decimationis delle pievi, nella grande maggioranza dei
38 A. Ferrarese
195. È senza dubbio interessante notare come tali norme gibertine presentino patentianalogie con alcuni degli ordinata predisposti dal cardinale Gasparo Contarini nella citata vi-sita pastorale del 1538; tra i verbali superstiti si trovano precise disposizioni sui compiti deimassarii: «quilibet massarius cuiuslibet ecclesiae teneatur omni et singulo anno finita eiusmassaria reddere rationem suae massariae coram domino suo plebano vel rectore et illud to-tum de quo debetur remanserit teneatur et debeat illico dare et exbursare massario subse-quenti electo» [De Boni, Il cardinale Gasparo Contarini vescovo di Belluno, cit., p. 476].
196. Alcune copie di elenchi di collazioni beneficiali si trovano in CV, b. 3, fasc. di c.n. n., riferiti al periodo 1528-1539: si tratta comunque di materiale in uno stato di assai pre-caria conservazione.
197. Cfr. in merito A. Ferrarese, Il diritto di decima nel territorio veronese in età mo-derna. (La struttura e la gestione), in «Studi storici Luigi Simeoni», LIII, 2003, p. 85-161.
casi corrispondenti al noto quartese dell’area veneta (i. e. alla quarta partesuperstite dell’intero ius), erano generalmente fruiti in associazione con lecompagini laiche che detenevano i restanti tre quarti dell’originario dirittopievano198. Come è facilmente intuibile, l’estrema appetibilità della redditi-vità decimale, come del resto la frequente e congenita debolezza della parteecclesiastica nel difendere con fermezza i propri interessi, avevano creato (econtinuavano a farlo nello scorcio dei primi decenni del cinquecento) situa-zioni di patente sperequazione – se non di vero e proprio abuso e rapina –nella divisione annuale dei raccolti, a tutto danno delle pievi199. Non stupi-sce, infatti, che anche nelle Costituzioni per il clero del 1542 o nelle antece-denti Monitiones generales200 compaiano ampie esortazioni al corretto pa-gamento delle decime da parte dei fedeli201, come pure altrettanto pregnantidisposizioni contra debitores decimales; questo, non risolveva d’altra parteil problema delle divisioni delle entrate di decima e la astiosa convivenzacon un laicato perennemente disposto alla frode di quanto spettava alla par-te ecclesiastica. Fino a quando le modalità di affitto e di divisione delle de-cime rimanevano sotto l’egida «monopolistica» della parte laica, ben diffi-cilmente si sarebbe potuto sperare in una paritetica partecipazione agli in-canti pubblici e ai conseguenti introiti: questo spiega perché, per spezzaretale inveterate consuetudini, le Costituzioni del 1540 imposero la direttapresenza di referenti ecclesiastici agli annuali affitti del tributo, in rappre-sentanza della quota di decima detenuta. Nel veronese202 infatti, nell’intento
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 39
198. Per una rapida sintesi delle vicende storiche a cui le decime veronesi andarono in-contro si rinvia ai noti saggi di A. Castagnetti, La decima da reddito signorile a privilegioeconomico dei ceti cittadini. Linee di ricerca, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso me-dioevo (sec. XIII-XV), Roma, 1984, v. I, p. 215-233 e Id., Le decime e i laici, in Storia d’I-talia, Annali 9, cit., p. 509-530, unitamente alle integrazioni dello scrivente nella tesi di cuialla nota successiva.
199. Alcune esemplificazioni nel merito sono raccolte in A. Ferrarese, Il diritto di deci-ma per la storia della economia e della società rurale nella Terraferma veneta in età mo-derna, tesi di dottorato di ricerca in Storia economica, Università degli Studi di Verona, re-latori prof. G. Borelli e prof.ssa G. Vivenza, Verona, 2002, p. 371-495; come pure da G.M.Varanini, Problemi di storia economica e sociale della Valpolicella nel cinquecento e pri-mo seicento, in La Valpolicella nella prima età moderna, cit., p. 123-124: l’autore riporta,sulla scorta di una documentazione riferibile agli anni cinquanta-sessanta del cinquecento,che «‘eserciti d’homeni armati’ scoraggiano preventivamente con minacce e ricatti chi in-tenda concorrere agli incanti, e se qualcuno si presenta ‘solo con una guardatura torta se lolevan dinanzi’. Così bravi, sicari, omicidi e banditi ‘vestono, cavalcano e si dan bon tempocon l’entrata delle decime delle povere chiese’» [Ibid., p. 123].
200. Sulle caratteristiche di questa raccolta, «sunto eterogeneo, non ancora sistematica-mente strutturato, delle Constitutiones», cfr. R. Pasquali, Storia del manoscritto delle Con-stitutiones, in CO, p. LXXXVII.
201. Cfr. ad esempio le Monitiones generales, cit., §V, cap. 22, p. 225: «quod populummoneant [i pievani e i parroci], et informent ad integram solutionem decimarum» e i Casusreservati, cit., p. 732: «Item mandat [il vescovo] moneri omnes, qui ad solutionem decima-rum tenentur, quod illas puras integras et non corruptas solvere studeant, alias sacrilegi suntet absolvi non possunt nisi integre satisfaciant».
202. Tali pratiche di decimazione sono attestate per l’intera area veneta di età moderna
di scansare le notevoli spese di raccolta e di stoccaggio dei prodotti decima-ti, era prassi che i detentori dello ius (i. e. la pieve assieme agli altri laici)affittassero annualmente al pubblico incanto la raccolta dei generi esatti203;l’asta avveniva in concomitanza della maturazione dei raccolti, in genere tramaggio e giugno per i grani maggiori, tra agosto e settembre per i grani mi-nori e tra ottobre e novembre per le olive. Gli appaltatori che si fossero ag-giudicati il pubblico incanto erano in seguito sottoposti ad una serie di vin-coli e di patti (i capitoli d’incanto) inerenti, ad esempio, alla qualità dei pro-dotti da consegnare ai decimatori, oppure alle modalità di misurazione deglistessi o alle norme di compensazione (ristoro), nel caso in cui le avversitàclimatiche o belliche avessero compromesso parte dell’intero raccolto. L’o-biettivo peculiare delle Costituzioni per le pievi fu quindi teso al recuperodel ruolo primario della quota rappresentata dal quartese delle pievi nelleannuali operazioni di affitto e di divisione (considerando inoltre che spesso,nella frammentata struttura delle quote laiche, il quarto ecclesiastico costi-tuiva la parte percentuale più consistente): solo infatti con la presenza diret-ta agli incanti, con la sottoscrizione notarile delle minute di affitto e con ilrispetto puntuale dei contratti (dei quali la rasoneria pretendeva la copia au-tentica), ma anche con la conseguente esclusione del clero e degli ammini-stratori della pieve dal ruolo di affittuali (i decimales), sarebbe stata salva-guardata la corretta ripartizione dei cospicui introiti decimali ed evitatequelle forme di collusione tra massarii e proprietari laici del diritto, di cuirimangono abbondanti testimonianze tra le carte archivistiche veronesi;
- modalità di controllo delle spese (§XII): nel rispetto del recupero del ruolocollegiale, la decisione di porre mano ad ogni spesa inerente la pieve venivavincolata alla decisione dell’intero capitolo; mentre nel pagamento dellespese veniva data precedenza alle tasse imposte dall’episcopio e alle neces-sità impellenti della pieve (§XXIII);
- modalità di convocazione del capitolo (solo in seguito all’autorizzazione delvescovo) e di svolgimento dell’assemblea e delle votazioni (§XIV-XVI);
- prescrizioni varie: divieto di affittare il beneficio senza licenza dell’episco-pato (§XVII), necessità di controllare le investiture e i fitti, rinnovando i ca-noni troppo vecchi (§XVIII).
In conclusione, riprendendo una domanda abbozzata parzialmente appenasopra, rimane tutta da verificare la effettiva «operatività» delle Costituzioni perle pievi: la morte del presule interruppe un ciclo e segnò la fine di una progettua-lità indefessa nella diocesi veronese. Alla resa dei conti, come ben sintetizzòProsperi, la scomparsa del Giberti portò con sé l’immensa struttura che era stataposta in essere a Verona, nonostante gli ultimi e strenui sforzi del vescovo per
40 A. Ferrarese
e presentano, nel contempo, molte analogie con la consuetudine di molte regioni europee diancien régime (in particolare Francia e Spagna), cfr. la bibliografia alla nota seguente.
203. Cfr. in merito alle complesse e «rituali» modalità dell’affitto di decima A. Ferrare-se, Ius incantandi. Note sull’affitto di decima nella Terraferma veneta in età moderna. Ilcaso veronese, in «Storia economica», in corso di stampa.
«arginare le conseguenze che la sua scomparsa poteva produrre in una diocesi ri-caduta nelle mani di vescovi non residenti»204: e l’oblio durò almeno fino alConcilio che ne riscoprì e ne valorizzo ampiamente l’operato, pur «snaturando-ne» in parte il programma, togliendo cioè «ogni apprezzabile continuità proprioin quello che era stato il suo terreno di elezione, la diocesi»205. Considerate talipremesse, diventa quindi estremamente difficile poter valutare appieno se e inquale modo le norme gestionali ed amministrative raccolte nelle Costituzioni perle pievi vennero recepite e adottate nella diocesi. Di certo, come accennato, nongodettero della fortuna «editoriale» delle Costituzioni per il clero, mentre nessu-na loro traccia compare tra le verbalizzazioni dell’ultima visita pastorale del1541: plausibilmente, scomparvero rapidamente assieme a molte delle esempla-ri istituzioni gibertine, nella fretta di un oblio con cui ampi strati dell’élite eccle-siastica della diocesi, capeggiata dagli agguerriti canonici della Cattedrale, spe-ravano di poter rapidamente recuperare lo status quo pre-gibertino. E le testimo-nianze in questo senso non mancano: si pensi solo al fatto che «qualche annodopo, il suo [della diocesi veronese] stato di decadenza morale e disciplinare co-stituiva argomento di riflessione per i padri conciliari riuniti a Trento»206.
Ad una più attenta analisi non sfugge che il progetto sotteso alle Costitu-zioni per le pievi – cioè il recupero di una centralità amministrativa pievanale,fortemente radicata ad una collegialità clericale «attiva» – potesse per moltiaspetti risultare anacronistico in un’epoca in cui da tempo la pieve rurale«stava attraversando una grave crisi»207, avendo ormai perduto il ruolo aggre-gatore. A prescindere dall’attribuire al Giberti una «mentalità archeologi-ca»208, si potrebbe obiettare che nonostante i manifesti segni di disgregazionedell’organismo collegiale, le pievi continuavano a rappresentare uno, se non ilpiù importante punto nevralgico della proprietà ecclesiastica veronese: solouna scorsa alle polizze d’estimo cinquecentesche e seicentesche conferma cheattorno all’istituto pievano seguitavano a gravitare patrimoni ingenti, decime,livelli e proprietà fondiarie di ampie proporzioni. Più che un recupero toutcourt di un organismo del passato, le norme gestionali delle Costituzioni perle pievi vanno quindi piuttosto inquadrate in un disegno teso a recuperare, en-tro strutture ampiamente collaudate, ancorché da troppo tempo desuete, unaunità amministrativa territoriale, la pieve, agente di un controllo entro i limi-tes della propria circoscrizione foranea, e a sua volta completamente innesta-ta nelle rigide maglie di una burocrazia vescovile progressivamente semprepiù onnipervasiva.
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 41
204. Prosperi, Tra evangelismo e controriforma, cit., p. 320.205. Ibid., p. 327.206. Ibid., p. 325.207. Ibid., p. 144; anche Prosperi, Tribunali della coscienza, cit., p. 323: «l’antica pieve
rurale lasciò il posto alla moltiplicazione di chiese parrocchiali; si trattò di un processo len-to e non uniforme, che trovò comunque in età tridentina una forte accelerazione, grazie al-l’opera di vescovi come Gian Matteo Giberti e Carlo Borromeo».
208. J. Bossy, L’occidente cristiano 1400-1700, Torino, 1990, p. 156 (ed. or. Christia-nity in the West. 1400-1700, Oxford, 1985).
APPENDICE
Documento 1Cedola d’estimo della pieve di Colognola ai Colli (1540).ASVr, Archivio privato Nichesola-Zennari, proc. a stampa n. 7 (seconda metà del sec.XVIII).
La pieve di Colognola ha il quarto della decima, e si affitta a minali tutto formento, alqual formento di decima s’aggiunge minali 234 quarte 2209 formento di fitti, e di tuttoquesto si cava minali 18 formento, cioè minali 6 per provisione al sindico, minali 2 perostie, e minali 10 per fitti inesigibili, e poi del resto che avanza si cava il terzo per l’ar-ciprete, qual cavato, si cava minali 50 per la provisione del capellano, il resto si dividein porzioni 25, e nota che li decimali sono tenuti pagar per regalia minali 6 legumi, ecarra 4 paglia.La decima de fasoli, il quarto della pieve, alli quali s’aggiunge i sei minali nominati diregalie, e di tutti si cava il terzo per l’arciprete, poi minali 3 per il capellano, il resto èdelli chierici.La decima del miglio è un quarto melega. La pieve ha il quarto di detta decima, e se210
ne cava il terzo, sì di miglio, come melega per l’arciprete, poi si cava minali 3 miglio,e minali 3 melega per il capellano, il resto si divide in porzioni 25. V’è minali 3 speltadi fitti della quale se ne da un minale all’arciprete per suo terzo.La decima di uva la pieve ha il quarto, si cava il terzo per l’arciprete. Poi si cavanocarra 3 per il capellano, il resto si divide ut supra.La decima d’oglio. La pieve ha il quarto, si cava il terzo per l’arciprete, poi si cavanobacede 6 per il capellano, e bacede 6 per la lampada, il resto è delli chierici.La decima d’agnelli211, il quarto della pieve, e di questo il terzo è dell’arciprete, il re-sto è de chierici.Dinari d’affitti n. 60 de quali se ne da troni 20 all’arciprete. Nota, che l’arciprete devepagar il terzo di tutte le spese comuni.Fitti de danari lire 61 soldi 10212.
Documento 2Costituzioni per le pievi (1540).BCVr, Carteggi, b. 810 (=Carte Ballerini, b. XIX), ms. miscellaneo del sec. XVIII dic. n. n.
Joannis Matthaei Giberti episcopi veronensis constitutiones213 de214 regimine plebiumdioecesis veronensis e manuscripto archivii episcopatus exscriptae, et collatae seu
42 A. Ferrarese
209. sciolto su min. 234:2.210. corretto su ce.211. corretto su angnelli.212. sciolto su l. 61:10.213. dopo un segno di rimando nel testo, segue in nota a piè di pagina hunc titulum
praetulimus e ms. Adami Fumani. In exemplo autem archivii episcopalis notatio anni [se-gue huic eraso] titulo substituitur his verbis expresse [da qui il testo prosegue sottolineatofino a 1540] Constitutiones Plebium Veronae 1540.
214. il corsivo nel documento riproduce le parti del testo sottolineate nel manoscrittooriginale.
emendatae opera exempli scripti manu Adami Fumani Giberti familiaris et canonici,quod extat in tabulario capitulari.
Infrascriptas constitutiones et capitula reverendissimus in Christo Patre et Domino do-minus Joannes Matthaeus episcopus Veronae et comes etc. ac legatus apostolicus et ju-dex exemptorum mandat inviolabiliter observari per reverendum dominum vicarium etalios commissarios suos pro tempore existentes, nec non archipresbyteros et clericosplebium dioecesis suae veronensis in electione syndicorum et massariorum, qui fiuntde anno in annum pro regimine earumdem plebium; in quibus dantur modus et formaeisdem syndicis et massariis circa sibi incumbentia, et tam in exactione fructuum215,reddituum, et proventuum, quam in administratione et dispençatione eorumdem, utomnia bona fide et recte fiant ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, et ad commo-dum et utilitatem eorumdem archipresbyterorum et clericorum. ||
[§I] De modo et forma eligendi syndicos et massarios, et qui abballotari possint, et quinon. Quod clerici de capitulo cuiuscumque plebis, qui ad syndicatus et massarias ab-ballotari voluerint, semper praeferantur clericis extraneis, idest qui non fuerint de gre-mio proprio illius capituli, cui providendum erit de syndico, vel de massario. Et nullusextraneus admittatur in concurrentia cum clericis de gremio, vel de capitulo, nisi ha-buerit ille extraneus duas ex tribus partibus vocum capituli. Et laici in concurrentiacum clericis tam de capitulo, quam non, nullo modo admittantur ad abballotationem,nisi eo casu, in quo non inveniretur clericus, qui abballotari vellet. Exceptuantur ordi-narie omnes archipresbyteri216, vicearchipresbyteri, et conductores quarumcumque ple-bium, qui non possint esse syndici, nec massarii illarum plebium, quarum fuerint ar-chipresbyteri. Reservato tamen semper praedicto reverendissimo || domino episcopoiure aliter faciendi vel disponendi tam, in praesenti217 capitulo, quam in infra dicendis.
[§II] Qui duos syndicatus habuerit, et unam massariam, ad plures obtinendos abballo-tari non possit218, et quod eiusmodi officia fiant et personaliter exerceantur. Quod nul-lus possit habere plus quam duos syndicatus, et unam massariam; nisi aliter visum fue-rit reverendissimo domino episcopo, vel eius reverendo domino vicario; et syndici etmassarii teneantur, et obbligati sint syndicatus et massarias in persona propria et nonper socios, vel substitutos fideliter exercere; et qui contrafecerit sit ipso facto privatussyndicatibus et massariis, quos vel quas habuerit, et sit inhabilis per annos tres conti-nuos inde sequuturos ad praedicta, et alia consimilia obtinenda, et perdat omnia emo-lumenta, seu salaria, applicanda pro dimidia parte accusatori, et pro altera dimidia fa-bricae cathedralis ecclesiae.
[§III] Quod qui electus fuerit in massariam alicuius plebis, teneatur praestare ido-neum fideiussorem, qui sit ecclesiasticus. Quod quilibet electus in massariam, si laicus|| fuerit, submittat se foro ecclesiastico, et teneatur accipere litteras suae massariae, ac
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 43
215. segue quam eraso.216. dopo un segno di rimando nel testo, segue in nota a piè di pagina vox vicearchi-
presbyteri [la parola vicearchipresbyteri è sottolineata] deest in ms. capitulari. Haec autemvox cum sequenti et conductores [le parole et conductores sono sottolineate] coniuncta illospresbyteros inivit, qui tum ante tridentinam synodum ab archipresbyteris non residentibussubstituebantur, et plebis redditus conducebant.
217. segue C eraso.218. segue cap. eraso.
in termino dierum trium dare et praestare idoneam et laudabilem fideiussionem, quaesit ecclesiastica persona, et obbliget se principaliter et in solidum una cum massario debene administrando, et fidele computum de administratis reddendo ad omne beneplaci-tum dominorum rasoneriorum plebium veronensis dioecesis, et de solvendo omniadamna, expensas, et interesse, quae pati posset plebs, cuius fuerit massarius, ob malamadministrationem; et ad hoc invigilent omnes syndici, quia si eorum negligentia velculpa omissum fuerit per massarios dare et praestare fideiussiones, et si illas praestite-rint, quae non sint idoneae, sufficientes, et laudatae, ad omnia damna, expensas, et219
interesse tenebuntur ipsi.
[§IV] Quod massarii non tradant portiones nisi clericis descriptis in libro clericaliumportionum factoriae episcopatus. || Quod nullus massarius possit, nec debeat dare por-tiones alicui clerico, nisi talis clericus descriptus fuerit in factoria episcopali in libroclericalium portionum; et teneantur massarii220 singulo anno semper tempore distribu-tionum faciendarum221 clericis portionariis facere schedam, seu listam in se continen-tem nomina omnium clericorum, quorum quilibet fuerit massarius, et illam collationa-re, seu incontrare cum libro praedicto; quae postquam collationata fuerit, subscribaturper notarium factoriae episcopatus; et notarius non se subscribat alicui polizae seuschedae in se continenti nomina clericorum, qui non sint descripti in libro praedictoetiam praetextu quarumcumque litterarum provisionis, ac assertae possessionis exigen-di quantumcumque longissimae, sub poena notario praedicto contrafacienti solvendi desuo quidquid secus exactum fuerit contra tenorem praesentis constitutionis. Qui nota-rius, sive factor habeat pro sua mercede a quocumque massario, de bonis tamen cleri-corum suorum, marcellum unum; et massarii contrafacientes cadant in poenam libra-rum viginti||quinque applicandarum fabbricae ecclesiae cathedralis.
[§V] Quod factor episcopatus nullum describat in libro clericalium portionum, nisicum licentia et mandato in scriptis reverendissimi domini episcopi, vel eius reverendidomini vicarii. Mandatur factori episcopatus, quod non audeat aliquem pro clerico por-tionario describere in libro clericalium portionum, nisi de licentia et mandato in scrip-tis reverendissimi domini episcopi, vel eius reverendi domini vicarii. Qui secus de-scripti reperiuntur, debeant existentes in civitate vel dioecesi veronensi in unius men-sis, et qui absentes, in quinque mensium terminis a die intimationis et publicationispraesentium computandorum, sub poenas privationis litteras suarum provisionum pro-duxisse, et praesentasse coram reverendissimo domino episcopo, vel eius reverendodomino vicario. Aliter elapsis terminis, vel non adimpletis praemissis, sint et intelli-gantur ipso iure privati iis222 quas possederint, ita quod sine alia privatione facienda li-bere et licite ||conferri possint et valeant.
[§VI] Quod nullus possit confirmari massarius, nisi integre satisfecerit223 omnibus sa-
44 A. Ferrarese
219. segue te eraso.220. dopo un segno di rimando nel testo, segue nel margine destro del foglio al[ter]
quotannis.221. segue cleris eraso.222. dopo un segno di rimando nel testo, segue nel margine sinistro del foglio scriben-
di clericalibus portionibus [le parole clericalibus portionibus sono sottolineate].223. segue archipresbytero, clericis, et capellanis plebis, cuius fuerit massarius, et nisi
prius rationem reddiderit coram dominis rasoneriis sottolineato ed eraso.
tisfaciendis, et nisi prius reddiderit ratio de administratis coram dominis rasoneriis224.Quod nullus possit confirmari massarius, nisi integre satisfecerit archipresbytero, cleri-cis, et capellanis plebis, cuius fuerit massarius, aut cum eis se amicabiliter composue-rit, nec non datiis ordinariis et extraordinariis, salariis, et aliis consuetis et ordinariisexpensis, et praesentaverit librum praecedentis anni super administratis per eum cumsufficientibus attestationibus huiusmodi satisfactionum seu solutionum dominis225 ra-soneriis cum incantibus decimarum manu notariorum, qui de ipsis incantibus rogatifuerint, et cum capitulis, pactis, et conditionibus proclamatis et appositis in dictis in-cantibus, quae pacta, capitula, et conditiones sint distincta, clara, et aperta, et non intri-cata, vel confusa; qui domini rasonerii bene et diligenter advertant, ne eorum226 incuriaquidpiam secus evadat227, || quod dictum est, quia ad omnia damna, expensas, et inte-resse per praesentes dicernitur illos inviolabiliter teneri et obbligatos esse.
[§VII] Quod massarii plebium debeant fecisse suas rationes, ubi non colligitur oleum,per totum mensem octobris, et ubi colligitur, per totum mensem novembris. Quod mas-sarii plebium, in quarum introitibus non colligitur oleum, per totum mensem octobris,et illi, in quibus percipitur oleum, per totum mensem novembris, sub poenam librarumdecem denariorum veronensium fabricae ecclesiae cathedralis applicandarum, debeantpraesentasse quilibet libros suae massariae dominis rasoneriis cum cedula factoris epi-scopatus, in qua descripta sint nomina clericorum plebium, quarum erunt massarii,cum instrumentis publicis fidem facientibus de incantibus, de pactis et conditionibus,ut supra constitutione sexta. Qui rasonerii dividant introitus frumenti, et aliorum minu-torum, et228 si necesse erit229 divi||dere per mensuram quartae; restans vero appretieturper eosdem dominos rasonerios, prout vendatur in foro seu publico mercatu tempore,quo fient rationes; et sic fiat de uvis, oleo, et aliis; et rasonerii non possint, nec valeantadmittere fictus aliquos in numero inexigibilium tam frumenti, quam denariorum alicuimassario, nisi de consensu capituli, nec saldum facere cum eodem, nisi integraliter sa-tisfecerit archipresbytero, clericis, et capellanis, ac aliis, prout expressum fuit constitu-tione praecedenti; et si contrafecerint rasonerii praesenti constitutioni, cadant in poe-nam periurii et amissionis officii, et teneantur ad refectionem omnium damnorum,quae pati possent clerici.
[§VIII] Quod decimae affictentur per archipresbyteros, syndicos, et massarios ad pu-blicum incantum, et quod introitus exigantur iuxta pacta et conventiones per massa-rios. Quod decimae omnium plebium tam frumenti, quam minutorum, agnorum, olei,uvarum, feni, et aliarum praestationi decimae subiectarum affictentur per archipresby-teros, ||syndicos, et massarios, et alios intervenire debentes ad publicum incantum, etnon aliter nec alio modo; nel ulla decima230, seu pars illius concedatur alicui extra in-
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 45
224. omnibus satisfaciendis, et nisi prius reddiderit ratio de administratis coram domi-nis rasoneriis inserito nel margine destro e sottolineato.
225. segue una parola erasa ed illeggibile.226. dopo un segno di rimando nel testo, segue in nota a piè di pagina Exemplum epi-
scopatus incurat quispiam seu evadat [il testo è sottolineato da incurat a evadat]. Ms. capi-tul. incurrat quispiam... secus evadat [il testo è sottolineato da incurrat a avadat].
227. segue quod eraso.228. segue un segno di punteggiatura eraso.229. segue un segno di punteggiatura eraso.230. segue seu eraso.
cantum secreto, vel, ut vulgariter dicitur, di orecchia, nisi ex legitima caussa et ratio-nabili aliter visum fuerit omnibus de capitulo, vel saltem duabus partibus capituli. Et inincantu interveniant syndici, archipresbyteri, massarii, et unus, vel duo ex clericis capi-tuli illius, cuius erunt decimae locandae, si sibi visum fuerit. Et massarii teneantur exi-gere a conductoribus decimarum decimas ipsas frumenti, minutorum, olei, uvarum, etcaeterorum iuxta et secundum formam capitulorum, pactorum, et conventionum prae-lectarum et proclamatarum in incantibus earumdem decimarum; et si secus factum fue-rit, possint et valeant, et possit et va||leat quilibet clericus cogere et compellere massa-rium, seu massarios ad sibi dandum, et exhibendum frumentum, et alios introitus sibispectantes secundum formam et tenorem capitulorum. Et ne in anfractu litigiorum pu-tet se quis involvi, declaratur per praesentes, quos vim validae et efficacis ac definiti-vae sententiae habere vult idem reverendissimus dominus, quod absque alio litigio seuformando processa quilibet clericus habeat exequutionem contra massarium seu mas-sarios sibi debitores, et reverendus dominus vicarius sic praesentem constitutionem adunguem exequatur.
[§IX] Quod syndici et massarii non possint alicui decimali remittere seu relaxare par-tem aliquam decimarum. Quod syndici et massarii non possint, nec valeant remittere,relaxare, seu, ut vulgariter dicitur, calare aliquam decimam seu partem illius, quocum-que praetextu, postquam levata fuerit in || incantu sine expressa licentia et231 consensucapituli; et qui contrafecerint, amittant ipso facto officium suum, et salarium, et te-neantur ad restitutionem omnium damnorum ex huiusmodi remissione, seu calo sequu-torum.
[§X] Quod archipresbyteri, vicearchipresbyteri, et conductores introituum quarum-cumque plebium non possint esse decimales. Quod nullus archipresbyter, nullus lo-cumtenens, nec conductor introituum alicuius plebis, nec syndicus, nec massarius pos-sint esse decimales illius plebis, cuius sunt archipresbyteri, locumtenentes, et conduc-tores etc. sub poena librarum quinquaginta et maiori ad arbitrium reverendissimi domi-ni episcopi, vel eius reverendi vicarii, syndicis et massariis privationis officii, et perpe-tuae inhabilitationis ad illa, et amissionis suorum salariorum232 applicandorum pro di-midia parte accusa||tori, et pro altera dimidia plebi et clericis, quorum fuerint syndici,vel massarii.
[§XI] Quod nullus possit esse perpetuus syndicus, vel massarius alicuius plebis. Quodnullus possit creari, vel institui perpetuus massarius, nec syndicus alicuius plebis, sedad annum tantum, qui expleto anno confirmetur a capitulo, vel a maiori parte illius,cuius erant syndici, et massarii.
[§XII] Quod nec syndici, nec massarii, nec clerici possint facere aliquas expensas,nisi de consensu capituli. Quod nullus syndicus, archipresbyter233, massarius, vel cleri-cus possit ac valeat aliquam fabricam ordinare, aut apparamenta emere, vel aliter ex-pendere de bonis clericorum, nisi de illorum consensu, ultra ea quae reverendissimusdominus episcopus, vel eius reverendus vicarius ordinaverint, aut de cetero ordinabunt
46 A. Ferrarese
231. dopo un segno di rimando nel testo, segue nel margine sinistro del foglio al[ter]consulto [la parola consulto è sottolineata].
232. segue appl eraso.233. segue una parola erasa ed illeggibile.
facienda; et qui secus fecerit, solvat de suo, nec aliquid petere possit a || clericis, sinequorum consensu expensas fecerit.
[§XIII] Quod massarii possint vendere frumentum clericorum, quorum culpa illud sibiper totum mensem septembris non solutum fuerit. Quod si clerici steterint in mora, etper totum mensem septembris non solutum fuerit in petendo et recipiendo portionessuas frumenti; massarii transacto234 mense possint, et valeant illud vendere; seu calumillius petere ratione minalium quinque pro quoque centenario, facta tamen prius denun-tiatione de venditione facienda coram factore episcopatus Veronae per tres dies antevenditionem clericis sic in huiusmodi mora existentibus, et hoc ad dirimendum et evi-tandum discordias, quae oriri possent inter clericos et massarios super calo, seu cor-ruptione frumenti.
[§XIV] De iis, qui vocem habere debent in capitulo, et qui non. Quod nullus clericus,qui non sit de capitulo, ||nec laicus, etiam sub praetextu alicuius mandati, sive procu-rae, vel arrendationis, aut affictus sibi de aliqua portione facta possit interesse capitulis,nec aliquo modo se in illis immiscere, nec abballotando, nec in aliquo alio tractatu fa-ciendo; et quidquid factum fuerit contra praesentem constitutionem, sit ipso iure irri-tum et inane. Officiales vero, qui permittent laicus ingredi in capitula ad vocem prae-standam, seu aliud tractandum, multentur in solidis viginti pro quaque vice. Clericivero portionarii nulli alteri delegent vices suas, cum contigerit illos, aut aliquem illo-rum abesse, nisi clerico, qui sit de capitulo235 eorum; et delegatus, sive substitutus proalio, non possit acceptare et dare nisi unam vocem236 pro se et alteram pro illo, a quosubstitutus est; et qui ha||buerit duas voces pro se, non possit subdelegari, nec substituiloco alterius; et qui se asseruerit alicuius clerici substitutum, non admittatur, nisi osten-derit mandatum proprium speciale ad hunc actum pro illa vice tantum, et non ultra inqua celebrandum erit capitulum. Ab hac determinatione et constitutione exceptuanturmassarii mensae corneliae, et acolytorum, et fabbricae ecclesiae cathedralis, sive sintlaici, sive clerici dicti massarii, quibus respectu portionum clericalium spectantiummensae et fabricae praedictis conceditur, quod possint libere et licite interesse capitu-lis, in quibus habebunt portiones237. ||
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 47
234. dopo un segno di rimando nel testo, segue nel margine sinistro del foglio al[ter]tempore [la parola tempore è sottolineata].
235. dopo un segno di rimando nel testo, segue nel margine destro del foglio al[ter] suo[la parola suo è sottolineata].
236. segue ita quod eraso, poi dopo un segno di rimando nel testo, segue in nota a pièdi pagina in exemplo episcopatus inseruntur haec verba ita quod non possit dare unam [iltesto è sottolineato da ita a unam], quae melius in ms. [segue Fumani eraso] capitulariomittuntur.
237. dopo un segno di rimando nel testo, segue in nota a piè di pagina In ms. episcopa-tus tantum haec adnotatio in margine legitur [il testo è sottolineato da in ms. a legitur].Nota quod die lunae 27 aprilis 1583 in factoria episcopali Veronae in capitulo plebis Capri-ni pro anno 1583 decretum fuit per reverendum dominum Petrum Stridonium vicarium ge-neralem, quod de cetero mandata sive procurae alicuius clerici ad exigendum et ad omniaalia, licet in eis non inserta fuerit clausula cum potestate abballotandi massarios et syndicos,dummodo nisi fuerint de gremio procuratorum constitutus, habeat facultatem constituendiunum videlicet de gremio, quia qui non est de gremio, abballotari non potest ipsa procurasine illa clausula abballotandi etc. teneat, et valeat pro abballotandis massariis, syndicis etc.omnia alia, quae opportuna fuerint etc. et ut latius per [segue nome corretto e illeggibile]cancellarium die suprescripta.
[§XV] De modo et ordine convocandi capitulum, et de poena clericorum non interes-sentium. Quod officiales episcopatus teneantur clericis portionariis in dioecesi exsi-stentibus intimare, quod intersint capitulis faciendis, et praesertim cum tractatur deelectione syndicorum et massariorum, aut de restauris decimarum, vel de aliqua impor-tantia, et necessaria caussa. Et si officiales praedicti non adimpleverint ea, quae sibiper praesentem constitutionem iniunguntur, amittant pro quoque clerico non vocato,seu citato marcellum unum argenteum. Et si clerici citati non comparuerint, vel se le-gitime non excusaverint, cadant in poenam solidorum viginti pro quaque vice238 fabri-cae cathedralis ecclesiae applicandorum; qui insuper in poenam solidorum decem inci-disse censeantur, quotiescumque vocati pro quacumque caussa contumaces exstiterint.||[§XVI] Quod aliquod capitulum convocari non possit sine licentia reverendissimi do-mini episcopi, vel eius domini vicarii. Quod officiales praedicti non possint convocarecapitulum alicuius plebis sine licentia reverendissimi domini episcopi, vel eius dominivicarii sub poena librarum trium denariorum veronensium; et capitulum sic vocatumnon admittatur, sed de novo citetur de mandato et licentia ut supra; et officiales dumcolliguntur ballotae, et dum tractatur de rebus capitularibus, non audeant loqui, necverbum proferre non spectans ad officium suum sub poena solidorum viginti.
[§XVII] Quod beneficium aliquod affictari non possit, nec locari sine licentia reveren-dissimi domini episcopi, vel reverendi239 eius domini vicarii. Quod nullus plebanus ar-chipresbyter, seu rector alicuius beneficii in civitate et dioecesi veronensi locare, seuaffictare possit aliquod beneficium, et similiter praenominati, nec quilibet alius clericussuae dioe||cesis, nec extraneus possit conducere240 beneficia, qualiacumque sint cumcura, vel sine cura, sine licentia praedicti reverendissimi domini episcopi sub poena li-brarum ducentarum monetae veronensis applicandarum pro dimidia ecclesiis sic contrapraesentem constitutionem locatis et affictatis, et per altera241 dimidia fabricae eccle-siae cathedralis; et locationes sic factae sint ipso iure nullae, nulliusque roboris, et mo-menti.
[§XVIII] De renovandis investituris. Quod omnes syndici debeant renovare investitu-ras, seu locationes veteres, et antiquas contra omnes et singulos affictuales tam deci-marum, quam frumenti et aliorum plebium sibi et cuilibet eorum commissarum subpoena amissionis officii et salariorum.
[§XIX] Quod omnes tam archipresbyteri, quam clerici accipere debeant portiones sibicontingentes de manibus massariorum. Quod archipresbyteri quarumcumque plebium,quae habent capitula, non possint nec debeant pro portione, seu quota illis || et eorumcuilibet contingente pro eorum archipresbyteratibus fructus aliquos, redditus, et pro-ventus aliter recipere, quam de manibus massariorum pro tempore existentium, ne quidfiat in fraudem clericorum; et hoc sub poena excommunicationis ipsis archipresbyteris;et tempore recollectionis frumenti et aliorum introituum teneantur massarii levare litte-ras seu mandata ab officio reverendi domini vicarii contra quoscumque decimales protempore existentes, quod sub poena excommunicationis, et iterum solvendi de suo
48 A. Ferrarese
238. segue una parola erasa ed illeggibile.239. segue una parola erasa ed illeggibile.240. segue qua eraso.241. segue una parola erasa ed illeggibile.
nihil aliis solvant aut respondeant, quam ipsis massariis, et massarius ille, qui circa hocnegligens deprehensus fuerit, teneatur solvere de suo, et ipso facto privatus sit officiomassariae, perpetuo factus inhabilis ad massariam, de qua privatus fuerit, et ad alias decetero amplius non admittatur.
[§XX] Quod expensae, quae occurrerint faciendae in communi per archipresbyteros etclericos, fieri debeant242 || per massarios. Quod omnes expensae faciendae in commu-ni inter archipresbyteros et clericos quarumcumque plebium, uti sunt illae quae fiunt inceris, pro hostiis, et aliis etc. ad quas in communi conferunt archipresbyteri et clerici,fiant et fieri debeant per massarios, et non separate, nec divise, et hoc sub poena ad ar-bitrium praefati reverendissimi domini episcopi, vel eius reverendi domini vicarii.
[§XXI] Quod omnes, quorum agitur interesse, moneantur, ut intersint rationibus fa-ciendis. Mandat postremo prefatus reverendissimus moneri omnes et singulos archi-presbyteros et clericos quarumcumque plebium et alios quoscumque sua communiteret divisim interesse putantes, quod velint interesse expensis, quas idem reverendissi-mus dominus necessaris decreverit, vel decernet de cetero faciendas in ecclesiis ad ho-norem Dei omnipotentis et manutentionem earumdem ecclesiarum, et videre computaet rationes, ad hoc ut recte et magis accurate fiant, quae faciendae erunt, et ut tollaturomnis suspicio et occasio quibuscumque se conquerendi quod expillentur, et non fiant,vel adimpleantur impositiones per eumdem reverendissimum || dominum episcopumordinatae.
[§XXII] Quod omnes capellani perpetui et amovibiles interesse debeant capitulis fa-ciendis. Quod omnes capellani tam perpetui, quam amovibiles quarumcumque plebiumvocentur in capitulis faciendis ad hoc, ut ab eis habeantur et intelligantur, quae quan-doque inopinate habenda et inteligenda emergunt, et tam circa curam animarum, quamregimen massariorum et expensarum factarum ex ordinatione prefati reverendissimidomini in plebibus et ecclesiis curae eorum commissis, sub poena solidorum vigintipro quoque contumace existente.
[§XXIII] De taxis exigendis impositis per reverendissimum dominum pro apparamen-tis, et fabricis etc. antequam archipresbyteri et clerici percipiant aliquid ex eorum in-troitibus, et similiter capellani perpetui. Quod massarii quarumcumque plebium archi-presbyteris, clericis, et capellanis perpetuis nihil solvant, aut respondeant de fru||ctibusetc. earumdem plebium sine expressa licentia et mandato in scriptis reverendissimi do-mini, vel eius reverendi domini vicarii; quia intendit idem reverendissimus, quod priu-squam aliquid accipiant de eorum introitibus, integre satisfaciant et solvant expensas,seu taxas, quae pro tempore imponentur et pro restauratione aedificiorum, et refectioneapparamentorum, et aliorum ad divinum cultum necessariorum; quae solutio, sive sati-sfactio huiusmodi expensarum, sive taxarum fiat per tres dies immediate sequentespost festum nativitatis gloriosae virginis Mariae de mense septembris; aliter autem ela-psis dictis tribus diebus, massarii libere ac licite vendere possint, et sic cum effectuvendant tantam quantitatem frumenti, et non ultra illius clerici, seu clericorum, qui nonsolverint in termino praedicto, quae bene valeat et capiat proportionabiliter taxam cui-libet clerico contingentem; et quantitatem pecuniarum eiusmodi venditione retractam,per alios tres dies immediate sequentes teneantur massarii sine aliqua excusatione, seu
Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica 49
242. segue per massarios eraso.
sub prae||textu de non vendidisse, seu pecuniam non recepisse, sub poena privationisofficiorum, perpetuae inhabilitatis ad illa, et amissionis salariorum suorum dare et tra-dere, et realiter ac cum effectu consignare depositario pro tempore existenti; aliter con-tra ipsos sic delinquentes tamquam contra inobendientes procedetur.
[§XXIV] De poenis syndicorum, et rasoneriorum, et massariorum, qui quoquo mododeprehensi fuerint defraudare clericos et eorum plebes. Licet in243 constitutione tertiasatis cautum sit, quod massarii bene fideliter se gerant in administratione suarum mas-sariarum; tamen quia de iis, ad quae de facili, ne dicam ab ipsa natura prona et procli-vis est maxima pars hominum, magis particulares, fortiores, et inculcatiores admonitio-nes fieri debent, et valde necessarium est delinquentes acrioribus poenis multando;ideo praedictus reverendissimus dominus advertens, quod saepissime et malitia et ne-gligentia sive incuria et syndicorum, et rasone||riorum, et massariorum fiunt et ponun-tur in libris massariarum suarum aliquae partitae expensarum, et quandoque falsae, etquandoque excessivae, et quandoque duplicatae; vult et mandat, omnes et singulossyndicos, rasonerios, et massarios quarumcumque plebium iterum secundo et tertio ad-moneri, ut in officiis suis diligenter cum bona fide et accurate se habeant, et quod quiex dictis syndicis, rasoneriis, et massariis in huiusmodi delictis culpabiles, negligentes,et vecordes deprehensi fuerint, sint ipso facto privati officiis ipsis perpetuo ad illa decetero consequenda inhabiles effecti, et teneantur ad reddendum quadruplum eo, inquo deprehensi fuerint defraudasse, excessisse, seu aliter244 permisisse plebes in earumexpensis plus solito aequo et debito gravatas esse; et ad hoc obligent se specialitermassarii in eorum creationibus cum eorum fideiussoribus principaliter et in solidumsubmittendo se simul, ut praedictum est in eadem constitutione tertia, foro ecclesiasti-co. ||
245Additio alius decreti eiusdem Giberti. Die 23 mensis aprilis 1540 in sala episcopatuspro plebibus omnibus veronensis dioecesis. Reverendissimus dominus episcopus vero-nensis ad beneficium omnium plebium veronensis dioecesis stabili decreto constituit etordinavit, quod massarii et syndici teneantur omnimodo exequi decreta suarum consti-tutionum, praecipue in legitimandis iuribus et246 affictibus ipsarum plebium et posses-sionum suarum, et in faciendo novas investituras cum sindicis contra conductores iux-ta constitutiones sub poena in constitutionibus contenta, et procurent etiam exequi om-nia alia, ad quae tenentur per formam suprascriptam. Aliter autem amittant salaria sua,et reficiant damna et expensas cum interesse, quae quomodocumque propter eorum ne-gligentiam et omissionem sequentur. Presentibus reverendo domino Philippo Strido-nio, domino Hieronymo Fracastorio, etc.
50 A. Ferrarese
243. segue una parola erasa ed illeggibile.244. nella parola seguente le prime tre lettere sono inserite nell’interlinea.245. dopo un segno di rimando nel testo, segue in nota a piè di pagina Haec additio
deest in capitulari codice Adami Fumani; legitur autem in ms. episcopatus, nec non in alioantiquo exemplo.
246. dopo un segno di rimando nel testo, segue nel margine sinistro del foglio al[ter]affictualibus [la parola affictualibus è sottolineata].
![Page 1: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: [2004] A. FERRARESE, «Quia ubi non est ordo, ibi est confusio». Gian Matteo Giberti e la ristrutturazione della proprietà ecclesiastica nella diocesi di Verona (1524-1543). In ‘Società](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6313aecbc32ab5e46f0c8759/html5/thumbnails/50.jpg)