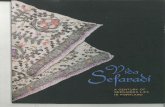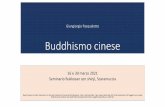La Diaspora Cinese nel Sud Est Asiatico
Transcript of La Diaspora Cinese nel Sud Est Asiatico
INDICE
Introduzione..................................................................................................................3
____________________________________________________________________
CAPITOLO 1: UNA MAPPATURA DELLA DIASPORA CINESE
NEL SUD-EST ASIATICO
1.1 Storia della Diaspora Cinese ed evoluzione del personaggio del Migrante
cinese.................................................................................................................7
1.2 La Diaspora Cinese nel Sud-Est Asiatico: cronologia e posizionamento
geografico dei flussi........................................................................................10
1.3 La dimensione demografica: entità dei flussi e dati statistici........................12
1.4 Le comunità Huaqiao in Thailandia, Malaysia, Filippine, Vietnam e
Singapore.........................................................................................................16
1.4.1 Thailandia..................................................................................................16
1.4.2 Malaysia.....................................................................................................18
1.4.3 Filippine.....................................................................................................19
1.4.4 Vietnam......................................................................................................20
1.4.5 Singapore...................................................................................................23
______________________________________________________________________
CAPITOLO 2: RUOLO DELLE COMUNITÀ CINESI NEL SUD-EST
ASIATICO
2.1 Processi di regionalizzazione, Organizzazioni transnazionali (SEATO,
ASEAN) nel territorio del Sud-Est Asiatico....................................................25
2.1.1 Processi di regionalizzazione nel Sud-Est asiatico.........................................25
2.1.1.1 La SEATO...........................................................................................30
2.1.1.2 L' ASEAN...........................................................................................31
2.2 Ruolo Economico dei cinesi d'oltremare e il Capitalismo cinese...................33
2.2.1 Il Capitalismo Cinese.................................................................................36
2.3 Rapporto economico-politico fra Huaqiao, Madrepatria e Stato d'approdo
(Influenze economiche, politiche e cenni alle leggi che regolano la migrazione
in Cina)............................................................................................................39
1
______________________________________________________________________
CAPITOLO 3 : IDENTITÀ, CULTURA E LETTERATURA DEI
CINESI D'OLTREMARE
3.1 Processi di assimilazione e la mancata assimilazione delle comunità cinesi in
Malaysia, Thailandia e Filippine.....................................................................44
3.1.1. Le comunità Huaqiao in Malaysia.................................................................44
3.1.2. Le comunità Huaqiao in Thailandia...............................................................46
3.1.3 Le comunità Huaqiao nelle Filippine.............................................................47
3.2 Rapporto fra Huaqiao e Madrepatria: Identità e Nazionalismo......................49
3.2.1 Testimonianze: Voci della Diaspora............................................................53
3.3 Il problema della Lingua.................................................................................55
3.4. Cenni di letteratura scritta da Huaqiao...........................................................57
Conclusioni.................................................................................................................60
Bibliografia.................................................................................................................65
2
Introduzione
Con il termine Diaspora si intende letteralmente “spostamento di popolazioni
dal paese d'origine ad un altro” (Johnston, 2000) o “abbandono della terra natale da
parte di un popolo che si disperde in varie parti del mondo” (Mitchell, 1997).
Diaspora deriva dal greco διασπορά, “dispersione” e dalla parola “disseminare” che
inizialmente veniva utilizzata per indicare “chi vive tra gente di religione diversa
dalla sua” (Cortelazzo, Zolli, 1985, s.v. Diaspora)1.
Nell'Atlante della Migrazione a Bergamo: La Diaspora Cinese, Emanuela Casti
scrive:
L'idea di diaspora evoca un territorio d'origine, focolare di una cultura a partire dalla quale, e per effetto di una dispersione, si è determinata la costruzione di un insieme di comunità distanti l'una dall'altra.
Inizialmente questo termine designava l'esperienza ebraica a seguito della conquista
della Palestina da parte dell'Impero Romano e la distruzione di Gerusalemme nel 70
d. C (Keller, 1971).
La parola Diaspora oggi viene utilizzata in modo più ampio per descrivere fenomeni
lontani da quello degli ebrei di Palestina, come, ad esempio, la “Black Diaspora”
che fu conseguenza della tratta degli schiavi dall'Africa o la “Diaspora Cinese” che
approfondirò in questo elaborato.
Sono state analizzate diverse forme del fenomeno migratorio diasporico: esso può
interessare rifugiati, lavoratori e commercianti; i flussi possono avere carattere
imperialista o culturale (Cohen, 1997).
Sono molti gli elementi teorici che condizionano l'analisi del flusso migratorio e
molte sono anche le conseguenze socio-culturali di tali flussi.
Per comprendere il fenomeno della Diaspora bisogna in primo luogo definire
i concetti di Migrazione e Immigrazione.1 Da Casti E., Bernini G. “Atlante dell'immigrazione a Bergamo: la Diaspora Cinese”
3
Con il primo termine intendiamo il cambiamento di residenza, che può essere
permanente o semi-permanente, di un individuo o gruppo di individui (Johnston,
2000). La Migrazione ha influenzato enormemente la cultura e la società dei Paesi
interessati da questo fenomeno ed è stata spesso fondamento di esperienze personali
profondamente epifaniche e fonte di materia letteraria. Lo studio delle migrazioni,
perpetrato soprattutto da geografi, è un elemento chiave per la comprensione del
senso dello Spazio, della Comunità e dell'Identità, in particolare per quanto riguarda
lo studio delle diaspore. Con Immigrazione intendiamo ovviamente una “forma di
migrazione in cui gli individui si spostano da uno Stato ad un altro” (Johnston,
2000). L'immigrazione permanente viene divisa dalla concezione dell'immigrato
“Sejourner”, che torna dopo breve tempo nel Paese d'origine e si sposta spesso per
motivi economici o lavorativi. Sovente l'immigrazione è forzata, come nel caso dei
rifugiati politici o delle vittime di guerre e persecuzioni, che sono costretti a lasciare
le loro case e a muoversi verso luoghi più pacifici.
La Diaspora è anch'essa una forma di migrazione, ma invece che interessare
individui o piccoli gruppi di persone, coinvolge interi popoli.
La questione della definizione di Diaspora sembra di difficile risoluzione a
causa della pluralità delle esperienze storiche, identitarie e migratorie che hanno
interessato un grande numero di comunità, immaginate (Anderson, 2009) o meno,
nel corso della storia dell'uomo.
Una delle prime possibili definizioni cerca di basarsi sulle idee di trauma, esilio e
nostalgia (Safran, 1991), ma la conseguenza è quella di costruire un'idea di Diaspora
basata sulle memorie delle comunità “diasporiche” (come quella degli Ebrei),
formulando un paradigma che può essere considerato fuorviante e riduttivo della
vera realtà del fenomeno.
Il nuovo approccio al tema Diaspora è preminentemente di tipo etnologico, con la
centralità delle condizioni e delle conseguenze socio-economiche che vanno a
formare i movimenti transnazionali. Ad esempio, gli studi sulla Diaspora Cinese
4
possono essere ritenuti paralleli ai Discorsi sul Transnazionalismo2 e sui processi di
Assimilazione3 socio-culturale che hanno contribuito in tempi recenti
all'elaborazione teorica e alla comprensione “pratica” del fenomeno della Diaspora
Cinese e delle comunità che essa ha creato, producendo un sviluppo di qualità nelle
ricerche sui Chinese Overseas, generando un campo di studi maturo e indipendente.
Con Chinese Overseas o Cinesi d'Oltremare (in cinese Huaqiao) intendiamo
individui di nascita o discendenza (totale o parziale) cinese che vivono
permanentemente fuori dalla Cina.
In senso stretto, Cinesi d'Oltremare è un termine che si riferisce ai cinesi di etnia
Han, mentre in senso più ampio si può ricondurre a tutti i 56 gruppi etnici
riconosciuti in Cina, i Zhonghua Minzu (cittadini di nazionalità cinese).
Gli Huaqiao sono, secondo le ultime stime, circa 40 Milioni di persone stanziate fra
il Sud-Est Asiatico, l'Australia, l'America del Nord e l'Europa.
Per la loro grande presenza nel mondo e per la loro importanza sociale, politica,
economica e culturale, gli studi sulla Diaspora Cinese e sul ruolo delle sue comunità
di Chinese Overseas si sono moltiplicati negli ultimi anni, anche grazie all'ascesa
della Cina sulla scena mondiale.
Il fatto che studi sulla Diaspora Cinese siano “materia da geografi” porta
all'elaborazione di nuove prospettive e nuove informazioni in un'area generalmente
dominata da storici, sociologi e critici letterari. Dal punto di vista geografico
fenomeni come la Diaspora Cinese vengono analizzati in rapporto alla globalità del
territorio, dal Sud-Est Asiatico, all'Oceania, all'America, all'Europa e gli ultimi studi
in merito si focalizzano sull'attualità, cioè sugli anni successivi al 1960.
Questo parallelismo rende la Diaspora Cinese uno dei temi principali dell'area dei
“Global Studies”, cioè quel campo di studi che interessa le relazioni politiche,
economiche, sociali e culturali fra Paesi nel mondo (processi politici e culturali, 2 Transnazionalismo: continuo movimento transnazionale nel quale gli immigranti sviluppano e
mantengono connessioni economiche, politiche, sociali e culturali in più di una nazione; Cit. R.J.Johnston “Dictionary of Human Geography,” 2000.
3 Assimilazione: processo tramite il quale nazioni o comunità e sub-nazioni e minoranze si mischiano e diventano simili; Cit. R.J.Johnston “Dictionary of Human Geography,” 2000.
5
impatti della globalizzazione). In “Space, Place and Transnationalism in the
Chinese Diaspora”, Laurence Ma scrive che “l'odierna concezione della migrazione
internazionale è semplicemente incapace di catturare la natura instabile e in rapido
cambiamento della migrazione globale”, e che le nuove teorie su di essa devono
approfondire la portata culturale delle emergenti società plurali, delle organizzazioni
sociali e dei Network famigliari (che non sono più basati su un unico luogo).
Gli immigranti cinesi spesso sviluppano un bagaglio culturale che sorvola i confini
nazionali. Ma enfatizza le dinamiche della popolazione dei Chinese Overseas come
un network globale fluido e flessibile e che la loro genesi deve essere posta in un
contesto storico più ampio al di là dei confini territoriali.
In questo elaborato voglio dunque approfondire l'analisi della Diaspora
Cinese nel Sud-Est Asiatico, basandomi sulla centralità economica delle comunità di
Cinesi d'Oltremare insediatesi nei Paesi dell'Asia Oceanica, sull' importanza
culturale dell' assimilazione e sulle tappe storiche che hanno portato alla
concentrazione dei cinesi in questa parte del globo. Fondamentali in questo studio
saranno l'indagine dei processi territoriali transnazionali messi in atto nel corso degli
ultimi settant'anni (come l'istituzione della SEATO e dell'ASEAN) e dei rapporti
socio-politici tra comunità di Huaqiao e Paesi ospitanti.
Nell'ultima parte ho deciso di soffermarmi sulla questione identitaria legata al
fenomeno diasporico, quindi sui processi di assimilazione o mancata assimilazione
delle comunità cinesi in Thailandia, Malaysia, Filippine, Vietnam e Singapore, sul
rapporto sociale fra comunità diverse e sulla letteratura cinese della diaspora.
6
CAPITOLO 1: UNA MAPPATURA DELLA DIASPORA CINESE
NEL SUD-EST ASIATICO
1.1 Storia della Diaspora Cinese ed evoluzione del personaggio del
Migrante cinese
La storia della Diaspora Cinese interessa, ovviamente oltre alla Cina,
molteplici paesi e culture. L'origine del flusso migratorio può essere trovata nei
primi secoli d. C, anche se è difficile stabilirne la data esatta, dato che il territorio
dell'Asia orientale è sempre stato caratterizzato da una "vivacità" migratoria
peculiare.
La figura del Migrante Cinese (Chinese Overseas o Huaqiao) e la sua
evoluzione in relazione alla storia della diaspora è stata teorizzata da Wang Gungwu,
considerato uno dei più importati studiosi della Diaspora Cinese e vice rettore
dell'Università di Hong Kong fra il 1986 e il 1995.
Sebbene ci siano state migrazioni verso l'Asia meridionale da parte della comunità
cinese anche prima, è il periodo della dinastia Ming (1368-1644) che vede la
formazione di un vasto flusso verso le Filippine, Malacca e verso le isole
dell'Indonesia. Si tratta prevalentemente di "Huashang" (Wang, 1991) o "Mercanti
Cinesi", cioè mercanti che commerciavano al di fuori della Madrepatria, creando un
flusso di merci da e verso la Cina. Con il passare del tempo molti di questi migranti
si assestarono in questi paesi, che dal punto di vista commerciale fruttarono enormi
ricchezze. La cultura che crearono era spesso un ibrido di tradizione cinese e cultura
locale, come la "Peranakan" che si sviluppò in Malaysia e Indonesia. Nonostante
questo, la "Cinesità", cioè l'identità etnica cinese, rimase forte e preponderante nei
mercanti "Huashang", così come rimase forte il loro legame con la Madrepatria.
Questa tipologia migratoria è caratteristica dei flussi a partire dal terzo secolo d. C,
7
sviluppatasi in particolar modo in Asia prima dell'arrivo degli europei. Infatti,
quando nel sedicesimo secolo d. C gli europei raggiunsero il Sud-Est Asiatico, le
comunità cinesi si erano già stabilite nella regione.
La caduta della dinastia Ming e l'ascesa della Dinastia mancese (e quindi
"non cinese") dei Qing nel 1644 provocò un'onda migratoria verso Taiwan e in Sud-
Est. In questo periodo la maggior parte delle migrazioni era illegale e ai cinesi, una
volta lasciato il paese, non veniva più permesso di rientrare in patria. Solo nella
seconda metà del 1800, a seguito delle Guerre dell'Oppio (1839-42; 1850-56) la
migrazione di massa venne considerata legale.
Il potere coloniale desiderava ottenere l'aiuto dei lavoratori cinesi nelle piantagioni
del Sud-Est Asiatico e in America. La seconda tipologia di migrante cinese, il
"Huagong" (Wang, 1991), ovvero Coolies cinesi , si sviluppò tra il 1840 e il 1920.
Gli "Huagong" formarono la prima forma significativa di migrazione dall'Asia verso
il Nord America e l'Australia, dove lavorarono nelle miniere d'oro e nella
costruzione delle ferrovie. La maggior parte degli "Huagong" erano contadini di
umili origini. Oltre ai braccianti, il flusso migratorio era composto da mercanti e
artigiani, ma solo in piccola percentuale.
Con la caduta della dinastia Qing (1911) e per tutta la prima metà del
Ventesimo secolo, si palesò una nuova forma di "Huaqiao", che Wang definisce
"Chinese Sejourner". Questa concezione supera l'idea di Coolie, in quanto i migranti
erano spesso professionisti guidati da un forte sentimento nazionalista e miravano a
promuovere la cultura cinese fra le comunità di Overseas, sopratutto del Sud-Est
Asiatico. Essi erano spesso associati a università in Europa e divennero i leader
politici della Cina repubblicana e successivamente comunista. Ciò che avevano in
comune con gli "Huagong" era l'intenzione di tornare in patria dopo il periodo
trascorso all'estero, ma questo fattore venne meno a seguito dei problemi economici
e politici che segnarono l'ascesa della Cina comunista all'inizio degli anni '50 del
Novecento.
8
La maggior parte dei cinesi migrati provenivano dalle province meridionali del
Guangdong e del Fujian. Il flusso migratorio dalla Cina del sud alla fine del
Diciannovesimo secolo è responsabile della creazione delle Chinatowns tutt'oggi
presenti nel mondo. La cultura tradizionale di questi individui ha plasmato la forma
e la struttura del rapporto tra gli Overseas Chinese e la Madrepatria nel corso del
Ventesimo secolo.
Una nuova ondata migratoria è iniziata dopo la messa in atto delle politiche
delle "porte aperte" in Cina nel 1970 che hanno portato alla migrazione di cinesi non
solo dal sud, ma da tutto lo stato per ragioni economiche verso gli USA, Canada e
Australia (possono essere considerati come una forma moderna di "Huashang" e
probabilmente anche "Huagong"). Prevalente nella migrazione cinese
contemporanea è il modello migratorio del "Huayi" (Wang, 1991), cioè
"Discendente cinese" che riguarda cinesi che risiedono fuori dalla Cina e che si
spostano in altri luoghi. Possono essere considerati "Huayi" i rifugiati cinesi dal
Vietnam alla fine degli anni settanta che migrarono in Nord America e Australia.
La natura economica della Diaspora Cinese ha causato conflitti fra gli
studiosi, in particolare riguardo al fatto che si debba chiamare "Diaspora", in quanto
essa non può essere paragonata, ad esempio, alla Diaspora degli Ebrei in quanto non
c'è la mancanza di Madrepatria e non c'è stata persecuzione. Inoltre esiste una
grande differenza fra la popolazione dei Cinesi d'Oltremare in termini di diversa
generazione (il flusso si è protratto per secoli), diverse origini (Fujian, Guangdong,
Hong Kong, Taiwan, Vietnam e altri), diverse destinazioni (Hong Kong, Taiwan,
Sud-Est Asiatico, USA, Australia, Europa), diverse classi sociali (dalle élite ai
gangster di strada) e diverse forme di rapporto con la Cina e con il paese d'approdo.
In “The Chinese Diaspora or the Migration of Chinese Peoples”, il geografo Ronald
Skeldon sostiene che il termine “Diaspora” nel suo significato storico non
rappresenti al meglio l'esperienza cinese, in quanto a suo parere spesso si dovrebbe
parlare di Immigrazione e non di diaspora. Molti studiosi sostengono che ciò che
9
vediamo oggi come comunità di Overseas Chinese è il risultato di tante, piccole
"Diaspore geografiche" (Chan, 1992), ognuna con una peculiare struttura causale.
L'unico aspetto che le unisce potrebbe essere la "Cinesità", che consiste
nell'immedesimarsi in una categoria razziale e che trasporta un forte significato
culturale.
1.2 La Diaspora Cinese nel Sud-Est Asiatico: cronologia e
posizionamento geografico dei flussi
Figura 1 : Il Sud-Est Asiatico
Fonte: www.33ff.com
Le tappe storiche dello sviluppo del movimento migratorio verso il Sud-Est
Asiatico sono le stesse della cronologia della Diaspora Cinese nel resto del mondo.
La centralità del flusso dei Cinesi d'Oltremare nell'estremo punto dell'Asia oceanica
è data sopratutto dalla significatività del ruolo economico e culturale
dell'insediamento che si è andato a creare nel corso dei secoli. Le prime popolazioni
d'oltremare arrivarono nel Sud-Est attraverso spedizioni navali nel Nanyang (Mari
del Sud) già nel Tredicesimo secolo, in quello che viene definito dallo studioso
Anthony Reid come “primo impulso mongolo4” che insieme alla prima ondata 4 “Cinesi d'Oltremare: l'insediamento nel Sud-Est Asiatico”, a cura di Anthony Reid, Ed. Fondazione,
10
migratoria dell'epoca Ming costituiscono i più celebri viaggi cinesi nella regione.
Dopo questa prima fase molti cinesi (Huashang) si stabilirono nella zona fino a
costituire una percentuale consistente nella popolazione totale in numerosi Paesi. Il
numero assoluto di migranti cinesi nel Sud-Est crebbe enormemente durante il
periodo coloniale. Gli Huaqiao, tra il Sedicesimo e il Diciottesimo secolo,
provenivano perlopiù dalle province marittime di Guangdong e di Fujian, seguite da
quella di Hainan (vi sono prove, però, di alcuni gruppi di immigrati cinesi insediatisi
a Malacca prima delle grandi onde migratorie del Sedicesimo secolo).
Nel Diciottesimo e Diciannovesimo secolo molti Hokkien (un gruppo etnico
-linguistico legato all'idioma del Dialetto Cinese Min Nan parlato da molti Cinesi
d'Oltremare nel Sud-Est Asiatico) e Cantonesi scelsero di lavorare in Asia sud-
orientale, dove avevano legami precedenti che risalivano all'era Ming. La città di
Taishan nella provincia del Guangdong fu il punto di origine di molti di questi
Huagong spinti da motivi lavorativi che si stabilirono in Siam, Vietnam meridionale,
Cambogia, Filippine. In Malaysia e Singapore si costituirono comunità cinesi
meticce. La maggior parte degli immigrati che raggiunsero l'area di interesse
nell'Ottocento non avevano intenzione di fermarvisi: essi possono dunque essere
definiti come emigranti temporanei che avevano l'intenzione di lavorare fino alla
creazione di capitale di risparmio. Nel Siam, ad esempio, una percentuale altissima
di Coolies cinesi (60-80 per cento) tornava in patria dopo pochi anni di manovalanza
e quelli che rimanevano o erano troppo poveri per ripartire, o avevano fatto fortuna.
Dalla metà del Diciannovesimo secolo in poi, l'emigrazione di Huaqiao si è diretta
primariamente verso i paesi occidentali come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, la
Nuova Zelanda, il Brasile, e le nazioni dell'Europa Occidentale, principalmente per
motivi di studio o lavoro. Nel Sud-Est Asiatico, nel frattempo, si erano già create
comunità cinesi a Hong Kong, Singapore, Malaysia, Filippine, soprattutto a seguito
dell'apertura dei porti commerciali alle potenze coloniali europee (anche a seguito
del Trattato di Nanchino, 1842). Peculiare fu l'esperienza degli Overseas in Vietnam Giovanni Agnelli, 2002
11
a partire dal Diciottesimo secolo, e in questo paese gli immigrati di etnia cinese
presero il nome di “Hoa” (Reid, 2002). Intorno al 1975, le comunità Hoa del nord e
del sud contavano circa 1,3 milioni di individui, quasi tutti residenti nell'area
metropolitana di Saigon, specialmente nella China Town di Cholon. L'etnia Hoa si è
stabilizzata anche ad Hong Kong nel corso del 1900.
Fino agli anni Venti del Ventesimo secolo le donne cinesi emigrate nel Sud-
Est Asiatico erano molto poche, di conseguenza i nuovi arrivati prendevano spesso
in moglie o come concubina una donna del luogo. Giunsero poi gli anni dei
mutamenti profondi, determinati dalla caduta dell'ingerenza coloniale nell'area. Il
Nazionalismo, sia cinese che indigeno, cominciò ad affermarsi: scuole, giornali,
riviste e circoli letterari cinesi contribuirono all'affermazione delle idee anticoloniali
del Guomindang che portarono alla crescita del senso di solidarietà tra cinesi a
favore di un processo di “Risinificazione5”, soprattutto fra i Peranakan in Indonesia
e Malaysia. A testimonianza dello stretto rapporto tra Huaqiao il governo di Sun-
Yat Sen vi fu un flusso di finanziamenti inviati dal Sud-Est Asiatico verso la Cina
per sostenere l'industrializzazione in patria e la guerra sino-giapponese dopo gli
anni Trenta. Con la vittoria di Mao Zedong nel 1949 e il consolidamento degli stati
indipendenti in Asia, fu chiesto ai cinesi di prendere la cittadinanza nei paesi dove
risedevano e di assumere l'identità nazionale. Negli anni Settanta la componente
politica del Nazionalismo cinese fece spazio al Nazionalismo etnico e culturale, teso
a sviluppare e mantenere l'identità cinese nelle società multirazziali del Sud-Est
Asiatico (Reid, 2002).
1.3 La dimensione demografica: entità dei flussi e dati statistici
I Cinesi d'Oltremare sono oggi circa 40 milioni e si sono stabiliti
prevalentemente nel Sud-Est Asiatico (circa 30 milioni e 100 mila individui)6. Per il
periodo precedente alla seconda metà dell’Ottocento non si hanno dati certi, ma solo
5 “Cinesi d'Oltremare: l'insediamento nel Sud-Est Asiatico”, a cura di Anthony Reid, Ed. Fondazione Giovanni Agnelli, 2002
6 “The Ranking of Ethnic Chinese Population Overseas - Compatriot Affairs Commission, R.O.C.”, 2010
12
stime approssimative del numero totale di Huaqiao residenti nel territorio in
questione. Anche i censimenti effettuati nell’ultima parte del periodo coloniale non
sono affidabili, con le eccezioni di Singapore e Malaysia. Nella seguente tabella
(Tab.1) espongo i dati relativi alla popolazione Huaqiao residente rispettivamente in
Thailandia, Malaysia, Singapore, Indonesia, Filippine e Vietnam tra i primi anni del
1800 e il 1922.
Tabella 1: Stima dei Cinesi residenti nel Sud-Est Asiatico 1800-1992
Thailandia Malaysia Singapore Indonesia Filippine Vietnam Cambogia
1800 203.000 14.000 /7 185.000 120000 Mestizo8
7000
Cinesi
/ /
1860 337.000 <100.000 50.000 222.000 290.000 Mestizo
23.000
Cinesi
/ /
1900 608.000 535.000 165.000 537.000 41.000 80.000 40.000
1930 648.000 1.700.000 422.000 1.233.000 110.000 200.000 100.000
1960 2.670.000 2.674.000 1.091.000 2.690.000 / 800.000 250.000
1980 6.000.000 4.200.000 1.800.000 4.100.000 / / /
1992 5.800.000 5.200.000 2.000.000 7.200.000 800.000 800.000 /
Fonte: V. Purcell, The Chinese in South-east Asia, 1951, pag. 3-43, 169,175; Dati 1992: The Economist,
18 Luglio 1992, pag. 21; “Cinesi d'Oltremare: l'insediamento nel Sud-Est Asiatico”, a cura di Anthony
Reid, Ed. Fondazione Giovanni Agnelli, 2002
7 Dati non pervenuti8 Mestizo: si riferisce a persone di etnia mista o discendenti da famiglie miste, termine utilizzato per
indicare l’etnia mista Cinese e Filippina
13
Negli ultimi dieci secoli sono state individuate cinque fasi di crescita demografica
cinese nel Sud-Est Asiatico (Wang, 1991):
• Nella prima fase, tra il Decimo e il Sedicesimo secolo, i mercanti cinesi o
Huashang giunsero nei porti dell’Asia Sudorientale rimanendovi
temporaneamente o a lungo termine, ma crearono raramente comunità Cinesi
permanenti;
• Nella seconda fase, tra il 1567 e il 1800 circa, i quartieri commerciali cinesi
si ampliarono, soprattutto nelle grandi città come Bangkok, Manila e Batavia.
Sorsero comunità minerarie e agricole in Vietnam, Cambogia, Malaysia. Si
svilupparono in questo periodo le popolazioni creole a Giava e nelle
Filippine (la percentuale di Mestizo e meticci toccò il suo apice nel 1800).
Comunque, anche in questa seconda fase migratoria, la popolazione di etnia
cinese in Asia rimase scarsa (percentuali sulla popolazione nativa tra il 2 e il
5 per Cento).
• La terza parte comprende il periodo che va dal 1800 al 1860, in cui le mete
della migrazione cinese furono Bangkok e Singapore. In questa fase si
sviluppa l’idea nazionalista della “Cinesità”.
• Nel quarto periodo (1860-1930) si verificò una crescita esponenziale dei
residenti cinesi (Huagong).
• Nel quinto ed ultimo periodo, tra il 1931 e il 1981, il tasso medio annuo di
incremento della popolazione cinese in Thailandia, Singapore e Indonesia
risulta superiore rispetto a quello dei settant’anni precedenti.
Oggi, la più grande comunità di Overseas in seno a questo territorio è quella di
Singapore, dove costituiscono l'etnia maggioritaria, e in minor misura (ma altrettanto
significativa) si sono stabiliti in Thailandia, Malaysia, Indonesia, Filippine e
Vietnam, come si evince dalla tabella 1.
14
Tabella 2: Dati popolazione di Huaqiao nei principali paesi del Sud-Est
Asiatico
Continente / paese Popolazione di Huaqiao Anno dei dati
Asia 30,100,000+
Thailandia 7.053.240 2005
Malaysia 6.390.900 2010
Singapore 2.794.000 2010
Indonesia 7.000.000 2008
Filippine 1.100.000 2005
Vietnam 1.200.000 2005
Cambogia 1.180.000 2008
Myanmar 1.100.000 2005
Corea del Sud 696.8612 2010
Giappone 655.3771 2008
Fonti: Population Distribution and Basic Demographic Characteristic Report 2010 (Updated:
05/08/2011 – Corrigendum); Table 3 Ethnic Composition of the Resident Population, in Singapore
Department of Statistics, Social Statistics Section, 2011
Le aree urbane9 con le più significative comunità cinesi nel Sud-Est Asiatico
sono Bangkok con 2.900.000 Huaqiao (secondo il censimento del 2009, riguardante
quindi i soli residenti registrati), Singapore con 2.800.000 abitanti provenienti dalla
Cina (censimento 2010), Kuala Lumpur con 612,277 individui (censimento 2000,
solo la città), Penang con 650.000 (2005), Giacarta con 528.300 (censimento 2010).
Proiettando questi dati nel futuro, Anthony Reid, nella sua Introduzione al volume
da lui curato “Cinesi d'Oltremare: l'insediamento nel Sud-est Asiatico”, sostiene che
sicuramente la popolazione cinese nel Sud-Est Asiatico continuerà a crescere,
raggiungendo i 35 Milioni di individui entro i prossimi vent’anni, a meno che il 9 Si prendono qui in considerazione le aree urbane del Sud-Est Asiatico più significative dal punto
di vista demografico rispetto alla popolazione di etnia cinese. Le aree metropolitane più importanti in Occidente sono: 1. New York con 665.714 Huaqiao 2. Area statistica combinata San Jose - San Francisco- Oakland con 562.355 ab. (2009) 3. Grande area di Toronto con 486.300 ab. (censimento 2006, area metropolitana).
15
tasso di crescita della popolazione Huaqiao diminuisca in modo drastico e
improvviso (rispetto a quella indigena).
1.4 Le comunità Huaqiao in Thailandia, Malaysia, Filippine, Vietnam e
Singapore
La Diaspora Cinese, le sue origini, il suo sviluppo e i suoi effetti economico-
culturali assumono diverse caratteristiche in base al paese che interessano. Nei
prossimi paragrafi prenderò in considerazione le peculiarità del flusso migratorio in
alcuni dei paesi del Sud-Est Asiatico che presentano una percentuale significativa di
residenti di etnia cinese, tanto da portare alla creazione di nuovi processi culturali,
economici e politici (Wang, 1991).
1.4.1 Thailandia
La Thailandia ospita una delle più grandi comunità di Huaqiao nel Sud-Est
Asiatico, con processi di integrazione e assimilazione culturale molto profondi.
Il flusso migratorio verso questo Paese ha interessato, negli ultimi decenni, circa 7
Milioni di persone (14 per Cento della popolazione).
La maggioranza dei Cinesi in Thailandia vive in città come Bangkok, Phuket, Hat
Yai e Nakhon Sawan. La maggioranza di questi Overseas appartiene al gruppo
etnico-linguistico di ceppo Han (etnia più diffusa in Cina) caratterizzato dal dialetto
Teochew. Molti di loro vivono nella parte settentrionale della Thailandia, che può
essere definita “confinante” con la provincia cinese dello Yunnan.
Il caso della Thailandia è peculiare dal punto di vista politico: infatti, l'attuale
monarchia nel Paese è retta dalla dinastia Chakti, discendente dal re Rama I, che era
un meticcio cinese. Anche il suo predecessore, re Taksin della dinastia Thonburi, era
figlio di immigranti cinesi provenienti dalla provincia di Guangdong e nacque con
16
un nome cinese. Altro dato che ci permette di capire quanto sia importante e
profonda l'influenza a livello dell'Amministrazione, del governo e dell'economia è
che la maggioranza dei Primi Ministri e Ministri in Thailandia sono di discendenza
cinese (Reid, 2002). Poiché essa è l'unica nazione nel Sud-Est Asiatico che non ha
mai sperimentato dominio coloniale europeo, il governo thailandese ha sempre
gestito da solo la questione della migrazione cinese sul suo territorio.
Al culmine del flusso migratorio cinese, alla fine dell' Ottocento, gli Huaqiao si
resero conto che l'unico modo per accrescere il loro status sociale era quello di
diventare un membro del governo Thai a livello amministrativo o militare. Questa
caratteristica sociale, come spiega G. William Skinner, ha creato una situazione in
cui "l'ascesa politica dei discendenti di immigrati cinesi, e il fatto che tutti
aspiravano a questo, ha fomentato un movimento sociale peculiare nella società
thailandese"10
Il governo thailandese, durante il regno di Mongkut tra il 1851 e il 1868,
aveva definito una chiara distinzione tra i cittadini cinesi e thailandesi. L'idea di
creare un netto contrasto tra le identità culturali di Huaqiao e nativi potrebbe trovare
la causa nella volontà di separare i due gruppi e portare la popolazione cinese ad
aggrapparsi alle pratiche culturali originarie, mancando il processo di assimilazione.
Prima del 1855, per esempio, i cinesi non avevano il diritto di viaggiare liberamente
all'interno del Paese, soprattutto al di fuori della città di Bangkok. Successivamente
il governo Mongkut rimase colpito dall'etica del lavoro cinese, e decise di mettere in
atto politiche per incoraggiare i cinesi ad emigrare in Thailandia. Si svilupparono in
questo periodo sentimenti positivi verso la minoranza di Overseas e nel 1909 la
monarchia thailandese dichiarò che i cinesi "non sono stranieri, ma un gruppo etnico
che deve essere ritenuto parte del nostro regno". Discorsi come questo non solo sono
stati accolti con favore da parte dei cinesi, ma li hanno spronati a far parte della
società Thailandese11.10 Da “The Journal of Asian Studies” :Chinese Assimilation and Thai Politics, February 1957 16: pag.
237-25011 Ibidem
17
1.4.2 Malaysia
La storia registra la presenza di cinesi in Malaysia già dalla fine del 1400, a
partire dalla creazione del Sultanato di Malacca controllato e protetto dalla Dinastia
imperiale Ming, per cui la presenza di Huaqiao in Malaysia fu sempre significativa.
Gli immigrati cinesi si mischiarono da subito con la popolazione nativa, attraverso
matrimoni con donne del posto, ma mantennero sempre una spiccata coscienza
identitaria, che si può inserire nei discorsi sulla “Cinesità” e sulla volontà dei Cinesi
d'Oltremare di tenersi in collegamento costante con la Madrepatria (Reid. 2002). La
maggior parte di loro proveniva dalla provincia cinese del Fujian ed avevano
rapporti di discendenza con l'aristocrazia malese. Essi sono conosciuti come i
Peranakan.
Tra il 1700 e il 1800, nel periodo del colonialismo inglese, vi fu una seconda
ondata migratoria proveniente dalla Cina, soprattutto dal Guangdong e dal Fujian. Si
trattava di Huashang, mercanti che trattavano con gli Straits Settlement ed avevano
le loro basi in Malaysia. Grazie al loro senso del Business, alla loro etica lavorativa e
alla portata delle opportunità economiche, sia il governo inglese che quello malese si
interessarono molto alla minoranza cinese, che ottenne il controllo commerciale di
molte miniere d'oro e la possibilità di lavorare nelle nuove piantagioni del Sud-Est
Asiatico. Successivamente molti cinesi si diressero verso le grandi città della
Malaysia dove istituirono banche di risparmio e credito, oltre a molte piccole e
medie imprese.
Oggi gli Huaqiao hanno un ruolo fondamentale nell'economia malese,
vivono in piccole cittadine dell'Hinterland, soprattutto nell'est e nell'ovest del Paese.
I cinesi malesi parlano un'ampia varietà di dialetti, oltre al cinese mandarino che
viene usato soprattutto nelle grandi città metropolitane come Penang e Malacca per
le transizioni commerciali (ovviamente oltre al malese e all'inglese). La comunità
18
cinese in Malaysia è, insieme a quella Thailandese, la più importante per quanto
riguarda il numero di residenti (6 Milioni di persone) e per la percentuale di
Huaqiao rispetto alla popolazione nativa (circa il 20 per Cento)12.
1.4.3 Filippine
Le stime sulla presenza dei Cinesi d'Oltremare o Tsinoy (gruppo di etnia
cinese) nelle Filippine variano da 600.000 a 900.000 residenti, dei quali meno di
150.000 nati all'estero (Reid, 2002).
Gli Huashang arrivarono e vissero a Manila prima dello sbarco spagnolo sulle sue
sponde. I mercanti cinesi provenivano dalla provincia del Fujian, facevano parte di
una più grande economia marittima che crebbe di importanza nel Sud-Est Asiatico
durante la Dinastia Song (1127-1276). Questo facilitò la creazione di un sistema
economico di esportazione dalla Cina e facilitò l'importazione di merci dal mercato
della Madrepatria, formando un gruppo di Cinesi d'Oltremare specializzati nel
commercio.
Dopo l'indipendenza delle Filippine nel 1946, vennero introdotte misure per
limitare le opportunità economiche dei Cinesi. Nel 1961 venne introdotta la
“Filippino First”, che favoriva gli interessi dei nativi rispetto a tutte le altre etnie e ai
Filippini naturalizzati, cioè quegli immigrati che erano stati assimilati nella società
del luogo, le industrie vennero nazionalizzate e le possibilità lavorative vennero
riservate ai Filippini. Nel 1974, sotto il governo del primo ministro Ferdinand
Marcos (1917-1989), vi fu un enorme cambiamento rispetto alle politiche statali
riguardo le procedure per l'ottenimento della cittadinanza filippina per gli
Overseas, che furono agevolate e i Cinesi entrarono a far parte dello Stato.
12 Population Distribution and Basic Demographic Characteristic Report 2010 (Updated: 05/08/2011 –
Corrigendum)
19
Oggi, la comunità cinese deve affrontare un problema di pregiudizio, dato che molti
di loro sono visti come ricchi uomini d'affari che, sostenuti da cartelli della
Madrepatria, hanno eliminato la concorrenza di altri gruppi aziendali, come quelli
istituiti dai nativi. Nonostante questo è da segnalare la presenza di una numerosa
classe operaia cinese nelle Filippine, e questo crea un forte divario tra Cinesi ricchi e
poveri. Nel complesso, malgrado il persistere di idee legate al passato e alla
cosiddetta mancanza di etica nel mercato, la comunità cinese è oggi ben integrata nel
paese, soprattutto la popolazione giovanile che spesso non conosce nemmeno il
cinese mandarino, ma solo l'inglese e il tagalog13.
1.4.4 Vietnam
L'esperienza cinese in Vietnam è caratterizzata da una storia complessa. Nel
periodo tra la dinastia Qin (221 a. C.- 206 a. C) e quello delle 5 Dinastie e Dieci
Regni (907 d. C – 979 d. C) la parte settentrionale dello Stato vietnamita fece parte
dell'impero cinese (Reid, 2002). Questa situazione venne rovesciata dal perdurare di
momenti di disintegrazione politica nel Paese del Centro14 che, insieme
all'incremento della Resistenza locale, fece cadere il Vietnam in modo discontinuo
sotto la sua influenza. I cinesi che giunsero in Vietnam come Huaqiao erano
soprattutto amministratori, soldati e mercanti. Essi portarono con sé la cultura tipica
della regione di provenienza e divennero i principali “missionari” dell'identità cinese
nella società vietnamita. Nello stesso periodo vennero contratti molti matrimoni tra
Cinesi d'Oltremare e nativi, che andarono a formare un'élite Sino-Vietnamita.
Le leggi sull'immigrazione e le politiche sull'accoglienza dei protagonisti
della Diaspora Cinese hanno seguito un corso altalenante, sono variate da periodo a
periodo e di intensità. In molte città i Cinesi erano costretti a vestire alla maniera
13 Wickberg, Edgar. (March 1964) The Chinese Mestizo in Philippine History. The Journal Southeast Asian History, 5(1), 62-100. Lawrence, Kansas: The University of Kansas, CEAS
14 Dal cinese 中国 Zhōngguó “Paese del centro”dalla concezione cinese della Cina al centro del mondo.
20
locale o a vivere in determinati quartieri. In periodi caratterizzati da maggiore
liberismo, essi potevano commerciare e risiedere in qualsiasi area, senza particolari
restrizioni. A seguito della caduta della Dinastia Ming (1368 d. C – 1644 d. C), molti
rifugiati cinesi si spostarono in Vietnam e vi si stabilirono. Molti Huashang presero
parte a queste comunità data l'instabilità politica che contraddistingueva la
Madrepatria alla fine del 1600. Essi erano chiamati Ming-Xiang o Minh Huong in
Vietnamita. Successivamente il loro nome venne reinterpretato dal governo del
luogo, e vennero definiti Ming-Xiang15, omofono della precedente denominazione
ma con significato diverso. Con questo nome vennero indicati anche i figli dei
Cinesi d'Oltremare a partire dal Diciottesimo secolo. Nel 1700 gli Huashang
avevano come sede commerciale la Chinatown di Cholon, nel Sud del Vietnam,
dove nel 1782 vi fu un massacro perpetrato dalle Forze dei Tây So'n16 nei confronti
della comunità cinese di Bien Hoa che si era rifugiata proprio a Cholon, provocando
la morte di circa diecimila Cinesi.
Il Vietnam perse la sua autonomia politica nel 1887 con l'arrivo dei Francesi
e la creazione dell'Indocina Francese (Vietnam centrale con capitale Annam, parte
settentrionale del paese con la città di Tonkin e il Sud con Cochin). In questo
periodo gli Huaqiao vi giunsero via mare e trovarono lavoro come commercianti,
artigiani e Coolies. Vennero create le comunità cinesi di Haiphong, Hanoi, Da Nang,
Saigon e Cholon e vennero istituite associazioni, costruiti scuole e templi per poter
soddisfare i bisogni dei gruppi di Chinese Overseas e preservare l'identità culturale
cinese.
Allo scoppio della guerra sino-giapponese, una delegazione di Cinesi del Vietnam
partecipò al Meeting a Singapore il 10 Ottobre 1938. Questo gruppo contribuì alla
15 Ming-Xiang 明乡: il primo carattere 明 indica uno strumento rituale che veniva utilizzato nelle cerimonie legate al lignaggio famigliare o politico, mentre il secondo 乡 carattere significa “villaggio”
16 Il nome Tây So'n indica un periodo di rivolte paesane fra la Dinastia del Naten Ye e la Dinastia Nguyen (1770-1802)
21
fondazione della Nanyang Federation of China Relief Fund17, un'associazione dedita
all'invio di finanziamenti a scopo supportivo dal Vietnam alla Cina. Durante la
Seconda Guerra Mondiale i giapponesi invasero il paese ed utilizzarono Hanoi come
base aerea per attaccare la Strada di Birmania o Burma Road18, una strada che
collegava la Cina alla Birmania. Dopo la guerra, i Francesi cercarono di reclamare
l'autorità coloniale sui territori vietnamiti senza ottenere grandi risultati. Infatti il
Paese fu diviso in due aree distinte nel 1954: Il Vietnam del Nord cadde sotto
l'influenza di Ho Chi Minh e dei Vietmin, mentre il Sud prese il nome di Repubblica
del Vietnam del Sud, con un governo filo-francese e capitale presso Saigon.
A seguito della Guerra del Vietnam (1960-1975), che vide contrapporsi Nord e Sud
del paese (ideologicamente Comunismo contro Capitalismo, rappresentato
dall'ingerenza degli Stati Uniti nel conflitto), Saigon cadde e i due territori vennero
riunificati politicamente sotto la dirigenza comunista di Hanoi.
I Cinesi d'Oltremare subirono la pressione anticapitalista durante la guerra
nel Vietnam del Nord, e furono soggetti a diverse campagne razziste nel Sud del
Paese. La conseguenza principale di questi fenomeni fu un'onda migratoria
massiccia verso la Cambogia e la Cina alla fine degli anni '70, di circa 250,000 Hoa,
l'etnia cinese più diffusa in Vietnam. Quasi tutti intraprendevano il viaggio dal nord
del Vietnam verso le regioni a sud della Cina (soprattutto Guangxi) su grandi barche;
per questo fu loro dato il nome di "popolo delle barche". Dal 1980 il Vietnam vide
una crescita economica importante e l'introduzione di riforme che hanno portato il
Paese ad emergere a livello mondiale.
Negli anni '90 il censimento ha rivelato che gli Huaqiao rappresentano l'1,1 per
Cento della popolazione totale, il sesto gruppo minoritario in Vietnam. Oggi i nativi
e i discendenti degli immigrati cinesi vivono a stretto contatto, le comunità di 17 La China Relief Fund o Nanyang Federation of China Relief Fund fu fondata nel 1938 da 170 Cinesi
d'Oltremare originari della regione del Nanyang, i Mari del Sud. Il loro obiettivo era quello di coordinare il supporto nei confronti della Madrepatria nella guerra Sino-giapponese.
18 La Strada di Birmania fu costruita dai britannici e dagli americani nel corso della II guerra mondiale, e serviva a garantire rifornimenti tra la Birmania e la Cina.
22
Chinese Overseas hanno costruito templi e istituito associazioni culturali che sono
simbolo di un'integrazione e assimilazione profonda nel territorio (Wang, 1991).
1.4.5 Singapore
A Singapore, la popolazione è in maggioranza di etnia cinese (76,8 per
Cento) e il Putonghua19 è riconosciuto come una delle lingue ufficiali, insieme ai
caratteri cinesi semplificati, in contrasto con altre comunità di Cinesi d'Oltremare
che hanno usato quasi esclusivamente i caratteri cinesi tradizionali fino al 1990,
quando cittadini della Repubblica Popolare Cinese cominciarono ad emigrare in
grande quantità e portarono con sé l'uso dei caratteri cinesi semplificati (Khánh,
Trâǹ, 1993)20. Sebbene gli Huaqiao residenti a Singapore siano prevalentemente di
discendenza Hokkien, il governo di Singapore scoraggia l'uso di lingue cinesi non-
mandarine attraverso la "Campagna parla mandarino" (Speak Mandarin
Campaign), un'iniziativa in vigore dal 1979 e volta ad incentivare la diffusione del
Putonghua. Il governo di Singapore promuove attivamente l'inglese come la lingua
comune di quella società multiculturale e i giovani singaporiani cinesi sono per la
maggior parte bilingui (parlano mandarino e inglese).
Quando gli Huaqiao giunsero a Singapore tra il Diciannovesimo e il
Ventesimo secolo si stabilirono in comunità etniche riconducibili per caratteristiche
e struttura alle Chinatowns, unite dalla prossimità linguistica e culturale. Essi
crearono 5 gruppi principali a base linguistica, chiamati Banggun (Khánh, Trân,
1993) :
•Hokkien Bang;
•Teochew Bang;
19 O Cinese Mandarino, Pǔtōnghuà 普 通 话 significa, letteralmente, “lingua comunemente/ universalmente utilizzata” in Cina. Venne introdotta nelle scuole nel 1956 per livellare il divario linguistico tra dialetti in Cina, ed è basata sul Dialetto cinese del Nord.
20 The Ethnic Chinese and Economic Development in Vietnam. Institute of Southeast Asian Studies.
23
•Cantonese Bang;
•Hakka Bang;
•Hainan Bang.
Nel 1900, il governo coloniale britannico adottò un approccio politico basato sul
concetto “I Cinesi per governare i Cinesi” e appoggiarono i leader Huaqiao, che
crearono organizzazioni in grado di rappresentare i cinesi già residenti a Singapore,
oltre a creare una rete di supporto per gli immigrati. Queste associazioni presero il
nome di Chinese Temples o Chinese Clan Associations.
I Cinesi di Singapore acquisirono nel tempo grande importanza a livello
economico: nel 1906 venne istituita la Camera di Commercio e per l'Industria
Cinese, che rappresentò la più alta forma di organizzazione commerciale tra Chinese
Overseas nel Paese. I componenti di questa Associazione combatterono per i diritti
degli immigrati cinesi a Singapore e durante la Seconda Guerra Mondiale spedirono
aiuti finanziari alla Madrepatria. Dopo aver ottenuto l'indipendenza nel 1960, il
governo di Singapore mise in atto misure per favorire l'armonia fra gruppi razziali
diversi e vennero istituiti gruppi preposti alla diffusione della cultura cinese come la
Confucian Association, il Singapore Chinese Opera Institute, insieme a molte
organizzazioni religiose (Khánh, Trân, 1993) .
24
CAPITOLO 2: RUOLO DELLE COMUNITÀ CINESI NEL SUD-EST
ASIATICO
2.1 Processi di regionalizzazione, Organizzazioni transnazionali
(SEATO, ASEAN) nel territorio del Sud-Est Asiatico.
La regione del Sud-Est Asiatico è stata ed è tutt'oggi interessata da profondi
processi si regionalizzazione che influenzano i rapporti fra i Paesi che appartengono
a questa zona del globo e gli Stati limitrofi.
In primo luogo, è importante definire il significato di “Processo di
regionalizzazione” per poi analizzare la situazione nell'area economico-geografica di
interesse.
Con questa espressione possiamo indicare il processo di creazione di rapporti
pacifici e collaborativi fra Paesi, uniti da fattori economici, culturali, identitari,
politici, atto alla stipulazione di accordi (economici, commerciali, politici,
giuridici...) e alla creazione di Organizzazioni Transnazionali come l' ASEAN, la
SEATO, l' OPEC e molti altri (Johnston, 2000).
2.1.1 Processi di regionalizzazione nel Sud-Est Asiatico
I vari processi di regionalizzazione in Asia e nel Sud-Est Asiatico sono
definiti attualmente come processi di tipo spontaneo.
Con Processo di regionalizzazione spontanea si intende lo sviluppo di relazioni
politico-economiche nate senza l'influenza di strutture transnazionali o Stati
prevalenti. La caratteristica principale di questo fenomeno è la pacifica coesistenza e
il rapporto di potere paritetico fra gli stati interessati (Di Nolfo, 1994).
La “spontaneità” dei processi di regionalizzazione nell'Asia Orientale e Sud-
Orientale è dovuta alla coesione culturale, religiosa, identitaria data dalla base
ideologica del Confucianesimo: Cina, Giappone e India rappresentano infatti il
25
Tridente Confuciano e la cultura predominante si è andata diffondendo nel corso dei
Secoli in tutti i territori della zona circostante queste grandi regioni (Di Nolfo,
1994).
I Processi di regionalizzazione in quest'area del globo non sono però stati sempre di
tipo Spontaneo: le esperienze coloniali hanno prodotto Processi di regionalizzazione
dall' Alto21 imposti dalle potenze imperialiste europee e nordamericane (Di Nolfo,
1994).
Per spiegare come si sia giunti alla situazione odierna è importante ricostruire
le tappe storiche che hanno portato alla formazione, a partire dagli anni cinquanta
del Novecento, delle Organizzazioni Transnazionali come la l'ASEAN o la SEATO.
Una fase importante fu quella dell'avanzare delle potenze coloniali in Asia nel
Diciannovesimo secolo quando molti Paesi, che costituiscono oggi gli Stati della
regione del Sud-Est Asiatico, divennero parte degli imperi coloniali francese e
britannico. Fra il Sedicesimo e Diciassettesimo secolo questo destino coloniale
aveva interessato l'Indonesia, le Filippine, Macao e Timor, rispettivamente
possedimenti coloniali di Olanda, Spagna e Portogallo (De Bernardi; Guerracino,
1987). Nel corso dell'Ottocento alcuni paesi persero la loro autonomia o vennero
forzati ad intrattenere rapporti economico-politici con gli Occidentali, come nel caso
del Giappone che dovette instaurare contatti commerciali con l'Olanda già nel
Diciassettesimo secolo22. Le grandi potenze europee si spartirono il mondo in
possedimenti coloniali: i motivi di questa corsa “imperialista23” furono l'eccedenza 21 Con “Processo di regionalizzazione dall'Alto” si intende, come per quello “Spontaneo”,
l'affermarsi si rapporti transnazionali in aree continue o lontane le une dalle altre, con la differenza che un paese predomina dal punto di vista politico e di potere sugli altri. Spesso lo Stato in questione è “esterno” alla realtà che domina, oppure è sempre stato più influente rispetto agli altri dal punto di vista storico. I Processi di regionalizzazione dall'Alto si sono sviluppati soprattutto durante il periodo coloniale, in Asia Orientale e in Medio Oriente (Di Nolfo, 1994).
22 Nel 1602 fu fondata la Compagnia Olandese delle Indie Orientali, la prima compagnia commerciale multinazionale mai creata. Questa compagnia ottenne il monopolio olandese sul commercio asiatico e lo mantenne per due secoli. A partire dal 1640, la Compagnia Olandese delle Indie Orientali deteneva il monopolio del commercio con il Giappone, con il suo porto commerciale sull'isola di Dejima (vicino a Nagasaki). Fino al 1854, gli olandesi furono l'unica finestra del Giappone sul mondo occidentale.
23 La dottrina imperialista si basa sul principio della superiorità di determinate razze e nazioni nei confronti di altre (Johnston,2000). Le “razze superiori” avevano nei confronti di questi popoli
26
di capitali da investire nei paesi asiatici e la necessità da parte degli apparati
industriali dei paesi europei, a fronte della recente industrializzazione, di
accaparrarsi materie prime e sbocchi di mercato (fino al Sedicesimo secolo la
Bilancia commerciale era stata a favore dei paesi asiatici per la presenza di merci
lussuose e spezie ricercate in Occidente, mentre è proprio per questi motivi che si
capovolse) (Collotti Pischel,2004). Assicurandosi il dominio politico diretto, sia in
Africa che in Asia, le potenze europee riuscirono a tutelare gli investimenti e il
successo delle attività economiche, cercarono di impadronirsi di territori strategici
dal punto di vista politico ed economico e ne cambiarono molto spesso le
configurazioni governative e sociali (Di Nolfo, 1994).
La spartizione dell'Asia orientale in colonie e zone di influenza provocò
contrasti e tensioni che si concentrarono sulla questione della Cina, un impero in
decadenza di cui Gran Bretagna, Francia, Russia e Germania erano intenzionati a
dividersi i territori. A queste potenze europee si aggiunse il Giappone, che nel corso
del Diciannovesimo secolo era stato interessato da un' intensa modernizzazione24,
facendo dello Stato una potenza industriale.
Un altro importante attore in questa fase coloniale furono gli Stati Uniti che,
utilizzando strategie economiche e commerciali antiprotezionistiche, cercavano di
conquistare un' egemonia politica imperialista (Collotti Pischel, 2004).
Nel corso del Diciannovesimo secolo la Cina subì ciò che viene definito
lo“Scramble of China”25 (Bickers, 2012): il controllo territoriale della dinastia
incapaci di amministrare, usare e gestire le proprie risorse, la responsabilità di “Civilizzarle”, impadronendosi di queste zone. É questa la ragione della “missione civilizzatrice” delle potenze europee che lo scrittore Rudyard Kipling, in relazione alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti d America, definisce “fardello dell uomo bianco” (Collotti Pischel, 2004).‟ ‟
24 Restaurazione Meiji (1866-1869).25 Disgregamento del territorio cinese in concessioni alle grandi potenze coloniali. Inoltre tra il 1840 e il
1845 la Cina entrò in conflitto con la Francia e nacque l'Indocina (alla Cambogia e al Vietnam meridionale (1863), si aggiunge il Vietnam settentrionale, sottratto al controllo della Cina a cui nel 1893 si aggiunse il Laos). Anche la Gran Bretagna portò a compimento l' invasione della Birmania (oggi Myanmar) nel 1886 e si spinse poi alla conquista della Malesia e di Hong Kong. Tra il 1894 e il 1895 il Giappone aggredì la Cina. Con il trattato di Shimonoseki il Giappone ottenne possedimenti territoriali in Cina (l' isola di Formosa, oggi Taiwan), da cui ebbe inizio un penetrazione che mutò profondamente il suo ruolo geopolitico in questa area.
27
Menchù26 si fece sempre più debole, minato dalla presenza britannica che
contrabbandava grandi quantità di oppio. Le Guerre dell' Oppio (1839-42; 1850-56)
garantirono alle potenze coloniali l'abbattimento delle politiche protezionistiche e
imposero al governo cinese la politica delle Porte Aperte (De Bernardi; Guerracino,
1987).
Figura 2: Scramble of China (1894-1900)
Fonte: www. blogs.swa-jkt.com: the-scramble-for-china-1894-1900
Alla fine del secolo la Cina consisteva in un complesso di “concessioni”
(Scramble of China), situazione che determinò la rivolta antimperialista nota come
Rivolta dei Boxers27. Un' ulteriore conseguenza fu lo scontro tra Russia e Giappone
entrambi interessati alla Manciuria e alla Corea, conclusasi con la vittoria28 del
Giappone nel 1905 (De Bernardi; Guerracino, 1987).
La fine della Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze determinarono l'ascesa
del Giappone come potenza regionale in Asia Orientale che divenne una soggettività
26 Ultima dinastia regnante in China (1644-1912).27 Rivolta operata dalla società segreta denominata “Ordine letterario e patriottico dei pugni chiusi e
armoniosi” avvenuta nel 1900. A questa seguì una spedizione punitiva internazionale, condotta da Gran Bretagna, Francia, Germania (che ottenne lo Shandong), Russia, USA e Italia (che ottenne la concessione del Tien Tsin).
28 Il Giappone ottenne il protettorato sulla Corea, il controllo della penisola cinese di Liadong, l' annessione di metà dell' isola di Sakhalin e il controllo sulla Manciuria.
28
politica locale fondamentale. La Cina divenne così il terreno su cui costruire il
nuovo assetto politico e strategico regionale, data la sua posizione così prossima al
Paese del Sole. Il Giappone, forte dell'alleanza con l'Intesa, avvantaggiato dalle lotte
interne al Guomindang e dal clima instabile causato dai Comunisti, mise in atto una
costante penetrazione nel territorio cinese. Nel 1927 i due schieramenti della scena
politica cinese decisero di allearsi per contrastare l'avanzata giapponese ma con
scarso successo29. I comunisti rilegati nella regione dello Jiangxi si insediarono
successivamente nella regione dello Yunnan, dove il partito risiedette dal 1935 al
1943 e venne alla luce la figura di Mao Zedong alla guida del Partito Comunista
Cinese.
Per la sopravvivenza di una Cina autonoma gli Stati Uniti e il Giappone si
scontrarono più volte: gli USA, infatti, difendevano la Cina con il fine di mantenere
la Politica delle Porte Aperte. La presenza giapponese nella produzione industriale e
nel commercio divenne molto forte in Cina e aumentò nel corso degli anni Trenta30
soprattutto grazie al controllo della Manciuria che divenne uno Stato indipendente
chiamato Manchukuo (legato al Giappone da una alleanza e definito spesso come
Stato Fantoccio31) con a capo l'ex imperatore cinese Pu Yi (De Bernardi, Guerracino,
1987). Il primo Ottobre del 1949 il Partito Comunista Cinese salì al potere. Il
Guomindang si rifugiò sull' isola di Formosa (Taiwan)32, che divenne un alleato
anticomunista degli Stati Uniti. La Repubblica Popolare Cinese, nel 1950, firmò un
patto difensivo con l'URSS, atto alla creazione di una sfera di influenza che rese
possibile la trasformazione del Sud-Est Asiatico in una regione nevralgica dal punto
di vista geo-politico, tanto da essere paragonata per importanza strategica all'Europa 29 Il partito comunista è costretto a ritirarsi nelle aree più periferiche del Jiangxi. Da questi luoghi il
partito comincia la lunga marcia per il potere.30 I Giapponesi godevano del controllo della Manciuria attraverso le ferrovie, godevano di diritti
di sfruttamento minerario, attività agricole, industriali e commerciali.31 Cit. “Storia dell'Asia Orientale 1850-1949” E. Collotti Pischel, 2004, pg. 67. Nel 1941 il Giappone si
apprestava a concretizzare il progetto egemonico in Asia e Sud Est Asiatico definito come la ricerca della “Sfera di comune prosperità” (nel piano rientravano i territori indocinesi, malaysiani e indonesiani) anche attraverso l'aiuto strategico della Germania di Hitler.
32 Dal 1945 al 1971 Taiwan ha occupato un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in quanto la Repubblica Popolare cinese non venne riconosciuta dalla Comunità Internazionale fino a quell'anno.
29
dell'Est33 (Reid, 2002). Oltre alla Cina rientrarono nella sfera di influenza sovietica
molti paesi dell'Asia Sud-Orientale: Corea del Nord, Vietnam del Nord, Laos e
Cambogia. Nella sfera di influenza USA furono inseriti il Giappone, la Thailandia,
le Filippine, la Corea del Sud34.
Nacque quindi un Nuovo Ordine Coloniale che vide come protagonisti i paesi
antagonisti della Guerra Fredda: URSS e USA. La Russia Comunista, attraverso il
Patto di Varsavia (alleanza difensiva) legò a sé i paesi dell' Europa dell'est. Gli Stati
Uniti sfruttarono una logica regionale e promossero nel 1954 la creazione della
SEATO (South East Asia Treatry Organization) sul modello della NATO.
2.1.1.1 La SEATO
La SEATO fu ed è tutt'oggi un'organizzazione di difesa e collaborazione che
comprendeva, nel 1954, le Filippine, il Pakistan, la Thailandia, il Laos, la Cambogia,
il Vietnam del Sud, a cui si aggiungevano altri paesi in qualità di osservatori, come
l' Australia, la Nuova Zelanda, oltre a USA, Gran Bretagna e Francia. Essa aveva
l'obiettivo di creare uno spazio politico sotto l'egida statunitense, alla base del quale
sottostava la Teoria del Domino elaborata da Eisenhower, in base alla quale
occorreva prevenire il passaggio nell'area di influenza sovietica di alcuni paesi,
specie il Vietnam, al fine di non far innescare l'effetto domino, ovvero il passaggio
tempestivo e automatico dei paesi vicini sotto la stessa influenza (Di Nolfo, 1994).
La stipulazione della SEATO causò una forte reazione del fronte comunista: i
partigiani comunisti del Vietnam del Nord, i Vietcong, penetrarono nel Vietnam del
Sud, poi in Cambogia e nel Laos.
33 Mi riferisco al bipolarismo ideologico, economico e culturale causa dalla Guerra Fredda fra URSS e Stati Uniti fra il 1947 e il 1989. L'Europa dell'Est e il Sud-Est asiatico sono stati definiti come “Stati-Cuscinetto” per la loro prossimità geografica con i paesi comunisti ed hanno avuto una funzione strategica molto importante.
34 In questi elenchi non vengono citati alcuni paesi che in questo periodo storico (1946-1954) ottengono l'indipendenza: nel 1946 l'Indonesia si libera del controllo Olandese; seguono la Birmania, Myanmar, Malaysia; gli accordi di Ginevra del 1954 sanciscono la fine dell' Indocina francese (Collotti Pischel, 2004).
30
L'escalation di eventi diede inizio alla guerra tra Vietnam e USA risoltasi
solo nel 1975 con l'unificazione del paese e il passaggio dei paesi occupati sotto il
controllo vietnamita e, pertanto, sovietico. Nonostante la guerra in Vietnam, i
rapporti fra Usa e Repubblica Popolare Cinese si distesero soprattutto grazie
all'azione del segretario di Stato USA Henry Kissinger35. Nel 1971 alla Cina di Mao
venne riconosciuto il diritto a sedere nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU in
sostituzione della Cina nazionalista di Taiwan. Gli Stati Uniti riconobbero nella RPC
una potenza regionale, interlocutore fondamentale per tutte le questioni relative al
quadrante dell'Asia orientale36.
2.1.1.2 L' ASEAN
Per quanto riguarda le successive politiche di “regionalizzazione” politica-
economica è importante analizzare l'Organizzazione Intergovernativa chiamata
Association of South East Asia Nations o ASEAN, nata del 1967 a Bangkok. Gli
Stati fondatori furono l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la
Thailandia a cui si unirono successivamente Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar e
Cambogia. L' ASEAN è dotato di un organo decisionale composto dai capi di Stato
e di governo, prevede incontri annuali tra i ministri degli Stati contraenti e possiede
una delegazione diplomatica nelle principali città del pianeta per sostenere le
relazioni esterne.
Gli obiettivi dell'Organizzazione sono: accelerare la crescita economica e lo
sviluppo culturale dei paesi della regione, promuovere la pace, la stabilità politica, la
sicurezza sociale nei paesi contraenti, sviluppando le relazioni tra loro attraverso la
collaborazione. Gli stati dell' ASEAN coprono oggi un territorio di circa 4,5 milioni
di kmq sul quale vivono quasi 600 milioni di persone37. A partire dal 2000 è stato
35 La Repubblica Popolare Cinese non intervenne mai a difesa dei comunisti vietnamiti Vietcong.36 Nacque così un Nuovo ordine coloniale mondiale in cui la Repubblica Popolare Cinese veniva
riconosciuta come grande potenza, accanto a USA, URSS e Europa.37 Dati Rapporto Asean Awaewness, 2012, Fondazione Economia Tor Vergata.
31
realizzato un imponente processo di crescita, attraverso il quale un’area
essenzialmente agricola ha conosciuto un processo di industrializzazione che,
seppure ancora non omogeneo, ne ha trasformato i caratteri. L’istituzione, a partire
dal 1992, di un’area di libero scambio, l’AFTA (Asia Free Trade Area), è stata
indubbiamente uno dei principali motori del cambiamento38. La liberalizzazione
dello scambio di beni e servizi e del flusso degli investimenti e, dal 2007, l’adozione
dell’obiettivo di realizzare un mercato unico e una base produttiva comune entro il
2015, hanno portato ad una crescente integrazione delle economie dei 10 paesi
aderenti all’Associazione. Non mancano, tuttavia, controversie che possono incidere
sullo sviluppo, come la disputa in materia di confini tra Thailandia e Cambogia39.
Nel 1994 l'ASEAN ha istituito l'ARF, l'Asia Regional Forum per promuovere
la costruzione di buone relazioni, un sistema di diplomazia preventiva e approcci per
la risoluzione dei conflitti. Nel 1997 l'ARF ha definito la piattaforma programmatica
dell'ASEAN Vision 2020 per promuovere l'apertura verso i paesi terzi e i paesi
associati, la prosperità e il rispetto dell' integrità territoriale e della sovranità di
ciascuno Stato.
Nel 2003 la Dichiarazione del II Concordato ASEAN di Bali, ha stabilito lo
costituzione dell' ASEAN secondo tre pilastri fondamentali: l'ASEAN Security
Community (risoluzione pacifica dei conflitti tra gli Stati membri), la Economic
Community (realizzazione di una comunità economica per il 2020, lotta contro la
povertà e le disparità economiche, abbattimento delle barriere tariffarie) e la Socio-
Cultural Community (potenziamento delle infrastrutture, per incrementare i flussi
turistici ma anche gli scambi intellettuali, miglioramento delle reti di
comunicazione).
Il punto di forza dell’ASEAN è la crescente integrazione delle economie dell’area,
nonché di queste ultime con Cina, Giappone e Corea, attraverso specifici accordi
bilaterali (FTA - Free Trade Agreement)40. 38 Cit. Rapporto Asean Awareness, 2012, Fondazione Economica Tor Vergata, pag. 539 Ibidem40 Ciò ha consentito di creare un rilevante network internazionale per la produzione di parti e
32
2.2 Ruolo Economico dei Cinesi d'Oltremare e il Capitalismo cinese
Il rapido sviluppo economico di Filippine, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Hong
Kong e dei paesi dell'ASEAN negli ultimi decenni ha richiamato l'attenzione sul
ruolo di primo piano svolto in tale processo dai milioni di Cinesi d'Oltremare che
popolano il Sud-Est Asiatico. Questo importante gruppo di "risparmiatori
prodigiosi e investitori" (Reid, 2002) costituisce oggi la minoranza più numerosa e
economicamente affermata, che ha avuto una rilevanza decisiva nella crescita del
capitalismo in questa regione dell'Asia.
Per comprendere le ragioni di tale successo e, più in generale, il ruolo
economico delle popolazioni Huaqiao in Asia, è importante essere a conoscenza
delle radici storiche del percorso di emigrazione e insediamento che si è articolato
nel corso dei secoli e che ho descritto nel precedente capitolo. La complessità della
storia della Diaspora Cinese in Asia sudorientale ha portato alla creazione di realtà
culturali e economiche molto diverse tra loro, che vanno dall'integrazione completa
nella società ospite, alla coesistenza e competizione di lungo periodo con essa, a
svariate realtà intermedie, configurando così un insieme di fenomeni di
acculturazione, adattamento e assimilazione che hanno influenzato il ruolo
economico di queste comunità (Reid, 2002). La figura del migrante cinese è stata
definita e analizzata da un gran numero di studiosi in base allo sviluppo del ruolo
che essa ha svolto nel corso della storia: all'inizio dell'ondata migratoria dalla Cina
verso il resto del mondo gli Huaqiao erano negozianti, mercanti, Coolies e poi, negli
anni ottanta, divennero facoltosi magnati degli affari che controllavano (e
controllano) le grandi Multinazionali (soprattutto nei settori della fabbricazione di
macchinari e tessile41). Ciò costituisce oggi una caratteristica saliente della vita
economica del Sud-Est Asiatico e i loro ruoli economici in questa regione sono stati
vari e variabili nel corso del Ventesimo secolo, cambiando secondo modalità
componenti soprattutto, anche se non solo, per il settore dei macchinari e dell’elettronica (Rapporto Asean Awareness, 2012).
41 Rapporto “ASEAN Awareness”, Università di Tor Vergata, Roma, 2012
33
genericamente simili in tutte le zone della regione a mano a mano che essi si
adattavano al graduale mutamento della realtà di ciascuna economia (Mackie; Reid,
2002). In ogni paese del Sud-Est Asiatico si sono affermati modelli lievemente
diversi, a ulteriore conferma che le circostanze locali sono cruciali per determinare il
successo o l’insuccesso tanto quanto le predisposizioni comuni a tutti i cinesi42
(Mackie, 2002).
Nei secoli, gli Huaqiao si sono imposti in alcuni settori commerciali (come le
miniere di stagno e la coltivazione della gomma in Malesia e Thailandia), mentre
non hanno avuto successo in altri (i minatori delle cave di stagno di Bangka o i
produttori di pepe del Kalimantan occidentale) (Somers Heidhues, 2003).
Un caso particolare fu quello dell'industria della pilatura del riso in Thailandia e del
suo successivo commercio, che si rivelò un trampolino verso attività più lucrose per
alcune imprese familiari come i Wanglee e i Lamsam in Thailandia (Mackie, 2002).
Nella seconda metà dell’Ottocento gli esattori delle imposte e i Re dell’oppio cinesi
erano i personaggi più ricchi e influenti nelle diverse comunità cinesi e
controllavano estese reti di distributori, spesso in associazione con le società segrete.
La situazione cambiò con gli attacchi agli appalti dell’oppio tra il 1890 e il 1910
(Reid, 2002). Dopo il 1900 le principali vie per accedere alla ricchezza furono le
miniere di stagno, la pilatura e il commercio del riso, il commercio al dettaglio e
all’ingrosso, le spedizioni marittime e, in misura minore, la coltivazione o il
commercio della gomma (nel caso eccezionale della ditta Oei Tiong Ham di
Semarang anche la produzione di zucchero) e successivamente la piccola
manifattura e l’industria alimentare43.
Tuttavia, il grosso degli immigranti cinesi che affluivano nel Sud-Est Asiatico
in questo periodo erano poveri che lavoravano in miniera, nelle costruzioni e più
42 Predisposizione al commercio dovuta alla secolare tradizione cinese in quest'ambito economico (Mackie, 2002)
43 M. F. Somers Heidhues, Bangka Tin and Mentok Pepper: Chinese Settlement on an Indonesian Island, Singapore, ISEAS, 1992, pag. 12-15
34
raramente come braccianti nelle piantagioni che tornavano in patria alla scadenza
del contratto. Alcuni di loro però riuscirono ad avere successo come artigiani e
piccoli negozianti nelle zone rurali delle Indie Olandesi, nel Borneo e in
Thailandia44.
Tra il 1930 e il 1960 (il periodo dell’occupazione giapponese, della
decolonizzazione e dell’instabilità politica45) – i cinesi, soprattutto quelli nati in Cina
e non legati alla struttura coloniale, assunsero ruoli economici svolti in precedenza
dai dominatori coloniali spesso scalzando anche i concorrenti indigeni e destando
perciò sentimenti nazionalisti ostili. Citando Wang Gungwu, avevano una
«ricchezza senza potere» (Wang, 1991), essendo politicamente impotenti e
vulnerabili a varie forme di violenza o discriminazione nazionalista. A partire dagli
anni sessanta i loro ruoli economici e la loro posizione socio-economica sono
notevolmente cambiati sotto l’impatto della crescita economica di tutti i paesi
dell’ASEAN ad eccezione delle Filippine.
I grandi uomini d’affari cinesi hanno occupato i vertici di tutte le economie della
regione lasciati liberi dagli europei, mentre ai livelli inferiori la gran parte dei cinesi
più poveri è stata in grado di abbandonare le occupazioni manuali, seppure in misura
minore nelle attività agricole e nella pesca all’interno delle vecchie enclavi rurali
(Reid, 2002). Il ruolo di punta svolto dagli uomini d’affari cinesi nelle
trasformazioni economiche che si sono verificate nella regione ha convinto i governi
locali a condannare gli episodi discriminatori nei confronti della minoranza e ha
fatto capire che i provvedimenti contro i cinesi potrebbero causare lo smembramento
dei canali commerciali, la riduzione dell’efficienza economica46 e del livello di
reddito47.
Concludendo, possiamo affermare che dagli anni ottanta del Novecento in poi
i cinesi del Sud-Est Asiatico hanno potuto affermarsi in tutti gli stati dell’ASEAN, 44 J. A. C. Mackie, «The Geographical Dispersal and Occupations of the Indonesian Chinese, 1900-
1930» in Asian Culture, 14, 1990, pag. 5-22.45 Prodromi all' instaurazione della Repubblica Popolare cinese il 1 Ottobre 1949.46 L'economia è efficiente quando quando utilizza in maniera economica le risorse a propria
disposizione (Cit. A. Scaletti, Efficienza, Capacità ed Economia).47 R. McVey “ Southeast Asian Capitalists”, Cornell University Southeast Asia Program Press,
2006, pag.20
35
anche se in minor misura in Malaysia dove la situazione sociale è in continua
tensione a causa della discriminazione razziale e nazionalista. Va inoltre sottolineato
che esiste un'enorme differenza fra l'organizzazione aziendale occidentale e quella
cinese. Il ruolo predominante delle interconnessioni o Bamboo Networks (in cinese
Guānxì关系 ) fra imprenditori rende le aziende cinesi potenti e ben organizzate.
Inoltre, questo tipo di approccio commerciale rende più fluidi i rapporti fra aziende,
il commercio e la diffusione capillare di beni e servizi.
2.2.1 Il Capitalismo Cinese
Nel 1979 Deng Xiaoping, che in quell'anno era alla guida del Partito
Comunista Cinese, diede avvio all'apertura dell'Economia della Repubblica
Democratica verso l'esterno. Le sue riforme portarono al cosiddetto “Socialismo con
caratteristiche cinesi” (Deng Xiaoping, 1979). La finalità delle riforme di Deng
Xiaoping era riassunta nel programma delle Quattro Modernizzazioni: agricoltura,
industria, scienza e tecnologia, apparato militare. La strategia da usare per
conseguire l'obiettivo di una nazione moderna e industrializzata era l' Economia
socialista di mercato (Gittings, 2005).
Deng Xiaoping pensava che la Cina si trovasse nello stadio base del socialismo
e che il dovere del partito era di perfezionarlo facendolo diventare un “socialismo
con caratteristiche cinesi”, una nuova interpretazione del Marxismo che ridusse il
ruolo e il peso della teoria delle decisioni economiche48 e diffuse l'idea che
socialismo non significa povertà condivisa.
48 Oggetto di studio della teoria delle decisioni è il processo decisionale. Attraverso l’analisi del comportamento degli attori (individui o gruppi) coinvolti nel processo si procede, cioè, all’esame di come i decisori prendono o dovrebbero prendere delle decisioni. Allo sviluppo della teoria delle decisioni hanno contribuito cultori di discipline diverse: filosofi e logici, matematici e statistici, psicologi e sociologi, economisti, ecc (cit. B. Chiandotto “Statistica per le decisioni” pag. 1).
36
La giustificazione teorica della decisione di entrare attivamente nel mercato
capitalistico fu:
Pianificazione e forze di mercato non rappresentano l'essenziale differenza che sussiste tra socialismo e capitalismo. Economia pianificata non è la definizione di socialismo, perché c'è una pianificazione anche nel capitalismo; l'economia di mercato si attua anche nel socialismo. Pianificazione e forze di mercato sono entrambe strumenti di controllo dell'attività economica49 (Deng Xiaoping, 1980)
Deng Xiaoping credeva che nessuna linea di condotta dovesse essere respinta
semplicemente per il fatto di non essere aderente a quella tenuta da Mao, e
diversamente dai leader più conservatori come Chen Yun50, egli non presentava
obiezioni a determinate politiche economiche per la sola ragione che esse erano
simili a quelle attuate nelle nazioni capitaliste (Meisner, 1996). Di fatto, il processo
delle riforme ebbe inizio con lo smantellamento delle Comuni contadine (1980-
1985) per poi continuare con la privatizzazione delle industrie.
La nuova politica economica della Repubblica Popolare Cinese, dal 1979 in
poi, cercherà di realizzare la convivenza tra comunismo (in politica) e capitalismo
(in economia) all'insegna dello slogan “un paese due sistemi”. Ciò comporterà
diversi cambiamenti: il primo effetto delle riforme si esprime attraverso una
riorganizzazione territoriale nel corso degli anni Ottanta con la nascita le ZES,
ovvero le Zone Economiche Speciali.
49 John Gittings, The Changing Face of China, Oxford University Press, Oxford, 2005 50 Politico cinese, viene considerato uno degli “Otto anziani del Partito comunista Cinese” (1905-
1955)
37
Figura 3: Le Zone Economiche Speciali in Cina
Fonte: www.lacrescitafelice.blogspot.it: investimenti stranieri e interesse, le ZES
Esse sono territori collocati lungo la costa della Cina in cui si praticano forme
economiche capitalistiche, dove sono possibili investimenti dall' estero e l'attività
imprenditoriale privata. Le prime ZES sono i territori costieri del Sud-Est del Fujian
e la regione dello Zhejiang; il processo ha poi coinvolto aree più vaste nel corso
degli anni Novanta come mostra la Figura 3.
Il successo delle Zone Economiche Speciali in Cina è collegato al fenomeno
delle Tigri Asiatiche (Singapore, Taiwan, Hong Kong e Corea del Sud): con questa
denominazione vengono indicati quei paesi che, a partire dagli anni Sessanta, hanno
intrapreso un percorso di industrializzazione e modernizzazione significativo ed
hanno svolto un ruolo determinante nel processo di regionalizzazione del Sud-Est
Asiatico, impegnandosi in un imponente processo di investimenti diretti nelle
economie poco dinamiche e avanzate dell' area. Negli anni Settanta questo processo
si è esteso a Malaysia, Thailandia, Filippine, Indonesia e alle ZES (in particolare al
Guandong e al Fujian). A questi si sono aggiunti negli anni Novanta il Vietnam e le
regioni cinesi dello Jiangsu e dello Zhejiang.
38
Dal 1990, il ritmo della restaurazione capitalistica aumentò, unitamente alla
necessaria repressione di tutte le ribellioni operaie e popolari. Negli anni novanta, in
quel contesto di reazione ideologica e regresso sociale, il cammino capitalista della
Cina non poteva che accelerare (Lopez, 2006) .
Gatto nero o gatto bianco , l’importante era che il gatto prendesse il topo
(Deng Xiaoping, 1979)51
2.3 Rapporto economico-politico fra Huaqiao, Madrepatria e Stato
d'approdo (Influenze economiche, politiche e cenni alle leggi che
regolano la migrazione in Cina)
Nei precedenti paragrafi è stata analizzata l'importanza della presenza cinese
nel territorio del Sud-Est Asiatico dal punto di vista economico e politico. Il ruolo
predominante delle comunità Huaqiao ha influenzato la nascita del fenomeno delle
Tigri Asiatiche e dei processi di regionalizzazione che hanno portato alla creazione
di un mercato orientato al Pacifico (“Look at East and at Pacific”) (Gittings, 2005).
Sia la Repubblica Popolare Cinese che la Repubblica di Cina (stabilitasi a Taiwan)
mantengono relazioni, seppur complesse, con le comunità di Cinesi d'Oltremare
residenti nel Sud-Est Asiatico. Infatti, entrambe hanno ministri che si occupano
degli affari degli Huaqiao. Tanto la RPC che la RDC52, inoltre, prevedono forme di
rappresentanza legislativa per i Cinesi all'estero (Hooker, 2002). È importante
sottolineare che spesso i Cinesi della diaspora hanno giocato un ruolo importante
nella politica cinese, infatti la maggior parte dei fondi per la rivoluzione
repubblicana del 1911, che vide la fine della dinastia Qing, venne dalle comunità 51 Cit. da un discorso di Deng Xiaoping del 1979 sulla nuova politica economica.52 Nel caso della RPC, alcuni seggi nell'Assemblea nazionale del popolo sono riservati ai Cinesi
d'oltremare tornati in patria. Nello Yuan legislativo della RDC, vi erano un tempo otto seggi destinati ai Cinesi d'oltremare, che venivano distribuiti tra i partiti politici in base al totale dei loro voti a Taiwan. La maggior parte di questi membri eletti nello Yuan legislativo possiedono la doppia cittadinanza, ma devono rinunciare a quella straniera prima di assumere la carica con il giuramento.
39
degli espatriati. Tra il 1950 e il 1960, la Repubblica Democratica Cinese cercò il
sostegno della comunità dei Cinesi d'Oltremare, riprendendo la strategia, resa nota
da Sun Yat-Sen, dell'“utilizzare” le comunità degli espatriati per raccogliere fondi
(come citato nel paragrafo precedente, il Guomindang fu finanziato dai cinesi
espatriati per la sua rivoluzione). Durante questo periodo, la Repubblica Popolare
Cinese tendeva a guardare con sospetto gli Huaqiao come possibili infiltrati
capitalisti, ritenendo più importante sviluppare le relazioni con le nazioni del Sud-
Est Asiatico piuttosto che ottenere il sostegno delle comunità all'estero, e nella
Dichiarazione di Bandung affermò espressamente che i Cinesi d'Oltremare
dovevano la loro lealtà primaria alla nazione in cui risiedevano (Hooker, 2002).
I Cinesi d'Oltremare, però, vivevano nell' insicurezza anche nelle nazioni di
residenza in quanto erano spesso perseguitati per legami presunti con la "Cina
comunista". Questa accusa fu usata ad esempio come pretesto per giustificare i
massacri dei Cinesi in Indonesia e in altri paesi dell'Asia sud-orientale53 (Wang,
2001).
Dopo le riforme di Deng Xiaoping, l'atteggiamento della RPC verso i Cinesi
d'Oltremare cambiò drasticamente. Anziché essere visti con sospetto, cominciarono
a essere considerati come persone che potevano aiutare lo sviluppo della Cina
attraverso le loro capacità e i loro capitali. Durante gli anni Ottanta del Novecento,
la Repubblica Popolare tentò attivamente di "corteggiare" l'appoggio dei Cinesi
d'Oltremare, ad esempio restituendo loro le proprietà che erano state confiscate dopo
la rivoluzione del 194954(Wang, 2001). Oggi gli Huaqiao stanno investendo in
Madrepatria fornendo risorse finanziarie, reti di contatti sociali e culturali55.
53 In Indonesia, ad esempio, dopo un fallito golpe comunista nel 1965 (il Gerakan September Tiga Puluh o l'Affare Gestapu), furono messi in atto massacri di comunisti e di persone di etnia cinese (Hooker, 2002).
54 Nel 1949 vennero confiscate le proprietà degli Huaqiao, insieme a quelle di tutti i proprietari terrieri cinesi, in onore della nuova legge sulla Proprietà privata.
55 Rimangono comunque molte differenze tra Cinesi emigrati all' estero e quelli residenti in Madrepatria, per la forte influenza della cultura confuciana, che vede l' abbandono del proprio paese come un atto negativo (Wang. 2001).
40
Nonostante la situazione legale degli Huaqiao sia migliorata nel corso dei secoli,
rimane traccia delle differenze fra i cinesi residenti all'estero e quelli che vivono
nella Cina continentale. Infatti, secondo l'articolo 5 della Legge sulla cittadinanza
della Repubblica Popolare Cinese:
Qualsiasi persona nata all'estero i cui genitori siano cittadini cinesi o uno dei cui genitori sia cittadino cinese deve avere la cittadinanza cinese. Ma una persona i cui genitori siano entrambi cittadini cinesi e si siano entrambi stabiliti all'estero, o uno dei cui genitori sia cittadino cinese e si sia stabilito all'estero e abbia acquisito la cittadinanza straniera alla nascita, non deve avere la cittadinanza cinese.
Al contrario, la Legge sulla cittadinanza della Repubblica Democratica Cinese,
consente la doppia cittadinanza e considera gli Huaqiao come cittadini della RDC.
41
CAPITOLO 3 : IDENTITÀ, CULTURA E LETTERATURA DEI
CINESI D'OLTREMARE
La situazione dei Cinesi d'Oltremare residenti nel mondo e in particolar
modo nel Sud-Est Asiatico si diversifica ampiamente per quanto riguarda il grado di
assimilazione o diassimilazione nelle comunità locali, per le interazioni socio-
economiche con esse e per le loro relazioni con la Cina. La migrazione storica dei
cinesi nel Sud-Est Asiatico ha determinato una gran quantità di fenomeni di
adattamento e acculturazione. Citando G. William Skinner56,
Quando lo si analizza57 dosando sapientemente scienza sociale e metodi storici, il Nanyang diventa un laboratorio virtuale per lo studio della
dialettica dell’etnicità.
Nella seconda metà del Quindicesimo secolo e nella prima metà del Sedicesimo,
quando i contatti diretti tra Sud-Est Asiatico e Cina si erano sensibilmente ridotti,
toccò il culmine la tendenza ad assimilare i cinesi tra le popolazioni già fortemente
multietniche dei porti principali del Sud-Est Asiatico. In Siam “i cinesi dapprima
conservano il proprio cognome, ma dopo qualche generazione vi rinunciano”
(Skinner, 2002), adottando perciò l'identità locale.
L’assimilazione era particolarmente accentuata nelle isole, che ridussero al minimo i
contatti diretti con la Cina: gran parte del commercio passava per Malacca o altri
porti e le popolazioni sino-asiatiche residenti nel Sud-Est non erano più considerate
in alcun modo cinesi58.
56 Cit. G.William Skinner, Le società creolizzate nel Sud-Est Asiatico, 2002, pg. 8157 Il Sud-Est Asiatico cit. G.William Skinner, Le società creolizzate nel Sud-est asiatico, 200258 Le classi mercantili della costa settentrionale di Giava e della regione di Manila erano considerate
null’altro che, rispettivamente, «giavanesi» e «luzonesi» dagli osservatori portoghesi, i quali non facevano menzione dei cinesi come gruppo separato (Skinner, 2002).
42
Negli ultimi ottant’anni non c’è stato un progresso costante verso l’assimilazione
degli individui di origine cinese: come già detto, il grado di acculturazione e
inserimento degli Huaqiao nelle comunità indigene varia a seconda della situazione
locale, ma in parte anche in base allo sviluppo della stessa Cina. Esistono infatti
realtà in cui l'atteggiamento verso i cinesi etnici è ed è stato, a fasi alterne,
esattamente opposto.
G. William Skinner59 pone l'accento su un genere particolare di etnogenesi
ossia la creazione, mediante “fusione”, di nuovi sistemi socio-culturali che possono
acquisire una propria autonomia e stabilità nonostante i contatti costanti con
entrambe le società da cui sono nati.
Per quanto riguarda il Sud-Est Asiatico, nelle Filippine, a Giava e negli insediamenti
in Malaysia nacquero sistemi sociali intermedi di questo tipo grazie alla mescolanza
tra elementi indigeni e cinesi. Già nella metà del Ventesimo secolo i Mestizo cinesi
delle Filippine, i Peranakan cinesi di Giava e i Baba cinesi di Malacca, Penang e
Singapore costituivano una comunità separata accanto alla società cinese e a quella
indigena, ma chiaramente distinguibile da esse.
In ciascuno di questi casi la mescolanza culturale di elementi cinesi e indigeni si era
stabilizzata in una «tradizione» propria e la lingua usata nella comunità, seppure
chiaramente influenzata dal cinese a livello sia grammaticale sia lessicale, era un
creolo basato sulla lingua indigena.
Il primo passo nella formazione storica di sistemi sociali intermedi sono stati i
matrimoni misti tra immigrati cinesi e donne indigene, fenomeno usuale nel Sud-Est
Asiatico. Prima della fine del Ventesimo secolo, infatti, alle donne era proibito
lasciare la Cina, e gli uomini che emigravano dovevano necessariamente rivolgersi
alle donne indigene: questo non solo nelle Filippine, a Giava e in Malaysia ma in
tutte le regioni del Sud-Est Asiatico. A mano a mano che le comunità intermedie
prendevano forma, i discendenti delle ondate successive di immigrati servivano a
alimentarle.
59 G.William Skinner, Le società creolizzate nel Sud-Est Asiatico, 2002
43
3.1 Processi di assimilazione o mancata assimilazione delle comunità
cinesi in Malaysia, Thailandia e Filippine
In questi paragrafi analizzerò il grado si assimilazione o diassimilazione dei
Cinesi d'Oltremare in Malaysia, Thailandia e Filippine. Questi tre Paesi hanno
rappresentato l' area d' approdo di milioni di immigrati Zhonghua Minzu nel corso
della storia, tanto che oggi accolgono le loro comunità più numerose.
3.1.1. Le comunità Huaqiao in Malaysia
I cinesi in Malaysia rappresentano circa il 20 per Cento della popolazione
totale, anche se, in un articolo pubblicato nel 1955 su "The Nation", venne diffusa
l'idea che:
In Malaysia the Chinese form nearly 59 percent of the entire population. Officially the percentage is smaller, but the Chinese probably control over 95 percent of all private business, excluding the activities of a small number of Western firms60.
A differenza della Thailandia, in Malaysia il divario fra Huaqiao e popolazione
autoctona ha portato diverse situazioni di tensione e violenza, fra cui la più nota del
Maggio 1969 in cui si manifertarono intense azioni di guerriglia razzista nei
confronti degli immigrati cinesi, compromettendone l' assimilazione degli nella
società malese. A proposito di questa escalation di eventi violenti nei confronti dei
Cinesi d'Oltremare, un cinese etnico residente in Malaysia testimonia che:
Malaysia gained full Independence in 1963, but Singapore seceded in 1965. At present Chinese are less than 30 percent of the total population. In the years leading for Independence, the Chinese leaders failed to gain equal rights for the Chinese. The terms of Independence ensured not only Malay sovereignty but that the Malays would have special rights over
60 Da "The Chinese Diaspora in Southeast Asia: Political Culture of Chinese in Thailand and Malaysia", 2008, pag. 3
44
people with Chinese and Indian ancestry. The years immediately following Independence saw the Chinese gaining political power. The ethnic tensions intensified and come to a boil in 1969. Beginning of May 13 th that year, rioting, looting and burning of Chinese properties, and killing of Chinese, went on for several days (…)61.
Tan Chong Koon (Malaysia)
Questa situazione è il risultato del lungo periodo di colonizzazione in cui la
Malaysia venne sottoposta al controllo delle potenza britannica. In questo periodo,
infatti, la popolazione autoctona si vide togliere la sovranità sul territorio e ciò
comportò la volontà del paese di mantenere intatta l'identità malese nel momento in
cui la riebbe, nel 1963 (Skinner, 2002). Per questo motivo il governo e la
popolazione in Malaysia guardavano con sospetto la comunità cinese e gli immigrati
stranieri, in quanto essi potevano rappresentare un problema nel mantenimento della
purezza della cultura locale. Per questo, subito dopo l'ottenimento dell'
indipendenza, il nuovo governo decise di legittimare la priorità dell'identità malese
nella costituzione (emettendo, ad esempio, leggi a favore dei cittadini di etnia
malese in campo economico e sociale) (Skinner, 2002).
La Costituzione definì con il termine “malese” solo gli individui musulmani, di
lingua autoctona e aderenti ai valori della cultura del luogo. Nel 1969, in seguito alla
perdita di potere del partito che aveva ottenuto la vittoria nell'anno
dell'indipendenza, i cinesi vennero utilizzati come capri espiatori e si verificarono
atti di violenza e discriminazione nei loro confronti. La percezione che i cinesi
delegittimassimo l'autorità del potere locale62 è diminuita del corso degli anni ma
sicuramente non è del tutto scomparsa.
61 Cit. da Wei Djao, Being Chinese: Voices from the Diaspora, 2003, pg. 4962 Ad esempio, anche le alte cariche dello Stato dimostrarono un particolare sentimento anti- cinese. Il
Primo Ministro Mahathir Mohamad, al potere dal 1981, nel 1969 scrisse il libro "The Malay Dilemma", nel quale dichiarava che le comunità cinese e indiana nascondevano la volontà di sovvertire il potere locale (Skinner, 2002)
45
3.1.2. Le comunità Huaqiao in Thailandia
La Thailandia ospita la più grande comunità di Huaqiao ed è anche il caso più
riuscito di assimilazione completa, in quanto molti Sino-Thailandesi si sono sposati
con donne e uomini locali. La comunità cinese in Thailandia, che rappresenta il 14
per Cento della popolazione63, dopo aver superato la furia anti-cinese esplosa negli
anni trenta del Novecento, è oggi integrata e partecipa alla vita politica ed
economica del Paese (lo stesso ex Primo Ministro Thaksin Shinawatra è sino-
thailandese) (Andornino, 2007). La Thailandia è l'unico paese nell'area di
riferimento che non abbia sperimentato il colonialismo europeo e il governo
Thailandese ha sempre affrontato da solo il problema della migrazione di cittadini
cinesi nel suo territorio. Alla fine del Diciannovesimo secolo l'ondata migratoria si
sviluppò ulteriormente, portando la comunità cinese a mischiarsi in modo sempre
più profondo con la realtà locale64. Nello stesso periodo molti Huaqiao riuscirono a
diventare membri della politica thailandese, anche perché questo era uno dei modi
per immergersi completamente, per essere assimilati nella nella comunità locale
anche se ciò avrebbe potuto comportare l'abbandono della vecchia identità culturale.
Nonostante ciò il governo Thai, tra il 1851 e il 186865, definì una rigida
distinzione fra cittadini cinesi e thailandesi, con lo scopo di creare un contrasto tra
diverse identità culturali. Citando G. William Skinner:
Intuitivamente sembrava si volessero separare i due gruppi dal punto di vista fisico, così da riportare i cinesi verso le loro originarie pratiche
culturali66
Ridisegnando le caratteristiche che separavano la “Cinesità” dalla “Thailandesità” il
governo evitò la costituzione di una comunità mista Sino-thai. La legge obbligò i 63 Da “The Journal of Asian Studies:Chinese Assimilation and Thai Politics”, 1957 : pag. 237-25064 Da "The Chinese Diaspora in Southeast Asia: Political Culture of Chinese in Thailand and Malaysia",
2008, pag. 165 Epoca del regno di Mongkut (Skinner, 2002)66 Cit. G.William Skinner, Le società creolizzate nel Sud-est asiatico, 2002, pg. 83
46
Chinese Overseas a scegliere tra la prospettiva di continuare ad essere loro stessi,
rimanendo esclusi dalla vita sociale, oppure adottare la cultura locale. Per gli
individui nati in Thailandia, ma di discendenza cinese, questa distinzione imposta
dal governo precluse la possibilità di trovare un equilibrio tra le due società, in
quanto essa forzava a scegliere tra quella d'origine e quella d'approdo67. Dalla fine
del 1800, però, i cinesi vennero incoraggiati a diventare membri attivi della società
thailandese attraverso politiche che garantirono privilegi specifici ai mercanti. Dal
1855 gli Huaqiao ottennero il diritto di muoversi liberamente nel paese al di fuori di
Bangkok. Inoltre il sovrano thailandese Mongkut, che era in parte cinese, lavorò per
creare politiche che rendessero più fluido il movimento degli Overseas dalla Cina
alla Thailandia. Mentre nel corso del Ventesimo secolo le politiche di assimilazione
culturale del governo Thai portarono gli Huaqiao ad integrarsi nella realtà locale, il
continuo altalenare di leggi pro e contro i cinesi e la continua presenza di
micrositemi economici e educativi separati68, dimostra che l'assimilazione nella
realtà locale non è perfetta nè completa. Paragonando la situazione thailandese
con quella malaysiana, però, essa rappresenta la comunità mista e assimilata più
significativa.
3.1.3 Le comunità Huaqiao nelle Filippine
Il caso delle Filippine può essere considerato un' “intermedio” fra la situazione
delle comunità Huaqiao in Malaysia e Thailandia. La comunità cinese raggiunge i
900.000 componenti, è ben integrata nella società locale anche se persistono alcuni
pregiudizi nei confronti degli immigrati legati ad avvenimenti del passato, quando
67 Per esempio, i Cinesi che decidevano di mantenere la loro cultura d'origine continuarono a portare i capelli legati in una coda (come era in uso nel periodo della Dinastia Qing), mentre quelli che adottavano lo stile Thai avevano il capo rasato o i capelli molto corti (Skinner, 2002).68 Molti cinesi etnici residenti in Thailandia ancor oggi mandano i propri figli alle scuole private cinesi nel territorio con la sicurezza che esse possano prepararli meglio ad affrontare il futuro, soprattutto dal punto di vista economico. La rete economica Huaqiao si basa sulle relazioni fra cinesi etnici nel mondo ed è spesso separata dall' economia locale (Reid, 2002)
47
gli Huashang erano soliti esportare prodotti dalle Filippine alla Cina favorendo la
Madrepatria. Prima dell'elezione a Presidente delle Filippine di Ferdinand Marcos
nel 1974, la comunità cinesi Tsinoy69 e Mestizo70 erano separate da quella locale.
In molte zone del Sud-Est Asiatico i cinesi Mestizo non sono stati formalmente e
legalmente riconosciuti come gruppo etnico separato dal resto della popolazione
autoctona e coloro che fanno parte di questo gruppo etnico sono stati definiti tali in
base a considerazioni genealogiche piuttosto che in base al luogo di nascita; il fatto
che i Mestizo siano in possesso di una combinazione unica di caratteristiche culturali
li rende ampiamente distinguibili dal resto della comunità di approdo.
L' ascesa al potere di Marcos portò numerosi cambiamenti nella realtà cinese
residente nello Stato: gli Huaqiao ottennero gli stessi diritti dei cittadini locali,
iniziarono ad essere considerati a tutti gli effetti “filippini”, al di là della cultura e
della lingua diverse. Un ulteriore cambiamento avvenne nel campo dell' educazione
dei Chinese Overseas. Infatti le scuole cinesi, che prima venivano controllate dalla
RPC, vennero sottoposte alla giurisdizione del governo filippino. Questo fatto
comportò lo studio obbligatorio da parte degli immigrati della lingua e della cultura
filippina, oltre a quella cinese. I provvedimenti di Marcos, dunque, portarono la
comunità cinese ad integrarsi sempre più in quella d' approdo (Wickberg, 1964).
Successivamente però, soprattutto sotto il governo di Cory Aquino (1986-1992),
Fidel Ramos (1992-1998) e Tony Estrada (1998-2000), le situazione divenne più
tesa in quanto si svilupparono sentimenti anti-cinesi fra la popolazione locale che
causarono numerosi atti di violenza e boicottaggio. In questi anni venne fondata la
prima organizzazione Sino-filippina chiamata Kaisa Para Sa Kaunlaran Inc. (Unity
for Progress) fondata da Teresita Ang-See che lottò per far cessare le incomprensioni
fra le due comunità per la ricerca di un dialogo pacifico e costruttivo.
69 Gruppo di etnia cinese residente nelle Filippine (E. Wickberg, The Chinese Mestizos in Philippine History, 1964)
70 Termine che sta ad indicare una persona di discendenza mista Cinese-Filippina (E. Wickberg, The Chinese Mestizos in Philippine History, 1964)
48
Anche il Presidente Aquino, di origini cinesi, lavorò alacremente per migliorare le
condizioni di vita degli Huaqiao.
Fonte: www.mblog.lib.umich.edu
Nonostante ciò persistono tutt'oggi alcuni problemi riguardanti l'integrazione degli
stranieri nelle Filippine anche se in generale la comunità cinese è ben integrata nella
realtà in cui risiede (Wickberg, 1964).
3.2 Rapporto fra Huaqiao e Madrepatria: Identità e Nazionalismo
Nel Sud-Est Asiatico, le diversità che si riscontrano tra i Chinese Overseas si
basano sulla diversa applicazione della cultura, nella maggior parte dei casi
confuciana, di provenienza, in quanto per molti aspetti il nucleo ideologico che sta
alla base della cultura cinese influenza ed ha influenzato profondamente
l' integrazione e la mancata integrazione nelle comunità di approdo. Nonostante ciò,
molti Huaqiao ormai emigrati da generazioni, hanno adottato quasi completamente
49
Illustrazione 1: Una famiglia di etnia cinese Mestizo a Manila,1920.
le abitudini e gli usi di altri Paesi. In un saggio sui cinesi del Sud-Est Asiatico e sul
loro ruolo nella storia e nella società della regione, M. Freedman ha osservato che
(..) essi appartengono a nazionalità diverse, parlano numerose lingue, seguono religioni differenti e adottano svariati stili di vita. Inoltre, come hanno dolorosamente scoperto alcuni di loro ritornando in una delle due Cine, molti hanno un modo d’essere tanto poco cinese da risultare per molti versi degli stranieri nella terra dei loro antenati71.
Tutti gli emigranti conoscono in una certa misura problemi di identità quando
scelgono se mantenere la loro nazionalità d'origine o adottarne una nuova e si
scontrano con tutti i dilemmi conseguenti ai sentimenti di lealtà e del senso di
appartenenza, che rappresentano nel caso degli Huaqiao due dei pilastri
fondamentali della cultura tradizionale confuciana. L’assimilazione nella società e
nella cultura del paese di residenza è sempre un processo lungo e spesso impossibile,
come nel caso della Malaysia, per cui anche nelle società multirazziali del Sud-Est
Asiatico si è verificato un fenomeno di integrazione piuttosto che uno di
assimilazione (Reid, 2002).
My family contains quite a bit of the history of Chinese settlements in the Malay peninsula. One of my great-great-grandmothers was a Nyonya72.(...)Her Father come from Fujian Province around 1830 when the British gained control of the Straits Settlements of Penang, Malacca and Singapore. He was a small trader. This Nyonya ancestress of mine was born in Malacca around 1850. My father still remembers what his grandfather said about her. At that time Baba and Nyonya children were brought up to regard themselves as Chinese, apart and different from the Malay. But in their daily life they actually incorporated quite a bit of Malay culture.(...) My great-great-grandmother always wore the Malay dress, (...)cooked a lot of Malay food and spoke Chinese with Malay words. However, she was not a Muslim but followed the Chinese customs, witch combined rites of veneration of ancestors with Buddhist and Daoist practices73
Tan Chong Koon (Malaysia)71 M. Freedman, «The Chinese in Southeast Asia: A Longer View» in M. Freedman e G. W. Skinner (a
cura di), The Study of Chinese Society cit., pagg. 20-2172 Con il termine Nyonya si indicano le figlie di padre cinese e madre malese, i figli maschi vengono
chiamati Baba ( da Wei Djao, Being Chinese: Voices from the Diaspora, 2003).73 Cit. da Wei Djao, Being Chinese: Voices from the Diaspora, 2003, pg. 47
50
Nel corso del Ventesimo secolo non sono mancate aspre polemiche su tali
problemi all’interno delle varie comunità cinesi della regione, in particolare sulla
perdita dell’identità cinese e sulle spinte alla risinificazione, in quanto le circostanze
storiche hanno reso più complesse del solito le scelte che si trovarono a dover fare,
sia durante il periodo coloniale sia dopo. Nell’era coloniale i Cinesi d’Oltremare
potevano scegliere riguardo la cittadinanza, giacché lo Jus Sanguinis che la Cina
propugnava incoraggiava la doppia nazionalità, ma negli anni cinquanta diventò
difficile mantenere quell’ambivalenza perché l’indipendenza delle nazioni del Sud-
Est Asiatico e l’affermazione di una nuova Cina nel 1949 rendevano fortemente
sospetti tali atteggiamenti agli occhi dei nazionalisti locali.
I cinesi del Sud-Est Asiatico erano chiamati a dimostrare la loro lealtà ai
paesi di residenza rinunciando a identificarsi con la Cina, implicitamente o
esplicitamente. Spesso queste richieste andavano oltre le questioni legali dei diritti di
cittadinanza: pressioni per adottare nomi locali (come è accaduto in Indonesia e in
Thailandia), per rinunciare a esibire pubblicamente i caratteri cinesi, per chiudere
scuole e associazioni di lingua cinese, per scoraggiare manifestazioni pubbliche
come i cortei funebri e le cerimonie nuziali (Reid, 2002). Ma si sono sempre avute
pressioni anche nella direzione opposta. È il caso della convinzione perdurante che
occorresse preservare la solidarietà nella comunità cinese come ultima risorsa contro
le discriminazioni o le persecuzioni razziali, particolarmente diffusa in Malaysia e in
Indonesia, dove le prospettive di un’integrazione reale o dell’assimilazione erano
molto più remote che in Thailandia o nelle Filippine (Wei, 2003).
Dopo la seconda guerra mondiale, e soprattutto a seguito della Rivoluzione
Culturale74 propugnata da Mao tra il 1966 e il 1969, molti cinesi del Sud-Est
Asiatico hanno preso le distanze dalla Cina per diventare sempre più «asiatici del 74 La Rivoluzione Culturale fu lanciata nel 1966 da Mao per ripristinare l 'applicazione dell' ortodossia
marxista-leninista. La Rivoluzione culturale era fondata sulla mobilitazione dei giovani, universitari e non contro le strutture dello stesso PCC. Basi teoriche erano il pensiero di Mao sulle "contraddizioni in seno al popolo e al Partito" e il “Libretto rosso”. Fu un periodo di caos che si interruppe solo nel 1969 (Pischel, 2004).
51
Sud-Est», con una nuova identità socio-politica (sino-thai, sino-indonesiani, cinesi
malesi, ecc.). L’interesse destato dai risultati socio-economici del regime di Mao nei
primi anni di vita, infatti, è andato presto scemando quando si sono fatti evidenti gli
sconvolgimenti politici e il caos economico prodottosi successivamente. Al
contempo, la rapida crescita dei paesi dell’ASEAN in quel periodo (cioè a partire
dagli anni sessanta) ha cominciato a diffondere una prosperità senza precedenti tra
molti cinesi del Sud-Est Asiatico, rendendo ancor meno allettante la prospettiva di
un ritorno in Cina. Negli anni Novanta, però, la tendenza a dissociarsi dalla Cina a
favore dei paesi di residenza si indebolirono, in quanto con Deng Xiaoping la Cina
stava attraversando un processo di modernizzazione sempre più capitalistico e
dinamico (Reid, 2002). Inoltre si assiste ad una rinascita d’interesse per la lingua
cinese e per il retaggio culturale che essa esprime, sia in quanto risulta utile nel
commercio sia grazie alla diffusa convinzione che i valori neo-confuciani siano in
qualche modo una delle ragioni del successo economico dell’Estremo Oriente negli
ultimi decenni. Se, dunque, è eccessivo parlare di un nuovo processo di
«risinificazione» tra i cinesi del Sud-Est Asiatico, certo è che dall’inizio degli anni
novanta si colgono i segni di un’oscillazione delle comunità di Chinese Overseas in
questa direzione.
Il sentimento di appartenenza alla comunità Overseas è collegato al
Nazionalismo cinese delle suddette realtà. L’ascesa del Nazionalismo fornì le
motivazioni per difendere l’identità e parte degli strumenti per mantenere tale
cultura in un ambiente straniero, ossia scuole e giornali. Inoltre, la nascita di una
stampa cinese e l’introduzione nelle scuole di una «lingua nazionale» consentirono
ai cinesi di gruppi linguistici disparati di comunicare tra loro. Il Nazionalismo cinese
mirava a riaffermare un' identità etnica e nazionale e appoggiava il movimento che
era a favore di un rafforzamento nazionale in Cina (Reid, 2002).
Il culmine del Nazionalismo cinese fu toccato tra il 1937 e il 1941, con la creazione
del Movimento per la salvezza nazionale, che organizzò il boicottaggio dei prodotti
giapponesi anche nel Sud-Est Asiatico e la raccolta di fondi a sostegno dello sforzo
bellico cinese. Anche l’occupazione giapponese dell’Asia sudorientale durante la
52
seconda guerra mondiale, che provocò terribili avversità ai cinesi, e le susseguenti
lotte anticoloniali per l’indipendenza nazionale stimolarono i sentimenti nazionalisti.
A partire dagli anni Settanta la componente politica del Nazionalismo cinese lasciò il
posto a un più diffuso Nazionalismo etnico o culturale, teso a preservare l'identità
cinese all’interno delle società multirazziali del Sud-Est Asiatico. Negli ultimi venti
anni, però, il vincolo sentimentale tra i cinesi della regione e la loro Madrepatria si è
affievolito anche a causa dell' integrazione delle comunità Huaqiao nelle realtà
locali (Reid. 2002)
3.2.1 Testimonianze: Voci della Diaspora
Come descritto nei precedenti paragrafi, le comunità di Huaqiao nel mondo e
nel Sud-Est Asiatico hanno storie diverse e un rapporto con la Madrepatria, l'identità
e la propria cultura d'origine che varia non solo in base al livello di integrazione
nella società d'approdo ma anche alle esperienze di vita personali.
Riguardo al tema dell'identità, dell'assimilazione o dell'integrazione dei Cinesi
d'Oltremare nelle società del Sud-Est Asiatico vorrei proporre alcuni stralci di
interviste svolte dal Professor Wei Djao dell'Università dell' Arizona, il quale le ha
poi raccolte nel volume Being Chinese: Voices from the Diaspora (Arizona
University Press,2003).
Yeoh Ean Tin è figlia di cinesi etnici trasferitisi a Singapore nel primo Novecento. In
questa testimonianza spiega la storia della sua famiglia, gli anni dell' invasione
giapponese e il suo legame con la cultura confuciana:
(...)My father was born in Chaozhou in 1913. He came with his parents in the 1920s, while he was in his early teens. He died in 1995. When the family first came, they have a tough time. There were few houses in Singapore then, and not very many people. (…)(…)I was only 5 or 6 when Japanese occupied Singapore. I remember those days, I remember the air raids just before the invasion.
53
(...)Singapore is a very good and prosperous society now. You can eat all you want and buy whatever you wish.(...)The most important things in life is Xiao. You remember your parents and ancestors for giving you life and for bringing you up. I still wish that my parents were alive so that I could look after them(...)75.
Deanna Li, invece, è figlia di una coppia cinese emigrata nelle Filippine:
I was born in Manila. My mother was a pure Chinese. Her family had to change their Chinese surname to a Filipino one when they became naturalized Filipinos. My father travelled from his native province, Fujian, to the Philippines (...)my dad wasn't rich. He started down at the lowest level, he would peddle fruits from wholesalers to the market in search of buyers.(...)
Riguardo alla questione della lingua e del sistema scolastico, Deanna Li spiega:
We speak Chinese at home. Fujian dialect was my mother tongue and Tagalog my second language. I learned English at school. My mum can read and write Chinese very well. She grew up in Cebu, in central Philippines. At that time (...) there were some excellent Chinese schools that taught everything in Chinese(...). About five years before I started school, the amount of Chinese taught in Chinese schools was decreased(...) so I went to a catholic private school for girls. (…) At that time, almost 99 percent of the students were Chinese(…)76.
Tan Chong Koon, ormai integrato nella comunità malese, testimonia la sua
esperienza da cinese etnico, spiegando come si possa essere contemporaneamente
malese e cinese:
I see Malaysia as my country of origin even though the Chinese in Malaysia are treated unfairly. The Chinese do try to fight for their rights (…) I am proud of being Chinese. The Chinese in Malaysia are essentially like the Chinese in China, the same idea about history and tradition, and the same feelings towards parents and family. In fact, I think, we the Chinese in Malaysia may have kept more of the old customs than the people in China (…)77.
75 Cit. da Wei Djao, Being Chinese: Voices from the Diaspora, 2003, pg. 156, 157, 15876 Cit. da Wei Djao, Being Chinese: Voices from the Diaspora, 2003, pg. 116,11777 Cit. da Wei Djao, Being Chinese: Voices from the Diaspora, 2003, pg. 53
54
3.3 Il problema della Lingua
L'utilizzo della lingua cinese da parte dei Cinesi d'Oltremare è stato
influenzato da un gran numero di fattori: l'origine degli Huaqiao, l'uso che i loro
antenati facevano della lingua, il grado di assimilazione nel Paese d'approdo, i
cambiamenti generazionali e le politiche ufficiali degli Stati ospitanti si sono
ripercossi sui metodi di comunicazione nelle comunità Overseas. Tutti questi
elementi hanno giocato un ruolo fondamentale nel corso dei secoli ed oggi la
tendenza generale vede un aumento dei cinesi che parlano la lingua mandarina
(Pǔtōnghuà 普 通 话 ovvero “lingua comune” ), soprattutto nelle Chinatown in
Occidente. Nel Sud-Est Asiatico, invece, la lingua d'origine si è spesso mischiata a
quella locale, portando alla formazione di numerose lingue Pidgin78, lingue miste
(Reid, 2002).
A Singapore, come già sottolineato nel primo capitolo, il Mandarino è
storicamente riconosciuto come una delle lingue ufficiali79, insieme ai caratteri
cinesi semplificati, in contrasto con altre comunità Cinesi d'Oltremare che usavano
quasi esclusivamente i caratteri cinesi tradizionali fino al 1990, quando molti
cittadini della RPC cominciarono ad emigrare e portarono con sé l'uso dei caratteri
cinesi semplificati. La politica ufficiale di Singapore ha anche un impatto sul vicino
Johor, nella Malaysia Peninsulare, dove il Mandarino è parlato prevalentemente tra
le comunità cinesi del luogo (Reid, 2002).
In Malaysia, però, si parlano anche diverse varietà dialettali: a Penang e
Malacca si concentrano soprattutto i parlanti Hokkien80, i gruppi residenti a Kuala
Lampur e Kuantan parlano cantonese Hakka81, nella Malaysia orientale (Borneo) le 78 Pidgin è un idioma derivante dalla mescolanza di lingue di popolazioni differenti, venute a contatto a
seguito di migrazioni, colonizzazioni, relazioni commerciali. Il "Chinglish" (chinese-english), parlato un tempo nel Sud-Est Asiatico, era una commistione di cinese e inglese.
79 Il governo di Singapore scoraggia l'uso di lingue cinesi non mandarine attraverso la "Campagna parla mandarino" (Speak Mandarin Campaign), un'iniziativa annuale in vigore dal 1979 e volta appunto a incentivare la diffusione del mandarino.
80 E le sue varie versioni (Skinner, 2002).81 La lingua Hakka (客家語, Kèjiā yǔ) è forse uno dei più antichi dialetti parlati in Cina e fa parte della
famiglia linguistica sino-tibetana. Essa è parlata dalla popolazione Hakka, originaria del gruppo cinese degli Han e stanziata nelle province del Guangdong, del Fujian e dello Jiangxi.
55
lingue principali sono l'Hakka e il Mandarino. Fino a qualche decennio fa la
diversità linguistica fra Huaqiao era molto più marcata. Oggi, indipendentemente
dalla località di residenza, le generazioni più giovani tendono generalmente a parlare
il Mandarino, che viene anche insegnato nelle scuole82. Dunque, la maggior parte
dei cinesi che vivono in Malaysia sanno parlare il malese (la lingua ufficiale dello
Stato), il Mandarino e l'inglese, che è usato ampiamente negli affari.
La situazione è diversa per i Cinesi d'Oltremare in Indonesia e in Thailandia:
essi sono stati spesso oggetto di politiche di assimilazione forzata, per cui molti di
loro non riconoscono più il Mandarino come madrelingua (in particolare i cinesi
etnici di Giava). Per quanto la Thailandia sia patria della più grande e integrata
comunità di Cinesi d'Oltremare, esistono molti dialetti che si differenziano su base
geografica. Ad esempio, un grande numero di Huaqiao appartiene al gruppo del
dialetto Teochew dei cinesi Han. Un piccolo numero di cinesi, appartenenti
principalmente al gruppo del dialetto Yunnanese, vive nella parte settentrionale della
Thailandia, anche perché si trova al confine con la loro regione di provenienza, ossia
la provincia cinese dello Yunnan (Skinner, 2002).
La situazione linguistica in Vietnam è legata al gruppo più numeroso di cinesi
etnici residenti nel Paese che fa parte di una minoranza chiamata Hoa. Circa
600.000 Chinese Overseas vivono oggi a Saigon e la maggior di loro parla
Cantonese, sebbene vi sia anche un vasto gruppo che parla Teochew83, facendo
risalire la loro patria ancestrale alla provincia di Guangdong in Cina, da dove i loro
antenati giunsero intorno a XVIII secolo.
Nelle Filippine la maggior parte dei cinesi e in particolar modo i più
giovani, parlano sia l'inglese che il tagalog (una delle lingue ufficiali delle
Filippine, parlata da un quarto della popolazione) (Skinner, 2002).
82 Un numero significativo di Cinesi vengono educati nelle scuole private, dove si impara e parla principalmente in lingua inglese (Skinner, 2002).
83 Il Teochew è, come il dialetto Hakka, una lingua sinitica. È parlato nella regione orientale della provincia di Guangdong al sud della Cina.
56
3.4. Cenni di letteratura scritta da Huaqiao
In questo paragrafo presenterò brevemente due dei più importanti autori di
origine cinese residenti nel Sud-Est Asiatico. È importante sottolineare che
l' influenza della tradizione cinese nella letteratura nel quadrante di riferimento è ed
è stata molto forte, soprattutto per quanto riguarda la diffusione di romanzi cinesi
nell'area. La grande e duratura popolarità delle versioni thailandesi del cinese
Il romanzo dei tre regni (Sānguó Yǎnyì 三国演义) esemplifica la capacità dei cinesi
di ogni classe sociale di ritagliarsi uno spazio nelle società del Sud-Est Asiatico.
A partire dalla fine del Diciannovesimo secolo il romanzo venne considerato
appartenente all’alta cultura letteraria thailandese, nel Novecento è entrato a far
parte della cultura popolare sotto forma di commedie, fumetti, telenovelas e trattati
di tattica militare. Nella sua infinita varietà di forme esso è emblematico della
vitalità della cultura sino-asiatica del Sud-Est e “costituisce una fonte finora
trascurata per comprenderla” (Mackie, 2002).
Il romanzo narra la storia degli ultimi anni della seconda dinastia Han e i
vent’anni e più di disordine dinastico, fino alla riunificazione parziale sotto lo stato
Qin (265 d. C.) ed è noto come veicolo di sinificazione nell’Asia pre-moderna. La
sua lunga storia, che si colloca nell’ambito della narrativa popolare cinese, ebbe
inizio nel Nono secolo. Il romanzo venne poi messo per iscritto all’inizio del
Quattordicesimo secolo, mentre la prima versione coerente ad opera di Luo
Guanzhong uscì a metà di quel secolo. Diventò uno dei quattro “capolavori”84 dell'
epoca Ming (Reynolds, 2002). Ancora oggi, in Cina e nei paesi della regione del
Sud-Est Asiatico sensibili alla civiltà cinese, Il romanzo dei tre regni continua a
essere riscritto e «applicato» ai problemi della vita quotidiana.
84 Quattro Romanzi: Sanguo Yanyi, Shuihu zhuan, Jin Ping Mei, Xiyouji
57
Graig J. Reynolds nel suo saggio “Il romanzo dei tre regni e il Sam Kok thai”
afferma che:
il Sanguo Yanyi nelle sue molteplici versioni è il fondamento di un’etica degli affari e della politica e anche l’espressione di una cultura della
strategia della vita pubblica85.
Oltre alla diffusione del Romanzo dei Tre Regni ed altre opere, anche molti scrittori
di origine cinese si sono affermati nel Sud-Est Asiatico e nel resto del mondo.
Kho Ping Hoo86 (1926-1994) fu un importante autore indonesiano di origini cinesi.
Divenne famoso grazie ai suoi romanzi ispirati al tradizionale metodo di
combattimento cinese delle arti marziali, oltre che ai film Kung-fu di Hong Kong e
Taiwan. Nei trent'anni della sua carriera ha scritto più di 400 storie influenzate dalla
cultura cinese di provenienza, ha introdotto l'uso di molti termini del dialetto
Hokkien nella lingua indonesiana. Questo autore rappresenta pienamente la
comunità Huaqiao residente in Indonesia: durante il regime di Suharto
l' insegnamento della lingua, della storia e della cultura cinese erano vietati e Kho
Ping Hoo divenne il simbolo del mantenimento dell'identità d'origine al di là del
proibizionismo dilagante negli anni della sua carriera. Il fatto che non abbia mai
imparato perfettamente il Mandarino, però, ha impedito ai suoi romanzi di avere
seguito in Cina. Il lavoro di Kho Ping Hoo ha dato un contributo significativo alla
letteratura colloquiale Indonesiana ed è tutt'oggi uno degli scrittori più amati nel
Sud-Est Asiatico.
Wen Ruian87 (1954 - ) è uno scrittore e poeta di origine cinese nato in
Malaysia. Wen Ruian scrive sopratutto novelle del genere Wǔxiá88. Uno dei suoi
scritti più famosi, Sì dàmíng bǔ (“I quattro grandi ufficiali”“四大名捕” ), è stato
adattato alle serie televisive “The Four” e “Face to Fate”, e al film “The Four”.
85 Cit. da “Il romanzo dei tre regni e il Sam Kok thai” , Craig J. Reynolds, 2002, pg. 155-15686 Nome cinese Xǔ Pínghé 許平和.87 Nome cinese Wēn Liángyù 溫涼玉.88 Con il termine Wǔxiá si intende un genere letterario tradizionale cinese che concerne le arti marziali
(Cin. Wǔ 武 marziale, militare e Xiá 侠 eroe, virtuoso).
58
Egli nacque a Bidor in Malaysia nel 1954 in una famiglia Hakka con antenati di
etnia cinese provenienti da Meixian, nel Guangdong. Negli anni Sessanta scrisse la
sua prima storia ispirata ai classici cinesi trovati nella biblioteca di casa. Negli anni
Settanta studiò psicoanalisi e estetica, iniziò a scrivere su diverse riviste taiwanesi e
pubblicò la sua prima novella Wǔxiá sul giornale di Hong Kong “Wǔxiá chūnqiū”
( 武俠春秋 ). Nel 1976 Wen e Fang E'Zhen, un altro scrittore di origine cinese,
fondarono la Compagnia di poesia “Società di poesia di Shenzhou” a Taiwan, ma
subito dopo venne chiusa perché accusata di sostenere il comunismo dal
Guomindang. Furono obbligati a tornare in Malaysia ma anche li subirono diverse
accuse di fomentare il movimento anti-governativo e furono esiliati a Hong Kong.
Da allora Wen Ruian vive a Hong Kong e scrive ancora novelle del genere Wǔxiá (S.
André, 2006).
59
Conclusioni
La Diaspora Cinese nel Sud-Est Asiatico è uno dei fenomeni migratori più
importanti a livello mondiale in quanto essa produce processi di regionalizzazione,
creazione di nuove comunità e lingue miste, problematiche molto profonde dal
punto di vista della cultura e dell'identità non solo per gli immigrati ma anche per le
popolazioni locali, cambiamenti economici e sociali. Proprio per le conseguenze che
questo fenomeno ha sulla vita di milioni di persone, gli studi sulla Diaspora sono
oggi molto più diffusi, anche perché in passato le ricerche su questo tema erano
spesso basate su dati scarsi e poco attendibili, soprattutto in merito alla dimensione
demografica delle comunità di cinesi Overseas nel Sud-Est Asiatico (Reid,2002).
Ho deciso di approfondire il tema della Diaspora Cinese in riferimento al
quadrante del Sud-Est Asiatico in quanto in questa particolare zona del globo
l'influenza della comunità Huaqiao è stata, nel corso della sua storia, molto
importante e decisiva in particolare dal punto di vista economico e politico.
L'influsso della Diaspora sulla componente culturale del fenomeno cinese nel Sud-
Est Asiatico è stata ed è oggi di grande importanza ed ho quindi deciso di analizzare
più profondamente questo tema non solo per interesse personale, ma anche perché è
proprio il bagaglio identitario dei Cinesi d'Oltremare che ha reso possibile
l'inserimento nel sistema economico dei paesi del Sud-Est Asiatico di nuovi settori
industriali, come quello tessile, quello dei macchinari o dell' elettronica89.
Le comunità cinesi residenti all'estero sono caratterizzate da una storia secolare e
ricca di problematiche riferite non solo al rapporto con i Paesi ospitanti (come nel
“caso-simbolo” della Malaysia sul quale territorio si sono verificati svariati atti di
violenza anti-cinese), ma anche con la Madrepatria che a ritmi alterni ha favorito gli
Huaqiao attraverso politiche economiche e condannato aspramente la scelta di molti
connazionali di abbandonare la Cina90. Infatti tutt'oggi i cinesi che risiedono 89 Rapporto Asean Awareness, 201290 Scelta ritenuta fortemente negativa sulla base della cultura confuciana che reputa l'abbandono dei
genitori e dei nonni come un atto di mancato rispetto e lealtà verso la famiglia e il paese.
60
all' estero non hanno diritto alla doppia nazionalità se uno dei genitori non ha la
cittadinanza cinese91.
Dal punto di vista storico, approfondito nel primo capitolo, la migrazione dei
cinesi verso il Sud-Est ha origine incerta, anche se gli studiosi ritengono che essa
iniziò nei primi secoli dopo Cristo e continuò incrementando la portata demografica
del fenomeno fino ai giorni nostri, in cui la situazione vede una presenza massiccia
(circa 30 Milioni di persone) degli Huaqiao in tutti gli Stati della regione.
La maggior parte dei migranti proviene dalle province cinesi del Guangdong (i cui
migranti si spostarono storicamente alla ricerca di lavoro manuale), dallo Zhejiang,
dal Guangxi e dal Fujian e si spostarono verso sud, come rappresentato nella Figura
4.
Figura 4: Flusso della Diaspora Cinese dal Guangdong e dal Fujian
Fonte: en.wikipedia.org
Nel corso dei secoli la popolazione di cinesi etnici è andata via via
aumentando e la folta popolazione Huaqiao ha creato la situazione ideale per
l'insediamento nel territorio ed ha influenzato la situazione economica dei paesi del
91 A differenza la RDC ammette la doppia nazionalità.
61
Sud-Est. Così come si sono creati nel corso dei secoli, la Cina sta rafforzando oggi
ancora di più i legami con gli Stati costieri del Sud-Est Asiatico attraverso accordi
commerciali e di cooperazione navale.
Emergono così i legami tra la macroeconomia nazionale e regionale cinese (legami
che trovano un esempio nell'applicazione, da parte dei Cinesi D'Oltremare, del
Capitalismo cinese a seguito delle riforme di Deng Xiaoping) e le vicine economie
nazionali e regionali sulla base dei quali si stanno sviluppando reti
economiche transnazionali che trascendono confini e sovranità e che definiscono
veramente che cosa siano oggi le catene valoriali globali, o per lo meno quelle
asiatiche (Sideri, 2009).
Come già esplicato nel secondo capitolo, dal punto di vista economico le
comunità Huaqiao hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle aree in
cui hanno deciso di risiedere e sono stati promotori della nascita di un sistema
economico, quello del Pacifico, che negli ultimi decenni ha visto un progresso
inarrestabile ed, insieme a Giappone, Corea del Sud e ovviamente alla Cina,
rappresenta un concorrente molto potente dell’Occidente in piena decadenza a causa
della crisi mondiale. La fondazione della SEATO e dell'ASEAN hanno reso un
territorio storicamente instabile a causa della colonizzazione europea e dei processi
nazionalistici e indipendentistici, un territorio i cui Stati si sono “auto-imposti” la
convivenza pacifica e rapporti economico-politici paritetici in processi di
regionalizzazione spontanei, a differenza di altre zone del mondo nelle quali, in
seguito alla decolonizzazione, le potenze europee hanno continuato ad imperare92.
La globalizzazione ha amplificato la forza della Diaspora Cinese nel mondo ed in
particolare nel Sud-Est Asiatico in ascesa economica, per cui i quaranta milioni di
cinesi nel mondo avanzano impercettibilmente, non conoscono confini soprattutto
grazie ai legami organici (chiamati Bamboo Networks) che stanno riconfigurando i
confini geopolitici.
92 Come nel caso del Medio Oriente.
62
In questo ambiente di pacifica cooperazione fra Paesi diversi, le comunità
Huaqiao hanno avuto esperienze diverse, più o meno positive, di integrazione e
assimilazione rispetto alle società locali. Secondo le testimonianze di alcuni cinesi
etnici, però, il tempo passato nei paesi del Sud-Est Asiatico ha fatto si che gli
Huaqiao di seconda, terza, quarta generazione ecc... si sentano orgogliosamente
parte della comunità di approdo, seppur mantenendo identità e tradizioni cinesi.
È proprio questo l' aspetto della migrazione dei cinesi sul quale ho voluto riflettere:
la Diaspora Cinese ha creato un senso del luogo comune93 nel Sud-Est Asiatico,
ha reso le comunità Huaqiao una “presenza simbolica” rappresentativa della
cultura millenaria di appartenenza. Ciò è avvenuto attraverso la diffusione della
cultura letteraria, linguistica, politica ed economica.
Nel corso dei secoli si sono create comunità miste e di conseguenza, lingue
miste. Esse sono state influenzate dall'origine degli Huaqiao, dal grado di
assimilazione nel Paese d'approdo, dai cambiamenti generazionali, dalle politiche
ufficiali degli Stati ospitanti e da molti altri fattori culturali. La peculiarità della
situazione linguistica nel Sud-Est è data dal fatto che ci sia stata la fusione fra la
lingua di provenienza e la lingua d'approdo, fenomeno che ha creato Pidgin e dialetti
(ad esempio, l'Hakka o il dialetto Hokkien).
Inoltre, la cultura cinese ha influito sulla letteratura scritta dagli immigrati nati in
Madrepatria ma anche sugli scrittori di seconda e terza generazione che, come
Wen Ruian e Kho Ping Hoo, si sono ispirati alle arti marziali, la leggendaria arte
di combattimento cinese ed hanno avuto un grande successo nel Sud-Est Asiatico
come rappresentanti di una tradizione secolare mai abbandonata. Nel terzo
capitolo, inoltre, ho voluto sottolineare come Il Romanzo dei Tre Regni sia stato
utilizzato come mezzo di sinificazione nella regione e sia considerato parte della 93 Il concetto di “luogo” ha mutato il suo significato nella disciplina geografica con lo sviluppo della
prospettiva umanistica: il legame emotivo che sussiste tra esseri umani e luoghi fa sì che questi ultimi non appaiano o siano percepiti così come sono, quindi esclusivamente nella loro “fisicità”, ma "come simbolo di ciò che rappresentano". È questo il caso delle comunità cinesi sorte nei paesi del Sud-Est asiatico in quanto rappresentano delle “colonie” cinesi in terra straniera e mantengono un' identità forte, seppur integrata alla realtà locale.
63
letteratura nazionale in Thailandia.
Dunque, non solo i processi storici ed economici, ma anche gli scrittori di etnia
cinese e la questione della lingua hanno concorso alla creazione di uno spazio
territoriale regionale nel Sud-Est Asiatico.
Analizzando il ruolo dei Cinesi d'Oltremare nel quadrante di riferimento
ho compreso l'importanza dell' identità e della tradizione cinesi in quanto ogni
azione portata avanti dalle comunità, siano state composte da Huashang, Huayi o
Huagong nel corso della storia della Diaspora in questi luoghi, hanno
influenzato, modificato il comportamento degli immigrati e la loro integrazione,
incarnando la cultura cinese.
Studiare oggi la Diaspora Cinese nel Sud-Est Asiatico, le sue componenti
culturali, politiche, economiche e le sue probabili conseguenze nel futuro della
regione del Pacifico è ancora molto complicato data la portata di questo fenomeno
migratorio a livello mondiale, anche se ritengo sia importante sottolineare che negli
ultimi anni si è compresa l'importanza di questa regione e della presenza cinese
residente nei suoi territori quali fautori di comunità integrate a livello economico e,
seppur con qualche eccezione, culturale.
64
Bibliografia
Airaghi, Angelo (a cura di), Rapporto Asean Awareness, Fondazione Economia Tor Vergata, Ministero degli Esteri, Italia, 2012
Anderson, Benedict, Comunità immaginate: origine e fortuna dei nazionalismi, Manifesto Libri, 2009
Barmè, Geremie R., “Strangers at home” , The Wall Street Journal, 19 Giugno 2010
Bickers, Robert, The Scramble of China: Foreign Devils in the Qing Empire 1832-1914, Penguin, Londra, 2012
Casti, Emanuela e Bernini, Giuliano, Atlante dell'immigrazione a Bergamo: la Diaspora Cinese, Il lavoro editoriale, Bergamo, 2008
Chan, Brenda,“Virtual Communities and Chinese National Identity”, Journal of Chinese Overseas, n. 1, Vol. 1 Maggio 2006, pag. 1-32
Cohen, Robin, Global Diasporas: An Introduction, University of Washington Press, 1997
Collotti Pischel, Enrica, Storia dell'Asia orientale 1850-1949, Carocci, 2004
Cortellazzo, Manlio e Zolli, Paolo, DELI Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, 1985
Crawford, Darryl, “Chinese Capitalism: cultures, the Southeast Asian region and Economic globalization”, The Journal of Asian Studies, n. 1, Vol. 21, 2000, pag. 69-86
De Bernardi,Alberto e Guerracino, Scipione, Il Novecento, Mondadori, 1987
De Bernardi,Alberto e Guerracino, Scipione, L'Ottocento, Mondadori, 1987
Di Nolfo, Ennio, Storia delle Relazioni Internazionali: dal 1918 ai giorni nostri, Laterza, 2008
Freedman, Maurice, “The Chinese in Southeast Asia: A Longer View” in M. Freedman e G. W. Skinner (a cura di), The Study of Chinese Society, pag. 20-2
Gittings, John, The Changing Face of China, Oxford University Press, Oxford, 2005
Haiming, Liu, The Chinese Diaspora in Southeast Asia: Political Culture of Chinese
65
in Thailand and Malaysia, Cornell University, 2008, pag. 3
Hooker, Michael Barry, Law and the Chinese in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies Press, 2002
Johnston, R.J.; Gregory, Derek; Pratt, Geraldine; Watts, Michael, Dictionary of Human Geography, Wiley-Blackwell, 2000
Keller, Werner, Diaspora: The post-biblical history of the Jews, Harcourt, 1971
Lopez, Francesco, Cina: il perché del ritorno al capitalismo, Arianna Editrice, 2006, pag. 3-5
Ma, Laurence J.C. e Cartier, Carolyn, The Chinese Diaspora: Space, Place, Mobility and Identity, Rowman & Littlefield, 1953
Mackie, Jamie A.C.,“The Geographical Dispersal and Occupations of the Indonesian Chinese, 1900-1930”, Asian Culture, n. 14, 1990, pag. 5
McVey, Ruth T., Southeast Asian Capitalists, Cornell University Southeast Asia Program Press, 1993, pag.20
Meisner, Maurice, The Deng Xiaoping Era: An Inquiry into the Fate of Chinese Socialism, 1978-1994, Hill and Wang, 1996, pag 20-21
Reid, Anthony (a cura di), Cinesi d'Oltremare: l'insediamento nel Sud-est Asiatico, Fondazione Giovanni Agnelli, 2002
Reid, Anthony e Skinner, G. William,“Le società creolizzate nel Sud-est asiatico”, in Cinesi d'Oltremare: l'insediamento nel Sud-est Asiatico, Fondazione Giovanni Agnelli, 2002
Reynolds, Graig, J., “Il romanzo dei Tre Regni e il San Kok Thai”, in Anthony Reid (a cura di), Cinesi d'Oltremare: l'insediamento nel Sud-est Asiatico, Fondazione Giovanni Agnelli, 2002
Safran, William, “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, Journal of Transnational Studies, n. 1, Vol. 1, 1991
Samphantharak, Krislert, “The Rise of China and Foreign Direct Investment from Southeast Asia”, Journal of Current Southeast Asian Affairs, n. 2, Vol. 2, 2011, pag. 65-75
Sideri, Sandro, La Cina e gli altri: nuovi equilibri di geopolitica, ISPI, 2009, pag 57-58
66
Skinner, G. William, “Chinese Assimilation and Thai Politics”, The Journal of Asian Studies, n. 16, Vol. 1, 1957, pag. 237-250
Somers Heidhues, M. F., Bangka Tin and Mentok Pepper: Chinese Settlement on an Indonesian Island, Singapore, ISEAS, 1992, pag. 12-15
St. André, James, “You can never go home Again: Cultural memory and Identity formation in the Writing of Southeast Asian Chinese”, Journal of Chinese Overseas, n. 2, Vol. 1, 2006, pag. 33-35
Trần, Khánh, The Ethnic Chinese and Economic Development in Vietnam, Institute of Southeast Asian Studies, 1993, pag 24-25; 60-84
Wai-Ming, Benjamin, “A critical Review of Japanese Scholarship on Overseas Chinese in Modern Japan”, The Journal of Asian Studies, n. 1, Vol 21, 2000, pag. 23-26
Wang, Gungwu, The Chinese Overseas, Harvard University Press, London, 2001
Wei, Djao, Being Chinese: Voices from the Diaspora, The University of Arizona Press, Tucson, 2003
Wickberg, Edgar, “The Chinese Mestizo in Philippine History”, The Journal of Southeast Asian History, n. 5, Vol. 1, 1964, pag. 62-100
Wong, Lew, “Tourism and the Chinese Diaspora”, in Tourism and Migration, Northern Arizona University, 2002, pag. 205-219
Sito ufficiale UCLA (Graduate School of Education and Information Studies), sito di ricerca bibliografica sulla Diaspora Cinese: www.pages.gseis.ucla.edu(data consultazione: 23-12-2012)
Sito ufficiale EAI (East Asian Institute): www.eai.nus.edu.sg(data consultazione: 24-11-2012)
Sito ufficiale dell'organizzazione "World Huaren Federation", informazioni sulle comunità cinesi in Thailandia, Malaysia e Filippine: www.huaren.org (data consultazione: 12-11-2012)
Rivista Online "Levante Online". Articoli di cronaca, divulgazione scientifica, attualità (nazionale e internazionale), recensioni: www.levanteonline.net (data consultazione: 23-12-2012)
Enciclopedia online, voce: Overseas Chinese. Storia, lingua dei Cinesi d'Oltremare: www.en.wikipedia.org (data ultima consultazione: 14-02-2013)
67