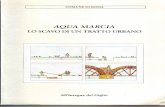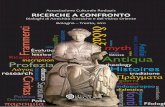Sri Lanka 2014: la continuazione del regime autoritario e la crescente insoddisfazione popolare
La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese
Transcript of La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese
1
Oliviero Diliberto
La lunga marcia.
Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese
in Disegnare il futuro con intelligenza antica. L’insegnamento del latino e delgreco antico in Italia e nel mondo (L. Canfora e U. Cardinalecur.), Bologna 2012, pp. 53 - 67
Sommario. 1. Due necessarie premesse. Primo. Lo studio deldiritto romano quale scienza storica del diritto. 2. Secondo.Il diritto romano come diritto, a suo modo, vigente. 3. La Rpc,il diritto romano e la codificazione del diritto civile. 4.Diritto romano e competizione globale? 5. Diritto romano ediritto cinese: un rapporto senza mediazioni. 6. Per(provvisoriamente) concludere.
1. Il Digesto di Giustiniano si apre solennemente con
l’esaltazione di iustitia e ius, per proseguire, subito dopo, con
la rivendicazione orgogliosa della storia giuridica di Roma
quale fondamento della grande Compilazione, il Corpus Iuris Civilis.
Il secondo titolo del primo libro del Digesto (D. 1.2.1)
conserva, infatti, la praefatio del commento del giurista Gaio
all’antichissima legge delle XII Tavole. Ora, si badi bene,
Gaio scrive a metà del secondo secolo dopo Cristo, il Digesto
è del sesto, sempre dopo Cristo, ma la legge commentata risale
al quinto prima dell’era cristiana. La circostanza è
tutt’altro che trascurabile: ci troviamo, infatti, di fronte a
testi appartenenti ad epoche tra loro diversissime, ma che –
2
nel loro intrinseco «riuso» attraverso i secoli – evidenziano
la convinzione profonda, da parte dei romani, di una continuità
giuridica, sulla base della quale emerge anche la certezza che
solo conoscendo la storia precedente si possa compiutamente (e
correttamente) intendere il presente.
Nella praefatio gaiana menzionata – che Giustiniano sceglie,
come detto, di porre all’inizio del Digesto – se ne rinviene
la motivazione esplicita: il principium – afferma Gaio –
rappresenta la potissima pars del tutto, cioè la parte prevalente
del diritto, rispetto al suo complessivo svolgimento storico.
Il principium è, dunque, intrinsecamente, più importante del
resto [Diliberto 2005b e ivi lett.].
Siamo di fronte, come è facile intendere, ad un punto
chiave.
Il giurista, infatti, attraverso tale – inequivoca –
affermazione, rivendica più valori insieme. Innanzi tutto,
leggiamo in essa la piena e matura consapevolezza che si può
conoscere il diritto vigente solo se si indagano la sua genesi
e il suo sviluppo nel corso dei secoli precedenti. Inoltre,
dalle parole di Gaio traspare chiaramente anche la
rivendicazione di una continuità, di un percorso ininterrotto,
che inizia, appunto, con la legge delle XII Tavole (il più
antico «codice» legislativo dell’Occidente) e che – in questo
caso nelle intenzioni di Giustiniano, che non a caso recupera
proprio quel frammento gaiano per il suo Digesto – doveva
trovare il suo apice (nonché la conclusione) con il Corpus Iuris.
Infine, il riferimento alla supremazia del principium del
diritto rappresenta anche l’intrinseco ossequio rispetto ad un
3
grande, straordinario passato (la reverentia antiquitatis) che
assurge, in sé, a valore.
La praefatio di Gaio al commento alla legge delle XII Tavole
rappresenta, quindi, una vera e propria dichiarazione
programmatica, che non esito a definire ideologica. Tutt’altro
che scontata o accidentale.
Nel brano in esame, peraltro, Gaio è esplicito. Non
intende redigere un commentario di natura meramente antiquaria
(non verbosos commentarios), destinato agli eruditi o ai
grammatici della lingua latina arcaica, ma rivolto
strettamente ai giuristi suoi contemporanei. La storia del
diritto più antico è individuata, dunque, come parte della
scienza giuridica tout court. E Gaio è conseguente a tale
dichiarazione programmatica. Nei brani a noi arrivati del suo
commento alla legge delle XII Tavole – proprio attraverso il
Digesto – il giurista parte dall’analisi (spesso lemmatica)
del testo decemvirale, per approdare rapidamente alla disamina
del diritto a lui coevo.
In altre parole, già i giuristi romani di età classica studiavano la storia
del diritto romano dei secoli ad essi precedenti.
La circostanza è di grande rilievo: si pensi infatti che
proprio Gaio è giurista a tutto tondo. Le sue Institutiones (che
noi conosciamo quasi nella loro interezza) sono un manuale
elementare di diritto privato, rivolto agli studenti del
secondo secolo d. C., teso ad insegnare, dunque, il diritto
vigente: ma la trattazione di ogni istituto giuridico si apre
con la storia di esso nelle epoche precedenti.
Un giurista, impegnato anche nell’insegnamento, sente
l’esigenza di redigere un commento ad una raccolta legislativa
4
arcaica quale la legge delle XII Tavole (promulgata sette
secoli prima) e giustifica ciò con l’affermazione che il
principium è la parte più importante dell’intero:
rivendicazione, quest’ultima, ripresa con enfasi, secoli dopo,
da Giustiniano e, di lì, arrivata ai giorni nostri.
Così come, dunque, il diritto romano arcaico era
indagato dai giuristi romani di età classica, al fine di
meglio comprendere – attraverso la sua evoluzione storica –
anche il diritto vigente alle loro epoche, così, il diritto
romano tout court rappresenta per noi contemporanei terreno di
ricerca per capire, sempre attraverso l’evoluzione giuridica
nei secoli, anche il diritto oggi vigente.
In altre parole, studiamo la storia delle istituzioni
giuridiche del passato perché, attraverso la conoscenza
della genesi degli istituti giuridici, della loro evoluzione
nel tempo, delle modificazioni intervenute, si comprende
assai meglio anche il diritto dei nostri tempi.
Un esempio per tutti (molto sommariamente: e me ne
scuso). Solo attraverso lo studio della storia del diritto
nei diversi secoli si può comprendere la differenza
strutturale – profondissima – tra la nozione di proprietà
privata quale si legge nel nostro codice civile del 1942 e
quella prevista invece nella Costituzione del ’48. Nel
codice civile (art. 832) si afferma una concezione
assolutista della proprietà privata, che si richiama al
diritto romano [cfr. infra § 5, ma è in realtà figlia
diretta del codice Napoleone del 1804, del diritto borghese,
della coincidenza tra libertà, cittadinanza e proprietà
5
privata. Nella Costituzione repubblicana (art. 42 c. 2),
viceversa, è esplicitamente prevista una «finalità sociale»
della proprietà privata, che dipende, insieme, dalla
dottrina sociale della Chiesa cattolica e dalle concezioni
marxiste [su tutto ciò Diliberto 2009, 69 ss.]. Tra i due
testi normativi richiamati (codice civile e Costituzione)
intercorrono pochissimi anni di distanza temporale, ma un
abisso concettuale.
Il conflitto tra essi – come è del tutto ovvio – si
spiega solo alla luce dei diversi contesti politici, sociali
ed ideologici che hanno determinato la genesi delle due
norme, nei differenti rapporti di forza tra le classi nella
società italiana, a cavallo tra il 1942 e il 1948. L’esempio
è volutamente macroscopico ed è qui proposto all’esclusivo
scopo di evidenziare – senza possibilità di equivoci – che
la comprensione del fenomeno giuridico può aversi appieno
solo attraverso l’analisi storico-giuridica degli istituti e
non grazie alla mera tecnica esegetica del testo (pur
anch’essa, come è altrettanto ovvio, indispensabile, ma non
sufficiente).
La storia del diritto romano è, dunque, innanzi tutto,
una disciplina eminentemente storica: indispensabile per la
formazione del giurista, checché ne pensi una dottrina oggi
(non innocentemente) di moda [Irti 2004; Diliberto 2005a].
Solo la piena consapevolezza storico-giuridica può infatti
evitare che il giurista della nostra epoca diventi mero
automa, esecutore tecnico o interprete pedissequo delle
norme: ognuna di esse, infatti, è figlia – circostanza che
6
oggi non è più così ovvia, come dovrebbe – di una specifica
temperie storica, culturale, economica, politica. E quella
certa norma, promulgata in un certo momento storico, può
assumere, volta a volta, sulla base dei concreti rapporti di
forza tra le classi entro una determinata società,
significati ed esiti diversi, pur rimanendo immutato il suo
tenore letterale. Conoscere quella storia, dunque, è
imprescindibile per intendere – in modo pieno e consapevole
– anche la norma medesima.
2. Ma se lo studio del diritto romano ha come primo
obiettivo la ricostruzione di un diritto del passato, per
meglio intendere quello del presente, vi è un altro aspetto
dello studio del medesimo diritto romano che ci porta più
strettamente all’attualità.
Infatti, a ben vedere, il diritto romano (intrisecamente
estinto) ha tuttavia continuato a vivere (con le modificazioni
dei secoli e delle latitudini) nei diversi ordinamenti
europei ed extraeuropei che gli sono tributari: mi riferisco
ad un sistema, ad una somma di categorie (e di lessico
giuridico) comuni, a criteri ermeneutici ed esegetici che –
tutto ciò rinnovandosi nel tempo e nello spazio – ancora
sono, nella chiave di lettura che cercherò di proporre,
vigenti.
Impiego quest’ultimo termine con cautela e prudenza. Ma
non ne trovo altro che renda meglio il concetto. Dalla fine
dell’esperienza storica del diritto romano (formalmente, dal
7
476 d.C. in Occidente e dal 565 d. C. in Oriente: morte di
Giustiniano I; o, se si vuole, dal 1453, presa di
Costantinopoli), quel diritto ha continuato a permeare di sé
– cosa notissima – tutti gli ordinamenti civilistici
dell’Europa continentale: dal Portogallo sino alla Russia
(Mosca quale «terza Roma», anche attraverso la mediazione
culturale ed ideologica del Patriarcato); e poi, partendo
dal vecchio Continente, ha segnato di sé l’intera esperienza
giuridica dell’America Latina [su tutto ciò, Schipani
2009b, per arrivare – tramite l’influenza determinante
della dottrina tedesca di fine ‘800 – sino all’ordinamento
civilistico giapponese. Ha continuato, dunque, a vivere in
Paesi con ordinamenti istituzionali e regimi politici tra
loro diversissimi (imperi, monarchie, repubbliche,
principati, liberi comuni, regno della Chiesa, dittature del
proletariato e ordinamenti borghesi, regimi reazionari e
liberali, comunisti e fascisti: si potrebbe continuare).
Certo, ognuno di questi Paesi ha modificato, soppresso,
aggiunto, «piegato» gli istituti romanistici alle diverse e
contingenti esigenze del tempo, della realtà geografica,
della politica e dell’economia. Ma la base, le istituzioni del
diritto privato romano, appunto, sono rimaste inalterate nella
loro sostanza di fondo [Diliberto 2005a].
Così come dalla lingua latina (in un ambito geografico
tuttavia assai più ristretto) sono sorte tante diverse
lingue neolatine, che, attraverso la comune matrice, possono
tra loro comprendersi senza soverchio sforzo; così il
diritto romano ha costituito la base per la nascita di
diversi diritti «neoromani», fondati – come detto – su un
8
comune sistema (l’impianto complessivo), su categorie
pressoché identiche, su un linguaggio comprensibile
all’interno del medesimo sistema, su una scienza giuridica
elaborata da tecniche giurisprudenziali di interpretazione
del testo (l’esegesi delle fonti) similari in ogni
latitudine. Ma, rispetto alla lingua latina, con uno spettro
geo-politico amplissimo.
Tutto ciò ha vinto la prova dei secoli perché è ancora
parte viva di ciò che applicano, come diritto vigente,
milioni e milioni di donne e di uomini nel mondo. Ma è
diventato ed è ancora parte viva, proprio per la capacità di
quel diritto, storicamente «estinto», di essere adattato,
metastoricamente, grazie ad una sua straordinaria duttilità, a
situazioni e ordinamenti diversissimi da quelli che lo
avevano a suo tempo determinato: reggono, insomma, alla
prova del tempo, da un lato, il sistema, la cornice, il
quadro di riferimento all’interno del quale inserire o
ritrovare, ben ordinati, tutti gli istituti sulla base dello
schema genus-species, come in una sorta di classificazione del
regno animale o vegetale alla Linneo; ma, dall’altro, ancora
è indispensabile quella scienza esegetica dell’analisi del
testo normativo o giurisprudenziale, che dal diritto romano
– transitando ed aggiornandosi nel corso di un millennio e
mezzo – è giunta sino a noi.
In definitiva, ogni generazione di giuristi ha costruito e
ricostruito le proprie istituzioni di diritto romano, utili all’attualità
del pensiero giuridico, splendidamente (ed apparentemente)
atemporali, ma in realtà calate, volta a volta, nel divenire
9
delle diverse società, perché idonee a rinnovarsi, ad essere
applicate ai contesti più multiformi. Immutabili e al
contempo cangianti.
3. In Europa, dunque, – tutta ad eccezione del Regno
Unito – nell’America Latina e in Giappone il sistema
romanistico ha rappresentato (e rappresenta) la base degli
ordinamenti dei diversi codici civili.
Nella Repubblica Popolare Cinese (Rpc), viceversa,
l’idea di avvalersi di un codice civile era stata per
lunghissimo tempo del tutto assente.
La storia è piuttosto semplice: la Cina, nella prima
metà del secolo scorso, aveva provato ad attuare alcune
esperienze codificatorie, nelle quali il diritto romano era,
per così dire, «penetrato» attraverso il Giappone: un
progetto di codice civile fu presentato nel 1911, ma non
venne approvato; fu ripreso infruttuosamente anche nel 1925,
per essere poi promulgato in altra forma nel 1931 [Fei 2007;
Schipani 2009b.
Ma quelle esperienze si andarono rapidamente frantumando
nel corso dei convulsi anni ’30, con la perdita da parte del
Guomindang del controllo sul Paese a favore del Partito
comunista: tanto è vero che il codice civile del ’31 è
rimasto in vigore, con modifiche, nella sola Taiwan.
Nel 1949, poi, con la vittoria della Rivoluzione
comunista e la nascita della Rpc, l’ordinamento preesistente
fu interamente abrogato. Ma se negli anni ’50 il riferimento
10
cinese al diritto era rappresentato dall’Unione Sovietica
(dove andavano a formarsi i giuristi cinesi, imparando anche
il diritto romano, come vedremo), a seguito della rottura
con Mosca iniziò in Cina la fase denominata del «nichilismo
giuridico»: si negava cioè, in via generale, ogni ruolo al
diritto [Schipani 2009b, 532.
Tutto era destinato a modificarsi con l’avvio delle
«quattro modernizzazioni» di Deng. Le riforme economiche
degli anni ’80 e l’apertura a forme di mercato suscitarono
infatti anche un nuovo, se pur ancora solo abbozzato,
interesse verso il diritto, le leggi, le regole.
Ma la svolta, che non esito a definire storica, stava
solo per avvenire. Era il 1988.
La Rpc andava procedendo tumultuosamente (ma era ancora
lontanissima dai risultati economici degli ultimi anni:
allora certo imprevedibili per un osservatore superficiale)
nella strada delle riforme economiche. Sandro Schipani,
allora docente di Diritto romano dell’Università di Roma Tor
Vergata, ebbe, dunque, una straordinaria intuizione.
Immaginò che, essendosi aperta al mercato, la Cina avrebbe
presto avuto necessità di dotarsi di regole del diritto
civile (contratti, obbligazioni, regolamentazione degli
assetti proprietari, etc.: cfr. Petrucci 1999, 319 ss.; Yin
2009, 91 ss.; Schipani 2009b, 532 ss.).
Così, Schipani incominciò – inizialmente da solo e (va
sottolineato) nell’incomprensione generale – ad avviare
contatti con le università cinesi ed in particolare con una
11
delle principali tra esse, l’Università Cinese di Scienze
Politiche e Giurisprudenza (Cupl) di Pechino. Firmò, dunque,
nel medesimo 1988 un primo protocollo d’intesa per
intraprendere la collaborazione scientifica tra le
università (Roma Tor Vergata, allora, poi si unirà anche La
Sapienza, e Pechino, appunto).
La firma di quel protocollo era stata resa possibile
dalla sua lungimiranza, ma anche da una circostanza
intrinsecamente fortunata.
Il decano dell’università cinese, Jiang Ping, aveva
infatti a suo tempo studiato a Mosca, ove – come già
sottolineato – aveva appreso anche il diritto romano,
intuendone l’utilità per la costruzione del nuovo diritto
civile cinese [Jiang 2008. Il terreno, poi, era fertile:
nel 1983 e nel 1987 erano apparsi, infatti, in Cina, due
manuali di diritto romano [Schipani 2009b, 533, a
testimonianza di un interesse, una curiosità, la
consapevolezza dell’utilità.
L’iniziativa di Schipani e Jiang diede a quell’interesse
un impulso decisivo, foriero di conseguenze, appunto,
storiche.
Quell’intesa sortì, infatti, subito un primo risultato:
la traduzione e relativa pubblicazione in cinese delle
principali fonti giuridiche romane: solo l’anno dopo, nel
1989, appariva già la traduzione delle Istituzioni di
Giustiniano ad opera di Zhang Qitai (ormai le fonti
giuridiche romane in cinese costituiscono decine di volumi).
12
Iniziava, altresì, la formazione a Roma di alcuni
giovani giuristi cinesi. Questi ultimi, peraltro, nel nostro
Paese, si cimentavano nello studio dei testi gius-
romanisitici con un approccio (né poteva essere
diversamente) diretto: essi imparavano, dunque, insieme alla
lingua italiana, anche il latino. Il primo di essi – vero
pioniere di questa storia –, Xu Guodong, studiò in Italia
tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ‘90.
Intanto, nel 1992, il XIV Congresso del Pcc promuoveva,
con relativa modifica costituzionale, l’«economia socialista
di mercato»: cresceva, in tal senso, anche l’esigenza dello
studio del diritto. Così, due anni dopo, si arrivò al primo
congresso internazionale sul diritto romano e la
codificazione del diritto civile in Cina: era il 1994.
I tempi erano maturi, insomma, per procedere verso una
codificazione organica del diritto privato. Nel 1999 (50°
anniversario della fondazione della Rpc), il gruppo
dirigente del Pcc decise, dunque, ufficialmente, di redigere
– come intuito dieci anni prima da Schipani – un corpo di
leggi civili per le principali materie riguardanti
l’economia di mercato (diritti reali e diritti di
obbligazione). Evento epocale, come si può immaginare: ma la
circostanza più interessante – ai fini di questo nostro
ragionamento – fu che le commissioni incaricate di lavorare
a tale progetto erano largamente costituite dai partecipanti
al primo congresso gius-romanistico (quello menzionato del
1994): una di esse era presieduta da Xu Guodong.
13
Restava il nodo del modello, dei riferimenti, della
cornice sistemica cui attingere, tra le esperienze
esistenti.
L’alternativa era tra l’adozione del modello europeo, a
base romanistica, o di quello anglosassone (common law), il
diritto fondato sul precedente giurisprudenziale che dalla
Gran Bretagna era divenuto il diritto anche degli Usa. La
discussione – evidentemente di fondo – coinvolse i gruppi
dirigenti dello Stato e i giuristi. Fu molto partecipata,
libera, appassionata, senza reticenze, anche aspra: alla
fine, prevalse la scelta del sistema romanistico.
Risultato straordinario, questo: ma possibile anche
perché, appunto, nel frattempo, si erano prodotti quei primi
risultati (fondamentale è stato evidentemente l’accesso
linguistico ai testi, grazie alle traduzioni in cinese che
nel frattempo Schipani aveva avviato).
Poi, ancora una volta, il caso.
Quando, infatti, nel 1999, la Rpc decideva di
intraprendere la strada della codificazione, io ero
diventato da pochi mesi Ministro della Giustizia in Italia:
ministro, peraltro, ma anche docente di diritto romano e
parlamentare comunista.
Le tre singolari e coincidenti caratteristiche sortirono
un’ulteriore accelerazione nella ricezione del diritto
romano in Cina.
Dopo pochi mesi dal mio insediamento al Ministero,
proprio nel 1999, tenemmo infatti a Pechino il secondo
14
congresso sul diritto romano e la codificazione cinese, con
i crismi dell’ufficialità, aperto proprio dai due ministri
della giustizia (italiano e cinese): iniziò così anche un
rapporto istituzionale fra i due Paesi. Sono seguiti
successivamente altri incontri internazionali di lavoro (nel
2005 e nel 2009) e la collaborazione è proseguita con
straordinaria intensità.
Molti studiosi di diritto romano (italiani e non solo:
oltre a docenti di altri Paesi europei, vi sono anche non
pochi latino-americani, a testimonianza del comune sistema
giuridico) svolgono con regolarità lezioni, seminari,
conferenze nella Rpc.
Centinaia di giovani studiosi cinesi studiano oggi il
diritto romano nelle nostre università (il primo di essi, il
già ricordato Xu Guodong, protagonista anche della
codificazione cinese, è oggi preside della facoltà di
giurisprudenza di Xiamen): sono stati costituiti numerosi
dottorati di ricerca congiunti (italiano e cinese).
Apprendono il diritto romano per poi riapplicarlo (e, a
loro volta, insegnarlo) in Cina, con le specificità del loro
ordinamento politico, economico ed istituzionale, nonché
coniugandolo con le loro millenarie tradizioni. Esistono
oggi circa 120 università cinesi nelle quali è insegnato il
diritto romano e presso l’università capostipite, a Pechino,
è stato fondato un centro di studio permanente del medesimo
diritto romano e di quello italiano, con relativa biblioteca
specializzata. Sono sorte numerose riviste cinesi gius-
romanistiche specializzate.
15
Tutto ciò, in poco più di vent’anni.
Ma la «scoperta» del diritto romano ha sortito un
complessivo interesse verso la nostra cultura classica. I
testi degli autori latini (non solo i giuristi: penso alle
opere di Cicerone) vengono tradotti e commentati: ma – come
sempre accade – agli studiosi non basta il testo tradotto,
occorre leggere in originale. Si incomincia a porre il
problema dello studio della lingua latina in Cina.
Ancora. Il diritto privato romano è stato recepito nella
Rpc per la redazione delle leggi civili. Uno scopo, dunque,
perfettamente in linea con quanto – sin dall’alba
dell’Ottocento – fecero i giuristi europei che si
cimentavano nella redazione dei codici civili continentali.
Ma incontrare il diritto romano a fini di attualizzazione
postula il suo studio: il che induce anche – superata la
fase iniziale dell’utilizzazione immediata ai fini della
legislazione corrente – a percepirne la portata
squisitamente storica. Si torna, insomma, a Gaio, al
principium potissima pars, alla dimensione degli studi gius-
romanistici come disciplina storico giuridica: anche nella
Rpc, infatti, sono iniziati gli studi di diritto romano in
una chiave non solo strettamente legata al presente, ma
finalizzata a capire la genesi di quegli istituti che – nel
frattempo – venivano scelti quale base per il nuovo codice
civile: anche in Cina si è tornati, dunque, non casualmente,
proprio alla legge delle XII Tavole e al suo studio [Zhang
2000; Diliberto 2002; Xu 2005], dalla quale abbiamo preso le
mosse nel raccontare questa avventura.
16
Il cerchio sembra chiudersi.
4. Sono, tuttavia, necessarie alcune ulteriori
annotazioni.
Non escludo, infatti, che nella scelta cinese di
potenziare enormemente lo studio del diritto romano (e la
sua stessa adozione quale base della codificazione
civilistica) vi sia stata anche una motivazione
squisitamente politica. Il sistema di common law
anglosassone è, infatti, quello vigente negli Stati Uniti
d’America. Avere scelto, dunque, il sistema ad esso
contrapposto può spiegarsi anche sulla base della
(implicita) volontà da parte cinese di evitare una
subalternità culturale rispetto al principale competitor
della Rpc su scala globale.
Non mi pare, infatti, semplicemente un caso, la
circostanza (per noi, di enorme valore) che presso la più
antica università del mondo (di circa un secolo precedente
rispetto alla più antica dell’Occidente: Bologna), quella di
Changsha, della regione dello Hunan, il centro studi di
diritto romano sia finanziato direttamente dal Partito comunista cinese
della medesima regione. Ciò produce un’intensa attività di
relazione con gli atenei romani, convegnistica
internazionale, corsi di formazione specialistici, il
finanziamento di borse di studio per molti dottorandi cinesi
che studiano in Italia.
17
Una nuova sfida per il diritto romano, attraverso il suo
impiego anche a fini ideologici? Non è dato sapere. Ma, nel
caso, sarebbe l’apoteosi dell’eterogenesi dei fini, il
ribaltamento paradossale della storia: perché, in questo
caso, il diritto dell’impero antico per eccellenza sarebbe
usato come strumento di battaglia ideologica contro l’impero
odierno per eccellenza.
5. Un ultimo punto. La promulgazione del codice civile
cinese (al momento non ancora terminata, ma in stato molto
avanzato) offre un ulteriore spunto di riflessione: la
legislazione già approvata segue, infatti, in misura
sicuramente maggiore rispetto all’Italia (e agli altri
codici moderni) il sistema «originale» del diritto romano.
Il punto è di enorme rilevanza sul piano giuridico, ma
anche squisitamente teorico.
Tutte le codificazioni a base romanistica hanno infatti
recepito il diritto romano attraverso la sua tradizione
secolare lungo il Medioevo e l’età moderna: in tali
codificazioni, per dirla in modo sommario, il diritto romano
è stato «filtrato» soprattutto dalla mediazione politica e
culturale del codice napoleonico, cui si è già accennato. I
codici civili contemporanei, in buona sostanza, hanno tutti
una base romanistica, ma essa è il prodotto di una
mediazione borghese, illuministica, che non discende
direttamente dal diritto romano in quanto tale, bensì dalla
18
lettura (e dall’utilizzo) che di quest’ultimo avevano fatto
i compilatori del codice civile francese del 1804.
Ancora una volta, mi limito ad un solo esempio. Come già
accennato, il diritto di proprietà (e la sua assolutezza: il
cosiddetto «diritto egoista»), così come previsto nel codice
civile italiano (e in gran parte degli altri), dipende dal
lavoro sulle fonti giuridiche romane svolto dai compilatori
del primo codice dell’età moderna, quello – appunto – di
Napoleone: addirittura, nel primo codice dell’Italia unita,
quello del 1865, la definizione della proprietà privata era
letteralmente e pedissequamente tradotta in italiano dalla
formulazione presente nel codice francese.
Ma nel diritto romano in quanto tale, l’assolutezza del
diritto di proprietà privata è categoria sconosciuta
[Diliberto 2009; Schipani 2009a]: solo la rielaborazione
delle fonti giuridiche romane operata in piena rivoluzione
borghese riusciva ad estrapolare da esse concetti
finalizzati all’affermazione dell’assolutezza e
dell’inviolabilità della proprietà privata. Il diritto
romano, nella sua duttilità ed adattabilità, rappresentava
la cornice, il sistema della codificazione napoleonica, ma i
contenuti – come già sottolineato in precedenza – li
determinava il legislatore del tempo: da lì, poi,
confluivano negli altri codici moderni.
La codificazione cinese, viceversa, ha – per così dire –
«saltato» la mediazione napoleonica, per cimentarsi
direttamente nell’appropriazione e nella rielaborazione del
sistema romanistico. Proprio le norme sulla proprietà,
19
promulgate in Cina nel 2007 insieme alla disciplina generale
dei diritti reali [Sun 2006, ne sono lampante
dimostrazione: non è contemplata la proprietà privata come
perno (una sorta di motore immobile) del sistema degli altri
diritti; manca del tutto il riferimento alla sua assolutezza
(tanto meno all’inviolabilità); non si pone il tema
dell’unitarietà del medesimo diritto: convivono, infatti, nelle
leggi cinesi, sullo stesso piano, diverse forme di
proprietà, quella statale (la terra, ad esempio, ancor oggi
principale mezzo di produzione in Cina, non può che essere
esclusivamente dello Stato), quella collettiva (delle
comunità) e infine, buona ultima, quella privata [Leggi
tradotte 21 ss.; Yin 2009].
6. In conclusione, il diritto privato dei romani (quello
«sistemico» conservato dalla Compilazione giustinianea)
ritrova, in una latitudine impensabile sino a qualche
decennio fa, nuova ragione d’essere, al fine di una
codificazione contemporanea. Ma quello stesso diritto antico
incomincia anche ad esser studiato in una prospettiva e con
metodo squisitamente storico, nella consapevolezza che si
tratta, certo, di un diritto impiegato per il presente, ma
appartenente intrinsecamente al passato.
E’ in questa dialettica che va rintracciata la vitalità
della disciplina oggetto di queste mie brevi riflessioni,
nel rimando costante tra presente e passato, tra diritto
romano in senso stretto e tradizione romanistica: quella che
20
si dipana dal Medioevo per arrivare sino ai giorni nostri,
sino alla Rpc.
In fondo, in questa appropriazione del passato, faticosa
ma densissima di implicazioni, ritroviamo echi di quanto un
grande poeta, forse il più grande del secolo breve che
abbiamo alle spalle, Thomas Stearns Eliot, scriveva a
proposito del rapporto dei moderni interpreti con il
classico, con i classici. Si tratta di parole celebri, che
val la pena riproporre quale epilogo (provvisorio) della
straordinaria storia che ho appena raccontato: «La
tradizione non può essere ereditata, e se uno la vuole deve
ottenerla con grande fatica. Essa implica, in primo luogo,
il senso storico … e il senso storico implica una
percezione, non solo della condizione di passato del
passato, ma della sua presenza» [Eliot 1919, ma 1959, 21
ss.].
21
BIBLIOGRAFIA
Diliberto, O.
2002 A New Chinese Translation of XII Tables Law: Some Reflection on the
Situation of Our Researches, in Roman Law and Modern Civil Law. The Annals
of Institute of Roman Law Xiamen University, 3, 2002, 51 ss.
2005a Sulla formazione del giurista (a proposito di un saggio recente), in
Rivista di diritto civile, 51. II, 2005, 109 ss.
2005b Le XII tavole nel Digesto, in Ius Antiquum, Accademia
Scienze di Mosca, 2 (16), 2005, 50 ss.
2009 Il diritto di proprietà: estensione e limiti. Dal diritto romano ai codici
contemporanei, in Roma e America. Diritto romano comune, 28, 2009,
59 ss.
Eliot, T. S.
1919 Tradition and the Individual Talent (cit. dall’ediz.
Harmondsworth, Penguin 1958)
Fei, A.
22
2007 Gli sviluppi storici del diritto cinese dal 1911 fino ad oggi. Lineamenti
di un’analisi relativa al diritto privato, in Roma e America. Diritto romano
comune, 23, 2007, 113 ss.
Irti, N.
2004 Nichilismo giuridico, Roma-Bari, Laterza
Jing, P.
2008 Diritto cinese e sistema giuridico romanistico (a cura di L.
Formichella, G. Terracina e E. Toti), Torino, Giappichelli
Leggi tradotte
2008 Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, V, Legge sui
diritti reali (a cura di S. Schipani e G. Terracina), Torino,
Giappichelli
Petrucci, A.
1999 La nuova Legge sui contratti della Repubblica popolare cinese, in
Roma e America. Diritto romano comune, 7 1999, 319 ss.
Schipani, S.
23
2009a Expedit enim rei publicae ne quis re sua male utatur, in Le nuove
leggi cinesi e la codificazione. La legge sui diritti reali (a cura di S.
Schipani e G. Terracina), Roma Tiellemedia ed., 335 ss.
2009b Diritto romano in Cina, in XXI Secolo, Norme e idee, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, 527 ss.
Sun, X.
2006 Problemi e discussioni nella elaborazione della legge sui diritti reali
in Cina, in Marco Polo 750 anni. Il viaggio. Il libro. Il diritto (a cura di F.
Masini, F. Salvatori, S. Schipani), Roma, Tiellemedia, 73
ss.
Xu, G.
2005 New Translation of the Law of the Twelve Tables (in cinese),
in Hebei Faxue (Hebei Law Science), 23, 2005, 2 ss.
Yin, T.
2009 Valutazioni sulla costruzione legislativa dei diritti sui beni dello Stato
secondo la legge sui diritti reali, in Le nuove leggi cinesi e la codificazione. La
legge sui diritti reali (a cura di S. Schipani e G. Terracina),
Roma, Tiellemedia, 91 ss.
Zhang, S.