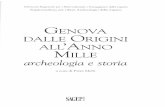Il monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Il monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni
Comune di Vicopisano Università Cà Foscari di VeneziaDipartimento di Scienze dell’Antichità
e del Vicino Oriente
Antonio Alberti
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca
Una storia lunga mille anni
GUIDA ALLA MOSTRA
Mostra archeologica:
Promozione e coordinamento: Comune di VicopisanoDirezione e coordinamento scientifico: Sauro Gelichi e Antonio AlbertiProgettazione allestimenti: Alessandro D’Anniballe, Marco Marradi, Gabriele NannettiProgetto grafico: Carlo Nacci ComunicazioneDisegni ricostruttivi: Riccardo Merlo Testi dei pannelli: Antonio Alberti, Federico Andreazzoli, Monica Baldassarri, Francesca Bertoldi, Massimo Dadà RestauriCeramiche: Bunicelli Melina, Bartali SabrinaMetalli: Chiara Di BeneMonete: Giuseppe MigliaroElementi architettonici: Elena FunginiRiproduzioni ceramiche: Lenzi Ghino Giacomo e Nesti GuidoCatalogo: a cura di Sauro Gelichi e Antonio AlbertiTesti di: Antonio Alberti, Federico Andreazzoli, Monica Baldassarri, Riccardo Belcari, Francesca Bertoldi, Emanuela Bisio, Massimo Dadà, Sauro Gelichi, Rita Giacomello, Stefano Giannotti, Gabriella Giuliani, Francesca Sbarra, Daniela Stiaffini.Guida alla Mostra: Antonio AlbertiEditore: Felici Editore srlCon la collaborazione di:Soprintendenza per i Beni A.P.P.S.A.D. per le Province di Pisa, Livorno e Massa CarraraSoprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana Comune di CalciArcheoclub d’Italia sez. PisaGruppo Culturale Ippolito Rosellini Con il patrocinio di:Regione ToscanaProvincia di PisaAPT Agenzia per il Turismo di PisaSponsor:Comitato Festa Medievale di VicopisanoGeofor. s.p.a.Delca s.p.aBraccianti EdiliziaPer Sempre Arredamenti C.M.S.A. Società Cooperativa Unicoop Firenze Sito web: www.viconet.it/aratroecalamo
Comune di Vicopisano Università Cà Foscari di VeneziaDipartimento di Scienze dell’Antichità
e del Vicino OrienteL’Aratro e il Calamo. Benedettini e Cistercensi sul Monte Pisano. Dieci anni di archeologia a San Michele alla Verruca
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni.
Felici Editore Srlvia Carducci, 64/C - Ghezzano56010 - San Giuliano Terme (Pisa)tel. 050 [email protected]
Responsabile editorialeFabrizio Felici
Responsabile marketingFrancesco Crisanti
Responsabile ufficio stampaSerena Tarantino
Grafica e impaginazioneClaudia Benvenuti, Felici Editore Srl
Testi a cura diAntonio Alberti
Referenze fotograficheLa maggior parte delle foto pubblicate sono a cura della direzione dello scavo archeologico.
© Felici Editore Srl - 2005Tutti i diritti sono riservati.Ogni riproduzione di foto, di testi e di carte, ogni rielaborazione, anche in forma ridotta, nonché ogni utilizzo abusivo, illegale ed improprio per la diffusione sulla rete Internet, è vietata senza il consenso scritto dell’Editore e/o degli aventi causa.
ISBN 88-6019-007-X
Mostra “L’aratro e iL CaLaMo”
E’ per me una grande gioia inaugurare la mostra relativa agli scavi archeologici del Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca.
Si porta a compimento l’ambizioso progetto - che inizialmente sembrava essen-zialmente un sogno - non solo di contribuire all’approfondimento della conoscen-za del territorio, ma soprattutto di coinvolgere tutti i cittadini in un processo di conoscenza diretta che renda partecipi di un evento che, parlando della nostra storia, porti a comprendere e sviluppare anche il nostro comune futuro.
Quando 10 anni fa, su iniziativa dell’Archeoclub di Pisa, seguita con entusiasmo dai Comuni di Vicopisano e Calci, si cominciò con il primo colpo di badile, forse neppure gli addetti ai lavori si sarebbero aspettati una tale ricompensa: un mona-stero ricco di testimonianze, un luogo denso di vita e di interesse architettonico: certo i resti non ancora crollati dell’abside non potevano indicarci con certezza la presenza di un complesso così articolato e dalle finiture tanto raffinate.
Oggi possiamo ben affermare che la costanza degli studiosi tutti, del Prof. Ge-lichi, dei suoi più stretti collaboratori, degli universitari che hanno lavorato alla sommità del colle e di tanti volontari appassionati di storia, sono stati abbondan-temente ripagati.
Il materiale raccolto è stato oggetto di numerose tesi di laurea ed è andato a costituire un consistente numero di reperti catalogati e interpretati che oggi, qui, finalmente, formano l’oggetto di questa mostra e degli studi che andiamo a pub-blicare.
Il Comune di Vicopisano, sotto l’abile guida dell’Università di Venezia e grazie alla notevole disponibilità della Soprintendenza Archeologica di Firenze e di quel-la pisana ai beni culturali, ha investito grandi risorse economiche e intellettuali per rendere possibile il cammino dallo scavo all’allestimento museale.
Grazie a tutti gli amministratori che prima di me e insieme a me, nel corso di questi lunghi dieci anni, non si sono stancati di credere nella bontà del progetto, riversando in esso le loro migliori energie e che oggi mi onoro di rappresentare
nella loro totalità.Anche se un luogo non può essere identificato con la pluralità dei sentimenti
che suscita, mi auguro di restituire a San Michele quella vitalità che ha saputo infondere nei cittadini contemporanei. I monaci benedettini o cistercensi ci hanno raccontato la loro vita perché noi potessimo capire meglio la nostra e noi altrettan-to fissiamo sui testi scientifici la loro storia perché non venga dimenticata.
Antonella Malloggi, Vicopisano, giugno 2005
Inaugurazione San Michele
Il sito di San Michele alla Verruca è stato oggetto di una delle più lunghe espe-rienze archeologiche (1996-2003) che abbiano interessato un insediamento dell’Ita-lia medievale; e, sicuramente, si tratta del primo monastero indagato in estensione e con metodi archeologici di tutta quanta la Tuscia. Un cantiere che ha visto la sperimentazione di metodi diagnostici non nuovi, ma ancora poco presenti nelle operazioni di recupero e restauro dei grandi monumenti architettonici o di aree archeologiche del nostro Paese: che ha registrato la presenza di oltre duecentocin-quanta tra studenti e dottorandi di diverse università italiane e straniere, tra cui Venezia, Parma e Pisa (insieme ad un folto gruppo di volontari dell’Archeoclub di Pisa); che è stato anche luogo di studio e formazione per giovani ricercatori, che hanno scelto nuclei tematici legati al San Michele per farne oggetto di tesi di laurea o di dottorato. Un cantiere, dunque, sensibile agli orientamenti della ricerca nazio-nale, ma nello stesso tempo ancorato ad una realtà locale ricca e in fermento, dove ancora aperta e vivace è la discussione storica (credo ne sia prova anche l’incontro organizzato nel 2000 ad Uliveto Terme).
Tuttavia non basterebbero tali condizioni a far transitare questa esperienza, certamente significativa sul versante metodologico, nel novero delle attività utili anche sul piano della conoscenza storica. Da questo punto di vista l’indagine sul San Michele riesce ad intercettare e a sviluppare due aspetti tematicamente rile-vanti della storia di questi territori. Uno, più generale, che riguarda le funzioni e le connessioni di questa categoria di complessi insediativi con gli sviluppi del popo-lamento nei secoli centrali del medioevo, i suoi rapporti con le risorse, le sue dina-miche con la strutturazione del potere (signorile prima, comunale poi), che stanno, insieme alle motivazioni di fede, alla base di una grande rinascita dell’esperienza benedettina nella Tuscia. L’altro, più circoscritto al sito, che si rivolge ad analiz-zare i meccanismi che qualificano l’organizzazione di quel luogo, a spiegare le relazioni tra spazi e funzioni, a mettere in luce e a caratterizzare le connotazioni sociali, culturali ed economiche delle comunità che lo hanno occupato. Un taglio,
introduzione
quest’ultimo, volto più a comprendere i nascosti meccanismi che governano la vita quotidiana (dei monaci, dei militari, dei boscaioli, cioè dei principali gruppi sociali che hanno vissuto nel tempo in questo luogo), che non a definire i grandi quadri della storia del potere e delle istituzioni. Due approcci in apparenza lontani tra di loro, che tuttavia riescono a coniugarsi nella misura in cui è la fonte archeologica, prioritario (ma non esclusivo) banco di prova della nostra indagine, ad orientarci nelle scelte. Semplificando, si potrebbe dire che questa ricerca intercetta più scale temporali d’analisi, ma si muove anche su livelli concettuali differenziati, dimo-strando come la fonte materiale possa qualificarsi strumento autonomo, e soprat-tutto duttile, nel processo di conoscenza storica.
Siamo abituati a pensare che il nostro patrimonio culturale (dunque anche ar-cheologico) sia essenzialmente costituito di manufatti ed oggetti portatori di valori universali, ma anche condensatori, di per sé, della nostra memoria storica: proprio per questo, dunque, da preservare, proteggere, tutelare. Non vi è dubbio che sia così. Tuttavia, e a maggior ragione per le fonti archeologiche, sbaglieremmo se confinassimo solo alle potenzialità informative autorefenziali degli oggetti l’unica possibilità che abbiamo per accedere alla conoscenza del passato. Risiede invece nelle capacità di comprendere i nessi tra le ‘cose’, e tra queste e il territorio, che dobbiamo riconoscere il nostro obiettivo; ed è su questo che dobbiamo concentrare la nostra azione, anche di tutela, facendo in modo che non si perdano irreparabil-mente (ed irresponsabilmente) le opportunità che ancora ci vengono offerte. Se la Mostra sull’esperienza dello scavo del San Michele riuscirà ad andare al di là della semplice elencazione ed esposizione degli oggetti, ma saprà raccontare anche fatti e storie, descrivere comportamenti e fenomeni, rappresenterà, come era negli au-spici di chi ha fortemente creduto in questo progetto, una tappa utile nel processo di conoscenza del nostro passato.
Sauro Gelichi, Venezia, maggio 2005
La ricerca di San Michele alla Verruca è stata avviata dall’Archeoclub di Pisa e dall’al-lora suo Presidente Onorario prof. Antonio Mario Radmilli. Lo scavo è stato realizzato, tra il 1996 e il 2003, in regime di concessione da parte dell’Amministrazione Comunale di Vicopisano (con la partecipazione del Comune di Calci) e sotto la direzione scientifica del prof. Sauro Gelichi, già docente presso l’Ateneo di Pisa (1996-1997) e poi all’Università Ca’ Foscari di Venezia (1997-2003).
Lo scavo è stato coordinato dal dott. Antonio Alberti, con la collaborazione della dott.ssa Francesca Sbarra, del dott. Massimo Dadà, del dott. Federico Andreazzoli (studio degli alzati) e della dott.ssa Francesca Bertoldi (per quanto concerne lo scavo delle necropoli).
Allo scavo hanno partecipato studenti delle Università Ca’ Foscari di Venezia, di Parma e di Pisa e numerosi membri dell’Archeoclub di Pisa, tra i quali si ricordano i Presidenti Luciano Di Lupo e Giulio Arnò e i collaboratori più stretti Andrea Genovese e Marco Bo-schi.
Lo scavo è stato finanziato dai Comuni di Vicopisano e Calci, dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e dall’Archeoclub di Pisa e in anni diversi anche dalla Provincia di Pisa e dalla Fondazione Cassa di Risparmio.
Al termine di questa esperienza di lavoro i curatori del progetto si sentono di dover ringraziare tutti gli studenti delle Università di Venezia, di Parma e di Pisa che hanno partecipato alle campagne di scavo e tutti gli Enti, le istituzioni e le persone che lo hanno permesso e facilitato e in particolare:
il Sindaco di Vicopisanola prof.ssa Anna Maria Catarsi l’Ufficio Tecnico del Comune di Vicopisanoil dott. Giacomo Minutiil Sindaco del Comune di Calci il sig. Casella e il gruppo dell’Antincendio del Monte Pisano il prof. Stefano Brunila Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
iL Luogo e iL progetto
I resti del monastero di San Michele alla Verruca sorgono a quota 440 m s.l.m. sulla cima del Monte Grande nel Monte Pisano, su un breve pianoro che si estende poco più a est del Monte Verruca, sul quale sono ancora ben visibili i ruderi dell’omonima fortezza.
L’abbazia è stata oggetto di una serie di indagini archeologiche, promosse dall’Amministrazione Comunale di Vicopisano e diret-te dall’Insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che hanno avuto la durata di otto anni, dal 1996 al 2003. L’intervento si è inserito in un più ampio progetto di ricerca che ha compreso lo studio delle evidenze architettoniche supersti-ti delle numerose fondazioni monastiche nate e operanti all’incirca nello stesso periodo del San Michele, insieme ad una serie di ri-cognizioni di superficie su aree campione del Monte Pisano. Tra il 2003 e il 2005 è stato completato lo studio della documentazione archeologica e dei reperti1.
Lo sCavo e La storia
Lo scavo archeologico ha interessato l’intero complesso monasti-co, anche se, ovviamente, non tutta l’area occupata dal monastero è stata scavata. Tuttavia in molti punti, come la chiesa, il sagrato, i magazzini del lato ovest, il chiostro, la sala capitolare e il loggia-to orientale, è stato raggiunto l’affioramento roccioso naturale. Per motivi di carattere statico non è stato possibile indagare la zona pre-sbiteriale della chiesa e per gli stessi motivi si è ritenuto opportuno non indagare l’ambiente identificato come la sagrestia, ubicato tra il transetto sud della chiesa e la sala capitolare. Tutta l’area meridio-nale inoltre, dove riteniamo dovessero trovarsi il refettorio e forse le cucine, non è stata esplorata perché fortemente compromessa da
1 Le indagini archeologiche e le ricognizioni hanno visto la partecipazione di circa 250 tra studenti delle Università di Parma, Pisa e Ca’ Foscari Venezia e di volontari dell’Archeoclub d’Italia, sede di Pisa. Lo scavo è stato effettuato in regime di concessione ministeriale e con il supporto economico dei Comuni di Vicopisano e Calci, dell’Archeo-club sede di Pisa, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pisa.
13
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni
14
episodi di collassamento del terreno.L’individuazione del tracciato del recinto che doveva chiudere
l’area monastica, conservato spesso ad un livello di poco superio-re alla spiccata di fondazione, ha permesso di dimensionare l’area aperta della zona orientale del sito, forse occupata dagli orti e da altre attività legate alla vita quotidiana del monastero, e compresa tra l’abside e il muro claustrale.
La documentazione archeologica, insieme alle informazioni rica-vate dalle fonti scritte, ha permesso di precisare sei periodi distinti di frequentazione; i primi cinque compresi tra l’VIII e la fine del XV secolo e l’ultimo, relativo ad un uso sporadico del sito, databile tra il XVI/XVII e l’inizio del XIX secolo, momento in cui crollano defi-nitivamente anche le strutture della chiesa abbaziale2.
2 Questo testo si basa sui contributi contenuti nel volume di studi miscellaneo a cura di S. Gelichi - A. Alberti, L’ara-tro e il calamo. Benedettini e Cistercensi sul Monte Pisano. Dieci anni di ricerche archeologiche al San Michele alla Verruca, Pisa 2005 (Felici Editore).
1. Localizzazione del Monte Pisano.
2. Il sito archeologico di San Michele alla Verruca sul Monte Pisano e localizzazione degli altri monasteri fondati tra X e XII secolo nello stesso territorio.
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni Antonio Alberti
16 17
Periodizzazione:I : pre-monastero (fine VIII - fine del X secolo)II : monastero benedettino pre-romanico (fine X - primi decen
ni del XII secolo)III : monastero benedettino romanico (primi decenni del XII se
colo - 1260)IV : monastero cistercense (1260-prima metà del XV secolo)IVa: acquisizione e riorganizzazione (1260-XIV)IVb: ultima fase presenza dei monaci (fine XIV-prima metà XV)V : assedio pisano-fiorentino (1496-1498)VI : frequentazione sporadica (XVI – XIX secolo)
3. Vista generale dell’area di scavo a fine campagna 1999.
La CappeLLa di san MiCheLe La storia di San Michele inizia nell’altomedioevo, quando nel
luogo detto Verrucola è documentata una chiesa dedicata all’Arcan-gelo, proprietà prima di Ferualdo dei conti Aldobrandeschi, poi del vescovado lucchese.
E’ del 30 giugno 861 il documento che testimonia di un certo Eri-prando, figlio di Ildiprando, che risarcì il vescovo di Lucca Geremia (suo figlio) con la sua quota di proprietà della chiesa di S. Benedetto a Settimo perché non era stato in grado di difendere in processo la sua quota di possesso della chiesa di Sant’Angelo nel luogo detto Verrucola che lo stesso Eriprando aveva ricevuto dall’avo materno Ferualdo e che aveva permutato in precedenza con alcuni beni nel
4. Planimetria generale dello scavo con la localizzazione delle aree indagate.
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni Antonio Alberti
18 19
territorio di Roselle con il predecessore di Geremia, Berengario. La chiesa di S. Angelo, comunque, a quella data esisteva già da tempo, almeno dalla fine dell’VIII sec., poiché faceva parte del patrimonio di Ferualdo, attestato vivo nell’800 e presente in un placito lucchese del 785.
E’ probabile che proprio quell’edificio si trovasse nella stessa area dove, due secoli più tardi, verrà fondato il monastero, anche se l’in-dagine archeologica interna alla chiesa abbaziale “romanica” non ha restituito evidenze strutturali certe relative a questo primo pe-riodo di frequentazione del sito. Le uniche tracce che testimoniano l’uso del luogo prima della fondazione del monastero sono piutto-sto labili e di non facile interpretazione. In effetti l’area che doveva posizionarsi in facciata dell’antica chiesa presenta evidenti segni di levigatura e modellazione della roccia naturale affiorante. Potrebbe trattarsi di interventi predisposti alla creazione di spazi aperti e sentieri che dal pianoro più alto scendevano verso valle in direzione sud.
La chiesa e gli edifici annessi sono ancora ricordati nei primi de-cenni del X secolo. Il 6 agosto 913 fu ceduta in livello da parte del vescovo Pietro di Lucca ad un certo Ariperto e ai suoi figli Auriper-to e Grimoaldo diacono per il censo annuo di dodici denari d’ar-gento da pagare nel mese d’agosto, con l’obbligo di farla officiare e di tenervi, “luminaria et incensum”. L’entità del bene sembra in questo documento riferirsi ad una struttura più complessa di quella dell’861, con la presenza di alcune costruzioni non meglio definite, annesse alla chiesa.
iL priMo Monastero benedettino
Solo alla fine del X secolo è ricordato per la prima volta il mona-stero di San Michele.
La prima attestazione di una chiesa e di un monastero di San Mi-chele Arcangelo “sito loco et finibus , ubi dicitur Verruca, que est de sub regimine et potestatem ecclesiae episcopatui nostri Sancti Martini [...]cum fundamento et omne edificio suo” si trova nel livel-
lo del 4 maggio 996 , per cui Gherardo, vescovo di Lucca, lo cedette a Maione, abate della chiesa e monastero di San Salvatore di Sesto nella diocesi di Lucca, per l’annuo canone, nel mese di gennaio, di otto soldi .
Il rapporto con l’abbazia di Sesto risulta molto importante e mol-to stretto almeno fino alla fine dell’XI secolo. Solo nel 1097 è attesta-to un priore di San Michele, Bernardo, dopo quasi un secolo in cui si trovava citato insieme all’abate di Sesto. Il 17 giugno 1097 si ha notizia di un abate di San Michele della Verruca, Bernardo, che rive-ste lo stesso titolo per San Nicola in Pisa, che allivellava a un privato per un censo annuo di 36 denari d’argento, un orto pertinente pro-prio alla chiesa di San Nicola posta fuori delle mura.
La nascita del monastero di San Michele si inserisce in un ampio panorama di fondazioni monastiche che caratterizza anche la no-stra zona nei secoli centrali del medioevo.
I monasteri benedettini sorti sul Monte Pisano tra il X e il XII se-colo rientrano infatti nel quadro della grande fioritura di fondazioni monastiche che, in quegli stessi anni, registrano in Toscana la pre-senza di oltre un centinaio di cenobi ispirati alla regola.
La promozione di queste fondazioni, sia ad opera dell’aristocra-zia laica che di altri istituti ecclesiastici, si basò su reali e forti moti-vazioni di carattere religioso, anche se una finalità, non poi troppo nascosta, era quella di promuovere l’affermazione sociale e politica della casata fondatrice. Ad esempio per il marchese Ugo di Toscana,
5. Struttura muraria caratterizzata da una apparecchiatura delle pietre a spina-pesce. Si tratta di una delle strutture superstiti relative alla fase pre-romanica del monastero (Periodo II).
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni
20
fondatore tra l’altro della Badia Fiorentina e artefice della ricostru-zione di San Ponziano a Lucca e San Salvatore di Sesto, i cenobi as-sumevano la funzione di centri organizzativi dei beni fiscali. Per le altre casate laiche si trattava di monasteri privati, nuclei di coordi-nazione di un ambito territoriale, in grado di favorire il radicamen-to signorile dei fondatori, soprattutto per coloro che tendevano a rendere dinastici i loro poteri di origine pubblica, come ad esempio i casati comitali.
Pur con le difficoltà derivanti dalla bassa visibilità e conservazione delle strutture e dei depositi relativi a questa fase, dovute essenzial-mente al cantiere della ricostruzione “romanica” che ha asportato
6. Tracce di struttura muraria rinvenuta all’interno della navata della chiesa abbaziale (Periodo II). Il muro, conservato per uno o due filari è stato tagliato dalla fondazione dei perimetrali nord e sud dell’edificio religioso.
7. Boccale nudo ad impasto grezzo (Periodo II).
8. Testello (Periodo II).
9. Disegno ricostruttivo del monastero pre-romanico di San Michele (Periodo II).
buona parte dei livelli d’uso più antichi, l’indagine archeologica ha permesso di farsi un’idea di come dovesse essere organizzato que-sto primo nucleo monastico. Si trattava di un complesso non ancora strutturato intorno ad un chiostro quadrangolare, un insediamento, cioè, privo di una organica pianificazione, con l’edificio ecclesia-stico ancora ubicato sul pianoro più alto e gli ambienti di servizio posizionati nello spazio immediatamente a sud, forse adattati alla morfologia del terreno in evidente pendenza sul lato meridionale.
Gli edifici si localizzavano in diverse zone del sito: sul pianoro della chiesa, dove all’interno della navata della abbazia “romanica” (area 1000) è stata riportata in luce una porzione di muro in pietra; nell’area magazzini (area 2000) dove una struttura riutilizzata come fondazione degli ambienti 1 e 4, e stata edificata con pietre irrego-lari e bozzette di medie e piccole dimensioni, solo spaccate e appa-recchiate a spina-pesce; porzioni di simili murature sono poi usate come fondazione del cordolo orientale che perimetra il chiostro. E’ forse in relazione a questo ultimo edificio, posizionato nell’angolo sud-est del sito, che sono state riportate in luce ben quattro sepoltu-re stratigraficamente precedenti alla costruzione di XII secolo della sala capitolare. Esse sono state ricavate in parte nella roccia affioran-te, in questo caso presentavano spallette su cui si andavano ad ap-poggiare le coperture in lastre di ardesia, in parte in fossa terragna, cioè scavate semplicemente nella roccia e coperte con lastre.
I materiali, ceramici e metallici, relativi alle fasi di frequentazione di questo periodo sono piuttosto scarsi proprio per la bassa conser-vazione dei depositi archeologici, che come detto sono stati per lo più asportati dal cantiere di ricostruzione del monastero di XII se-colo. Sono state comunque recuperate frammentarie olle da fuoco, testelli e brocche o boccali ad impasto grezzo e nude in superficie, parti di brocche ad impasto depurato, in un caso con decorazioni dipinte in bruno.
Antonio Alberti
23
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni
24
iL grande Monastero benedettino Probabilmente in conseguenza del fatto che almeno dalla fine del-
l’XI secolo il cenobio si fosse svincolato completamente da Sesto, i primi decenni del secolo successivo segnano una svolta nella politi-ca patrimoniale del monastero di S. Michele alla Verruca.
Significativamente l’accresciuta ricchezza dell’abbazia si esplicita proprio nella decisione di ricostruire interamente il monastero, sul-la base delle indicazioni della Regola benedettina.
All’impianto del cantiere “romanico” è probabilmente da corre-
10. Prospetto orientale esterno del transetto nord della chiesa abbaziale di San Michele.
11. Vista di ambiente 2 di area 2000 (cantina) a fine scavo.
12. Area 2000, ambiente 1 e 2, in fase di scavo.
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni
26
lare l’attestazione della proprietà di cave di pietra, desumibile da una serie di testimonianze prodotte in seguito ad una controver-sia avvenuta tra l’arcivescovo di Pisa e l’abate del monastero della Verruca, in data non specificata, ma che si fa risalire agli anni ’50 del XII secolo sulla scorta del nome dell’abate presente alla stesu-ra dell’atto, Ildebrando. Il riferimento cronologico della proprietà della cava da parte del monastero ai primi decenni del XII secolo è ancora deducibile dal documento: i testimoni giurano infatti di aver visto i fatti descritti già trenta o quaranta anni prima. La controver-sia riguardava la gestione di parte del territorio e delle sue risorse, più specificatamente del mirto, delle felci, del carbone e delle pie-tre. Sulla base di queste informazioni sappiamo quindi che l’abate di San Michele controllava direttamente l’estrazione della pietra. In una cava, nel luogo detto “Serra de Plaia”, erano attivi “magistros” e “secantes lapides” che avevano a disposizione locali (“capanna”), con un sistema di trasporto (“asinarii”) che permetteva di trasporta-re le pietre già lavorate dalla cava fino all’Arno. Il toponimo “Serra de Plaia” non è indicativo di un luogo specifico ma doveva comun-que trovarsi tra Montemagno e Calci.
La proprietà della cava divenne quindi elemento essenziale per impiantare il cantiere per la ricostruzione completa del cenobio be-nedettino.
Ad un unico progetto e ad un unico cantiere di realizzazione sem-bra infatti da attribuire buona parte dell’impianto del monastero così come è emerso durante lo scavo. Il materiale utilizzato e le tec-niche murarie impiegate nella chiesa e nelle altre strutture del ceno-bio organizzate intorno al chiostro centrale, anche se in alcuni casi con lavorazione e finitura differenti, confermano la datazione del cantiere entro la prima metà del XII secolo.
Il monastero nuovamente edificato si caratterizza per una pianta organicamente definita dai suoi edifici. La chiesa abbaziale (Area 1000) era ubicata a nord del complesso, sul pianoro più ampio e regolare, con planimetria a croce latina ed orientamento canonico. Nell’ampio spazio a sud della chiesa abbaziale, ricavato asportando le asperità create dagli affioramenti rocciosi e creando così un ampio
Fig. 13
13. Veduta generale del chiostro del monastero durante le fasi di scavo della cisterna.
14. La cisterna del chiostro. La struttura aveva la funzione di conservazione dell’acqua che si incanalava nelle canalette del chiostro. Le condutture portavano acqua al refettorio e alle latrine.
Antonio Alberti
29
15. Loggiato orientale del monastero. Vista delle tombe del cimitero dei monaci.
spazio regolare, venne realizzato il chiostro centrale, a pianta rettan-golare, con i loggiati che corrono lungo il suo perimetro (Area 3000) e la grande cisterna nell’angolo nord-est (Area 6000). Sui loggiati si affacciavano gli ambienti tipici di un monastero benedettino. A sud era ubicato un corpo di fabbrica (Area 7000) che corrisponde al re-fettorio dei monaci e alle cucine e che, almeno nella porzione centra-le, risulta sotto-scavato, quindi con cantine e magazzini. Ad ovest (Area 2000) il corpo di fabbrica era suddiviso in quattro ambienti, due dei quali (Ambiente 2 e 3) anch’essi sotto-scavati e probabil-mente utilizzati come cantine, quindi come magazzini o comunque per vani di servizio. Ad est del chiostro, infine, si distribuiscono gli spazi più importanti del complesso monastico, quelli della sagre-stia, in appoggio al transetto meridionale della chiesa, e della sala capitolare (Area 4000). I dormitori dei monaci dovevano trovarsi ai piani superiori degli edifici: è questa, tuttavia, un’ipotesi che si basa essenzialmente sulla scorta dei confronti con piante-tipo di altri mo-
16. Tombe 7 e 8. Sepolture a cassa inserite in ampi tagli della roccia in posto.
Antonio Alberti
31
17. Spazio cimiteriale riservato ai laici localizzato in facciata della chiesa.
18. Tomba 16. Sepoltura nel cimitero dei laici ricavata nella roccia in posto e coperta con lastre di ardesia.
nasteri benedettini, in quanto non sono conservati perimetrali i cui alzati superino il piano terra. Intorno al monastero, inoltre, correva un muro di cinta (muro della clausura) che delimitava il perimetro dello spazio monastico, che è stato interamente individuato nella porzione a oriente del complesso e che comprendeva, tra esso e gli edifici del monastero, un’ampia area aperta forse destinata ad atti-vità artigianali e produttive (orti, forni, laboratori).
E’ nella fase benedettina che si struttura in maniera definitiva an-che lo spazio funzionale al cimitero dei monaci. Tale funzione viene riservata ai quattro loggiati che si affacciano sul chiostro, all’inter-no dei quali, sotto i livelli pavimentali costituiti semplicemente da piccole lastre di ardesia e terra compattata, vengono scavate una serie di strutture in cassa litica, con muretti perimetrali inseriti nello spazio ricavato dall’asportazione della roccia in posto, con coper-tura in lastre di ardesia di medie dimensioni. Il cimitero riservato ai monaci mantiene la sua ubicazione originaria anche quando il complesso passa dai Benedettini ai Cistercensi, nella seconda metà del XIII secolo. In questa fase alcune tombe sono riutilizzate, altre costruite nuovamente.
E’ solo nella fase cistercense, poi, che si struttura anche lo spazio cimiteriale antistante la chiesa e riservato ai laici. Nella fase finale di presenza dei monaci, poi, le grandi casse con copertura monolitica del cimitero dei laici sono state riutilizzate come ossari.
Nel monastero si identificano con certezza oltre trenta tra tombe strutturate in cassa litica e in fossa terragna, 9 tombe sono pertinenti all’area della chiesa, mentre le restanti sono localizzate all’interno dello spazio claustrale: nel chiostro, nei portici che lo circondano e nella sala capitolare, in questo ultimo caso per quanto riguarda le sepolture relative al Periodo II.
Grazie agli studi paleobiologici e paleopatologici su un campione di 184 individui recuperati nei cimiteri di San Michele, in alcuni casi solo parzialmente conservati nella struttura scheletrica, è stato in-nanzitutto possibile determinare la quantità dei monaci sepolti (84) rispetto a quella dei laici (59), oltre all’età media di vita, alle patolo-gie che hanno causato la morte, ecc.
Antonio Alberti
33
19. Disegno ricostruttivo del monastero benedettino romanico (Periodo III).
iL Monastero CisterCense Nel 1260 il monastero della Verruca passa all’obbedienza cister-
cense come risulta da una vertenza nella stessa data tra il Comune di Pisa e i Cistercensi di S. Galgano; l’obbedienza è riconfermata nel 1261 ne-gli Statuti Cistercensi del Capitolo Generale.
I decenni successivi, entro la fine circa del XIII secolo, sono caratterizza-ti da una serie di atti da cui è evidente il tentativo da parte dell’abate di S. Galgano di disfarsi di San Michele, forse per la posizione poco strategica, piuttosto lontana da Pisa, forse per stato di crisi patrimoniale in cui allo scorcio del Due-
20. Porta di accesso alla chiesa dal transetto meridionale.
21. Scorcio dell’interno della chiesa di San Michele.
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni
34
cento pare essere caduto il cenobio.
A partire però dagli inizi del XIV secolo sono attivi in San Michele una serie di cantieri che apportano no-tevoli modifiche non tan-to al complesso monastico quanto all’organizzazione interna di alcuni edifici. E’ evidente che la decisio-ne, da parte dei monaci di obbedienza cistercense, di non abbandonare il ceno-bio acquisito solo qualche decennio prima induce ad un investimento non in-differente per adattare gli ambienti preesistenti ai dettami della nuova Regola. In particolare tali interventi vedevano coinvolta l’antica chiesa (ecclesia) con pianta a forma di croce, la cui navata centrale doveva venire suddivisa in due parti principali, il coro dei monaci e quello dei conversi. La nuova organizzazione spa-
ziale, dunque, prevedeva che le file degli stalli del coro si trovassero l’una di fronte all’altra, mentre gli ultimi due stalli (quel-lo dell’abate e del prio-re) dovevano chiudere la struttura ad ovest, fino a configurarla a forma di U, in modo che rimanes-se un solo passaggio al
22. Pavimento in mezzane laterizio a spina-pesce relative alla chiesa abbaziale cistercense.
23. Altare localizzato al centro del transetto meridionale.
24. Vista generale della chiesa in fase di scavo.
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni Antonio Alberti
36 37
retrocoro, ambiente dove si trovavano i banchi per i monaci malati. Per gli ospi-ti, familiari e domestici del monastero, erano a disposi-zione posti solo nella parte occidentale o nelle navate laterali. In capo alla chiesa, a est, si trovava lo spazio per l’altare, il sopraelevato presbiterio (per la messa conventuale), fiancheggia-to dalle cappelle laterali per le messe private. Sul transetto nord si doveva aprire la porta dei morti che dava accesso al cimi-tero dei monaci, in questo
caso coincidente con l’area cimiteriale più antica, già ubicata lungo i loggiati.
Dal transetto sud si accedeva poi alla sagrestia (vestiarium) e, per una scala, al dormitorio dei monaci. L’ala orientale del monastero, cioè quella dei monaci, si congiungeva quindi con il transetto ed era composta da: sagrestia, aula capi-tolare, parlatorio, corridoio o scala, sala dei monaci, al pian terreno, e dormito-rio (dormitorium) al di sopra. Alla parte estrema dello stesso edificio (a sud), sul
25. Scala di accesso alla chiesa.
26. Canaletta che corre lungo il perimetrale orientale del chiostro.
canale di scolo, si trovano le latrine (necessaria dormitorii).
In vista del rispetto di questi dettami, l’adegua-mento e quindi l’intervento più rilevante è documenta-to all’interno della chiesa, dove lo spazio risulta sud-diviso in almeno quattro set-tori scanditi dall’uso di una pavimentazione differente: il presbiterio con un pavi-mento in lastre quadrate di pietre, con l’altare centrale e gli altari laterali nel transet-to; il coro dei monaci pavi-
mentato in mezzane di laterizio disposte a spina-pesce in cui si riconoscono anco-ra le impronte degli stalli dei monaci che chiudono verso ovest con l’alloggiamento dello stallo dell’abate e, a destra dello stes-so, quello del priore; il coro degli infermi, determinato da uno spazio in cocciopesto; il coro dei conversi ancora con pavimento in mezzane.
Anche lo spazio antistante la facciata della chiesa subisce profonde modifiche. Oltre alla ricostruzione della scalinata di accesso all’abbazia, ad un certo punto co-
27. Canaletta che attraversa longitudinalmente il loggiato orientale.
28. Resti di un forno da pane (Periodo IVb).
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni
38
perta con tettoia lignea, di cui si sono documentate le buche per palo ai lati della scala, la porzione meridionale dell’area si trasforma in una vera e propria cappella funeraria, riservata ad una serie di inumazioni di laici.
Oltre agli interventi documentati nella chiesa abbaziale, anche negli altri edifici del complesso monastico i Cistercensi interven-gono più o meno profondamente. Il complesso della sagrestia-sala capitolare viene in parte modificato con la creazione di un vano ul-teriore tra la sagrestia stessa e il capitolo. Questa spazio così ricava-to doveva comprendere una grande scala in legno per l’accesso ai dormitori, i cui alloggiamenti sono ancora visibili nei perimetrali superstiti nord e est. L’intervento è stato probabilmente coevo alla riorganizzazione del piano superiore dell’intero complesso orienta-le, che già accoglieva il dormitorio dei monaci. L’icnografia del mo-nastero cistercense prevedeva infatti un passaggio stabile che col-legasse la chiesa, attraverso il transetto, con l’adiacente spazio dei monaci (come novità rispetto alla Regola benedettina che imponeva
29. Vista generale del sito con in primo piano le strutture di ambiente 4.
30. Disegno ricostruttivo della fase cistercense del monastero (Periodo IV).
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni Antonio Alberti
40 41
invece un perfetto isolamento dello spazio sacro). Tali interventi sono ipotizzabili anche sulla scorta dei crolli scavati nel loggiato prospiciente l’area 4000, sulla base dei quali è legittimo supporre che la parte superiore, almeno della sagrestia, fosse stata costruita in questa fase interamente in laterizio, con finestre ad arco con mattoni sagomati a cuneo.
Il chiostro, già strutturato nel periodo precedente, probabilmen-te è oggetto di limitati interventi che riguardano le condutture che dalla grande cisterna portavano l’acqua al refettorio e alle latrine, che proprio in questo periodo dovrebbero essere state costruite nel-la porzione finale del complesso dell’Area 4000.
Nella prima metà del Quattrocento, prima dell’abbandono defi-nitivo del San Michele da parte dei monaci, si notano ovunque i segni di un progressivo declassamento funzionale delle strutture e la riduzione ad un uso, sempre più esclusivo, della chiesa e dello spazio ubicato immediatamente a sud di essa. Probabilmente dalla fine del XIV - primi del XV secolo, comunque non oltre la metà del Quattrocento, rimangono in funzione alcuni ambienti che mutano la loro destinazione originale: il loggiato nord, con la costruzione di un forno da pane appoggiato al prospetto della chiesa; la sagrestia, collegata direttamente al presbiterio; l’Ambiente 4 dell’Area 2000, già ampliato fino ad appoggiarsi all’angolo sud-occidentale dell’ab-bazia e che in questa fase comincia ad essere utilizzato come cucina (all’interno del vano sono stati documentati due focolari); il loggiato est e il chiostro che assumono funzione di area cimiteriale non strut-turata, con deposizioni in fossa terragna, che nel caso del corridoio orientale insistono negli strati di obliterazione delle tombe a cassa.
Nel caso del cortile centrale, peraltro, una delle sepolture era di-sposta perpendicolarmente alla canaletta centrale e la tagliava in superficie, dimostrando come oramai anche l’impianto idraulico avesse perso totalmente la sua originaria funzione.
I magazzini 1 e 2 dell’area 2000 risulterebbero già in disuso verso la fine del ‘300, come confermano i materiali ceramici provenienti dai piani di frequentazione coperti dagli stessi crolli dei perimetrali.
Le suppeLLettiLi dei MonaCi
La fase cistercense del monastero di San Michele è la più con-servata dal punto di vista stratigrafico, sono cioè stati documentati interi ambienti del cenobio in cui si conservavano ancora i piani pavimentali, i riporti per rialzamenti di quote, i livelli di abbandono e di crollo. Grazie a queste evidenze si è reso possibile ricostruire, anche se parzialmente, la cultura materiale di un cenobio di XIV secolo del Monte Pisano.
La grande quantità di materiale ceramico e poi metallico e vitreo ha permesso di determinare un quadro piuttosto completo di ciò che era nell’uso quotidiano dei monaci: stoviglie per la mensa e la cucina, arnesi e elementi di abbigliamento in metallo, tipo di ali-mentazione desumibile anche dalle analisi dei resti di fauna raccolte nei contesti dello scavo.
Le quantità riferibili al Periodo IV della periodizzazione sono esplicative del campione a disposizione: si tratta di oltre 1800 esem-plari di manufatti in ceramica, corrispondenti a quasi 6300 fram-menti.
Se continuano ad essere attestati tipi di contenitore già docu-mentati anche nelle fasi precedenti, come le brocche nude e depu-rate, i boccali nudi ad impasto grezzo e in ge-nerale i manufatti usati sul fuoco (olle e testelli, quest’ultimi con alcune variazioni nella forma), a partire dalla fine del XIII secolo sono intro-dotti in grande quan-tità i contenitori da
31. Boccale di maiolica arcaica pisana decorato in verde e bruno (Periodo IV).
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni
42
mensa prodotti in area pisana. Si tratta di ciotole, scodelle, catini e boccali di “maiolica arcaica” pisana, che trovano il loro picco di produzione e distribuzione dal XIV e per buona parte del XV secolo. A differenza poi della fase precedente, che comunque ha restituito una bassa percentuale di materiale ceramico, vengono introdotte pentole e tegami invetriati da fuoco, documentati soprattutto nella fase finale di permanenza dei monaci, entro la metà del XV secolo. Molto pochi sono gli esemplari di importazione da aree extra-re-gionali: si tratta di alcuni esemplari di scodelle o ciotole invetriate e graffite di produzione savonese (Liguria), una scodella smaltata e decorata in blu cobalto d’origine valenzana (Spagna) e ancora un lustro metallico di produzione spagnola.
32. Ciotola di maiolica arcaica pisana decorata a motivi vegetali e raggi in verde ramina.
33. Ciotota di maiolica arcaica pisana decorata a croce in ramina e raggi in manganese.
34. Ciotola di maiolica arcaica pisana monocroma con sigla in bruno al centro del cavetto.
35. Boccale o brocchetta nuda depurata.
36. Reperti vitrei. Fiale.
37a. Denaro. Lucca, prima metà del XII secolo.
37b. Denaro “picciolo”. Pisa, seconda metà del XIV secolo.
37c. Denaro aquilino. Signoria pisana su Lucca, 1342-1369.
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni Antonio Alberti
46 47
L’oCCupazione MiLitare deL Monastero: Le truppe pisane e fiorentine
La chiesa e il monastero di San Michele alla Verruca, alcuni de-cenni dopo l’abbandono del cenobio da parte dei monaci che si era-no nel frattempo trasferiti nel monastero suburbano di San Ermete in Orticaria, furono occupati militarmente dal 1496 al 1498, durante la guerra tra Pisa e Firenze.
Le notizie riguardanti l’occupazione fiorentina del sito si dedu-cono essenzialmente dalle fonti narrative contemporanee o di poco posteriori agli avvenimenti narrati.
Il “Memoriale” di Portoveneri tratta gli avvenimenti di Pisa tra il 1494 e il 1502 e dedica ampio spazio alle vicende che interessarono San Michele in quegli anni. In data 30 marzo 1497 (in stile pisano) il testo ci informa della conquista della chiesa, dove si doveva trova-re un avamposto pisano della vicina rocca, da parte dei Fiorentini: ”E ad 30 di detto, 1497, el campo di Firentini vene a Veruca, e pre-se S.Michele [...] molti fanti Alamanni e Taliani e omeni di Cascina vennero a Veruca che si tiene pè Pisani, e assaltono la guerdia era a S. Michele e ruppeli”.. Il passo seguente, datato al “ 4 d’aprile dit-to” dello stesso anno, descrive l’attacco alla rocca della Verruca da parte di un contingente di Fiorentini accampato in San Michele:” E la fanteria dè Firentini andonno a S. Michele a Veruca con alquanta artiglieria, e detteno più battaglie alla Veruca[...] E Firentini s’acam-porono a S. Michele, facendo bastioni per assediare Veruca”.
Tra il marzo e l’aprile del 1496 si concluse la prima fase delle osti-lità tra le parti avversarie con il complesso monastico che fu usato dapprima come ridotto fortificato della rocca della Verruca da parte dei Pisani e, in seguito, dai Fiorentini come campo base dal quale lanciare gli attacchi al vicino fortilizio.
La seconda fase di guerra si sviluppò nel 1498, allorché i Fiorenti-ni occuparono San Michele per scendere di qui a Vicopisano, anche se vennero in seguito cacciati dalla chiesa grazie ad un’operazione della fanteria di Iacopo di Tarsia.
Le truppe militari ebbero quindi ampio spazio a disposizione
dove poter stanziare i loro accampamenti e le suppellettili da loro utilizzate. Le tracce archeologiche dell’occupazione delle strutture del monastero è piuttosto chiara, soprattutto nella chiesa abbaziale e nella sala capitolare, dove sono evidenti i livelli di frequentazio-ne delle fasi precedenti, attraverso la stesura di piani pavimentali ricreati utilizzando materiale residuo in parte già crollato. Di fronte alla facciata è stata trovata la traccia di un muro che evidentemen-te fortificava l’accesso principale al complesso occupato, mentre il chiostro, ripulito dai crolli, poteva essere stato utilizzato come piaz-za d’armi.
Le tracce più evidenti dei combattimenti avvenuti tra le parti in guerra sono rappresentate da notevoli quantità di dardi di verret-tone, di punte freccia, di puntali di lancia, di proietti in piombo e in pietra, concentrate nell’area antistante la chiesa e nell’edificio abba-
38a. Punta di freccia o dardo da allenamento in lega di rame.
38b. Punta di verrettone in ferro.
38c. Proietto in pietra per artiglieria da fuoco del peso di circa 2,5 Kg.
39. Scodella di maiolica arcaica pisana monocroma.
40. Boccale di maiolica arcaica pisana monocroma.
41. Scodella di maiolica di area fiorentina. Produzione di Montelupo Fiorentino.
42. Scodella di maiolica di area fiorentina. Italo-moresca.
43. Boccale di maiolica di area fiorentina. Decorazione a foglie di brionia.
44. Boccale di maiolica di area fiorentina. Decorazione a reticolo puntinato con stemma centrale. Produzione di Montelupo Fiorentino di inizio XVI secolo a testimonianza della frequentazione del sito da parte dei militari fiorentini dopo la conquista definitiva della vicina Rocca della Verruca.
45. Lamina in bronzo con fori per applicazione su elementi di abbigliamento. Probabile insegna di pellegrinaggio.
46. D
iseg
no ri
cost
rutt
ivo
del m
onas
tero
dur
ante
l’as
sedi
o de
lle tr
uppe
fior
entin
e (P
erio
do V
).
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni Antonio Alberti
52 53
ziale stesso: sicuramente l’unica struttura ancora in piedi al momen-to dell’assedio e dunque uno dei bersagli più importanti da colpire per gli assediati.
tagLiaLegna e Carbonai: L’uso saLtuario deLLe rovine
Le tracce di frequentazione successive all’assedio fiorentino sono piuttosto labili, e si riferiscono quasi esclusivamente al deposito archeologico documentato dentro la chiesa, che rimane l’unico edi-ficio ancora in piedi almeno fino alla fine del ‘700 (un quattrino del 1778 di Leopoldo Lorena arciduca di Toscana, rinvenuto sotto i crol-li, rappresenta un terminus post quem per il suo abbandono). Ma-teriale ceramico relativo poi a questo periodo è stato raccolto anche sugli spessi crolli degli edifici, a testimonianza di un uso continuo nel tempo dell’intero complesso.
Indicativamente entro il XVIII secolo, prima del crollo dei peri-
47. Vista della porzione anteriore della navata della chiesa abbaziale. Sono evidenti quattro buche che avevano la funzione di basi sottostavate per carbonaie (Periodo VI).
metrali della chiesa, nel-l’abbazia di San Michele, oramai priva del tetto, è organizzata una attivi-tà legata probabilmen-te allo sfruttamento del bosco, con l’evidenza di tre buche interpretabili come carbonaie. In fase con questa attività sono da mettere in relazione i resti di una probabile capanna, costruita con cordolo di fondazione in pietre di riutilizzo e probabile alzato in materiale deperibile, che si trovava nell’area del presbiterio, al di sotto della cupola absidale probabilmente ancora in alzato; allo stesso periodo deve essere ri-condotto un riparo simile ricavato nell’angolo esterno compreso tra il perimetrale nord e il transetto della chiesa, un altro piccolo edi-ficio costruito con pietre di riutilizzo e murato a secco in appoggio alla porzione meridionale del muro di cinta del monastero, mentre un semplice riparo e ricavato nei crolli interni alla grande cisterna del chiostro.
Il quadro delineato grazie ai pochi resti documentati ci descrive quindi l’area del monastero oramai coperta dai crolli degli edifici del cenobio e con la sola chiesa ancora in piedi anche se in ampie porzioni già collassata. Negli spazi liberi dall’ingombro delle mura-ture crollate sono state costruite capanne o ripari d’emergenza per coloro che vivevano delle attività del bosco, boscaioli, taglialegna, carbonai, pastori, che per breve tempo si stanziarono a San Michele che rimaneva, ancora nell’800, punto di riferimento non solo per i locali ma anche per i viaggiatori e gli appassionati che in più occa-sioni hanno rappresentato i ruderi del monastero, insieme a quelli della vicina Rocca, nei loro dipinti, disegni e racconti.
48. Particolare di una delle buche per carbonaia ancora riempita di carbone.
49. Pentola invetriata da fuoco.
50. Ciotola o catino ingobbiato e dipinto in verde e rosso.
51. Disegno ricostruttivo della fase di frequentazione sporadica del sito del monastero (Periodo VI).
Il Monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca. Una storia lunga mille anni Antonio Alberti
56 57
san MiCheLe oggi
Nell’ultimo secolo, rapinatori in cerca di materiale edilizio e inco-scienti ‘cercatori d’oro’ hanno infierito sulle spoglie di questo mo-numento, per fortuna scalfendolo solo in superficie. L’archeologia lo ha recuperato nella sua dimensione storica e materiale, raccon-tandone le vicende e esplicitandole attraverso le spoglie che il tem-po aveva conservato al di sotto degli imponenti crolli. Oggi tutta l’area del San Michele è però più debole e vulnerabile. Rischia cioè di subire un ulteriore e definitivo degrado se le comunità locali, ma anche gli Istituti di Tutela, non sapranno essere sensibili nel conser-varla e preservarla.
Rischia però anche di essere nuovamente ferita da nuovi ‘cercato-ri d’oro’, ai quali sapremo rispondere solo se una coscienza condivi-sa di un bene comune saprà farsi largo tra la gente.
bibLiografia essenziaLe di riferiMento
ALBERTI A., GELICHI S. 1998, Archeologia di un monastero medievale: San Michele alla Verruca. Resoconto della campagne di scavo 1996-1998, “Archeologia Medievale”, XXV, pp. 117-126.
FRANCOVICH R., GELICHI S. 2003, Monasteri e castelli fra X e XII secolo. Il caso di San Michele alla verruca e le altre ricerche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale, Firenze.
GELICHI S. (a cura di) 2000, Il monastero di San Michele alla Verruca sui Monti Pisa-ni. Resoconto delle ricerche 1996-1999, in Brogiolo GP. (a cura di), II Congresso di Ar-cheologia Medievale (Brescia 28 settembre – 1 ottobre 2000), Firenze, pp. 336-356.
GELICHI S., ALBERTI A., SBARRA F. 2002, Nuovi dati sullo scavo del monastero di S. Michele alla Verruca, in Le Missioni Archeologiche dell’Università Cà Foscari di Venezia, Venezia, pp. 86-95.
GELICHI S., ALBERTI A. 2002, Monasteries in Medieval Tuscany: the example of Monte Pisano area, in Medieval Europe, Basel 2002, 3, pp. 293-298.
NOFERINI G. 1995, La fortezza e l’abbazia di Verruca, Pisa.
KURZE W. 1989, Monasteri e nobiltà nel senese e nella Toscana Medievale. Studi diplo-matici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali, Siena.
ONORI A.M. 1984, L’Abbazia di San Salvatore di Sesto e il lago di Bientina, Firenze.
Mostra “L’aratro e il calamo” (Antonella Malloggi) 7
Introduzione (Sauro Gelichi) 9
Il luogo e il progetto 13
Lo scavo e la storia 13
La cappella di San Michele 17
Il primo monastero benedettino 18
Il grande monastero benedettino 24
Il monastero cistercense 33
Le supellettili dei monaci 41
L’occupazione militare del monastero: le truppe pisane e fiorentine 46
Taglialegna e carbonai: l’uso saltuario delle rovine 52
San Michele oggi 56
Bibliografia 57
Sommario