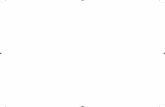M. E. CORTESE, Il monastero e la nobiltà. Rapporti con l’aristocrazia laica, formazione del...
Transcript of M. E. CORTESE, Il monastero e la nobiltà. Rapporti con l’aristocrazia laica, formazione del...
BIBLIOTECA
STORICA
TOSCANA
LIX
OLSCHKI
2009
PA
SS
IGN
AN
OIN
VA
LD
IP
ES
A–
I
ISSN 0391-819X
ISBN 978 88 222 5902 8
BIBLIOTECA STORICA TOSCANA
A CURA DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA
LIX
PASSIGNANOIN VAL DI PESA
UN MONASTEROE LA SUA STORIA
IUna signoria sulle anime, sugli uomini, sulle comunita
(dalle origini al sec. XIV)
a cura di
PAOLO PIRILLO
Tutti i diritti riservati
CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI
Viuzzo del Pozzetto, 850126 Firenze
www.olschki.it
Volume pubblicato col contributo di
Il volume contiene i risultati di indagini storico-documentarie finanziatedal Comune di Tavarnelle Val di Pesa per gli anni 2007-2008
ISBN 978 88 222 5902 8
MARIA ELENA CORTESE
IL MONASTERO E LA NOBILTA.
RAPPORTI CON L’ARISTOCRAZIA LAICA,
FORMAZIONE DEL PATRIMONIO ABBAZIALE
E TRADIZIONE DOCUMENTARIA (SECC. X-XII)*
Tutti i filoni superstiti di scritture documentarie per il periodo anteriore alXII secolo ci sono stati tramandati da enti ecclesiastici. Di conseguenza, comee ben noto, l’unica possibilita che abbiamo per ricostruire almeno alcuni trattidella societa laica attiva in un determinato ambito geografico risiede nel fattoche singoli individui o interi gruppi familiari abbiano stabilito qualche tipo direlazione con una chiesa, il cui archivio sia poi giunto fino ai nostri giorni.1 Ilfondo pergamenaceo dell’abbazia di S. Michele a Passignano, custodito pres-so l’Archivio di Stato di Firenze e completamente inedito, ci offre una di que-ste opportunita; e si tratta di un’opportunita eccezionale.2 In primo luogo per
* Nelle note al testo saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni: Bullettone = Archivio di Statodi Firenze, Manoscritti 48 bis (raccolta trecentesca di regesti delle carte del perduto archivio episco-pale fiorentino); Canonica = Le carte della canonica della cattedrale di Firenze (723-1149), a cura diR. Piattoli (Regesta Chartarum Italiae, 23), Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1938;Carta Rationes = carta allegata a Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Tuscia, 2 voll., acura di M. Giusti e P. Guidi (Studi e Testi, 58), Modena, Foto-Lito Dini, 1976; Coltibuono = Regestodi Coltibuono, a cura di L. Pagliai (Regesta Chartarum Italiae, 4), Roma, Istituto Storico Italiano peril Medio Evo, 1909; Diplomatico = Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico; Montescalari = Le cartedel monastero vallombrosano di S. Cassiano a Montescalari, a cura di G. Camerani Marri, «ArchivioStorico Italiano», CXX (1962), pp. 47-75, 185-221, 379-418, 480-520, CXXI (1963), pp. 76-121;Passignano = Diplomatico, Passignano; Placiti = I Placiti del Regnum Italiae, a cura di C. Manaresi,3 voll., Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1955-1960; REPETTI = E. REPETTI, Diziona-rio geografico fisico storico della Toscana, 5 voll. e Appendice, Firenze, Repetti, 1833-1846, ristampaanast. Firenze, Sansoni, 1972; S. Felicita = Le carte del monastero di S. Felicita di Firenze, a cura diL. Mosiici («Fonti di Storia toscana», 1), Firenze, Olschki, 1969; S. Miniato = Le carte del monasterodi S. Miniato al Monte (secoli IX-XII), a cura di L. Mosiici («Documenti di Storia italiana», s. II, IV),Firenze, Olschki, 1990.
1 Su questi aspetti si veda: P. CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia delle fontiscritte, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, cap. 1.
2 Per alcuni dati quantitativi ed un rapido quadro delle principali caratteristiche del fondo pas-
— 155 —
l’enorme ricchezza dell’archivio monastico, che ha conservato circa un terzodi tutta la documentazione disponibile per il territorio fiorentino nel periodoqui preso in considerazione (oltre duemila carte fino all’anno 1200). In secon-do luogo perche i documenti coprono un ambito territoriale piuttosto ampio:infatti, se e vero che per la maggior parte si riferiscono all’area piu vicina alcenobio (grosso modo i pivieri di S. Pietro a Sillano e S. Stefano a Campoli),consistenti gruppi di documenti illuminano anche zone piu periferiche, entrouna larga fascia orizzontale che si estende dal segmento centrale della Valdelsafino al tratto del Valdarno tra Incisa e San Giovanni.
Ma ancora una terza caratteristica del fondo passignanese si rivela estre-mamente favorevole alle nostre ricerche, ovverosia il notevole disordine chelo contraddistinse; poiche e grazie al fatto che gli archivisti dell’abbazia nonfurono particolarmente zelanti se si sono conservate numerose minute e dop-pioni e soprattutto non sono stati eliminati, una volta divenuti inutili, centi-naia di documenti che attestavano il possesso di beni e diritti, provenientida archivi di famiglie laiche e confluiti come monimina al momento dell’alie-nazione al monastero di parti del loro patrimonio. Sono appunto questi attiche hanno restituito una notevole mole d’informazioni, sulle quali e stato pos-sibile impostare lo studio prosopografico di un nutrito gruppo di stirpi appar-tenenti all’aristocrazia intermedia attive nella porzione meridionale del comi-tatus fiorentino a partire dalla fine del X secolo.3
E su questo segmento dell’elite laica ruotante intorno al monastero checoncentrero la mia attenzione, perche proprio riguardo alla fitta schiera dicompagini signorili di media e piccola levatura la documentazione ha fornitola messe di dati piu ricca, mentre i rapporti tra l’alta aristocrazia regionale ed ilcenobio, ubicato in un’area piuttosto marginale rispetto ai principali nuclei dipotere delle casate maggiori, furono nel complesso limitati; 4 con la sola par-
signanese si puo fare riferimento a W. KURZE, Il monastero di Passignano: il materiale archivistico – Leorigini – Il collegamento con Giovanni Gualberto, in Passignano e i Vallombrosani nel Chianti, Attidella giornata di studio (Badia a Passignano 3 ottobre 1998), a cura di I. Moretti, «Il Chianti. Storia,arte, cultura, territorio», 23, 2004, pp. 11-28.
3 Quanto di seguito esposto fa parte di una ricerca piu ampia sulle signorie rurali e l’evoluzionedelle compagini aristocratiche nel comitatus fiorentino tra la fine del X e la meta XII secolo, alla qua-le mi permetto di rimandare per un inquadramento piu generale dei temi qui trattati: M.E. CORTESE,Signori, castelli, citta. L’aristocrazia del territorio fiorentino tra X e XII secolo, Firenze, Olschki, 2007.
4 Nel 1019 il marchese di Tuscia Raineri e sua moglie Gualdrada donarono al monastero unasors nel piviere di S. Pancrazio a Lucardo: Passignano, 10 gennaio 1019. I conti Aldobrandeschi ave-vano alcune proprieta in Val di Pesa in localita Pisignaulo (nel piviere di Sillano: ivi, agosto 989), nelcastello di Fabbrica (nel piviere di Campoli cfr. REPETTI, II, p. 79: Passignano, novembre 1059 e Bul-lettone, c. 72), nel castello di Callebona e nella corte di Matraio, nel piviere di Sillano, che prima del1113 avevano ceduto agli Alberti (Passignano, 1113; per l’esatta ubicazione di queste due localita cfr.
MARIA ELENA CORTESE
— 156 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
ziale eccezione dei conti Alberti, che nel corso dell’XI secolo espansero la loroinfluenza in Val di Pesa e di conseguenza entrarono in contatto con le com-pagini aristocratiche piu legate a Passignano ed in qualche occasione diretta-mente con il monastero stesso.5
Nelle centinaia di carte dell’archivio passignanese vediamo muoversi unamoltitudine di persone nelle vesti di donatori al cenobio, venditori e compra-tori, concessionari di livelli, confinanti, testimoni. La maggior parte di esse,naturalmente, non apparteneva al livello piu eminente della societa, bensıera costituita da piccoli e medi proprietari o semplici lavoratori della terra,che andavano a formare un tessuto sociale complessivo piuttosto articolato.6
In mezzo a questa folla e pero possibile riconoscere la presenza di numerosefigure di rango aristocratico, vale a dire personaggi appartenenti all’elite mili-tare che controllava i castelli del nostro territorio. Molte di queste presenzeconsistono spesso soltanto in nomi non collegabili gli uni agli altri, o che s’in-contrano una sola volta, il che rende difficile ricostruire con certezza sequenzegenealogiche e vincoli parentali. Il tutto e poi ulteriormente complicato dallatendenza ad un notevole frazionamento dei patrimoni aristocratici ed allacompresenza, all’interno dei medesimi castelli, di titolari diversi e di piu nucleiparentali che si spartivano il dominio sui centri fortificati in quote anche pic-colissime. Tuttavia, all’interno di questa galassia aristocratica si stagliano alcu-ne famiglie a cui il monastero fu legato con continuita e che, grazie a questolegame, ci hanno tramandato una memoria meno sfuocata e frammentaria del-la loro struttura familiare, dell’assetto ed evoluzione del loro patrimonio, del-l’ambito in cui si svolse la loro azione politica.
infra, nota 45); prima del 1070 Ildebrando V entro in contenzioso con il monastero a proposito dellevessazioni e prelievi arbitrari imposti ad alcuni villaggi dipendenti dall’abbazia: ivi, 3 novembre 1070.Per quanto riguarda i Cadolingi, sappiamo che nel 1096 i conti Ugo e Raineri figli di Uguccione re-futarono al monastero una quota di una sorte nel luogo Valle (piviere di Sillano) che in precedenza ilsuddetto conte Uguccione ed i suoi fideles avevano conteso al cenobio: ivi, 20 maggio 1096.
5 Agli anni ’40 dell’XI secolo risalgono le prime attestazioni di possedimenti della casata nellevicinanze del castello di Ripa, in Val di Pesa, nel piviere di S. Pancrazio a Lucignano, al confine conS. Giovanni in Sugana (REPETTI, IV, p. 764). Sempre in Val di Pesa, ma piu a sud, nell’area limitrofaal monastero, proprieta degli Alberti saranno documentate a partire dalla seconda meta dell’XI se-colo nel castello di Callebona e nella contigua curtis di Matraio; sulla presenza degli Alberti in Val diPesa e Valdelsa cfr. piu ampiamente M.E. CORTESE, Assetti insediativi ed equilibri di potere: Semifon-te nel contesto delle fondazioni signorili in Toscana, in Semifonte in Valdelsa e i centri di nuova fon-dazione dell’Italia medievale, Atti del convegno nazionale organizzato dal Comune di Barberino Vald’Elsa (Barberino Val d’Elsa 12-13 ottobre 2002), a cura di P. Pirillo, Firenze, Olschki, 2004,pp. 197-211, alle pp. 204-207.
6 Si vedano a questo proposito le fondamentali pagine di E. CONTI, La formazione della strut-tura agraria moderna nel contado fiorentino. I, Le campagne nell’eta precomunale, Roma, Istituto Sto-rico Italiano per il Medio Evo, 1965, pp. 149-192, 246-261.
— 157 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
In teoria avrebbe potuto essere questo il caso della famiglia che promos-se la nascita del cenobio; invece dei fondatori di Passignano sappiamo po-chissimo e nell’archivio monastico non si e neppure conservato l’atto di fon-dazione, del quale ci sono giunte solo le citazioni inserite da Fedele Soldaninella sua storia del monastero, tratte dalla trascrizione fatta da un eruditocinquecentesco.7 Secondo la ricostruzione di Wilhelm Kurze, che ha analiz-zato questi passi giuntici per tradizione indiretta, appare molto plausibileche uno dei fondatori sia stato il poco noto vescovo di Fiesole Zenobio, at-tivo nel penultimo decennio del IX secolo, il quale avrebbe affiancato ilproprio fratello Sichelmo nell’istituzione dell’abbazia, appoggiandolo conil prestigio che derivava dal suo ufficio ecclesiastico. I due fratelli, figli diun Benedetto, fondarono il cenobio probabilmente nell’anno 890, donandoin tale occasione due servi, alcuni beni ubicati in Val di Pesa nelle localita diPassignano, Sillano, Martignano e Rovenzano, ed i non meglio identificabilioratori di S. Lorenzo in Montagnano (nel piviere di S. Pietro) e di S. Minia-to (nel piviere di S. Lazzaro). In seguito questi personaggi non sono rintrac-ciabili nella documentazione conservata nell’archivio passignanese, peraltroscarsa per quasi tutto il primo secolo di vita dell’abbazia: solo 12 atti fino al980 (cui si aggiungono altre 24 carte tra 980 e 990 ed altrettante nell’ultimodecennio prima del Mille).8
A questo proposito Kurze, istituendo un parallelo con il caso della BadiaBerardenga, faceva notare che per la prima fase di vita delle abbazie privateistituite in anticipo rispetto al periodo del grande sviluppo delle fondazionifamiliari in Toscana (tra gli ultimi decenni del X e gli anni 30/40 dell’XIsec.) si e conservato pochissimo materiale, in quanto «l’economia di questeistituzioni si fondava quasi solo sullo sfruttamento dei beni regalati con l’attodi fondazione».9 A differenza che per la famiglia fondatrice della Badia Berar-denga, pero, i cui discendenti riemergono con forza nella documentazione po-steriore al Mille,10 non e da escludere che la linea di sangue dei fondatori diPassignano si sia estinta e si rivelano comunque privi di basi solide, percheimpostati solo su parziali corrispondenze onomastiche, i tentativi di ricollegar-li con stirpi meglio conosciute, gravitanti intorno al monastero nel periodosuccessivo. Ad esempio, con lo Zenobio fondatore dell’abbazia potrebbe es-
7 KURZE, Il monastero di Passignano, pp. 13-19.8 Per la consistenza della documentazione si veda ivi, tabella a p. 25.9 Ivi, pp. 18-19.10 P. CAMMAROSANO, La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della societa senese nei
secoli XI-XIII, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo, 1974.
MARIA ELENA CORTESE
— 158 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
sere messo in relazione quello Zenobio comes, citato come defunto in alcunidocumenti passignanesi degli ultimi decenni del X secolo, il cui figlio Guinil-do tra il 982 ed il 990 era attivo in Firenze e nell’area piu vicina a Passignano,ma anche ai margini opposti del comitatus, e che in altra sede ho ipotizzatoessere il capostipite dei Guineldi/Figuineldi, famiglia in seguito legata a Pas-signano.11 L’ipotesi e certamente plausibile, ma purtroppo non suffragabilecon prove certe. Del resto, se vogliamo proseguire in questo gioco di fragilicongetture, si puo notare che il nome Zenobio compare anche nella genealo-gia degli Attingi, altra famiglia che come vedremo ebbe strette relazioni con ilmonastero nel corso dell’XI secolo e fu al contempo molto legata ai suddettiFiguineldi; ed allo stesso modo dobbiamo osservare che il nome Sichelmo ap-pare caratteristico delle piu antiche generazioni dei da Montebuoni, stirpe im-piantata proprio in Val di Pesa a partire dalla fine del X secolo, che alienoparte del suo patrimonio al nostro cenobio.
Uscire da questa incertezza appare al momento impossibile e per spostarcisu un terreno piu sicuro dobbiamo dunque arrivare agli ultimi decenni del Xsecolo, momento a partire dal quale il numero delle carte confluite nell’archi-vio claustrale si fa consistente a sufficienza da permetterci di riconoscere concertezza alcuni ‘punti forti’ nella societa che gravitava intorno a Passignano,alcune famiglie eminenti che spiccano in forza del portato documentario dimemoria che le relazioni da esse stabilite con l’abbazia implicarono.
La prima compagine aristocratica ad entrare in contatto diretto con il mo-nastero ed a stabilire con esso legami duraturi fu quella dei signori del castellodi Vicchio (in seguito detto Vicchio de’ Longobardi o Vicchiomaggio), che e ilpiu antico centro fortificato attestato nel territorio fiorentino.12 Il castello fuquasi certamente fondato nella prima meta del secolo X dalla famiglia stessa,radicata principalmente nel piviere di S. Pietro a Sillano ed in quello contiguodi S. Stefano a Campoli, i cui esponenti risiedevano sia nel suddetto castelloche nella curtis di Campoli (anch’essa per breve tempo incastellata tra la finedel X e gli inizi dell’XI secolo) ed a partire dalla seconda meta dell’XI secolosaranno spesso indicati nelle fonti come de Vicclo.13
11 CORTESE, Signori, castelli, citta, pp. 306-307. I documenti riguardanti questi personaggi sono:Passignano, 30 aprile 982; ivi, giugno 986; ivi, agosto 990; ivi, settembre 1009.
12 Ivi, settembre 957. Si tratta di Vicchio, ubicato in Val di Greve, nella diocesi di Fiesole (RE-
PETTI, V, p. 752) da non confondersi con il vicino Vicchio dell’Abate, anch’esso in Val di Greve, main diocesi di Firenze.
13 Documenti relativi ai piu antichi possessi della famiglia: Passignano, agosto 991; ivi, 30 ago-sto 994; ivi, novembre 999; ivi, 2 giugno 993; ivi, sec. X; ivi, giugno 1012. Per maggiori dettagli sullaprosopografia familiare si veda CORTESE, Signori, castelli, citta, pp. 370-375.
— 159 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
I legami con l’abbazia di Passignano, e di conseguenza le attestazioni do-cumentarie degli esponenti di questa famiglia nel fondo monastico, non ap-paiono correlate con il trasferimento di rilevanti quote del loro patrimonioal cenobio: le alienazioni, infatti, tutto sommato non furono molte, risultanodi entita piuttosto modesta 14 e soprattutto non riguardarono il castello di fa-miglia, che piuttosto passo in parte sotto il controllo del monastero di Monte-scalari a partire dagli inizi del XII secolo.15 Le frequenti apparizioni dei daVicchio nella documentazione, invece, paiono connesse principalmente conil notevole prestigio di cui questi personaggi godevano nell’area piu vicinaal castello di famiglia ed anche al di fuori di essa: infatti compaiono spessoin posizione di rilievo come testimoni di atti di una certa importanza riguar-danti sia il nostro monastero,16 che altri enti ecclesiastici (Abbadia a Isola),17
che stirpi aristocratiche del loro stesso livello (quali i da Callebona, i da Mon-tebuoni e i da Cintoia);18 senza contare il fatto che almeno uno dei membridella famiglia presenzio ad un placito marchionale in Firenze nel 1061.19
Dopo il 1140, pero, essi praticamente sembrano scomparire dalle carte diPassignano, se si eccettua l’intervento a fine secolo – ancora una volta indicedi autorevolezza – di Ubaldino de Vickio come arbitro in una lite in corso tra ilmonastero e Bernardo da Montecorboli.20 Probabilmente questa eclissi docu-mentaria fu dovuta semplicemente all’interruzione dei rapporti col nostro mo-nastero – per motivi che ignoriamo – e non alla mancanza di continuita dina-stica. A quanto sembra, infatti, i da Vicchio continuarono a mantenere ilcontrollo sul castello eponimo, probabilmente in condominio con l’abbaziadi Montescalari, nella cui documentazione una linea familiare, con ogni pro-babilita derivata dai piu antichi signori del luogo, riemergera nel corso delDuecento.21
14 Passignano, febbraio 1045; ivi, agosto 1088; ivi, novembre 1101; ivi, marzo 1102; ivi, feb-braio 1139.
15 Montescalari, 140, 8 novembre 1100; Diplomatico, S. Vigilio di Siena, luglio 1105.16 Passignano, dicembre 1033 (tre pergamene); ivi, agosto 1062.17 P. CAMMAROSANO, Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell’eta romanica. Con una edizione
dei documenti (953-1215), Castelfiorentino, Societa storica della Valdelsa, 1993, n. 46, 24 settem-bre 1109-24 marzo 1110; ivi, n. 49, 1 settembre 1123.
18 Passignano, dicembre 1072; ivi, 11 aprile 1093; ivi, luglio 1101; ivi, luglio 1105; ivi, 18 di-cembre 1119; Diplomatico, Bonifazio, 1114; Diplomatico, Ripoli, 105...
19 Placiti, 413, 1 dicembre 1061: Ugo di Guinildo.20 Passignano, 29 novembre 1193.21 Paiono discendere dai da Vicchio i signori di Vicchio de’ Lambardi documentati nel corso
del ’200 nelle carte di Montescalari, e sicuramente inurbatisi, anch’essi caratterizzati dall’alternarsidei nomi Ubaldino/Guinildo: cfr. ad es. Diplomatico, S. Marco, 7 marzo 1256; Diplomatico, S. Vigiliodi Siena, 20 settembre 1284; ivi, 8 dicembre 1284.
MARIA ELENA CORTESE
— 160 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
Di tipo molto diverso si presenta invece la vicenda patrimoniale di un’altrafamiglia entrata precocemente in rapporto con Passignano, quella che desi-gneremo convenzionalmente come Ghisolfi, riprendendo il nome piu caratte-ristico dello stock familiare.22 Questo gruppo parentale, documentato a parti-re dal penultimo decennio del X secolo e certamente inserito nella clienteladei conti Cadolingi, era dotato di consistenti possedimenti in un’area compre-sa tra la Val di Pesa e la Valdelsa e risiedeva principalmente nel castello diMontepaldi in Val di Pesa,23 nella corte di Luiano, ubicata nel versante vol-terrano della Valdelsa,24 e nella localita di Montespertoli, che i Ghisolfi stessiincastellarono negli ultimi decenni del secolo XI.25 I Ghisolfi, inoltre, avevanoalcuni possedimenti anche nella zona piu vicina a Passignano, che in parte do-narono al monastero: in questo modo anche una serie di carte dell’archiviofamiliare passo nell’archivio monastico.26 Inoltre un secondo canale di relazio-ni con la nostra abbazia fu costituito dal fatto che i Ghisolfi ebbero frequenticontatti con i signori del castello di Callebona, che come vedremo in seguitoerano i maggiori proprietari nell’area piu vicina al cenobio stesso. Le due fa-miglie, infatti, avevano nuclei fondiari contigui nel piviere di Sillano27 ed era-no imparentate per via femminile (Raineri/Pagano di Ghisolfo aveva sposatoGhisla di Teuderico dei da Callebona, tramite la quale alcuni nuclei fondiaridella famiglia d’origine passarono nel patrimonio dei Ghisolfi).
Ma nel loro caso il fattore decisivo per i destini di una fetta cospicua delpatrimonio familiare fu di natura prettamente dinastica: infatti, l’unico figliosuperstite dei suddetti Raineri e Ghisla, Ildebrandino, non sembra aver avu-to una discendenza, cosicche buona parte dei suoi beni furono incameratiproprio dal monastero di Passignano. Egli stesso nel 1098 investı l’abate del-la sua intera quota della corte, castello e chiesa di Montepaldi e delle corti diBignola, Montespertoli e Luiano. Con un altro atto rogato nella stessa data,
22 Per maggiori informazioni su questa stirpe e i suoi nuclei di possesso fondiario, si veda COR-
TESE, Signori, castelli, citta, pp. 321-324.23 Montepaldi, nel piviere di S. Giovanni in Sugana (REPETTI, III, p. 455).24 Luiano, nel piviere di S. Maria a Chianni (ivi, sub voce S. Maria a Chianni).25 Montespertoli (tra la Val di Pesa e la Valdelsa, attualmente capoluogo di comune: ivi, III,
p. 532): Passignano, aprile 1000; ivi, marzo 1057; ivi, giugno 1083; ivi, luglio 1093.26 Ivi, agosto 981; ivi, aprile 1000; ivi, 14 agosto 1037; ivi, febbraio 1056; ivi, giugno 1083; ivi,
4 luglio 1097.27 Si vedano, ad esempio, alcune transazioni tramite le quali esponenti dei Ghisolfi cedettero ai
signori di Callebona case e terre ubicate nel piviere di Sillano, nella curtis di Matraio, ed alcune quotedel poggio un tempo fortificato di Castelvecchio, anch’esso ubicato nella corte di Matraio: ivi, 11marzo 1057; ivi, 27 ottobre 1075 (due atti). Per la localizzazione di questo castellare: CONTI, La for-mazione, pp. 87 e 110.
— 161 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
inoltre, insieme alla madre Ghisla dono pro anima la meta della quota che ladonna possedeva nella corte di Matraio e la propria parte della medesimacorte.28 Che Ildebrandino non avesse avuto figli sembra dimostrato anchedal fatto che parte del patrimonio avito passo a suo nipote, nato da unasua sorella. Infatti nel 1101 Teuderico di Gualando, personaggio di spiccoin area valdarnese, dono per la salvezza dell’anima della propria nonna Ghi-sla di Teuderico, del marito di lei Raineri/Pagano e delle loro figlie, la cortedi Luiano con la chiesa di S. Cristoforo, due quote della corte di Montepaldieccettuato il castello, i mansi di Lignano e Matraio e la corte di Trivili con lachiesa di S. Miniato a Fonterutoli (anche questa proveniente dal patrimoniodei da Callebona), specificando che tutti questi beni erano stati a lui donatidalla stessa Ghisla.29 Il definitivo passaggio di queste proprieta sotto il con-trollo dell’abbazia e confermato da documenti successivi, con i quali sia al-cuni personaggi inseriti nella clientela dei Ghisolfi, sia uno degli ultimi espo-nenti a me noti del gruppo familiare, rinunciarono ai loro diritti sull’ereditadi Ildebrandino di Ghisolfo.30
Tratti ancora diversi presenta la storia delle relazioni tra Passignano e lastirpe dei da Montebuoni, gruppo familiare documentato a partire dall’ultimodecennio del X secolo, che nell’XI e XII fu la piu cospicua compagine signo-rile del piviere di Impruneta, dove si trovava il castello eponimo e dove il ra-mo principale della famiglia rimase stabilmente radicato fino al terzo decenniodel 1100, quando si inurbo probabilmente in seguito alla distruzione di questocentro fortificato ad opera dei Fiorentini.31 L’area di origine della stirpe sem-bra pero essere stata la Val di Pesa, dove essa controllava un nucleo di beninel piviere di Campoli, che comprendeva il castello di Montemacerata, la con-tigua curtis di Paterno, probabilmente il vicino castello di Fabbrica, oltre adaltri beni sparsi.
Di qui gli stretti contatti con la nostra abbazia, alla quale questi aristocraticiscelsero di alienare una larga fetta del patrimonio familiare in Val di Pesa, con-testualmente avvicinandosi ai centri di potere urbani – in particolare l’episco-pio – e spostando la loro area di gravitazione verso Firenze e l’area immedia-
28 Passignano, agosto 1098 (due pergamene). Su Montepaldi, Montespertoli, Luiano, Matraio:cfr. le note precedenti. Bignola: in Val di Pesa, nel piviere di S. Pancrazio a Lucignano (REPETTI, I,p. 327).
29 Passignano, 20 maggio 1101. Trivili e quasi certamente da identificare con Tregole (cfr. CartaRationes), vicino a Fonterutoli, al confine tra le diocesi di Fiesole e Siena nel piviere di S. Leolino inConio. Lignano era una localita del piviere di Sillano (CONTI, La formazione, p. 118).
30 Passignano, gennaio 1103; ivi, novembre 1107.31 In dettaglio cfr. CORTESE, Signori, castelli, citta, pp. 334-340.
MARIA ELENA CORTESE
— 162 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
tamente a sud lungo la Val di Greve. Nel 1015, infatti, il capostipite Sichelmodi Giovanni dono pro anima al nostro monastero la sua quota della corte e ca-stello di S. Maria sito Macerata, della curtis donicata di Paterno e di beni a Tiz-zana, Cerreto e S. Cristina 32 e nel 1022 suo fratello Azzo dono a sua voltaquanto possedeva a Paterno.33 I figli di Sichelmo, inoltre, (Raineri detto Paga-no/Paganello, Sichelmo e Giovanni) tra il 1023 ed il 1043 appaiono impegnatiin alcune complicate transazioni con Passignano, riguardanti una casa e sorteposta nel piviere di Sillano in localita Camugnano (vendite ed acquisti, dietro iquali probabilmente si celavano prestiti su pegno fondiario), che si concluserocon una permuta in base alla quale i beni di Camugnano passarono definitiva-mente al cenobio. Gli atti in questione sono degni di nota in quanto documen-tano proprio lo spostamento dell’ambito d’attivita della famiglia dalla zona diCampoli/Sillano all’area in cui sorgeva il castello di Montebuoni, che sara daora in poi il nucleo centrale dei possedimenti per un ramo della nostra stirpee sua residenza prediletta.34 Appare dunque plausibile pensare che alcune dellealienazioni effettuate in precedenza fossero solo in apparenza delle donazionied avessero avuto, almeno in parte, anche lo scopo di procurare i mezzi finan-ziari necessari per sostenere l’ampliamento della base fondiaria suburbana ed ilsalto di qualita della famiglia verso lo status di vassalli vescovili.35
A questo punto, pero, i destini dei tre rami familiari derivati dai figli diSichelmo di Giovanni sembrano divergere: dei figli del primo (che si chiamavaSichelmo come suo padre) sappiamo soltanto che probabilmente rimasero ra-dicati in Val di Pesa, in quanto nel 1058 ottennero a livello dall’abate di Pas-signano i beni un tempo donati da loro nonno e da suo fratello Azzo nelle lo-calita di Montemacerata e Paterno.36 Lo stesso dicasi dei figli di Giovanni(Raineri/Pagano e Giovanni/Pagano): il primo, quasi certamente privo di di-scendenza, pur essendo presente piu volte in citta37 mantenne possedimenti
32 Passignano, maggio 1015. S. Maria a Montemacerata, nel piviere di Campoli (REPETTI, III,p. 7); Paterno, vicino a Montemacerata (CONTI, La formazione, pp. 46-47, n. 147); Tizzano, in Vald’Ema vicino a Rubbiana (REPETTI, IV, pp. 839-40); Cerreto, situato 4 km a nord di Paterno (CONTI,La formazione, pp. 46-47, n. 147); S. Cristina a Montefiridolfi, poco distante da Montemacerata (RE-
PETTI, III, p. 391).33 Passignano, gennaio 1021: un quinto di due case e sorti.34 Ivi, 17 febbraio 1022, rogato a Pozzolatico (localita vicinissima a Montebuoni); ivi, ottobre
1041, rogato «in loco Monteboni»; ivi, novembre 1041; ivi, 3 febbraio 1042, rogato nel castello diMontebuoni. Su Montebuoni: REPETTI, III, pp. 327-328. Per Camugnano: CONTI, La formazione,pp. 59, 122.
35 Si veda infra.36 Passignano, dicembre 1058.37 Ivi, 16 marzo 1055; ivi, 17 agosto 1059.
— 163 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
nell’area di Campoli-Sillano, in parte donati al monastero dalla sua vedova nel1082;38 l’attivita del secondo e dei suoi 5 figli e documentatissima tra il 1043ed il 1096 ed appare quasi esclusivamente concentrata intorno ad alcune lo-calita dei pivieri di Sillano e S. Cresci, dove essi effettuarono numerosi acquistidi piccoli appezzamenti e presero terre a livello da altri proprietari e dal mo-nastero di Passignano.39 Di questo ramo, le cui proprieta appaiono estrema-mente frazionate gia prima della fine del secolo XI, si perdono in seguito letracce.
La linea familiare della quale si puo continuare a seguire la genealogia einvece quella derivante da Raineri/Pagano figlio di Sichelmo, che piu delle al-tre si allontano dall’area di provenienza: gia lo stesso Raineri, infatti, sicura-mente si inserı nell’entourage dei vescovi fiorentini nei primi decenni dell’XIsecolo;40 inoltre, allargo i suoi possedimenti nell’area di Montebuoni,41 purmantenendo dei contatti con la zona d’originario radicamento della famiglia.42
Con le generazioni seguenti i possedimenti in quest’area vennero – forse de-finitivamente – liquidati in favore del nostro monastero,43 mentre al contemporisaltano con sempre maggiore evidenza gli stretti legami instaurati con l’epi-scopio fiorentino e la proiezione degli esponenti di questa compagine familia-re verso la citta, dove essi diedero origine alla ben nota stirpe fiorentina deiBuondelmonti.44
Anche se le loro relazioni dirette con il monastero risultano piu tarde ri-spetto a quelle stabilite dai gruppi aristocratici fin qui descritti, tra le famigliela cui fisionomia possiamo ricostruire attraverso le carte provenienti dall’ar-chivio di Passignano spiccano in assoluto, grazie alla quantita di documenta-zione conservatasi, due stirpi radicate almeno dagli ultimi decenni del X seco-lo nel castello di Callebona e nella contigua curtis di Matraio, gia parzialmente
38 Ivi, giugno 1082.39 Su Giovanni ed i suoi figli: ivi, aprile 1043; ivi, gennaio 1043; ivi, 6 febbraio 1046; ivi, giugno
1049; ivi, 8 febbraio 1053; ivi, marzo 1058; ivi, 2 marzo 1065; ivi, 29 giugno 1067; ivi, 30 aprile 1068;ivi, giugno 1070; ivi, 21 maggio 1073; ivi, 2 novembre 1075; ivi, dicembre 1080; ivi, giugno 1083; ivi,ottobre 1084; ivi, maggio 1085; ivi, marzo 1095.
40 Presenzia a due atti vescovili del 1009 e 1026 (S. Miniato, 4 e 8) entrambi redatti a Firenze.41 Canonica, 47, 1 luglio 1042: acquisto una casa e sorte a Bagnolo, localita nel piviere di Im-
pruneta, vicinissima a questo castello (REPETTI, I, p. 248).42 Passignano, agosto 1036: compare nel castello di Fabbrica, per primo dopo i giudici, nell’e-
lenco dei boni homines testimoni ad una refuta al monastero di Passignano fatta da membri di unafamiglia che in parte controllava tale castello. Fabbrica: supra, nota 4.
43 Passignano, 13 aprile 1059; ivi, 7 giugno 1100; ivi, ottobre 1118, ivi, 18 dicembre 1119; ivi,maggio 1122.
44 Sui rapporti tra i da Montebuoni e l’episcopio fiorentino si veda CORTESE, Signori, castelli,citta, pp. 219-222.
MARIA ELENA CORTESE
— 164 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
studiate da Elio Conti per l’area campione di Poggialvento e da lui designateconvenzionalmente come «signori del castello I» e «signori del castello II».45
Non e possibile stabilire se le due famiglie discendessero da un ceppo comu-ne, poiche le carte in nostro possesso non consentono di ricostruire eventualilegami genealogici. Tuttavia esse appaiono strettamente connesse, non soloper quanto riguarda i rapporti intrattenuti con il monastero, ma soprattuttoper via della distribuzione dei loro possessi nei medesimi luoghi, del condo-minio sugli stessi castelli, delle numerosissime transazioni di terre tra loro in-tercorse e della costante reciproca presenza alla stipulazione dei medesimi atti;al punto che talvolta i nessi di tipo patrimoniale tra le due schiatte appaionoaddirittura piu stretti delle relazioni individuabili tra le diverse linee di sanguedella stessa famiglia.
Alcuni esponenti di entrambi i gruppi parentali vengono talvolta indicatinelle fonti con il toponimico de Calebona ed in effetti il complesso di proprie-ta ubicato intorno al suddetto castello e nel territorio dipendente era proba-bilmente il piu compatto – ed e comunque il piu conosciuto, in quanto mag-giormente rischiarato dalla documentazione della vicina abbazia, che ne entroprogressivamente in possesso.46 Va tuttavia sottolineato che le due famiglie,viste nel loro insieme, presentano un assetto patrimoniale piuttosto ampio,cioe articolato non su uno-due castelli ma su un complesso di tipo ‘zonale’:infatti controllarono diverse curtes, castra e chiese distribuiti tra la Val di Pesae la Valdelsa, che probabilmente costituivano centri di possesso fondiario e di
45 CONTI, La formazione, pp. 153-154, 247-248. Per maggiori dettagli sulla prosopografia diqueste famiglie, si rimanda a CORTESE, Signori, castelli, citta, pp. 274-293. Il castello di Callebona,oggi del tutto scomparso, e forse identificabile con i ruderi presenti presso l’attuale podere «Campoa Sole», ubicato a breve distanza da Poggialvento; il nucleo centrale della curtis di Matraio si trovavanelle immediate vicinanze del suddetto castello, piu o meno in corrispondenza dell’attuale podere«San Brizzi», che ricorda nel nome l’intitolazione dell’antica chiesa curtense: CONTI, La formazione,pp. 87-88.
46 Ad esempio i documenti riguardanti la prima generazione del gruppo familiare disceso da uncapostipite di nome Guido (filii Guidi) sono quasi tutti redatti a Callebona e mostrano che i suoi figliebbero casa e corte in questo centro (definito «curte et castello meo de Callebona» da Tedaldo diGuido gia nel 1009), terre intorno al castello, mansi e sortes in varie localita comprese nel territorioda esso dipendente: Passignano, 984; ivi, febbraio 1009; ivi, gennaio 1009; ivi, 12 giugno 1010. An-che i due figli di Tedaldo, Raineri e Guglielmo, avevano come base principale Callebona (definito«curte et castello nostro in loco Callebona» nel 1031); sono poi ulteriormente documentati loro pos-sedimenti nei pressi del castello, in localita che facevano parte della sua curtis e di quella contigua diMatraio, o anche in altri luoghi compresi nel piviere di Sillano: ivi, febbraio 1024; ivi, maggio 1031;ivi, 29 settembre 1044; ivi, maggio 1058; ivi, 2 marzo 1065; ivi, 23 marzo 1068; ivi, giugno 1072.Anche i primi esponenti noti del gruppo familiare disceso da un Ildebrando di Teuderico (filii Ilde-brandi) ebbero casa e corte nel castello di Callebona e furono in possesso almeno in parte della cortedi Matraio con la chiesa di S. Brizio: ivi, maggio 995; ivi, marzo 1013; ivi, aprile 1014; ivi, 20 gennaio1042; ivi, 13 ottobre 1049; ivi, febbraio 1056.
12— 165 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
potere altrettanto rilevanti (in particolare le corti e castelli di Voltigiano, Ripae Fabbrica), pur se meno illuminati dalle fonti superstiti.
Per quanto riguarda i filii Guidi (che per maggiore chiarezza indichero diseguito come ‘da Callebona I’), di particolare interesse e un atto del 1056con il quale Guglielmo figlio di Tedaldo di Guido vendette al proprio fratelloRaineri l’intera quota di tutte le terre, beni, castelli e chiese in suo possesso. Latransazione, infatti, ci offre per la prima volta un quadro complessivo dell’inse-diamento fondiario di questi aristocratici a tale altezza cronologica, che com-prendeva il castello e corte di Voltigiano con la cappella di S. Cristoforo, il ca-stello e corte di Ripa Vultunaria con la cappella di S. Pietro, la corte di Bignolacon la cappella di S. Maria, il castello e corte di Fabbrica, beni in localita Vallaricon la cappella di S. Margherita, beni in localita Paterno ed in localita S. Go-denzo con la chiesa di S. Godenzo, il castello e corte di Coniolo, il castello ecorte di Fundagnano, la corte di Matraio con la chiesa di S. Brizio, la corte ecastello di Callebona con la chiesa di S. Andrea.47 Si trattava di un patrimonionotevole che, a parte un nucleo di proprieta piuttosto eccentrico (S. Genesio),risulta distribuito lungo la Val di Pesa, in una striscia allungata da nord a sudche, come specifica lo stesso documento, interessava i territori plebani di S. Pie-tro a Sillano, S. Pietro in Bossolo, S. Stefano a Campoli, S. Pietro in Mercato,S. Pancrazio a Lucignano, S. Giovanni in Sugana, S. Cecilia a Decimo.
Sara in effetti questo l’ambito territoriale entro il quale anche in seguito edocumentata l’attivita della famiglia, che dopo la meta dell’XI secolo apparesuddivisa in tre rami. I discendenti del suddetto Guglielmo, nel cui patrimo-nio dopo il 1056 non appaiono piu proprieta di rilievo ma solo possedimentimolto frammentati, fino al terzo decennio del XII secolo si mossero tra Ma-traio, Callebona, Fabbrica e Voltigiano, incontrando pero sempre maggioridifficolta economiche e progressivamente alienando i loro beni.48 Ranieri diTedaldo ed i suoi figli, che in seguito alla transazione del 1056 riunirono
47 Ivi, 2 dicembre 1056. Voltigiano: in Valdelsa, nel piviere di S. Pietro in Mercato (REPETTI, V,p. 836); Ripa Vultunaria: da identificarsi con Ripa in Val di Pesa, cfr. supra, nota 5); Bignola: in Val diPesa, nel piviere di S. Pancrazio a Lucignano (ivi, I, p. 327); Fabbrica: supra, nota 4; Vallari: quasicertamente da identificarsi con Vico Vallari, piu tardi Borgo S. Genesio, presso S. Miniato in provin-cia di Pisa; Paterno: supra, nota 32; S. Godenzo, quasi certamente S. Godenzo a Coniolo, in seguitodetto a Campoli, in Val di Pesa (REPETTI, I, pp. 431 e 793); Coniolo, in Val di Pesa, castello scom-parso ubicato presso la suddetta chiesa di S. Godenzo a Coniolo (ivi, I, p. 793); Fundagnano: castelloscomparso, nel piviere di S. Pancrazio in Val di Pesa (ivi, II, p. 363).
48 I tre figli di Guglielmo furono autori di alcune piccole donazioni al monastero di terre nelpiviere di Campoli, poi riottenute a livello (Passignano, gennaio 1059; ivi, ottobre 1060; ivi, agosto1062; ivi, gennaio 1067; ivi, febbraio 1122) e di alcune vendite, soprattutto ai membri del loro ramofamiliare o ad Ildebrando di Tegrimo, il personaggio di maggior spicco del gruppo familiare dei daCallebona II: ivi, 1 agosto 1067; ivi, 20 gennaio 1067; ivi, 30 aprile 1068; ivi, 2 novembre 1075; ivi,18 aprile 1076; ivi, aprile 1085; ivi, aprile 1112.
MARIA ELENA CORTESE
— 166 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
una buona fetta dei possedimenti familiari, risiedevano rispettivamente nei ca-stelli di Fabbrica49 e Callebona50 ed ebbero proprieta anche nelle corti diMucciana e Bignola,51 che nel complesso rimasero sotto il loro controllo finoalla fine dell’XI secolo, mentre solo in seguito presero il via importanti aliena-zioni in favore del monastero. Gli esponenti del ramo disceso da Ildebrandodi Guido, infine, oltre a porzioni del castello e corte di Callebona e della cortedi Matraio,52 controllarono anche quote della corte di Bignola e dei castelli diVoltigiano (dove essi risiedevano di preferenza)53 e Bagnolo (probabilmenteuna fondazione di questo stesso ramo familiare).54 Anch’essi gia a partire daglianni ’60 del secolo XI cominciarono ad alienare terreni e quote di mansi,55
nonche porzioni dei loro castelli di Callebona e Voltigiano, cedendole princi-palmente ai loro condomini, cioe al gruppo familiare dei filii Ildebrandi (‘daCallebona II’).56
Anche questi ultimi presentano una fisionomia tipicamente ‘zonale’: infat-ti, gia con la prima e seconda generazione di uno dei due rami discesi dal ca-postipite Ildebrando di Teuderico, quello di suo figlio Tegrimo, appare chiaroche l’assise patrimoniale andava ben oltre il nucleo costituito dal castello diCallebona e dalla curtis di Matraio,57 in quanto comprendeva mansi e sortinei pivieri di Campoli, S. Giusto in Salcio e S. Leonino in Conio (qui si tro-vava una loro curtis presso Fonterutoli),58 S. Pancrazio a Lucignano, S. Gio-
49 Ivi, 1053; ivi, novembre 1059; ivi, 3 febbraio 1064; ivi, giugno 1065; ivi, 23 marzo 1068.50 I tre figli di Raineri di Tedaldo (Benno, Rolando ed Alberto) risiedevano di preferenza nel
castello di Callebona mentre, a differenza del padre, sono piu raramente presenti in quello di Fab-brica. Atti redatti a Callebona: ivi, 29 aprile 1074; ivi, 26 ottobre 1074; ivi, 2 novembre 1075; ivi, 18aprile 1076; ivi, aprile 1085; ivi, marzo 1086. Atti redatti nel castello di Fabbrica: ivi, aprile 1085; ivi,settembre 1098.
51 Ivi, 3 febbraio 1064; ivi, 19 novembre 1064. Mucciana: a poca distanza da S. Casciano Val diPesa (REPETTI, III, p. 625).
52 Callebona: Passignano, 27 aprile 1054; ivi, 8 maggio 1054; ivi, 26 maggio 1054; ivi, 30 marzo1055; ivi, 20 febbraio 1054; ivi, 22 dicembre 1059. Corti di Callebona e Matraio e piviere di Sillano:ivi, 2 giugno 1022; ivi, luglio 1055; ivi, 23 febbraio 1041.
53 Ivi, 2 giugno 1022; ivi, 23 febbraio 1041; ivi, 30 marzo 1055; ivi, 12 marzo 1056; ivi, 22 di-cembre 1059.
54 Ivi, 20 febbraio 1054; ivi, 8 maggio 1054; ivi, 5 febbraio 1066. Bagnolo in Valdelsa, non lon-tano da Voltigiano, nei pressi dell’attuale Castelfiorentino (cfr. Carta Rationes).
55 Passignano, 8 maggio 1054; ivi, 26 maggio 1054; ivi, 30 marzo 1055; ivi, luglio 1055; ivi, 12marzo 1056; ivi, dicembre 1061; ivi, febbraio 1063; ivi, 22 agosto 1066; ivi, 9 ottobre 1069; ivi, 27gennaio 1073; ivi, 18 ottobre 1073; ivi, 26 ottobre 1074; ivi, dicembre 1087; ivi, marzo 1089; ivi,gennaio 1091; ivi, 31 gennaio 1092; ivi, maggio 1093.
56 Ivi, 5 febbraio 1066; ivi, 17 ottobre 1068 (2 pergamene); ivi, 21 maggio 1073.57 Riguardo ai quali supra, nota 46.58 Passignano, settembre 1009; Coltibuono, 7 ottobre 1003. Per l’ubicazione di Trivili cfr. supra,
nota 29.
— 167 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
vanni in Sugana, S. Cecilia a Decimo59 e soprattutto una parte del castello diRipa60 e del castello di Voltigiano, che era certamente uno dei centri piu im-portanti sotto il controllo di questo ramo familiare: infatti Ildebrando di Te-grimo – che in una carta del 1075 viene esplicitamente definito de Vultegiano –ed i suoi figli vi risiedevano regolarmente.61 Le transazioni patrimoniali effet-tuate dagli esponenti di questa linea, inoltre, paiono corrispondere ad un pre-ciso disegno di allargamento e compattamento dei propri possedimenti fon-diari all’interno del castello di Callebona e nel suo territorio dipendente,nella contigua curtis di Matraio e nel castello di Voltigiano;62 operazione lungae difficoltosa – visto il complesso intreccio delle proprieta in quest’area tra fa-miglie aristocratiche ed altri liberi allodieri63 – e che di fatto non approdo aduna presa di possesso completa. Il patrimonio di questo ramo, comunque, siaccrebbe a compatto almeno fino ai primi anni del XII secolo, mentre solo daquel momento presero il via importanti alienazioni in favore del monastero diPassignano.
La struttura disseminata del patrimonio fondiario di questi aristocratici ri-sulta ancor piu evidente nella documentazione concernente i discendenti diTeuderico di Ildebrando. Infatti questi ultimi, pur insediati anch’essi nel ca-stello di Callebona,64 non risiedevano stabilmente nell’area piu vicina a Passi-gnano e risultano attivi anche in zone piu lontane, muovendosi da un puntoall’altro di possedimenti decentrati rispetto al nucleo principale. Molto signi-
59 Passignano, 12 marzo 1056; ivi, 8 dicembre 1076; ivi, dicembre 1079.60 Ivi, aprile 1042, tre pergamene, si tratta di un patto di difesa riguardante il suddetto castello,
per la cui ubicazione cfr. supra, nota 5.61 Passignano, 30 marzo 1055; ivi, 12 marzo 1056; ivi, 22 dicembre 1059; ivi, 5 maggio 1060;
ivi, 2 settembre 1062; ivi, 17 ottobre 1068; ivi, 27 ottobre 1075; ivi, dicembre 1086; ivi, 11 febbraio1088.
62 Ivi, marzo 1046; ivi, 2 settembre 1062; ivi, 1 marzo 1063; ivi, novembre 1064; ivi, 20 gennaio1067; ivi, 31 gennaio 1067; ivi, febbraio 1068; ivi, 2 febbraio 1072; ivi, 16 aprile 1076; ivi, ottobre1078; ivi, 29 aprile 1085; ivi, novembre 1086; ivi, novembre 1093. In particolare acquisirono variappezzamenti presso il castello di Callebona come pegni di prestiti concessi a Rodolfo di Ildebrandoed ai suoi figli, esponenti dei da Callebona I (ivi, 8 maggio 1054; ivi, 26 maggio 1054; ivi, 30 marzo1055; ivi, luglio 1055; ivi, 12 marzo 1056; ivi, 27 gennaio 1073; ivi, dicembre 1087; ivi, 31 gennaio1092; ivi, maggio 1093) ed anche appezzamenti con case e una torre dentro il castello sempre daRodolfo di Ildebrando e dai suoi figli: ivi, 5 febbraio 1066; ivi, 17 ottobre 1068; ivi, 21 maggio1073. Entro il territorio di Callebona-Matraio Ildebrando acquisto anche alcune quote del poggiodi Castelvecclo, gia castellare nel 1075, suddiviso in piccole porzioni in parte spettanti ai Ghisolfi:supra, nota 27.
63 Si veda CONTI, La formazione, pp. 149-174, 246-259.64 Cfr. ad es. Passignano, 26 giugno 1100 (patto di difesa reciproca del castello stipulato tra
Teuderico di Ildebrando e Enrico di Teuderico); ivi, 17 ottobre 1098: donazione di beni nella cortedi Matraio, escluso pero il poggio (qui definito per l’unica volta castello) e la chiesa di S. Brizio con lesue pertinenze.
MARIA ELENA CORTESE
— 168 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
ficativi a questo proposito sono due atti dei quali furono autori Ugo di Ilde-brando e la di lui moglie Imilda di Rodolfo: nel settembre del 1097 Ugo, vi-cino alla morte, trovandosi nel castello mugellano di Scopeto, cedette (sottoforma di donazione, ma dietro versamento di un launechild di 100 lire) al cau-sidicus Uberto di Benzo – che sara in seguito definito de Florentia – tutti i beniche possedeva nel contado fiorentino e fiesolano e che comprendevano le cor-ti e castelli di Montespertoli, Manzano, Monte Tedaldi e Scopeto. Circa diecigiorni dopo Imilda, ormai vedova di Ugo, che si trovava in Firenze sotto ilmundio del suddetto Uberto di Benzo, cedette a sua volta al fratello di que-st’ultimo, Ildebrando, dietro pagamento di un analogo launechild, tutti i benia lei pervenuti per morgincap dal marito nelle corti e castelli di Manzano,Montedaldi, Scopeto, Matroia, Bignola e Turre Rozi.65
Inoltre, anche se i possedimenti principali dei da Callebona II erano ubi-cati in un’area che, come sottolineava Conti, presenta tutto sommato debolilegami con Firenze,66 essi ebbero certamente contatti non trascurabili conl’ambiente cittadino. Esponenti di questo gruppo parentale, innanzitutto,nel corso del secolo XI furono talvolta presenti in citta per effettuare transa-zioni riguardanti i loro nuclei patrimoniali comitatini67 e per presenziare aiplaciti marchionali.68 Un ramo familiare, inoltre, fu certamente in relazionecon il monastero cittadino di S. Felicita ed ebbe terre ubicate nel suburbiodi Firenze, nella zona di S. Donato e Colombaia.69 Le relazioni tra i da Cal-lebona II e la citta sono poi ulteriormente testimoniate dai sopra citati attidel 1097, tramite i quali Ugo di Ildebrando e sua moglie furono coinvoltiin un complesso passaggio di proprieta insieme a due fratelli fiorentini, cheEnrico Faini ha ipotizzato essere i primi membri conosciuti della ben notastirpe cittadina degli Uberti.70
65 Passignano, 22 settembre 1097: entrambi gli atti sono stati scritti di seguito in un’unica per-gamena; il secondo e pero datato 1 ottobre ed e redatto presso il monastero di S. Miniato di Firenze.Montespertoli: supra, nota 25; Manzano: in Valdelsa nel piviere di S. Pietro a Mercato (REPETTI, III,p. 50); Monte Tedaldi: supra, nota 23; Scopeto: in Mugello, nel piviere di Scopeto/Viminiccio (RE-
PETTI, V, p. 232); Matroia: probabilmente da leggersi Matraio; Bignola: supra, nota 28; Turre Rozi:non identificabile. Ma si considerino anche i possessi di questo ramo nella corte di Trivili (ivi, 24marzo 1114; per la localizzazione supra, nota 29).
66 CONTI, La formazione, p. 170.67 Coltibuono, 7 ottobre 1003; Passignano, dicembre 1079; ivi, 22 settembre 1097.68 Teuderico di Ildebrando: Placiti, 413, 1 dicembre 1061; ivi, 424, 25 maggio 1070; S. Felicita,
11, 26 febbraio 1073 (in quest’ultima occasione e presente anche il suo congiunto Ildebrando di Teu-derico).
69 S. Felicita, 7... 1068; ivi, 8, 2 giugno 1068; ivi, 9, agosto 1070; ivi, 10, gennaio 1071; ivi, 20,1082.
70 Supra, nota 65; si vedano inoltre Passignano, 17 luglio 1098; ivi, 17 ottobre 1098. Sui da
— 169 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
Alla fine di questa rapida panoramica possiamo senza dubbio concludereche, se l’ambito entro il quale si mossero le due famiglie dei signori di Callebonaera per lo piu compreso nell’ampia zona di principale radicamento patrimonia-le, esse non solo intrecciarono parentele con altre famiglie della media e piccolaaristocrazia, con le quali condivisero il dominio su un’ulteriore serie di localita ecastelli, ma ebbero anche contatti con l’ambiente cittadino e collegamenti con ivertici del potere politico regionale: certamente con i marchesi di Tuscia ed an-che con una delle piu importanti famiglie comitali della Toscana, gli Alberti,nella cui clientela vassallatica le nostre stirpi appaiono certamente inserite.71
La dimensione ed articolazione dell’insediamento fondiario di questi ari-stocratici, le loro relazioni politiche a livello comitatino, le loro alleanze e vin-coli di parentela con altre compagini di eguale rango ci sono note, spesso neidettagli, grazie al fatto che essi conservarono nei propri archivi familiari qual-che centinaio di documenti a partire dal penultimo decennio prima del Mille.Questo fiume di carte per la stragrande maggioranza confluı nell’archivio delmonastero di Passignano solo a partire dagli ultimissimi anni dell’XI secolo,accompagnando, con funzione di monimina, gli atti di progressiva alienazionedei patrimoni familiari. Infatti si deve sottolineare che, se senza ombra di dub-bio queste compagini aristocratiche furono in contatto con il cenobio fin dallesue origini – per via della stretta contiguita geografica –, esse per oltre un se-colo, a differenza di altre considerate in precedenza, furono decisamente re-stie a trasferire all’abbazia nuclei fondiari cospicui, evitando in particolaredi cedere quote dei propri castelli. Infatti, tra le decine e decine di transazionieffettuate dagli esponenti di queste famiglie, compaiono solo una quindicinadi modeste donazioni pro anima di piccoli appezzamenti e frazioni di mansi, inparte riottenute a livello.72 Solo dal 1098, in coincidenza con momenti di crisidinastica ed incertezza per quanto riguardava la successione, ma sicuramenteanche di difficolta finanziarie, prese il via una serie di donazioni o vendite piucospicue, che avevano per oggetto soprattutto quote del castello eponimo edella sua corte.
Montespertoli e sui rapporti con gli Uberti, cfr. R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, 8 voll., Firenze,Sansoni, 1977-1978 (ed. orig. Berlin 1896-1927), I, pp. 822, 888 e E. FAINI, Il gruppo dirigente fio-rentino in eta protocomunale (fine XI-inizio XIII secolo), tesi di laurea in Istituzioni Medievali, Uni-versita degli studi di Firenze, anno accademico 1999-2000, pp. 52-53, 264.
71 Sulla presenza degli Alberti in Val di Pesa cfr. supra, nota 5; sui rapporti tra la casata comitaleed i signori di Callebona: CORTESE, Assetti insediativi.
72 Da Callebona I: Passignano, febbraio 1024; ivi, 1053; ivi, gennaio 1059; ivi, ottobre 1060; ivi,dicembre 1061; ivi, agosto 1062; ivi, 22 agosto 1066; ivi, gennaio 1067; ivi, 9 ottobre 1069; ivi, gen-naio 1091; ivi, settembre 1096; ivi, 1 agosto 1098. Da Callebona II: ivi, febbraio 1084; ivi, aprile1085; ivi, maggio 1085; ivi, marzo 1086.
MARIA ELENA CORTESE
— 170 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
Per quanto riguarda i da Callebona I, nel 1098 Alberto di Raineri (delquale non e nota una discendenza e che con tutta probabilita si trovava inpunto di morte) e la moglie Ghisla di Ugo donarono al monastero la loro por-zione del castello di Ripa e di tutti i beni che possedevano nelle corti di Ripa eBignola e nelle localita di Mucciana e Fezzana. Contestualmente il solo Alber-to, senza la partecipazione della moglie, dono la meta della sua parte della cor-te di Callebona e Matraio, con la sua intera quota della selva ubicata presso ilmonastero, escludendo pero il castello e la chiesa di Callebona, che con attocontemporaneo aveva ceduto a suo zio materno Sichelmo di Rodolfo.73 Laquota della corte di Callebona e Matraio spettante a Ghisla, moglie di Alber-to, passo comunque al monastero dopo la morte di lei.74 Nel 1100, inoltre, lavedova di un nipote di Alberto completo il trasferimento a Passignano di nu-clei patrimoniali situati in alcune delle suddette localita: infatti dono l’interaquota spettante al suo defunto marito del castello di Ripa, della corte di Bi-gnola e della corte di Mucciana.75 Dopodiche gli esponenti della famigliacompariranno solo sporadicamente nella documentazione passignanese, perpoi scomparire dal terzo decennio del secolo: la maggior parte dei beni spet-tanti a questa linea, infatti, erano ormai passati all’abbazia oppure erano statiin precedenza alienati ai da Callebona II, che a loro volta li cedettero al mo-nastero insieme alle quote provenienti dal patrimonio avito.
Infatti tra il 1098 ed il 1101, come abbiamo visto in precedenza, alcunequote della corte di Matraio e della corte di Trivili con la sua chiesa, che eranoconfluite nel patrimonio dei Ghisolfi tramite il matrimonio di Ghisla di Teu-derico, furono donate al cenobio 76 e nello stesso 1098 un’altra parte della cor-te di Matraio fu donata dalla vedova di un nipote di Ghisla,77 mentre il fra-tello di quest’ultima, Enrico, nel 1114 completo il trasferimento al monaste-ro (in parte oneroso) della corte di Trivili.78 Una cronologia analoga si riscon-tra per l’altro ramo familiare: nel 1103 Teuderico di Ildebrando, che fino aquel momento aveva avuto pochi rapporti con Passignano, promise all’abateUgo che da allora in avanti suo figlio Ildebrando non avrebbe avuto facolta diassegnare a sua moglie ne in alcun modo alienare la sua quota della corte ecastello di Callebona se non al monastero e, se fosse morto senza figli legittimi,
73 Ivi, settembre 1098 (due pergamene). Fezzana, in Val di Pesa nel piviere di S. Pancrazio (RE-
PETTI, II, p. 104). Per le altre localita cfr. le note precedenti.74 Passignano, giugno 1116.75 Ivi, marzo 1100.76 Supra, note 28-30.77 Passignano, 17 ottobre 1098.78 Ivi, 24 marzo 1114.
— 171 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
quest’ultima sarebbe passata in piena proprieta al cenobio.79 La promessaprobabilmente fu fatta in un momento di difficolta economiche (si noti il ver-samento di un meritum di 20 lire) e soprattutto di incertezza riguardo alla suc-cessione, forse a causa di una malattia di Teuderico e della mancanza di eredidi Ildebrando. Effettivamente Teuderico deve essere morto di lı a poco ed Il-debrando qualche anno dopo, ancora senza eredi, visto che i beni oggetto del-la promessa del 1103 passarono sicuramente nel patrimonio del monastero.80
In seguito, anche le frazioni residue del castello e corte di Callebona ancora inmano a questa linea familiare passarono nelle mani dell’abbazia grazie ad alie-nazioni di cui furono autrici Adalasia, sorella del defunto Ildebrando, e la dilui vedova.81
In questo modo gia entro i primi decenni del 1100 Passignano riuscı adincamerare la maggior parte dei beni e centri incastellati un tempo apparte-nenti a questa complessa compagine aristocratica nell’area piu vicina all’abba-zia, mentre degli altri nuclei di proprieta sparsi tra Valdelsa e Val di Pesa, chenon entrarono sotto il controllo di Passignano ma di altre schiatte signorili,non sappiamo piu niente. Sembra dunque che l’attrazione del monastero sisia fatta irresistibile al momento in cui, dietro la spinta demografica, la coesio-ne familiare si andava disgregando ed i patrimoni si polverizzavano, in seguitoalla suddivisione in rami che agivano sempre piu autonomamente, ed all’estin-zione di alcuni di essi. Ma niente affatto estranee a questi trasferimenti all’ab-bazia appaiono anche le evidenti difficolta economiche da cui erano afflitte lenostre stirpi a cavallo tra XI e XII secolo, ben testimoniate dal fatto che alcu-ne delle alienazioni sopra citate erano delle, piu o meno esplicite, vendite almonastero, con il cui erario queste schiatte si trovavano probabilmente inde-bitate. Ad analogo destino non sfuggirono neppure i rami che ebbero una cer-ta continuita dinastica, come dimostra bene l’esempio dei discendenti diUberto di Teuderico de Calebona, che fino alla fine del XII secolo rimaseroradicati in due castelli posti a breve distanza dal monastero, Poppiano e Sam-buco: le loro transazioni (solo vendite e concessioni su pegno al cenobio o apersonaggi ad esso collegati) indicano che una cronica scarsita di denaro atta-nagliava questi domini locali: buona parte del loro patrimonio passo quindinelle mani del monastero prima del 1200, dopodiche anch’essi spariscono dal-la nostra documentazione.82
79 Ivi, agosto 1103.80 Ivi, marzo 1110.81 Ivi, aprile 1111; ivi, giugno 1116; ivi, marzo 1123.82 Ivi, giugno 1123 (3 pergamene); ivi, marzo 1136; ivi, 25 settembre 1138; ivi, 7 dicembre
1138; ivi, 3 ottobre 1146; ivi, 10 ottobre 1152; ivi, 11 settembre 1166; ivi, 27 ottobre 1169; ivi,
MARIA ELENA CORTESE
— 172 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
Un andamento simile a quello riscontrato per i da Callebona configura latradizione documentaria relativa ad un altro importante gruppo aristocraticodel territorio fiorentino, gli Attingi, il cui archivio familiare e confluito in partein quello di Passignano a partire dalla meta dell’XI secolo, quando le proprie-ta e gli interessi del monastero cominciarono ad espandersi massicciamenteverso il Valdarno di Sopra ed in particolare l’area di Figline.83 Qui, infatti,si incentrava uno dei principali nuclei patrimoniali della famiglia, della qualesi ha notizia a partire dal primo decennio dopo il Mille, grazie a due documen-ti riguardanti Teuderico e Rodolfo, figli del capostipite Azzo, i quali, stando inFirenze, vendettero alcuni beni ubicati proprio a Figline.84 In modo ancor piuaccentuato rispetto ai da Callebona, pero, gli Attingi nella prima meta dell’XIsecolo non appaiono stabilmente impiantati in una sola localita, ma anzi con-stavano di un patrimonio vasto e disperso (almeno 13 curtes di cui 7 incastel-late), distribuito in varie aree del comitatus fiorentino: in Mugello, Val di Sie-ve, Val di Pesa e Valdarno, oltre che nella citta e nei suoi dintorni. Un quadrocomplessivo della consistenza del patrimonio familiare, infatti, ci e dato da undocumento del 1042 con il quale Gualdrada di Uberto, moglie di uno dei figlidel succitato Rodolfo, trovandosi nella sua casa nel castello di Cercina (poco anord di Firenze), cedette al proprio figlio Rodolfo tutti i beni che a lei eranovenuti dal suo precedente marito, dal proprio suocero e dall’attuale marito. Sitrattava di un notevole complesso di proprieta fondiarie, che comprendeva ca-se, terre ed una curtis in Firenze, le corti non fortificate di Sesto, Marine, Fab-brica, Monteloro, Montefanni, e le corti incastellate di Petriolo, Cercina, Cer-reto, Mozanello, Casole, Figline, Riofino.85
29 ottobre 1179; ivi, 9 aprile 1182; ivi, 29 novembre 1190: Poppiano, nel piviere di Campoli: REPET-
TI, IV, p. 577; Sambuca, nel piviere di S. Pietro in Bossolo: ivi, V, p. 13.83 Sulla famiglia si vedano C. WICKHAM, Dispute ecclesiastiche e comunita laiche. Il caso di Fi-
gline Valdarno (XII secolo), Firenze, Comune di Figline Valdarno-Opus Libri, 1998 e CORTESE, Si-gnori, castelli, citta, pp. 266-273. Sulla presenza di Passignano nell’area di Figline, oltre al saggiodi Wickham, si vedano M. RONZANI, L’organizzazione della cura d’anime e la nascita della pieve diFigline, in Lontano dalle citta. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII, Atti del convegno (Montevar-chi-Figline Valdarno 9-11 novembre 2001), a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Roma, Viella, 2005,pp. 213-277 e F. SALVESTRINI, Influenza monastica vallombrosana nel territorio di Figline. Antagoni-smi, scontri e mediazioni durante il secolo XII, in Storie di una pieve del Valdarno. San Romolo a Ga-ville in eta medievale, a cura di P. Pirillo e M. Ronzani, Roma, Viella, 2008, pp. 29-54.
84 Passignano, novembre 1008; ivi, marzo 1008.85 Ivi, 24 aprile 1042. Le localita citate sono Sesto nel Valdarno a nord ovest di Firenze, nel-
l’omonimo piviere (REPETTI, V, p. 282); Marine, probabilmente una localita nel piviere di S. Donatoin Val di Marina/Calenzano (ivi, I, p. 39); Fabbrica, in Val di Pesa (supra, nota 4); Monteloro ad estdi Firenze, nell’omonimo piviere (REPETTI, III, pp. 410-411); Montefanni, identificabile con MonteFanna, toponimo che attualmente designa un’altura prossima a Monteloro; Petriolo, tra la Val di Pe-sa e la Val di Greve, nel piviere di Decimo (ivi, IV, pp. 149-150); Cercina, a nord di Firenze, nel-
— 173 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
Possiamo poi ricordare che esponenti degli Attingi, oltre a comparire inalmeno un’occasione nell’entourage marchionale,86 furono presenti regolar-mente in citta per stipulare contratti che riguardavano i loro beni comitati-ni,87 ed ebbero importanti legami con la Canonica88 ed il vescovo fiorentino(al quale cedettero a varie riprese, tra il 1047 ed il 1074, uno dei loro castellipiu importanti: Cercina),89 imparentandosi con altre famiglie aristocraticheche facevano parte della cerchia vescovile (Suavizi, Figuineldi). Questo grup-po familiare, tuttavia, intorno agli anni ’70 del secolo sembra in parte aver giaperso il suo impianto multizonale ed il possesso di alcuni castelli, in seguitoad una serie di cospicue donazioni ad enti religiosi: la Canonica e l’episcopiocittadino, come abbiamo gia accennato, ma anche il monastero di Passigna-no. Quest’ultimo fu beneficiato in primo luogo dal ramo disceso da Rodolfodi Azzo, che quasi certamente si estinse prima della fine dell’XI secolo. Al1043 risale la prima consistente donazione: Zenobio detto Saracino figliodi Rodolfo, trovandosi in Firenze, dono per la salvezza della sua anima l’in-tera corte di Riofino con il castello, la chiesa e tutte le terre dominicali ed ibeni da essa dipendenti; riservo pero l’usufrutto vitalizio per se e per uneventuale suo figlio maschio, mentre in caso di mancanza di eredi i beni inquestione sarebbero passati in piena proprieta al monastero.90 Egli pero qua-si certamente non ebbe figli poiche nel 1052, stando nel castello di Cercina,confermo la cessione della corte di Riofino al monastero, questa volta senzapiu clausole di riserva relative a suoi eventuali eredi.91 Egli risulta morto po-chi anni dopo, nel 1056, quando la sua vedova si era gia risposata con unesponente dei Suavizi: in tale anno la donna dono al monastero tutte le terredella corte di Riofino, oltre ad altre proprieta ubicate nella stessa zona, che alei erano pervenute da Zenobio.92
l’omonimo piviere (ivi, I, pp. 655-656); Cerreto, che Repetti identifica con Cerreto in Val di Sieve,circa mezzo miglio a nord ovest di Barberino di Mugello (ivi, I, p. 659); Mozanello, in Val di Sieve, inpassato nel piviere di S. Gavino Adimari, circa tre miglia a nord ovest di Barberino (ivi, III, p. 624);Casole, probabilmente Casole in Val di Sieve, nel piviere di S. Cassiano in Padule (ivi, I, p. 521);Riofino, non piu localizzabile, nel settore valdarnese del piviere di Cavriglia (ivi, IV, p. 763).
86 Rodolfo di Bulgaro: Placiti, 430, 27 febbraio 1073.87 Oltre ai due atti citati nella nota 84, cfr. Passignano, 3 ottobre 1043; ivi, 16 marzo 1055; ivi,
22 ottobre 1099; Canonica, 52, 28 marzo 1050; ivi, 61, 20 settembre 1058.88 Canonica, 52, 28 marzo 1050; ivi, 61, 20 settembre 1058; ivi, 112, aprile 1084; ivi, 159, 28
aprile 1113.89 Bullettone, cc. 316 (anni 1047 e 1074), 311 (1072).90 Passignano, 3 ottobre 1043.91 Ivi, 12 ottobre 1052.92 Ivi, 16 marzo 1055.
MARIA ELENA CORTESE
— 174 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
Il ramo disceso da Teuderico di Azzo, invece, ebbe continuita: risulta inseguito stabilmente basato sull’area di Figline e la zona subito a sud (mentrela presenza nel castello di Cercina, in Firenze e nei suoi dintorni non e atte-stata oltre la fine dell’XI secolo)93 e continuo a mantenere strette relazionicon il monastero di Passignano, tanto piu che con buona sicurezza va ricono-sciuto come esponente degli Attingi quell’Ubaldo «inter seculares valde nobi-lis», celebre (gloriosus) nel castello di Figline ed in molti altri, che nella VitaS. Iohannis Gualberti di Andrea da Strumi – in un episodio attribuibile aglianni ’60 dell’XI secolo – viene citato come amico personale del santo e com-patronus del monastero di Passignano.94 Donazioni al monastero – ed all’o-spedale che da esso dipendeva, fondato (forse proprio dagli Attingi) nelle vi-cinanze di Figline, presso il torrente Cesto – cominciarono negli anni ’70dell’XI secolo per iniziativa di Rolando di Teuderico e dei suoi figli.95 In par-ticolare Azzo di Rolando nel 1080 dono tutto cio che possedeva «infra virtutede le Fighine», la meta della sua quota della curtis di Firenze (eccettuando pe-ro la casa di abitazione) e la meta dei beni ubicati in vari luoghi dei pivieri diGaville, Incisa e S. Reparata di Firenze; inoltre suo fratello Ubertino, nel 1110dono la sua quota di Castel d’Azzi (ubicato nell’area di Figline) ed i suoi beninei pivieri di Gaville, Schergnano e S. Reparata.96
Con le generazioni successive le donazioni al monastero continuaro-no,97 in parte rivelando alcune difficolta economiche di questi aristocratici:ad esempio nel 1099 Ubaldo di Ugo dava in pegno ad un prestanome diPassignano la meta del castello e della corte «qui vocatur Acecalfolle ubiRufino dicitur» in cambio di un prestito di 20 lire, che egli evidentementenon fu in grado di restituire, visto che la pergamena e rimasta nell’archiviopassignanese.98 Gli Attingi si muovevano ora su un raggio d’azione che,tranne poche eccezioni, appare circoscritto al tratto di Valdarno compresotra Figline ed il castello di Pianalberti, molto probabilmente da loro fonda-to e dove paiono risiedere di preferenza nella seconda meta del XII seco-lo.99 Tuttavia essi rimanevano di gran lunga la famiglia locale piu importan-
93 Ivi, 24 febbraio 1070; ivi, marzo 1079; ivi, 22 ottobre 1099.94 Su questo episodio e per l’identificazione con uno degli Attingi: CH. WICKHAM, Figline: no-
bili, milites e masnadieri, in Lontano dalle citta, pp. 379-394: 379-380.95 Passignano, 24 febbraio 1070; ivi, 25 marzo 1077; ivi, 30 settembre 1084.96 Ivi, 1 marzo 1109.97 Ivi, dicembre 1089.98 Ivi, 22 ottobre 1099: si tratta evidentemente di Riofino, piu volte documentato come posse-
dimento familiare.99 Prima attestazione del castello nel 1131: ivi, 1131.
— 175 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
te, con legami politici di primo piano (in primo luogo con i conti Guidi): inparticolare tra il 1120 ed il 1185 e documentata l’attivita di Rolandino diUbaldo de Figine, che fu certamente una delle figure centrali della vita po-litica del Valdarno nel XII secolo.100 Quest’ultimo, in linea con la politicadei suoi antenati, fece diverse donazioni a Passignano, tra le quali nel 1160la sua parte dei diritti di patronato sulle chiese di S. Maria e di S. Lorenzodi Figline e di S. Tommaso a Castelvecchio.101 Inoltre i suoi figli, insiemead alcuni esponenti dei Figuineldi ed alcuni membri di famiglie aristocra-tiche mugellane (signori di Combiate, Latera, Guinizzingo, Rezzano) com-paiono come patroni dell’abbazia in un singolare documento redatto intor-no al 1169. In tale occasione essi vendettero per 100 lire all’abate Ugo unaserie di chiese e xenodochi, ubicati sia nell’area di Figline che nell’alta Valdi Sieve, con tutte le prerogative signorili relative e tutti i diritti di patro-nato, eccettuati quelli sul monastero medesimo, che si impegnavano pero anon vendere ne alienare.102
Certamente l’atto si pone in traiettoria con la documentazione piu risalen-te, che mostra un forte allineamento politico tra la famiglia figlinese ed il mo-nastero, il che secondo Chris Wickham spiega di per se la generosita verso ilcenobio e la facilita con cui si espanse l’influenza monastica nella zona nel se-colo precedente il 1170.103 Tuttavia proprio questo documento, come e statodi recente sottolineato, indica anche una stretta dipendenza economica dellacasata (e delle altre ivi citate) dal monastero e pare celare una probabile formadi indebitamento; alcuni elementi interni, infatti, indicano che esso va proba-bilmente letto come un risarcimento tramite cessione di pegni immobiliari, inprecedenza alienati ai monaci in cambio dell’anticipo di somme di denaro.104
Confortano questa lettura altri riscontri documentari, che mostrano un inde-bitamento di questa schiatta nei confronti dell’erario abbaziale a partire giadalla fine dell’XI secolo.105 In ogni caso, rimane molto difficile capire il reale
100 CORTESE, Signori, castelli, citta, pp. 271-272.101 Passignano, 11 febbraio 1159. Altre donazioni di Rolandino: ivi, 1131; ivi, 18 settembre
1138; ivi, maggio 1145; ivi, 8 gennaio 1153; ivi, 26 aprile 1163; ivi, dicembre 1182; ivi, 17 aprile1185.
102 Ivi, 1170, carta mancante di data, assegnata al 1170 in base all’ordinamento interno dell’ar-chivio del monastero; a partire dal 1169, tuttavia, era abate Lamberto e l’indicazione dell’abate Ugofa sı che la carta sia databile tra il 1165 ed il 1169. I beni ceduti comprendevano lo xenodochio diRufine (cioe Riofino) nella curia di Pianalberti; lo xenodochio di Combiate (in Mugello); una chiesa ecappella posta nel distretto di Combiate; la canonica e chiesa di S. Maria di Vigesimo (in Mugello); lacanonica e chiesa di S. Bartolomeo di Figline.
103 WICKHAM, Dispute, pp. 18-19.104 SALVESTRINI, Influenza monastica, p. 36.105 Oltre alla cessione in pegno effettuata da Ubaldo di Ugo nel 1099 (supra, nota 98) si vedano
MARIA ELENA CORTESE
— 176 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
significato del ruolo di patronato di queste famiglie nei confronti del nostromonastero e valutare la reale influenza che esse potevano esercitare sul ceno-bio, poiche i patroni di Passignano raramente compaiono in seguito nei docu-menti e perche ormai la ricchezza e la potenza dell’abbazia erano di gran lun-ga superiori a quelle di queste compagini aristocratiche, gia molto indebolitedal punto di vista del possesso fondiario. In effetti, una volta travasati nel pa-trimonio claustrale gran parte degli antichi averi dislocati nella zona di Figline(e con essi i documenti relativi) anche gli ultimi discendenti degli Attingiscompaiono dalle carte passignanesi.
Una vicenda simile e stato possibile ricostruire per i Figuineldi, la cui area diinfluenza nel XII secolo appare limitata alla zona di Figline, ma che in prece-denza dovevano avere un impianto molto piu articolato (anche se forse su scalaminore che per gli Attingi).106 Infatti facevano parte dell’entourage marchiona-le,107 intrattenevano importanti relazioni con i vescovi di Firenze e contavanoanche su un nucleo patrimoniale ubicato nella zona a nord della citta: il gia ci-tato castello di Cercina, che i Figuineldi controllavano in condominio con gliAttingi e che anch’essi cedettero all’episcopio nel 1072.108 Le due stirpi, in ef-fetti, appaiono costantemente associate nella documentazione e, anche se non edimostrabile che discendessero da un unico ceppo, ebbero comunque legamistrettissimi, soprattutto per quanto riguarda la signoria su Cercina e nella zonadi Figline, dove essi controllavano dagli ultimi decenni dell’XI secolo il ‘‘ca-strum qui dicitur Guinildi’’.109
Gli esponenti di questo gruppo familiare cominciarono con certezza a faredonazioni al monastero di Passignano a partire dagli anni ’70 dell’XI secolo econtinuarono fino alla meta del XII,110 momento a partire dal quale la loroattivita appare sempre piu limitata alla zona di Figline. Infatti, dopo una seriedi contenziosi con i presuli riguardanti i castelli di Vico (in Val di Sieve) e
alcune altre cessioni in pegno effettuate da Ubaldo, da sua moglie e dai suoi figli (in particolare il bennoto Rolandino): ivi, 10 novembre 1124; ivi, 18 settembre 1140; ivi, 4 novembre 1155.
106 Sulla famiglia si vedano WICKHAM, Dispute e CORTESE, Signori, castelli, citta, pp. 306-307.107 Sichelmo di Guido: Placiti, 424, 25 maggio 1070; Bernardo di Albertino da Cercina: Die
Urkunden und Briefe der Markgrafin Mathilde aus Tuszien, a cura di E. Goez, W. Goez («Monumen-ta Germaniae Historica, Diplomata: Laienfursten-und Dynasten-Urkunden der Kaiserzeit», II),Hannover, Hahn, 1998, 91, 7 ottobre 1105.
108 Sui rapporti tra i Figuineldi e l’episcopio fiorentino: CORTESE, Signori, castelli, citta, pp. 224-225.
109 Passignano, 27 maggio 1085.110 Ivi, 24 febbraio 1070; ivi, aprile 1079; ivi, agosto 1114; ivi, 30 dicembre 1148. Inoltre prima
del 1153 essi avevano ceduto al monastero la chiesa di S. Pietro a Castel Guineldi (WICKHAM, Dispu-te, p. 13 e nota 21).
— 177 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
Montebuiano (in Mugello) – che probabilmente erano delle fortificazioni ve-scovili in precedenza date in concessione alla famiglia per via dei suoi legamiclientelari con la cattedra fiorentina – non si hanno piu tracce di relazioni congli enti ecclesiastici cittadini e la famiglia assume un profilo decisamente piulocale, avvicinandosi piuttosto ai conti Guidi ed alla sede episcopale fiesolana.
Agli anni ’60 del 1100 risalgono anche le ultime relazioni dirette dei Figui-neldi con Passignano: sono documentate alcune donazioni e refute in favoredel cenobio111 e soprattutto va notata la partecipazione di Teuderico e Gui-nildo figli di Raineri, al fianco degli Attingi e di altri aristocratici mugellani,tutti designati come patroni dell’abbazia, alla gia citata vendita al cenobio diuna serie di chiese e xenodochi, ubicati sia nell’area di Figline che nell’altaVal di Sieve.112 Di lı a pochi decenni, pero, i Figuineldi scompariranno deltutto dalla documentazione di Passignano e dai primi anni del Duecento sene perderanno le tracce.
Le vicende patrimoniali dei piu importanti gruppi parentali rintracciabilinelle pergamene di Passignano durante il periodo piu antico di vita dell’abba-zia illuminano in modo particolarmente chiaro e dettagliato uno degli aspettifondamentali dei rapporti tra le famiglie aristocratiche ed i monasteri, sia diloro diretta fondazione che non: l’ampliamento del patrimonio di questi entiin modo direttamente proporzionale all’affievolirsi dei complessi fondiari edelle giurisdizioni signorili di matrice laica, nonche gli effetti sulla conserva-zione della memoria documentaria relativa a queste schiatte che tale travasodi beni e diritti determino.113
I legami tra gli strati piu eminenti della societa ed il monastero di Passi-gnano, come abbiamo visto, si manifestarono in concreto innanzitutto attra-
111 Passignano, 18 settembre 1138; ivi, 26 giugno 1145; ivi, 23 aprile 1168; ivi, 1172.112 Supra, nota 102.113 Sui rapporti tra le famiglie aristocratiche e gli enti monastici in Toscana si vedano soprattut-
to: CAMMAROSANO, La famiglia dei Berardenghi; ID., Abbadia a Isola; W. KURZE, Monasteri e nobiltanel senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali, Sie-na, Accademia senese degli Intronati-Ente Provinciale per il Turismo, 1989; G. MICCOLI, Aspetti delmonachesimo toscano nel secolo XI, in ID., Chiesa gregoriana, Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. 47-73; M. RONZANI, Il monachesimo toscano del secolo XI: note storiografiche e proposte di ricerca, in Gui-do d’Arezzo monaco pomposiano, Atti del convegno di studio (Codigoro, Abbazia di Pomposa 3 otto-bre 1997; Arezzo, Biblioteca Citta di Arezzo 29-30 maggio 1998), a cura di A. Rusconi, Firenze,Olschki, 2000, pp. 21-53. Per altri esempi di ambito fiorentino: CORTESE, Signori, castelli, citta,pp. 86-112; G. FRANCESCONI, La signoria monastica: ipotesi e modelli di funzionamento. Il monasterodi Santa Maria di Rosano (secoli XI-XIII), in Lontano dalle citta, pp. 29-65; F. SALVESTRINI, S. Maria diVallombrosa. Patrimonio e vita economica di un grande monastero medievale, Firenze, Olschki, 1998,cap. II. Come testo di riferimento generale: G. SERGI, L’aristocrazia della preghiera. Politica e sceltereligiose nel Medioevo italiano, Roma, Donzelli, 1994.
MARIA ELENA CORTESE
— 178 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
verso i cicli di donazioni, che talvolta si concentrarono in pochi anni e talaltrasi protrassero per secoli, ma che spesso implicarono il trasferimento al ceno-bio di ampie quote dei patrimoni familiari, compresi nuclei strategici qualicorti, castelli e chiese private.114 E probabile che una parte di questi beniin una prima fase restasse sotto il controllo delle suddette casate, venendo re-stituiti subito indietro sotto forma di livelli – come piu volte attestato – o feudi– dei quali invece non si dava documentazione scritta. Tuttavia le proprietadonate al monastero, a maggior ragione in quanto cedute ad un ente sul qualenon si disponeva di una forma di patronato o di controllo dinastico, sfuggiro-no nel volgere di poco tempo alla gestione familiare e le donazioni costituiro-no in definitiva un pesante fattore d’indebolimento patrimoniale.
Proprio quest’ultima osservazione introduce lo spinoso problema della rea-le natura delle donazioni alle chiese da parte dei laici, assolutamente predomi-nanti sulle compravendite nell’XI secolo. Si e spesso rimarcato, infatti, che mol-te cartule offersionis in apparenza dettate da motivi pii, potevano nascondere inrealta dei prestiti su pegno fondiario o sottacere delle vendite vere e proprie, inuna sorta di ‘adeguamento formale’ di qualunque trasferimento di beni direttialle chiese alla veste della pia donazione.115 Le attestazioni di launechild o me-rita molto remunerativi ovviamente permettono, dove presenti, una chiara di-stinzione tra le semplici chiusure simboliche delle transazioni e le corresponsio-ni di quello che diventava un vero e proprio prezzo, trasformando l’apparentedonazione in un’effettiva vendita. Tuttavia, questo tipo di documenti rappre-senta solo una piccola percentuale sul totale delle alienazioni conservatesi: laquestione e dunque difficile da risolvere e rimane sostanzialmente aperta.
Di fronte alla crescente presenza di compravendite nel corso XII secolo, siha pero l’impressione che ci troviamo in presenza di un cambiamento nellapratica notarile: cio induce a pensare che realmente i monasteri avessero difatto pagato almeno una parte delle donazioni anche nel secolo precedente– forse soprattutto quelle in cui non si specificava che la transazione avvenivapro anima – spesso approfittando delle difficolta economiche in cui versavano
114 In generale sui cicli di donazioni: C. WICKHAM, Vendite di terra e mercato della terra in To-scana nel secolo XI, «Quaderni storici», LXV, 1997, pp. 355-377; ID., La montagna e la citta. L’Ap-pennino toscano nell’alto Medioevo, Torino, Paravia, 1997, pp. 208-211.
115 CAMMAROSANO, La famiglia dei Berardenghi, pp. 111-123; ID., Abbadia a Isola, pp. 71-72 enota 29 e, proprio per Passignano, CONTI, La formazione, pp. 161-162. Sui prestiti dissimulati:C. VIOLANTE, Per lo studio dei prestiti dissimulati in territorio milanese (secoli X-XI), in Studi in onoredi O. Fanfani, 6 voll., Milano, Giuffre, 1962, I, pp. 643-735; G. ROSSETTI, Motivi economico-sociali ereligiosi in atti di cessione di beni a chiese nel territorio milanese per i secoli XI-XII, in Contributi del-l’Istituto di Storia Medioevale 1: Raccolta di studi in memoria di G. Soranzo, Milano, Vita e Pensiero,1968, pp. 349-410.
— 179 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
molte famiglie aristocratiche locali. Il caso di Callebona e Matraio puo essereesemplare in questo senso: dopo le prime donazioni di quote del castello edella corte, fatte probabilmente in punto di morte o in caso di malattie chemettevano in discussione i destini del patrimonio familiare, le successive alie-nazioni, riguardanti sistematicamente le altre quote del castello e delle duecorti con le rispettive chiese, sembrano effettivamente pilotate dal monasterodi Passignano, che pote cosı ricomporre in un complesso relativamente unita-rio le frazioni disperse tra i vari rami delle due famiglie che in origine control-lavano questo centro. E probabile, dunque, che soprattutto le alienazioni diquote residuali di beni sui quali il nostro cenobio aveva ormai esteso il propriodominio non siano state sempre spontaneamente dettate dalla pietas religiosa,bensı sollecitate dai monaci, che erano in grado di pagare per esse. Tanto piuche, come abbiamo messo in evidenza, appaiono innegabili le difficolta eco-nomiche in cui molte famiglie aristocratiche si dibattevano – soprattuttoper l’estrema proliferazione delle linee familiari e la conseguente frantumazio-ne dei patrimoni – e sono piu volte esplicitamente documentate situa-zioni di indebitamento da parte di queste schiatte con l’erario abbaziale.
Tutto cio non mette pero minimamente in dubbio il fatto che i cicli di do-nazioni, anche quando una parte di esse erano ricompensate in denaro, nonesaurissero la loro funzione in uno scambio meramente economico, ma fosserocomunque veicolo di legami molto piu complessi – politici, di appoggio e pro-tezione, latamente clientelari – che univano Passignano ai segmenti piu eminentidella societa laica.116 Un cenobio di tale prestigio (sia per il suo ruolo spirituale,sia per il patrimonio di cui era titolare), infatti, si prestava come imprescindibilepunto di riferimento per un’aristocrazia in piena ascesa sociale, cosicche il be-neficiarlo, il proteggerlo o l’entrare nella sua clientela potevano servire per daremanifestazione visibile della potenza raggiunta e per favorire il tentativo diemergere come forza egemonica nella zona in cui l’abbazia sorgeva.
Tali cicli di donazione si esaurirono sostanzialmente entro la meta del XIIsecolo; in seguito lo slancio espansivo delle proprieta monastiche rallento, per-che si erano ormai estenuati i patrimoni delle maggiori famiglie della vecchiaaristocrazia locale. Queste ultime, quando non si estinsero, risprofondarononell’oscurita una volta interrottosi il flusso documentario verso l’archivio ab-baziale legato all’alienazione delle loro proprieta avite.
I rapporti del monastero con l’aristocrazia laica negli ultimi decenni del1100 furono piuttosto improntati ad un’estenuante ‘guerra di posizione’
116 Sul valore «sociale» e non meramente economico delle donazioni ai monasteri: WICKHAM,Vendite di terra.
MARIA ELENA CORTESE
— 180 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
con i signori di alcuni castelli circostanti (Monteficalle, Roffiano, Montecorbo-li), appartenenti a schiatte ancora molto agguerrite (in particolare i Firidolfi) eche in precedenza non comparivano nella documentazione passignanese, forseperche i loro dominii si erano estesi a quest’area solo di recente: sembrerebbeproprio questo il caso dei Firidolfi e dai da Cintoia nel castello di Montefical-le, che nell’XI secolo era invece controllato da altri gruppi familiari.117
Il XII secolo dunque si chiuse con una complicata serie di vertenze e discontri violenti tra abbazia e signori laici, entrambi impegnati nel faticoso ten-tativo di costruire territori signorili coerenti e compatti in un’area caratteriz-zata da un inestricabile viluppo di proprieta e diritti, le cui radici in gran parteaffondavano nella frammentazione dei patrimoni fondiari aristocratici dei se-coli precedenti.118
117 Sui da Cintoia ed i Firidolfi fino alla meta del XII sec.: CORTESE, Signori, castelli, citta,pp. 294-305, 312-320.
118 Su queste dispute e sulla frammentazione e sovrapposizione dei diritti signorili in questa zo-na centrale del Chianti si veda C. WICKHAM, La signoria rurale in Toscana, in Strutture e trasforma-zioni della signoria rurale nei secoli X-XIII, a cura di G. Dilcher e C. Violante (Annali dell’Istitutostorico italo-germanico, 44), Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 343-409, pp. 379-383 e ID., Legge, prati-che e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo, Roma, Viella, 2000,pp. 327-342. Per la signoria monastica a Poggialvento nel XIII sec. si veda il classico J. PLESNER, L’e-migrazione dalla campagna alla citta libera di Firenze nel XIII secolo, Firenze, Papafava, 1979 (ed.orig., Copenhagen 1934).
13— 181 —
IL MONASTERO E LA NOBILTA
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
INDICE
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. V
Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » VII
Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » IX
PASSIGNANO NELLA STORIOGRAFIA
GIOVANNI CHERUBINI, Johan Plesner ed Elio Conti: la vicenda diPassignano come paradigma di fenomeni generali. . . . . . . . . . » 3
PRIMA DEL MONASTERO
IGOR SANTOS SALAZAR, Il territorio prima del monastero. La mediaVal di Pesa nei secoli VI-IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15
PASSIGNANO, VALLOMBROSA E FIRENZE
ANNA BENVENUTI, San Michele aveva un gallo... Spunti di riflessionisulla dedicazione all’angelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43
FRANCESCO SALVESTRINI, San Michele Arcangelo a Passignano nel-l’Ordo Vallisumbrosae tra XI e XII secolo . . . . . . . . . . . . . . » 59
ENRICO FAINI, Passignano e i Fiorentini (1000-1266): indizi per unalettura politica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 129
— 317 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
IL MONASTERO, GLI UOMINI, LE COMUNITA
MARIA ELENA CORTESE, Il monastero e la nobilta. Rapporti con l’a-ristocrazia laica, formazione del patrimonio abbaziale e tradizio-ne documentaria (secc. X-XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 155
SIMONE M. COLLAVINI, I poteri signorili nell’area di San Michele diPassignano (secc. XI-XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 183
TOMMASO CASINI, L’abate e gli homines di Poggialvento (secc. XII eXIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 205
PAOLO PIRILLO, L’abate, il Comune e i pesci del fossato: mezzo se-colo di dispute a Passignano (secc. XIII-XIV) . . . . . . . . . . . . » 223
TESTIMONIANZE MATERIALI
ITALO MORETTI, La badia a Passignano: le origini e l’architetturamedievale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 255
GLORIA PAPACCIO, I mulini dell’abate. Il monastero e l’uso delle ac-que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 275
INDICI
Indice dei nomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 295
Indice delle localita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 303
Indice degli autori e curatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 311
INDICE
— 318 —
copi
a co
nces
sa p
er e
sclu
sivo
uso
nell’
ambi
to d
ella
VQ
R 2
004-
2010
ope
rata
dal
l’AN
VU
R -
ogni
ripr
oduz
ione
o d
istrib
uzio
ne è
vie
tata
copy
gra
nted
for e
xclu
sive
use
in V
QR
200
4-20
10 b
y AN
VU
R -
it’s f
orbi
dden
to c
opy
or d
istrib
ute
© C
asa
Editr
ice
Leo
S. O
lschk
i, Fi
renz
e - ©
Leo
S. O
lschk
i Pub
lishe
r, Fl
oren
ce, I
taly
BIBLIOTECA
STORICA
TOSCANA
LIX
OLSCHKI
2009
PA
SS
IGN
AN
OIN
VA
LD
IP
ES
A–
I
ISSN 0391-819X
ISBN 978 88 222 5902 8
BIBLIOTECA STORICA TOSCANA
A CURA DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA
LIX
PASSIGNANOIN VAL DI PESA
UN MONASTEROE LA SUA STORIA
IUna signoria sulle anime, sugli uomini, sulle comunita
(dalle origini al sec. XIV)
a cura di
PAOLO PIRILLO