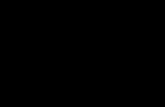Il paradiso ritrovato. Novità sul ciclo pittorico del monastero di Santa Maria e Brigida a Pian di...
Transcript of Il paradiso ritrovato. Novità sul ciclo pittorico del monastero di Santa Maria e Brigida a Pian di...
201
Alcuni recenti inter venti direstauro hanno riportato alla luce itre affreschi che completano il gran-de ciclo pittorico conservato nellachiesa dell’ex Monastero di SantaMaria e Brigida al Paradiso, primonucleo monastico italiano dell’ordi-ne brigidino1. Sulla base di quantoriportato nei documenti apprendia-mo che il complesso fu edificato neiprimi anni novanta del Trecento supreesistenti strutture che facevanoparte del cosiddetto Paradiso degliAlberti2, villa suburbana che NiccolòAlberti donò al figlio Antonio nel13763. Poco dopo la conversione daluogo laico a luogo monastico avve-nuto per volere di Antonio Alberti4,la cappella di Santa Maria e Zanobial Fabroro, antica cappella di fami-glia, fu trasformata in chiesa5 e sitrovò ad essere al centro del com-plesso permettendo così la preghie-ra condivisa dei religiosi sia maschisia femmine6. Nel 1395 infatti la cap-pella fu annessa al monastero eaffrescata con un cospicuo ciclo pit-torico attribuito già dai primi annidel secolo scorso ad un pittore dalfare artistico vicino a quello di Nic-colò di Pietro Gerini.
Le prime proposte attributivefurono avanzate da Guido Carocci eRiccardo Mazzanti in una relazionetecnica del 30 maggio 19077 laquale, oltre ad essere un importantepunto di partenza per comprenderelo stato di conservazione delle pittu-re agli inizi del XX secolo8, sottoli-nea l’importanza storico-artisticadegli affreschi e ne sconsiglia la ven-dita. In un primo momento ilCarocci assegnò le pitture a SpinelloAretino, per poi notare però unamaggior somiglianza con le pitturedi Niccolò di Pietro Gerini ed inparticolare con quelle della sagre-stia di Santa Croce a Firenze9.
La forte impronta geriniana degliaffreschi fu notata sia da Osvald
Sirén, che nel 1908 attribuì il ciclo aMariotto di Nardo, già apprendistanella bottega del Gerini10, sia daBasile Khvoshinsky e Mario Salmiche nel 1914 attribuirono le pitturealla collaborazione tra Lorenzo diNiccolò, ancora creduto figlio diGerini, e Mariotto di Nardo11; Rai-mond van Marle12, invece, nel 1924affidò la paternità esclusiva a Loren-zo di Niccolò.
L’ipotesi di un influsso gerinianodivenne una decisa attribuzione allostesso Gerini nel 1930 quandoRoberto Piattoli13 rese noto un docu-mento conservato all’Archivio Dati-ni di Prato14 in grado di attestare lapresenza del pittore al Paradisodegli Alberti in data 28 aprile 139515.Oltre a ciò il Piattoli vedeva comeseconda mano, meno rilevante,quella di Lorenzo di Niccolò16.
Agli inizi degli anni trenta Ber-nard Berenson17 assegnò gli affre-schi a Niccolò di Pietro Gerini,affiancato questa volta da Lorenzodi Niccolò, Mariotto di Nardo eAmbrogio di Baldese. Più tardi, Fre-derick Antal18 li attribuì a Niccolò diPietro Gerini aiutato da Lorenzo diNiccolò e Mariotto di Nardo. Nel1975 Miklós Boskovits propose cheil ciclo fosse stato dipinto in parteda Niccolò di Pietro Gerini19 e inparte da un collaboratore identifica-to in via ipotetica con Ambrogio diBaldese20, come confermato ancheda Filippo Todini nel 198521.
La critica più recente ha quindiinserito le opere del “fantomatico”22
Ambrogio di Baldese nel catalogodella fase giovanile di Mariotto diNardo23 per cui anche gli affreschidel Paradiso, in precedenza attribui-ti ad Ambrogio, sono stati affidatialla mano del giovane Mariotto24.
L’unico contributo organicovolto a ripercorrere la storia delmonastero e a proporre un recupe-ro mirato alla salvaguardia delle
Il paradiso ritrovato. Novità sul ciclo pittoricodel monastero di Santa Maria e Brigida a Piandi Ripoli.
Francesca Goggioli
The church of the twofold monasteryof Saint Mary and Saint Brigid atthe Plain of Ripoli (Tuscany) hasrecently been restored and some unpu-blished frescos have been brought tolight: Heaven, the Last Judgementand the Transfiguration. They havebeen studied once more from the pointof view of style and iconography; theycomplete the cycle of Niccolò di PietroGerini and Mariotto di Nardo(1395) allowing the expert to under-stand the Brigidian inspiration of theiconographic plan. The scenes of thePassion, which are the main objectsof meditation counteract the postmortem apparitions connected to thetheophanic nature of the Revelationsof Saint Brigid. The importance ofthe divine manifestation reaffirms theHeavenly scene and the absence of theinfernal element in the Judgment. Forthis reason it becomes “un unicum”preserved by the painting by NiccolòAlberti, father of the commissioner.The “Heavenly” fresco besides depic-ting saints and figures of the oldtestament of which an identificationis attempted as well as notifying theprevalent feminine vocation of theorder with three rows of femininesaints, wishes to give homage to thename of the villa next to and pre-exi-stent of the monaster y, namely theAlbertis’ Paradise. The frescoed buil-ding intended as a church in 1395 isremembered by the nuns as the Chap-ter in 1516, but the presence of atabernacle makes us think it had amultiple function, and was also usedto celebrate Masses. On analysing thestyle of the “Heavenly” fresco we notethe emergence of Gerini’s directionand the collaboration of more modernartists as Mariotto and Lorenzo diNiccolò.
202
1. Niccolò di Pietro Gerini e bottega,Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti.
2. Mariotto di Nardo, Giudizio Univer-sale, Firenze, Paradiso degli Alberti.
3. Niccolò di Pietro Gerini, Trasfigu-razione, Firenze, Paradiso degli Alber-ti.
4. Niccolò di Pietro Gerini, Lavandadei Piedi, Firenze, Paradiso degliAlberti.
5. Niccolò di Pietro Gerini, Cattura diCristo, Firenze, Paradiso degli Alber-ti.
6. Niccolò di Pietro Gerini, Cristodavanti a Pilato, Firenze, Paradisodegli Alberti.2
3
testimonianze storico-artistiche èstato il libro Il ‘Paradiso’ in Pian diRipoli: studi e ricerche su un anticomonastero, pubblicato a Firenze nel1985 a cura di Mina Gregori e Giu-seppe Rocchi; sulla base di questapubblicazione, fondamentale soprat-tutto per la proposta di ricostruzionedell’edificio attraverso i documenti,ho avviato i miei studi che presenta-no una nuova riflessione sulla desti-nazione degli ambienti e una nuovalettura stilistica e iconografica degliaffreschi alla luce dei recenti ritrova-menti non ancora presi in considera-zione dalla critica.
L’affresco con il Paradiso (fig. 1)che decora la parete orientale difondo e i due riquadri delle paretiadiacenti con il Giudizio Universale(fig. 2) e la Trasfigurazione (fig. 3)furono riportati alla luce grazie ailavori di restauro svoltisi tra il 1989 eil 1992 dalla ditta PT color di Firen-ze, durante i quali vennero distruttele superfetazioni presenti all’inter-no della cappella ed in particolare ilmuro di mattoni al di là del quale sitrovavano “un forno e un soppal-co”25 che fino ad allora ne avevanonascosto le pareti di fondo. Nel2004, inoltre, venne avviato un mira-to intervento di recupero, conserva-zione e restauro degli affreschi por-tato avanti dall’Istituto per l’Arte e ilRestauro di Palazzo Spinelli diFirenze.
L’intero ciclo pittorico ha iniziodal fondo della chiesa con la Trasfi-gurazione 26, posta nel primo riqua-dro della parete destra e si sviluppalungo un registro sovrastante uno
4
203
zoccolo di finti marmi colorati; lanarrazione prosegue in ordine ora-rio con la Lavanda dei piedi (fig. 4),la Cattura (fig. 5), Cristo davanti aPilato (fig. 6), l’Andata al Calvario(fig. 7) e la Crocifissione in controfac-ciata (fig. 8). Le storie continuanoquindi sulla parete sinistra con l’In-contro con i discepoli a Emmaus (fig.9), l’Incredulità di San Tommaso (fig.10), l’Ascensione (fig. 11), la Penteco-ste (fig. 12), ed infine il Giudizio uni-versale che introduce al maestosoaffresco con il Paradiso sulla paretedi fondo.
Il soggetto dell’ultimo affrescosulla sinistra che ho supposto essereun Giudizio Universale risulta di parti-colare interesse: in una mandorla diluce posta al centro della scena tro-viamo Cristo benedicente che, con-tornato da quattro angeli recanti glistrumenti della Passione, si scosta laveste e mostra la piaga del costato;alla sinistra del Cristo non figurano idannati e tutto lo spazio al di sottodella mandorla è occupato da unafolla indistinta di uomini e donneche pregando attendono l’eternagrazia (fig. 13). La totale assenzadell’elemento infernale fa di questoGiudizio un’iconografia unica e par-ticolarmente adatta ad ispirare lecontemplazioni beatifiche di unmonastero brigidino.
1
5
6
204
Nonostante la scena sia moltorovinata spiccano in primo piano unangelo e un beato isolati dal gruppoe rivolti in senso opposto ad esso;l’angelo afferra per il braccio ilbeato incredulo e gli indica il Para-diso raffigurato sulla parete adiacen-te. Possiamo ipotizzare che que-st’uomo dal volto caratterizzato edai radi capelli brizzolati (fig. 14)possa essere l’unico ritratto cheabbiamo del padre di AntonioAlberti27, Niccolò Alberti, il quale,defunto nel 1376, lasciò il comples-so del Paradiso in eredità al figlioche in questo modo avrebbe omag-giato il padre e assicurato la salvezzaeterna della sua anima.
Da un confronto diretto tra ilGiudizio Universale di Mariotto diNardo e quello di Buonamico Buf-falmacco del Camposanto di Pisaemergono alcune significative affi-nità: sia il gesto con cui Cristomostra la ferita (figg. 15, 16), insoli-to per un’iconografia di questogenere, sia il brano con l’angelo chesalva il beato in atteggiamento distupore (figg. 17, 18) sono duemotivi presenti in entrambe le ver-sioni. La supposizione che Mariottoabbia visto il Giudizio di Buffalmaccoporterebbe ad avvalorare l’ipotesiavanzata da Miklós Boskovits28
secondo la quale il pittore sarebbe
8
7
9
205
7. Niccolò di Pietro Gerini, Andata alCalvario, Firenze, Paradiso degliAlberti.
8. Mariotto di Nardo, Crocifissione,Firenze, Paradiso degli Alberti.
9. Mariotto di Nardo, Incontro con idiscepoli a Emmaus, Firenze, Paradisodegli Alberti.
10. Mariotto di Nardo, Incredulità diSan Tommaso, Firenze, Paradiso degliAlberti.
11. Mariotto di Nardo, Ascensione,Firenze, Paradiso degli Alberti.
12. Mariotto di Nardo, Pentecoste,Firenze, Paradiso degli Alberti.
stato attivo come collaboratore nellabottega del Gerini durante i lavoridella decorazione della sala capitola-re di San Francesco a Pisa nel 1392.
Il recente recupero della grandio-sa scena conclusiva con il Paradiso cipermette una riflessione più profon-da sulla complessità del ciclo e sulleparticolarità del programma icono-grafico interpretato alla luce dellerichieste della committenza e dellepeculiarità della regola brigidina.
Con la raffigurazione del Paradisonella nuova chiesa monastica Anto-nio Alberti volle omaggiare l’anticavilla di famiglia, denominata untempo Paradiso degli Alberti, colle-gandosi idealmente a questonome29. Al momento della conver-sione da villa di piacere e diletto amonastero si mantenne l’intitolazio-ne, ma cambiò l’accezione assegnataal termine “Paradiso”, non più inte-so come mero locus amoenus ma spi-ritualizzato alla luce dell’importanzache la regola brigidina assegnavaalla manifestazione della divinità. Fuinfatti proprio durante le sue appa-rizioni che Cristo ordinò a Brigidala costituzione del nuovo ordine30.
Nelle sue visioni la santa ripercor-se molte vicende della vita di Cristotramite gli occhi della Madonna;benché nelle Rivelazioni celesti sianodescritti in modo particolarmentedettagliato alcuni episodi della Pas-sione, nel ciclo non sono presentiespliciti riferimenti all’esperienzamistica della santa31. Nonostante ciòil programma iconografico racchiu-de in sé i due concetti ai quali i reli-giosi e le religiose brigidine eranoparticolarmente legati: la meditazio-
10
11
12
ne sulla Passione di Cristo32, intornoalla quale ruotano le Rivelazioni, e lanatura teofanica delle stesse. Notia-mo infatti che alle più drammatichee affollate scene della Passione sullaparete di destra si contrappongonole apparizioni post mortem della pare-te opposta, più statiche e dal saporemistico: le prime si concludono gran-diosamente nella Crocifissione,momento saliente della Passione,mentre le altre trovano coronamentonel Paradiso, scena estatica che forseaccompagnava le preghiere e le medi-tazioni dei religiosi e delle religiose ealla quale più volte Brigida sembraalludere nelle Rivelazioni 33. Il doppioregistro narrativo ed il maggior rilie-vo che si voleva assegnare alle duescene sulle pareti brevi centinate(che, a differenza delle scene sullepareti lunghe34 erano affrescate finoalla sommità35 grazie all’originalecopertura a capriate36) racchiudonoin sé questi due concetti. In lineacon tale lettura l’assenza della raffi-gurazione infernale mira a privile-giare l’aspetto teofanico così da nonturbare le preghiere che secondo laRegola rappresentavano il primopasso per sollevare la Chiesa e ilmonachesimo dal decadimentomorale e spirituale37.
Per quanto riguarda la composi-zione del nostro Paradiso notiamo
206
15 13
14
13. Mariotto di Nardo, Giudizio Uni-versale, Firenze, Paradiso degli Alber-ti (particolare).
14. Mariotto di Nardo, Giudizio Uni-versale, Firenze, Paradiso degli Alber-ti (particolare con Niccolò Alberti).
15. Buonamico Buffalmacco, GiudizioUniversale, Pisa, Camposanto (parti-colare).
16. Mariotto di Nardo, Giudizio Uni-versale, Firenze, Paradiso degli Alber-ti (particolare).
17. Buonamico Buffalmacco, GiudizioUniversale, Pisa, Camposanto (parti-colare).
18. Mariotto di Nardo, Giudizio Uni-versale, Firenze, Paradiso degli Alber-ti (particolare).
207
che esso si pone in linea con le raffi-gurazioni paradisiache trecentescheautonome rispetto all’iconografiadel Giudizio Universale, come, adesempio, il Paradiso di Giotto nellaCappella della Maddalena nel Palaz-zo del Bargello (c. 1334-1335)38,quello di Nardo di Cione della cap-
delle quali si riconoscono a destradella bifora centrale Cristina, Agne-se, Caterina, Dorotea ed Orsolaseguita da altre martiri che potreb-bero corrispondere alle sue compa-gne, le undicimila vergini che mori-rono con lei in nome della fede edella purezza44; a sinistra Maria Mad-dalena, Marta, Rosalia, Lucia, Chia-ra, Apollonia ed Elena. Nella filasovrastante le Vergini, occupata dasanti confessori, sta un vescovo daitratti fisionomici molto caratterizza-ti, San Girolamo e un santo papa(fig. 26); nella parte di sinistra tro-viamo due vescovi, identificabili pro-babilmente con Agostino45 e Ambro-gio46, un santo papa e Sant’AntonioAbate (fig. 27). La fila ancora sopracon santi martiri comincia con unsanto imberbe cui seguono i quattrodiaconi tonsurati: San Vincenzo,Santo Stefano con lo stendardo cro-ciato e il capo ferito (fig. 28), SanLorenzo con la graticola del martirioe San Leonardo che reca in mano iceppi dei condannati (fig. 29). Ilsanto martire coronato e imberbe alfianco di quest’ultimo potrebbe esse-re San Miniato, uno dei santi patronidi Firenze. Nel penultimo registro,occupato dai patriarchi (figg. 28, 29),il primo personaggio da sinistra, delquale scorgiamo solo una folta barbabianca, sembrerebbe Abramo47, men-tre quello vicino a lui, dalla scurabarba biforcuta, potrebbe essere suofiglio Isacco, padre di Giacobbe, fre-quentemente raffigurato insieme ad
1716
pella Strozzi della chiesa domenica-na di Santa Maria Novella (1353-1359)39, il frammento di affrescodegli anni settanta del Trecento conangeli e santi di Niccolò di Tomma-so sulla parete di fondo dell’orato-rio del Tau di Pistoia40, l’affresco diTaddeo di Bartolo sulla controfac-ciata della Collegiata di Santa MariaAssunta a San Gimignano (1393)41 eil Paradiso di Giovanni di Bartolo-meo Cristiani nella chiesa di SanDomenico a Pistoia, ora strappato econservato nel refettorio (c. 1390)42.
L’assemblea di santi, nel nostrocaso sette file di beati che seguonol’ordine delle sette litanie, ricorda lacomposizione giottesca (fig. 19) inquanto le figure sono disposte sim-metricamente intorno ad una gran-de finestra; ma se nella Cappelladella Maddalena, in alto, si staglia lafigura di Cristo in mandorla circon-dato da angeli, al Paradiso possiamoinvece ipotizzare che ad occupare lospazio sopra la finestra43, ora nasco-sto dalla volta cinquecentesca, fosse,proprio come nel Paradiso di Nardodi Cione, l’immagine di Cristoaffiancata dalla Vergine, visto l’im-portante ruolo di mediatrice ricono-sciuto a quest’ultima dalla spiritua-lità brigidina. L’identificazione deisanti è risultata in alcuni casi diffici-le per la mancanza dei tipici attribu-ti ma possiamo tuttavia proporreuna lettura (figg. 20, 21). Dal basso,le prime tre file sono occupate dasante vergini e martiri (figg. 22-25)
18
vicino a lui sono Mosè, che con lamano destra indica una fiamma,Aronne e Salomone (fig. 29). L’ulti-ma fila, meno leggibile, è occupatadagli apostoli (figg. 28, 29) tra iquali riconosciamo solamente Tom-maso e Paolo.
La peculiare presenza di ben trefile di sante non ha precedenti ed èfinalizzata a rimarcare la vocazionefemminile dell’ordine brigidino, chein quanto “ordine di monache inonore della gloriosa Vergine Maria”51
prevedeva all’interno del monastero,il cui capo spirituale era la Badessa,la presenza di un maggiore numerodi monache rispetto a quello deimonaci52.
Non è chiaro come la funzionedella cappella cambi nel corso deisecoli: se la bolla del 10 gennaio1395 la designa come prima chiesadel monastero per le monache e imonaci, la costruzione di una nuovachiesa con un coro per le monachenel 1401, appena sei anni dopo,
208
20
19
Abramo48. Il terzo personaggio recain mano un fascio di frumento; percompletare la triade siamo portati apensare che egli sia Giacobbe49 e pergiustificare tale identificazione pos-siamo riferirci ad un passo dellaGenesi che racconta il momento incui Giacobbe riceve la benedizionedel padre Isacco; quest’ultimo sperache l’abbondanza di frumento siauna delle cose che Dio riserbi per ilfiglio: “Iddio adunque ti dia dellarugiada del cielo, e delle grassezze dellaterra, ed abbondanza di frumento e dimosto” (Gn 27, 28-29). In un passosuccessivo, quando Isacco ed Esaù siaccorgono dell’inganno di Giacob-be, Isacco risponde alla disperazio-ne di Esaù dicendo: “ecco, io l’ho costi-tuito tuo padrone, e gli ho dato tutti ituoi fratelli per servi; e l’ho fornito difrumento e di mostro” (Gn 27, 37-38).Ritroviamo questo personaggioanche nel Paradiso di Nardo dove èaffiancato da Noè (fig. 30), propriocome a Pian di Ripoli. Sul latodestro della composizione e in lineacon i patriarchi sta una figura la cuilunga capigliatura, la veste scollata epelosa (fig. 31) e la posizione a sini-stra di Cristo permettono di identifi-carvi il Battista50. I tre personaggi
209
appare quantomeno strana, ma tut-tavia testimoniata da alcuni docu-menti rinvenuti da Giuseppina Baca-relli53 che ci informano della costru-zione di un coro per le monache edella chiusura di alcuni altari sotto levolte54: interventi questi che devonoessere riferiti ad una nuova strutturae non alla cappella che fu voltatasolo nel Cinquecento e che non pre-senta segni visibili di un cororialzato55. Riferimenti più o menodiretti a questa nuova chiesa si trova-no in alcuni pagamenti del 1401 aGiovanni di Tano Fei per l’esecuzio-ne di una tavola raffigurante SantaBrigida56 e per la realizzazione dellostesso soggetto ad affresco accantoall’altare maggiore della chiesa57;nella presentazione del monasteronel Decimario del 1438, grazie allaquale sappiamo che la chiesa si tro-vava su via del Paradiso, accostata almonastero delle monache58; nellagenerica descrizione dell’internodella chiesa nella Relazione pastora-le del 169259; infine in una lapideritrovata nei locali in via del Paradisogià sede della chiesa60. Nel corso delXV secolo l’antica chiesa forse rima-se ad uso interno del monastero perle religiose di più stretta clausura,forse rimase uno spazio di preghieraper i religiosi o forse, come sostiene
21
19. Giotto, Paradiso, Firenze, MuseoNazionale del Bargello, Cappelladella Maddalena.
20. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti, parete a destra della biforacentrale (proposta di identificazionedei santi). 1 Santa martire, 2 SantaCristina, 3 Santa, 4 Sant’Agnese, 5Santa Caterina, 6 Santa Dorotea, 7Santa martire, 8 Santa, 9 Santa, 10Santa, 11 Santa martire, 12 Santamartire, 13 Santa, 14 Santa, 15 Santamartire, 16 Santa, 17 Sant’Orsola, 18Santo confessore, 19 Santo vescovo,20 San Girolamo, 21 Santo papa, 22Santo martire, 23 San Vincenzo, 24Santo Stefano, 25 Abramo, 26 Isac-co, 27 Giacobbe (?), 28 Noè, 29 SanTommaso (?), 30 San Paolo (?).
21. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti, parete a sinistra della biforacentrale (proposta di identificazionedei santi). 31 Santa, 32 Santa MariaMaddalena, 33 Santa Marta, 34Santa Rosalia, 35 Santa Lucia, 36Santa, 37 Santa martire, 38 Santa, 39Santa Chiara, 40 Santa martire, 41
Santa martire, 42 Sant’Apollonia, 43Santa, 44 Sant’Elena (?), 45 Santa, 46Santa, 47 Santa, 48 Sant’Agostino(?), 49 Santo papa, 50 Sant’Ambro-gio (?), 51 Sant’Antonio Abate, 52San Lorenzo, 53 San Leonardo, 54San Miniato, 55 Santo martire, 56
22
San Giovanni Battista, 57 Mosè, 58Aronne, 59 Salomone, 60 Apostolo,61 Apostolo, 62 Apostolo.
22. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
Lucia Meoni, la costruzione di unanuova chiesa portò alla trasformazio-ne di quella trecentesca in capitolodelle monache61. Considerando lacrisi interna dei monasteri doppi,come era quello al Paradiso, permotivi di ordine morale, possiamoipotizzare che per tale ragione sisiano voluti distinguere nettamentegli spazi62 destinati ai maschi e allefemmine63.
Se alcuni documenti del 1516 rin-venuti da Lucia Meoni lasciano pen-sare che il nostro ambiente fosse ilcapitolo delle monache64, la presen-za di un comunichino65 sulla paretedi destra, attraverso il quale le mona-che potevano ricevere la comunione,fa sorgere il dubbio che la cappellaabbia avuto più destinazioni d’uso66.La pianta del monastero del 178167
(fig. 32) definisce la cappella “stanzadel Capitolo con il comunicatorio” e
la chiesa che affaccia sulla via “chie-sa pubblica con 7 altari e due portesulla strada”; supponendo che ladenominazione rimandi a quellaantica e non ad un uso esclusiva-mente settecentesco, e consideran-do che la presenza di un “comunica-torio” presupponga la celebrazione,siamo portati ad avvalorare l’ipotesidi una polifunzionalità della cappel-la.
Da un’analisi stilistica degli affre-schi possiamo riconoscere due manidistinte: quella di Niccolò di PietroGerini e quella del suo collaborato-re Mariotto di Nardo. Le scene dellaparete di destra sono riferibili alprimo, che al tramonto degli anninovanta accentua più che mai laseverità e la solennità delle sue figu-re; queste, avvolte da pesanti vestisolcate da pieghe dal profondo sot-tosquadro, sono statiche, monumen-
tali e impassibili, e ci rimandano adun confronto diretto con i protago-nisti degli affreschi dell’Orcagna, delvecchio Taddeo Gaddi e dello stessoGerini nelle Storie di San Matteo dellasala capitolare di San Francesco aPisa. Lo spazio è costruito dalla pos-sente volumetria dei corpi e la quie-ta narratività del racconto è accre-sciuta dal ritmo paratattico dellacomposizione. Il tratto secco e grafi-co e il disegno squadrato distinguo-no queste scene da quelle della pare-te opposta dove il segno è menotagliente e più dolce, morbido e sfu-mato, e dove le figure sono menopossenti. Qui riconosciamo la manodel giovane Mariotto di Nardo, inquesto momento ancora legato allabottega dello zio Jacopo di Cione maaperto verso raffigurazioni più dina-miche e addolcite, espressioni piùvive, composizioni più ariose. Il rilie-vo plastico, la linea decisa dei con-torni, il chiaroscuro accentuato, lecomposizioni serrate testimonianoun’innegabile discendenza orcagne-sca ma la scioltezza dei movimenti, lasensibilità paesaggistica, le espressio-ni “aperte e colloquiali”68, le ombrefumose, lo “squilibrio latente”69 e lafrequente elusione della frontalitàavvicinano il pittore al nascente lin-guaggio tardogotico. L’interesse peri paesaggi rocciosi e le città lontanericorda le ricerche di Agnolo Gaddi,mentre la luminosità più astratta esensibile rimanda al giovane Loren-zo Monaco.
Più problematico è un commentostilistico univoco sul Paradiso. Quiriconosciamo le fisionomie tipichedel Gerini; Salomone (fig. 33), adesempio, ricorda il sacerdote giudeoche assiste alla Crocifissione affrescatada Gerini in Santa Felicita a Firenze(1388) nonché un apostolo che par-tecipa all’Ascensione nella sala capito-lare di San Francesco a Pisa; Aronne(fig. 34) presenta la capigliatura, leciocche spiralate, la barba bipartita el’espressione accigliata del San Mat-teo Evangelista raffigurato da Gerininel Capitolo di San Francesco aPrato (c. 1395), (fig. 35); il San Giro-lamo (fig. 36) ha la stessa espressio-ne severa e impassibile del Sant’Anto-nio Abate nella tavola dello StewartGardner Museum di Boston del 1380circa70; Santa Doretea (fig. 37) congli occhi allungati, la bocca piccola eil viso ovale ricorda la figura di SantaCaterina affrescata in San Francescoa Prato, ma anche quella dellaMadonna del Museum of Fine Artsdi Boston del 1404. I lineamenti
210
23
26
211
23. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
24. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
25. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
26. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
27. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
24
25
27
Bibliografia
D. M. MANNI, Osservazioni istoriche di Dome-nico Maria Manni accademico fiorentino soprai sigilli antichi de’ secoli bassi, X, Firenze,1742. D. MORENI, Notizie Istoriche dei contorni diFirenze, V, Firenze, 1794.
L. PASSERINI, Gli Alberti di Firenze: Genealo-gia, storia e documenti, II, Firenze, 1870.O. SIRÉN, Gli affreschi del Paradiso degliAlberti: Lorenzo di Niccolò e Mariotto di Nardo,in “L’arte”, XI, 1908.B. KHVOSHINSKY, M. SALMI, I pittoritoscani dal XII al XVI secolo, II, Roma, 1914.R. VAN MARLE, The Development of the Ita-
tetragoni dei volti segnati da pesantiombre, le arie severe e le massicceproporzioni si attenuano però nellefigure delle sante e dei diaconi dovepossiamo notare un incarnato piùimpastato e dei contorni più morbi-di e aggraziati. La maggior eleganzalineare e la maggior gentilezza delleforme caratterizzò in effetti l’attivitàdel Gerini sullo scadere del XIVsecolo; egli, pur mantenendo il trat-to duro che lo caratterizza, risentìprobabilmente dell’influenza del piùgiovane pittore Mariotto, attivo alsuo fianco, e dei suoi tipi “aristocrati-camente allungati”71 dagli occhi amandorla e dalle bocche piccole.
Probabilmente fu anche la vici-nanza a Lorenzo di Niccolò72, che giàa metà degli anni novanta lavoravanella bottega del Gerini73, a incideresu questa maggiore dolcezza, anchese da un confronto diretto con i tipidi Lorenzo di Niccolò notiamo che ilineamenti delle sue figure sono piùminuti e contenuti rispetto alle figu-re al Paradiso (figg. 38, 39).
Siamo probabilmente davanti adun Gerini più “addolcito”, influenza-to da pittori come Pietro Nelli, Jaco-po di Cione, Mariotto di Nardo, Spi-nello Aretino, Lorenzo di Niccolò,“più attenti di lui alle istanze innova-trici della cultura tardogotica” 74, coni quali Gerini si trovò a collaborare75;e forse, in questa gentilezza, giocòun ruolo anche la personalità ormaiaffermata di Lorenzo Monaco.
In conclusione possiamo ipotizza-re che il Paradiso sia stato eseguitosotto la stretta regia del capo bottegama coadiuvato in subordine da colla-boratori come Mariotto e Lorenzo diNiccolò.
lian Schools of Painting, III, The Hague,1924.R. OFFNER, Studies in Florentine painting: thefourteenth century, New York, 1927.R. PIATTOLI, Un mercante del Trecento e gliartisti del suo tempo, in “Rivista d’arte”, XI,1930.G. GABETTI, G. RICCIOTTI, s. v. Brigida,in Enciclopedia Italiana, VII, Milano, 1930.B. BERENSON, Italian Pictures of the Renais-sance, Oxford, 1932.R. PIATTOLI, Il monastero del paradiso pressoFirenze nella storia dell’arte del primo quattrocen-to, in “Rivista d’arte”, XVIII, 1936.G. KAFTAL, Iconography of the saints in tuscanpainting, Firenze, 1952.R. OFFNER, Corpus of Florentine Painting,sezione IV, vol. II: the fourteenth centur y,Nardo di Cione, Firenze, 1960.F. ANTAL, La pittura fiorentina e il suoambiente sociale nel Trecento e nel primo Quat-trocento, Torino, 1960.L. RÉAU, Iconographie de l’art chrétien, II:Ancien Testament, Parigi, 1956.E. CROCE, s.v. Abramo, in Bibliotheca Sancto-rum, I, Roma, 1961.I. CECCHETTI, s.v. Brigida di Svezia, inBibliotheca Sanctorum, III, Roma, 1963.S. FORA, s.v. Isacco, in Bibliotheca Sanctorum,VII, Roma, 1966.G. PREVITALI, Giotto e la sua bottega, Mila-no, 1967.J. E. GUGUMUS, s.v. Orsola, in BibliothecaSanctorum, IX, Roma, 1967.BOSKOVITS, Sull’attività giovanile di Mariot-to di Nardo, in “Antichità viva”, V, 1968.E. FAHY, On Lorenzo di Niccolò, in “Apollo”,CVIII, 1978.L. MEONI, Il patrimonio privato negletto, inLa città degli Uffizi: i musei del futuro, a curadi G. Bacarelli, Firenze, 1982.Il “Paradisino” in Pian di Ripoli: studi e ricerchesu un antico monastero, a cura di M. GREGO-RI e G. ROCCHI, Firenze, 1985.L. MEONI, Le preesistenze e il primo nucleomonastico: 1392-1398, in Il ‘Paradiso’ in Piandi Ripoli: studi e ricerche su un anticomonastero, a cura di M. Gregori e G. Rocchi,Firenze, 1985.G. BACARELLI, Storia del monastero di SantaMaria e Brigida al Paradiso: 1392-1776, in Il‘Paradiso’ in Pian di Ripoli: studi e ricerche suun antico monastero, a cura di M. Gregori eG. Rocchi, Firenze, 1985.G. BACARELLI, L’edificio conventuale nelquattrocento: i nuovi lavori di ampliamento e la
definitiva sistemazione, in Il ‘Paradiso’ in Piandi Ripoli: studi e ricerche su un antico monaste-ro, a cura di M. Gregori e G. Rocchi, Firen-ze, 1985.L. MEONI, Le trasformazioni del monasterodal 1500 al 1776, in Il ‘Paradiso’ in Pian diRipoli: studi e ricerche su un antico monastero,a cura di M. Gregori e G. Rocchi, Firenze,1985.R. QUERCI, La Cappella, in Il ‘Paradiso’ inPian di Ripoli: studi e ricerche su un anticomonastero, a cura di M. Gregori e G. Rocchi,Firenze, 1985.F. TODINI, Niccolò Gerini e gli affreschi nel-l’antica chiesa, in Il ‘Paradiso’ in Pian di Ripo-li: studi e ricerche su un antico monastero, acura di M. Gregori e G. Rocchi, Firenze,1985.Y. CHRISTE, s.v. Giudizio Universale, in Enci-clopedia dell’arte medievale, VI, Roma, 1995.A. TARTUFERI, s. v. Gerini, Niccolò di Pietroin Enciclopedia dell’arte medievale, VI, Roma,1996.J. BASCHET, s.v. Paradiso, in Enciclopedia
212
29 28
28. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
29. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
30. Nardo di Cione, Paradiso, Firen-ze, Santa Maria Novella, CappellaStrozzi (particolare).
31. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
32. Pianta del monastero di SantaMaria e Brigida al Paradiso (immagi-ne pubblicata nel libro Il ‘Paradiso’ inPian di Ripoli: studi e ricerche su unantico monastero, a cura di M. GRE-GORI e G. ROCCHI, Firenze, 1985).
32
213
(1) Il nuovo ordine fondato da SantaBrigida (Ordo Sancti Augustini Sancti Salvato-ris) e confermato da Urbano VI con la bolladel 1378 (G. GABETTI, G. RICCIOTTI, s. v.Brigida, in Enciclopedia Italiana, VII, Milano,1930, p. 855) prevedeva la presenza di dueconventi separati per le monache e i mona-ci e di una chiesa in comune (M. CARPI-NELLO, Brigida di Svezia, patrona d’ Europa,Casale Monferrato, 2000, p. 52) ma conaccessi distinti. Le monache non dovevanosuperare il numero di sessanta; i monaci,che dovevano appartenere all’ordine diSant’Agostino e seguire la regola del SantoSalvatore, quello di venticinque elementi:tredici sacerdoti, quattro diaconi e otto fra-telli laici (Carpinello, 2000, p. 43).
(2) L. MEONI, Le preesistenze e il primonucleo monastico: 1392-1398, in Il ‘Paradiso’ inPian di Ripoli: studi e ricerche su un anticomonastero, a cura di M. Gregori e G. Rocchi,Firenze, 1985, pp. 34-39.
(3) L. PASSERINI, Gli Alberti di Firenze:Genealogia, storia e documenti, II, Firenze,1870, pp. 155-185.
(4) Il 26 gennaio 1392 Antonio di Nic-colò Alberti ottenne da papa Bonifacio IXla concessione per fondare il monasterobrigidino nei pressi della propria villa inPian di Ripoli (Passerini, 1870, pp. 200-201).
(5) La bolla di papa Bonifacio IX del 10gennaio 1395 che stabilì l’annessione dellapreesistente cappella al monastero è con-servata all’Archivio di Stato di Firenze (ASF,Archivio dello Spedale di S. Maria Nuova,Monastero di S. Brigida detto del Paradiso,filza 1, cc. 26 v-r, 27 r) e riportata da LuigiPasserini (Passerini, 1870, pp. 201-203).
(6) Carpinello, 2000, p. 52.
(7) Soprintendenza speciale per il polomuseale di Firenze (SSPMF), Archivio Stori-co del Territorio (Ast), Archivio Carocci,cartella 502, cc. 15-21.
(8) La relazione è completata da unaserie di fotografie che documentano lostato di conservazione della cappella neiprimi anni del Novecento.
(9) SSPMF, Ast, Archivio Carocci, cartel-la 502, fascicolo 5, c. 19.
(10) O. SIRÉN, Gli affreschi del Paradisodegli Alberti: Lorenzo di Niccolò e Mariotto diNardo, in “L’arte”, XI, 1908, pp. 179-196.
(11) B. KHVOSHINSKY, M. SALMI, Ipittori toscani dal XII al XVI secolo, II, Roma,1914, pp. 58, 61.
(12) R. VAN MARLE, The Development ofthe Italian Schools of Painting, III, The Hague,1924, p. 641.
(13) R. PIATTOLI, Un mercante del Tre-cento e gli artisti del suo tempo, in “Rivista d’ar-te”, XI, 1930, pp. 97-150.
(14) Archivio Datini, lettere, c. 334.
(15) Piattoli, 1930, p. 98.
30
31
dell’arte medievale, XXVI, Roma, 1998.S. CHIODO, Mariotto di Nardo. Note per unegregio pittore, in “Arte Cristiana”, LXXXVII,1999.CARPINELLO, Brigida di Svezia, patrona d’Europa, Casale Monferrato, 2000.M. BOSKOVITS, Giotto: un artista poco cono-sciuto?, in Giotto: bilancio critico di sessant’an-ni di studi e ricerche, catalogo della mostra acura di A. Tartuferi, Firenze, 2000.S. CHIODO, s. v. Mariotto di Nardo di Cione,in Dizionario biografico degli italiani, LXX,Roma, 2008.
A. BAGNOLI, La collegiata di San Gimigna-no: l’architettura, i cicli pittorici murali e i lororestauri, Siena, 2009.U. FERACI, L. FENELLI, Gli affreschi di Nic-colò di Tommaso nella chiesa del Tau: una rilet-tura iconografica, in Il museo e la città: vicendeartistiche pistoiesi del Trecento, Pistoia, 2012.A. DE MARCHI, Come erano le chiese di SanDomenico e di San Francesco nel Trecento? Alcu-ni spunti per ricostruire il rapporto tra spazi edimmagini sulla base dei frammenti superstiti edelle fonti, in Il museo e la città: vicende artisti-che pistoiesi del Trecento, Pistoia, 2012.
(16) Piattoli, 1930, p. 100.
(17) B. BERENSON, Italian Pictures of theRenaissance, Oxford, 1932, p. 395.
(18) F. ANTAL, La pittura fiorentina e ilsuo ambiente sociale nel Trecento e nel primoQuattrocento, Torino, 1960, pp. 303-304.
(19) Boskovits ha attribuito al Gerini inparticolare l’Andata al Calvario e parte dellaLavanda dei piedi (M. BOSKOVITS, Pitturafiorentina alla vigilia del Rinascimento, Firen-ze, 1975, p. 409).
(20) Ad Ambrogio di Baldese Boskovitsha affidato la Crocifissione, parte delleLavanda dei piedi, l’Incontro con i discepoli aEmmaus, l’Incredulità di San Tommaso, l’A-scensione e la Pentecoste (Boskovits, 1975, p.274).
(21) Filippo Todini, a differenza diMiklós Boskovits, ha attribuito ad un Geriniall’apice della sua carriera tutte le scenedella parete di destra: la Lavanda dei Piedi,la Cattura di Cristo, l’ Andata al Calvario (F.TODINI, Niccolò Gerini e gli affreschi nell’anti-ca chiesa, in Il ‘Paradiso’ in Pian di Ripoli:studi e ricerche su un antico monastero, a curadi M. Gregori e G. Rocchi, Firenze, 1985, p.84). Solamente la parte destra della scenacon Cristo davanti a Pilato viene attribuitaipoteticamente a Mariotto di Nardo (Todi-ni, 1985, p. 84). La Crocifissione, l’Incontrocon i discepoli a Emmaus, l’Incredulità di SanTommaso, l’Ascensione e la Pentecoste furonoeseguite, secondo il Todini, da Ambrogio diBaldese (Todini, 1985, p. 91).
(22) Boskovits, 1975, p. 109.
(23) S. CHIODO, Mariotto di Nardo. Noteper un egregio pittore, in “Arte Cristiana”,LXXXVII, 1999, pp. 91-104.
(24) Sonia Chiodo, nel 2008, specifica lescene che furono affidate alla mano di
Mariotto, quali l’Incontro con i discepoli aEmmaus, l’Incredulità di San Tommaso e l’A-scensione di Cristo (S. CHIODO, s. v. Mariottodi Nardo di Cione, in Dizionario biografico degliitaliani, LXX, Roma, 2008, p. 587).
(25) Soprintendenza per i beni architet-tonici, paesaggistici, storici, artistici edetnoantropologici per le provincie diFirenze, Pisa, Prato, cartella A 651, fascico-lo 3.
(26) L’insolita presenza della Trasfigura-zione come prima scena del ciclo potrebbeessere spiegata alla luce dell’importanzache la visione teofanica aveva per la regolabrigidina.
(27) Escludiamo che il beato raffiguriAntonio Alberti perché nel 1395 avrebbedovuto avere quasi quaranta anni mentre ilbeato ha l’aspetto di un uomo più anziano;inoltre sembra strano che venga raffiguratoun uomo ancora in vita nelle vesti di undefunto resuscitato durante il GiudizioUniversale.
(28) M. BOSKOVITS, Sull’attività giova-nile di Mariotto di Nardo, in “Antichità viva”,V, 1968, pp. 3-13.
(29) Domenico Maria Manni ricordache il monastero di Santa Brigida al Paradi-so era “così chiamato per rispetto della bel-lezza, e ornamenti degli edifizi, e giardini,che vi erano, e de’ diletti corporali, che isecolari in essi ci pigliavano” (D. M.MANNI, Osservazioni istoriche di DomenicoMaria Manni accademico fiorentino sopra isigilli antichi de’ secoli bassi, X, Firenze, 1742,p. 58).
(30) I. CECCHETTI, s.v. Brigida di Sve-zia, in Bibliotheca Sanctorum, III, Roma,1963, p. 469.
(31) Strana infatti sembra essere l’as-senza della Flagellazione, descritta da Brigi-
da in modo piuttosto minuzioso e cruento.
(32) Brigida nelle sue visioni assistette aldramma di Cristo e attraverso le parole dellaVergine ne ripercorse alcuni momenti salien-ti. Le Rivelazioni riportano le parole dellaVergine a Brigida a proposito dei dolori cheil figlio sopportò, ma le sue sono anche paro-le di ammonimento al tempo presente: “iomi lamento ora che il Figlio mio più doloro-samente è crocifisso dai suoi nemici, chesono ora nel mondo, che non facessero allo-ra i giudei. Infatti, sebbene la divinità siaimpassibile e non possa morire, tuttavia essilo crocifiggono con i propri vizi” (Le Rivela-zioni celesti di Santa Brigida di Svezia, libro I,cap. XXXVII).
(33) Le Rivelazioni celesti di Santa Brigidadi Svezia, libro I, capp. XXI, L.
(34) Potendo escludere l’antica presen-
214
33 34
33. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
34. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
35. Niccolò di Pietro Gerini, San Mat-teo Evangelista, Prato, San Francesco(particolare).
36. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
37. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
215
za di affreschi sul registro più alto, nonessendo visibile la consueta discontinuitàdegli intonaci che in un caso simile preve-drebbe la sovrapposizione dell’intonacosuperiore sull’affresco sottostante, siamoportati a pensare che forse esisteva un pre-
ciso progetto decorativo che prevedeva findall’inizio il maggior sviluppo in altezzasolo delle due scene della Crocifissione e delParadiso.
(35) Purtroppo la costruzione di una
cinquecentesca volta a padiglione (R.QUERCI, La Cappella, in Il ‘Paradiso’ in Piandi Ripoli: studi e ricerche su un anticomonastero, a cura di M. Gregori e G. Rocchi,Firenze, 1985, p. 109) ha portato alla distru-zione della sommità del Paradiso e di granparte delle finestre trecentesche, delle qualisono riconoscibili solo parte degli sguanci;inoltre l’apertura nello stesso periodo didue finestre in facciata ha contribuito allaperdita di gran parte della Crocifissione.
(36) Querci, 1985, p. 109.
(37) Carpinello, 2000, p. 46.
(38) G. PREVITALI, Giotto e la suabottega, Milano, 1967, pp. 348-349; M.BOSKOVITS, Giotto: un artista poco conosciu-to?, in Giotto: bilancio critico di sessant’anni distudi e ricerche, catalogo della mostra a curadi A. Tartuferi, Firenze, 2000, pp. 92- 94.
(39) R. OFFNER, Corpus of Florentine Pain-ting, sezione IV, vol. II: the fourteenth century,Nardo di Cione, Firenze, 1960, pp. 47-55.
(40) U. FERACI, L. FENELLI, Gli affre-schi di Niccolò di Tommaso nella chiesa del Tau:una rilettura iconografica, in Il museo e la città:vicende artistiche pistoiesi del Trecento, Pistoia,2012, pp. 81-119.
(41) A. BAGNOLI, La collegiata di SanGimignano: l’architettura, i cicli pittorici muralie i loro restauri, Siena, 2009.
(42) A. DE MARCHI, Come erano le chiesedi San Domenico e di San Francesco nel Trecen-to? Alcuni spunti per ricostruire il rapporto traspazi ed immagini sulla base dei frammentisuperstiti e delle fonti, in Il museo e la città:vicende artistiche pistoiesi del Trecento, Pistoia,2012, pp. 13-51.
(43) La grande finestra al centro, postasul lato orientale, avrebbe potuto esserestata sfruttata per far entrare la luce cheavrebbe evocato il chiarore celestiale delParadiso e avrebbe esaltato la natura divisione ultraterrena tramite la metaforadella luce.
(44) J. E. GUGUMUS, s.v. Orsola, inBibliotheca Sanctorum, IX, Roma, 1967, pp.1252-1253.
(45) G. KAFTAL, Iconography of the saintsin tuscan painting, Firenze, 1952, p. 101.
(46) Kafltal, 1952, p. 21.
(47) L. RÉAU, Iconographie de l’art chré-tien, II: Ancien Testament, Parigi 1956, p. 126;E. CROCE, s.v. Abramo, in Bibliotheca Sancto-rum, I, Roma, 1961, p. 107.
(48) S. FORA, s.v. Isacco, in BibliothecaSanctorum, VII, Roma, 1966, p. 909.
(49) I tre patriarchi Abramo, Isacco eGiacobbe, soprattutto nell’iconografiaorientale del Giudizio Universale, accolgo-no e tengono in grembo le anime dei beati(Y. CHRISTE, s.v. Giudizio Universale, inEnciclopedia dell’arte medievale, VI, Roma,1995, p. 800). L’iconografia del Seno d’Abra-mo, evocato nella parabola di Lazzaro (Lc
35
36
37
16, 19-31; Mt 8, 11; Lc 13, 28), comparveper la prima volta in area bizantina, doveebbe una duratura espansione, e nel 990circa si sviluppò in Occidente (J. BASCHET,s.v. Paradiso, in Enciclopedia dell’arte medievale,XXVI, Roma, 1998, p. 171).
(50) Anche Nardo di Cione raffigurò il
Battista in alto a sinistra ma allineato congli apostoli.
(51) Carpinello, 2000, p. 43.
(52) Cecchetti, 1963, p. 470.
(53) G. BACARELLI, L’edificio conven-
tuale nel quattrocento: i nuovi lavori di amplia-mento e la definitiva sistemazione, in Il ‘Paradi-so’ in Pian di Ripoli: studi e ricerche su un anti-co monastero, a cura di M. Gregori e G. Roc-chi, Firenze, 1985, pp. 41-42.
(54) Uno dei documenti che hanno por-tato la Bacarelli ad ipotizzare la costruzionedi una nuova chiesa ci informa che il 21marzo vennero dati trenta soldi “per aghutti[…] quando s-armava la vela del coro dellesuore” (BACERELLI, 1985, p. 41; ASF, Archi-vi dello Spedale di S. Maria Nuova, Monaste-ro di S. Brigida detto del Paradiso, filza 145,c. 52 r). Un secondo documento parla delpagamento di altri soldi “per fare la chiusadegli altari di sotto le volte” (BACERELLI,1985, p. 41; ASF, Archivi dello Spedale di S.Maria Nuova, Monastero di S. Brigida dettodel Paradiso, filza 277, c. 16 v).
(55) Bacarelli, 1985, p. 41.
(56) R. PIATTOLI, Il monastero del para-diso presso Firenze nella storia dell’arte del primoquattrocento, in “Rivista d’arte”, XVIII, 1936,pp. 297-298.
(57) Miklós Boskovits ha identificato latavola con quella della collezione Bassi diMilano che raffigura Santa Brigida mentreconsegna la Regola ad un gruppo di mona-che e monaci e l’ha attribuita al Maestrodel 1399 (Boskovits, 1975, p. 241), oggiriconosciuto dalla critica con Giovanni diTano Fei. La pala presenta al centro lagrande figura della santa che consegna laRegola attorniata da altri personaggi, sog-getto questo assai insolito per un altaremaggiore e che quindi lascia ipotizzare chela tavola fosse destinata al nuovo coro per lemonache costruito nella nuova chiesa su viadel Paradiso e i cui lavori risalgono infatti aiprimi anni del Quattrocento. Nel documen-to che ci informa dei pagamenti a Giovannidi Tano Fei, riportato dal Piattoli (Piattoli,1936, pp. 297-298), si parla anche della raf-figurazione di Santa Brigida in un affrescoaccanto all’altare maggiore della chiesa eciò avvalora l’ipotesi che la tavola fosse statadestinata al coro delle monache come pen-dant ideale dell’affresco a lato dell’altaremaggiore.
(58) Sempre grazie agli studi di Giusep-pina Bacarelli, sappiamo che il Decimariodel 1438 nell’indicare i confini del mona-stero specifica che “da primo la via che valungo el monasterio delle suore d-andarealla chiesa”, per cui ricaviamo che la chiesaera posta su via del Paradiso (BACERELLI,1985, pp. 41-42).
(59) Bacarelli, 1985, pp. 42-43; ASF,Manoscritti, Minutario, 175, relazione 17.
(60) Bacarelli, 1985, pp. 41-42.
(61) L’ipotesi della studiosa si basa sudei documenti cinquecenteschi che testi-moniano alcuni interventi nel capitoloriguardanti la costruzione delle volte, l’a-pertura di due finestre in facciata e la tra-sformazione del portale d’ingresso; inter-venti che possiamo riscontrare nella struttu-ra della chiesa trecentesca (L. MEONI, Letrasformazioni del monastero dal 1500 al 1776,in Il ‘Paradiso’ in Pian di Ripoli: studi e ricerche
216
38
39
217
su un antico monastero, a cura di M. Gregorie G. Rocchi, Firenze, 1985, p. 51; ASF,Archivio dello Spedale di S. Maria Nuova,Monastero di S. Brigida detto del Paradiso,filza 145, cc. 146 v, r.). La relazione pastora-le del 1692 ricorda inoltre che il “luogochiamato il Capitolo” era “già anticamentela Chiesa” (ASF, Manoscritti, Minutario,175, relazione 17, c. 1).
(62) Sappiamo anche da alcuni docu-menti che nel 1396 Antonio Alberti chiesea Bonifacio IX di devolvere il complesso aicamaldolesi o agli olivetani (G. BACAREL-LI, Storia del monastero di Santa Maria e Brigi-da al Paradiso: 1392-1776, in Il ‘Paradiso’ inPian di Ripoli: studi e ricerche su un anticomonastero, a cura di M. Gregori e G. Rocchi,Firenze, 1985, pp. 21-22). Alla base di talevolontà potrebbe esserci stata sia la suainsoddisfazione verso il rigore morale divita monastica che avrebbe portato alladecisione di modificare l’assetto spazialedel monastero privilegiando la netta distin-zione dei locali destinati ai monaci e quellidestinati alle monache ed edificando unanuova chiesa con un coro per le monacheposta al di fuori della clausura femminile;sia l’insufficienza delle rendite del monaste-ro (D. MORENI, Notizie Istoriche dei contorni
di Firenze, V, Firenze, 1794, pp. 133-134); siale tensioni che si crearono tra l’Alberti eLuca di Jacopo, priore del monastero dal1396 (Bacarelli, 1985, p. 21). Nonostante larichiesta dell’Alberti, che il ponteficeaccettò solo formalmente, sappiamo che ibrigidini rimasero di fatto gli unici legitti-mi proprietari del monastero (Bacarelli,1985, pp. 21-22).
(63) Ad avvalorare l’ipotesi dellavolontà di distinguere nettamente gli spazic’è il documentato insediamento deimonaci nell’antico palagio albertiano nel1404 (Bacarelli, 1985, pp. 22-23); da questomomento tutti gli ambienti intorno al chio-stro piccolo (precedentemente destinati aimonaci) e a quello grande e quelli adia-centi alla cappella rimasero ad uso dellesole monache; ne consegue che la cappellarimase confinata in questo spazio destinatoesclusivamente ad esse. Dal 1594, un annodopo la bolla di Clemente VIII che invitavai monaci a trasferirsi in un altro luogodella Diocesi fiorentina, il monastero fuabitato per due anni solamente dallemonache, dopodiché nei locali del mona-stero maschile si insediarono i preti (L.MEONI, Il patrimonio privato negletto, in Lacittà degli Uffizi: i musei del futuro, a cura diG. Bacarelli, Firenze, 1982, p. 140).
(64) Cfr. nota 61.
(65) La presenza di un comunichino èoggi testimoniata dall’affresco tardo cin-quecentesco che ne decora il profilo e chenasconde in parte la scena della Cattura diCristo. Inoltre gli studi archivistici di LuciaMeoni ci informano che il 31 dicembre1516 venne pagato Niccolò di Giovanni“fabro in sul Ponte Vecchio [...] per piùferri minuti per le mense e le finestre dellecomunioni”, ipotizzando che questi lavorifurono realizzati nel locale denominatonella pianta del 1781 come “Stanza dellaComunione” che si affaccia nella nostracappella (Meoni, 1985, p. 54; ASF, Archi-vio dello Spedale di S. Maria Nuova, Mona-
stero di S. Brigida detto del Paradiso, filza291, c. 385 v). Infine la visita pastorale del1692 ricorda “la finestrella della comunioneche risponde nel luogo chiamato il Capito-lo” (ASF, Manoscritti, Minutario, 175, rela-zione 17, c. 1).
(66) Sempre grazie alle ricerche di LuciaMeoni sappiamo che alcuni pagamenti quat-trocenteschi ricordano la chiesa dei monaci,distinta da quella del monastero, e che essaè di nuovo menzionata in riferimento adalcuni lavori eseguiti tra il 1611 e il 1614(Meoni, 1985, p. 56). La nostra cappella sitrova all’interno della clausura femminilema in prossimità della parte del monasterodestinata ai monaci; non escludiamo quindiche l’ambiente fosse usato anche dai mona-ci per celebrare la messa alla quale le mona-che potevano assistere ed essere comunicateattraverso il comunichino.
(67) Nel 1734 la bolla Universae Ecclesiaeprocurationem emanata da Clemente XIIvietò la consacrazione di nuove monache(Manni, 1742, p. 79; Moreni, 1794, p. 167;Passerini, 1870, p. 199) e nel 1776 il mona-stero venne definitivamente soppresso.
(68) Chiodo, 1999, p. 93.
(69) Boskovits, 1968, p. 4.
(70) R. OFFNER, Studies in Florentinepainting: the fourteenth century, New York,1927, p. 84.
(71) Boskovits, 1968, p. 6.
(72) E. FAHY, On Lorenzo di Niccolò, in“Apollo”, CVIII, 1978, pp. 374-381.
(73) Fahy, 1978, pp. 374-381.
(74) A. TARTUFERI, s. v. Gerini, Niccolòdi Pietro in Enciclopedia dell’arte medievale, VI,Roma, 1996, p. 552.
(75) Tartuferi, 1996, p. 552.
38. Niccolò di Pietro Gerini e botte-ga, Paradiso, Firenze, Paradiso degliAlberti (particolare).
39. Lorenzo di Niccolò, Santa Fina,San Gimignano, Museo Civico (parti-colare).