La pala dei Capuccini. Un dipinto ritrovato di Augusto Majani per Budrio
Transcript of La pala dei Capuccini. Un dipinto ritrovato di Augusto Majani per Budrio
La pala dei CappucciniUn dipinto ritrovato di Augusto Majani per Budrio
BACCHILEGA EDITORE
Euro 22,009 788896 328330
ISBN 978-88-96328-33-0
La pala dei Cappuccini BACCH
ILEGA ED
ITORE
La pala dei CappucciniUn dipinto di Augusto Majani per Budrio
Presentazione del dipinto
Bologna, Accademia di Belle Arti,17 novembre - 29 novembre 2011
Budrio, Sala rosa di Palazzo Medosi Fracassati,3 dicembre 2011 - 6 gennaio 2012
Promotori
Comune di Budrio
Con la collaborazione di
Con il patrocinio di
Coordinamento progettoLorella Grossi
Restauro a cura diLaboratorio di Restauro dei Dipinti su Tela e Tavola -
Accademia di Belle Arti di Bologna
Assistenza tecnicaFabio Dalla Valle, Gennario Cantelmi, Antonio Palermo,
Andrea Trivellone
Pubblicazionerealizzata con il contributo di
Pubblicazione a cura di Elena Rossoni
Testi diCesare FantazziniGiuseppe Virelli
Marilena GamberiniElena Rossoni
Referenze fotogra!cheComune di Budrio, !g. 1; tavv. 2, 3, 5, 10
Vittorio Bonaga !gg. 6, 7; tav. 8Archivio della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici
ed Etnoantropologici di Bologna, !gg. 5, 6, 11, 12Marco Baldassari, tavv. 1, 19, 29
Danilo Mattioli, tav. 7Bologna, Archivio di Stato, tavv. 15-18
Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, !g. 10Bologna, Museo d’Arte Moderna, tavv. 4, 6Bologna, Collezioni d’Arte e di Storia della
Fondazione Cassa di Risparmio, !g. 9Bologna, Archivio della chiesa del Sacro Cuore,
!g. 4, tavv. 11, 12, 13, 14
RingraziamentiMiledi Bentivogli; Don Ferdinando Colombo; Daniela
Dalmonte; Rosa D’Amico; Giuseppe Federici; Pietro Lenzini; Padre Antonio Maggioli; Ciro Testoni; Padre
Floriano Zanarini
ISBN978-88-96328-37-8
© 2011 Bacchilega Editorevia Emilia, 25 - Imola
tel. 0542 31208 - fax 0542 31240www.bacchilegaeditore.it
e-mail: [email protected]@bacchilegaeditore.it
Stampato in Italia da Galeati Industrie Gra!che Srl (Imola, ottobre 2011)
copertinaA. Majani, Sacra Famiglia con San Francesco d’Assisi
I diritti di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adatta-mento totale o parziale con qualsiasi mezzo
(compresi i micro!lm e le copie fotostatiche) sono riservati.
La pala dei CappucciniUn dipinto di Augusto Majani per Budrio
A cura di Elena Rossoni
BACCHILEGA EDITORE
4
Sommario
5 Introduzione
9 Una felice esperienzaRitrovata una pala di Augusto Majani che si riteneva perdutaCesare Fantazzini
15 Un “altro” MajaniLa pala della Sacra Famiglia con San Francesco d’Assisi per la chiesa dei Cappuccini di BudrioGiuseppe Virelli
25 Le chiese dei Cappuccini a BudrioUn’indagine per un patrimonio artistico dispersoElena Rossoni
47 Il restauro della pala dei CappucciniMarilena Gamberini
15
Un “altro” MajaniLa pala della Sacra Famiglia con San Francesco d’Assisi per la chiesa dei Cappuccini di Budrio
Giuseppe Virelli
La fama del noto artista budriese Augusto Majani è legata ancora oggi per la maggior parte del grande pubblico alla sua attività di disegnatore e caricaturista d’ingegno, bona-rio e arguto testimone della vita bolognese, e non solo, a cavallo fra Ottocento e Nove-cento. Infatti, seppure la critica abbia rico-nosciuto armai da tempo e unanimemente un alto valore artistico alle sue tele, sono re-lativamente pochi i contributi importanti ed esaurienti specificatamente dedicati all’ atti-vità pittorica dell’ artista. Tra questi ultimi, ricordiamo i noti scritti di Italo Cinti e Au-gusto Morelli (1947)1, quelli sempre di Cinti insieme ad Angiolino Boriani (1960)2 men-tre, in tempi più recenti, l’ importante saggio di Antonio Storelli pubblicato all’ interno del bel catalogo edito in occasione della notevole mostra Augusto Majani, pittore, illustratore e uomo di spirito (Budrio 2002)3 e il contri-buto di Romeo e Dante Forni per il volume Ritorno a Budrio. L’ arte di Augusto Majani (1867-1959), pubblicazione legata alla serie di manifestazioni dedicate all’ artista budriese nel 20074. In!ne, è da ricordare l’ ultima mostra promossa dal Comune di Budrio nel 2011 e a cura di Ciro Testoni, Majani (Nasìca) ritrovato, importante esposizione che ha presentato opere dell’ artista (gra!ca e pittura) di collezione pri-vata in parte inedite e di grande interesse5. In tutti questi apporti critici, per altro im-prescindibili per una comprensione del Ma-jani pittore, manca però proprio un’ analisi approfondita relativa alla pala dedicata alla Sacra Famiglia con San Francesco d’Assisi e que-sto per gli ovvi motivi contingenti legati alla
sua scomparsa dalla visione pubblica per più di mezzo secolo. Con la recente acquisizione sul mercato antiquario di questa opera dunque, avvenuta grazie all’ impegno e alla sensibilità dei padri Cappuccini di Bologna6, si aggiunge così non solo un tassello importante alla ‘gal-leria’ personale di Augusto Majani, ma si apre contemporaneamente la possibilità di pote-re fare alcune nuove ri"essioni circa l’ operato dell’ artista (tav. 1). A questo riguardo, è utile procedere per gradi di approfondimento successivi, partendo pre-cisamente dalla vicenda legata alla misteriosa sparizione della pala dalla chiesa dei Cappucci-ni di Budrio, cercando di sciogliere quell’ ingar-bugliata matassa di dati e di notizie di cui siamo in possesso, in modo tale da poterne ricavare utili indicazioni per successive e più speci!che considerazioni di merito. Dell’ esistenza di quest’opera, della sua commit-tenza e della sua originaria collocazione si sa-peva già da tempo, ma ignota era !no ad ora la sua condizione attuale. Sino a poco tempo fa, infatti, questa pala era nota solo attraverso una sua riproduzione fotogra!ca !rmata dallo stesso artista, facente parte del così detto “Al-bum Majani” (tav. 2)7, mentre completamente avvolta dal mistero rimanevano le circostanze legate alla sua scomparsa e i suoi successivi spo-stamenti, tanto che nel tempo le vicende ad essa legata avevano assunto addirittura i connotati di un piccolo giallo. Tutti i più autorevoli criti-ci di Majani, infatti, asserivano in più parti che la suddetta pala fosse stata rimossa quasi im-mediatamente dopo la sua collocazione presso l’ altare maggiore della piccola chiesa annessa al
16
convento budriese, perché, secondo il resocon-to di Boriani,
avendo egli preso per modella colei che era la sua le-gittima !danzata e divenne poi la sua legittima mo-glie, vi fu chi ebbe modo di malignare, di trovarvi quasi motivo di scandalo, ed un bel giorno, andando in chiesa, non vide più il suo quadro sull’ altare8.
Secondo Codicé-Pinelli questo episodio avrebbe naturalmente amareggiato profondamente l’ ar-tista il quale però, cedendo al suo animo gentile e garbato, non lo riportò nel suo Ricordi fra due secoli9.In realtà, se Majani stesso non menziona questa ‘spiacevole circostanza’ nella sua autobiogra!a è perché la realtà dei fatti potrebbe essere al-quanto di#erente. Dal Campione del Convento dei Cappuccini di Budrio10, infatti, risulta che la pala, commissionata al giovane pittore dal Baro-ne Federico Dalla Noce11, fu collocata sull’ alta-re maggiore della chiesa verosimilmente già al momento della sua consacrazione, avvenuta il 23 gennaio del 1895, e qui rimase esposta alla venerazione dei fedeli per “parecchi anni”12. Suc-cessivamente venne spostata sopra la porta della chiesa perché, a detta del frate che annotò tale trasferimento, “da quel quadro l’ arte era stata bandita a#atto”13. In seguito, venne nuovamente spostata per altre due volte: prima nel coro14 e poi de!nitivamente allocata nei corridoi dell’ an-nesso convento15. In!ne, nel settembre del 1942 Majani stesso chiese ai frati Cappuccini di potere riavere indietro il dipinto, perché era suo espres-so desiderio “ritoccarlo gratuitamente e a suo tempo restituirlo”16. Così avvenne e il 3 novem-bre dello stesso anno l’ artista informò i frati del convento di avere ricevuto dal loro confratello Francesco da Imola la pala “intatta” presso la sua residenza di Casalecchio di Reno, residenza che purtroppo subì un bombardamento nel 194217. Recentemente è stata rintracciata presso l’ archi-vio dei frati Cappuccini di Bologna una seconda riproduzione fotogra!ca del dipinto (identica a quella conservata a Budrio nell’ “Album Majani”) sul retro della quale è riportata la seguente noti-zia: “Fu consegnato il quadro al Pittore nel 1943 che desiderava di ripulirlo. Venne colpito nella casa sua di Casalecchio di Reno da un bombar-
damento aereo (...)”. Seppure la data ivi indicata non corrisponda perfettamente con quella ri-portata nel Campione del Convento di Budrio, anche questo documento risulta molto impor-tante perché rappresenta un’ulteriore conferma circa l’ e#ettiva riconsegna della pala all’ artista budriese e in più con la medesima !nalità18.La volontà dell’ artista di ritoccare questa sua opera a distanza di quasi cinquant’anni non deve stupire. Majani, infatti, era solito ritornare più e più volte sulla stessa tela anche a intervalli di tempo molto lunghi, magari con interventi an-che pesanti. Come a#erma Cinti, infatti, spesso l’ artista eccedeva in questo suo a$ato tanto che molto spesso “non si peritava di fare aggiunte di strisce o di fasce anche larghe al quadro”19. A partire da questo momento però, le prove relative all’ ubicazione della pala dedicata alla Sacra Famiglia diventano, per cosi dire, di na-tura indiziaria. In un primo momento il Padre Provinciale dei Cappuccini, Mauro da Griz-zana, espresse l’ idea di trasferire l’ opera, una volta riconsegnata, a Bologna presso la Pina-coteca dell’ ordine, perché lì erano conservati i “migliori quadri, oggetti ecc. dei Conventi della Provincia”20; senonché Majani non restituì mai la pala ai frati. Infatti, se è vero che negli atti del Congresso Eucaristico di Budrio del 1946 la pala viene elencata fra i beni posseduti dal Con-vento21, una nota del Campione del convento di Budrio recante la data 1952 ne attesta ancora l’ ubicazione nella residenza bolognese dell’ ar-tista (o in quella di Casalecchio di Reno)22. A quella data però l’ ottantacinquenne Majani ri-siedeva ormai da tempo a Buttrio, in provincia di Udine, presso la !glia Franca ed è verosimile che l’ artista avesse portato con sé l’ opera. A so-stegno di tale ipotesi, si può citare ancora una volta Codicè-Pinelli il quale, anche lui credendo all’ episodio dello ‘scandalo’ legato all’ identi!ca-zione fra il volto della Madonna e quella della !-danzata e poi moglie dell’ artista, Olga Lugaresi, così scrive nel 1968: “Così Budrio fu privato di questo notevole dipinto del Majani attualmente conservato dalla !glia Franca a Buttrio”23. Una conferma ulteriore e, insieme, ultima debole te-stimonianza del lungo cammino percorso dalla pala, la si ritrova inoltre nella già citata fotogra-
17
!a dell’ opera appartenente ai frati Cappuccini di Bologna. Sul retro di quest’ultima vi è scritto: “È stato nel 1976 donato ai Frati Minori Osservan-ti di ... [sic] dalla !glia del pittore Majani”. Chi ha scritto questo appunto purtroppo ha omesso di indicare il luogo di destinazione dell’ opera (molto probabilmente perché egli stesso non lo sapeva con esattezza), ma in ogni modo tale documento depone ulteriormente a favore della tesi che Majani avesse trattenuto per sé la pro-pria opera; da questa data, e sino alla recente ri-comparsa sul mercato antiquario, le tracce della pala si perdono completamente.Ora, come già detto sopra, ricostruire le vicende legate alle varie peregrinazioni della pala della Sacra Famiglia non costituisce solo una piccola caccia al tesoro, volta ad aggiungere una tesse-ra importante al mosaico delle opere dell’ artista di Budrio, né tanto meno un mero esercizio di stampo !lologico !ne a sé stesso, ma permette altresì di poter fare delle nuove considerazioni circa l’ artista Majani nel suo complesso ossia, di allargarne gli orizzonti culturali tradizional-mente riconosciutili e di capirne meglio alcuni aspetti sino ad ora non del tutto indagati.Infatti, come posizionare stilisticamente questa pala all’ interno del percorso artistico di Majani? In quale sequenza di opere inserirla e in qua-le invece escluderla? La critica, anche quella più quali!cata sull’ opera del maestro budriese, si è limitata sino ad ora a giudizi vaghi e di carattere generale complice, bisogna ancora una volta ri-cordare, l’ impossibilità materiale di potere vedere da vicino questa tela. Morelli, ad esempio, parla solamente di “un’opera di pregio”24, mentre Boria-ni, in maniera altrettanto concisa, si limita a dire “che gli riuscì bene”25; Codicé-Pinelli si concede qualche ri"essione in più e riporta che appena ricevuto l’ incarico Majani “si mise all’ opera con grande fervore e dipinse una bella pala […] uma-namente commovente e resa sacra da una mae-stosità tenera e luminosa”26. Più recentemente Storelli, che però formula il suo giudizio a%dan-dosi solamente alla fotogra!a del già menzionato “Album Majani”, a#erma che si tratta di un’opera “d’impostazione piuttosto tradizionale”27.Oggi invece, che abbiamo la fortuna di poterla vedere dal vero e, soprattutto, dopo il recente e
ben riuscito restauro condotto ad opera del la-boratorio di restauro dei dipinti su tela e tavola dell’ Accademia di Belle Arti di Bologna diretto da Marilena Gamberini28, possiamo, per così dire, ‘aggiustare il tiro’ e fare diverse e più ampie considerazioni. Innanzi tutto, la prima ri"essio-ne che si deve fare è che la presente pala della Sacra Famiglia si presenta, all’ interno della pro-duzione nota dell’ artista budriese, come un uni-cum, un pezzo eccezionale (nel senso letterale del termine) che non trova, stilisticamente, altri esempi simili in opere coeve come, ad esempio, i famosi E!etto di luna nella campagna romana (1894) 29, E!etto di Luna (1895) 30, Ritratto di Quirico Filopanti (1895)31, Egloga (1896) 32 o il celeberrimo Mentana; I Garibaldini (1897) (tav. 5) 33, esposti con successo di pubblico e di critica in varie esposizioni34.Medesimo discorso vale anche per quei lavori in cui Majani a#ronta in maniera più o meno diret-ta il tema religioso. Opere come Vittime. Lascia-te che i fanciulli vengano a me (1896)35, I disoc-cupati. Ama il prossimo tuo come te stesso (1896) (tav. 4) 36, L’ ombra della Croce (1897-1947)37, o i più tardi Consummatum est (1911)38, il trittico Visioni Cristiane (La notte di Natale – Il Martirio – Alba del cristianesimo 1914) 39, Il Salvatore del mondo (1922) (tav. 3)40 e la grande pala dedicata a San Giovanni Bosco alla Chiesa del Sacro Cuore di Bologna (1937) (tav. 11)41, non hanno infatti alcuna a%nità con la pala dedicata alla Sacra Fa-miglia, né a livello compositivo, né tanto meno da un punto di vista stilistico formale.Eppure quest’opera non nasce dal pennello di Majani dal nulla. Pur riconoscendone l’ unicità, essa è comunque frutto di profonde meditazioni e attenti studi compiuti dall’ artista che ri"ettono le radici culturali maturate da Majani !no a quel momento in seno all’ ambiente in cui viveva. In questo senso quindi, quando Storelli sostiene che questa pala presenta un’impostazione “tra-dizionale” non sbaglia a#atto, a condizione però di recepire questo aggettivo correttamente e di valutarne di conseguenza la giusta portata. Se per tradizionale s’intende ‘consuetudinÈ o ‘re-gola abitualÈ, allora siamo senz’altro di fronte a un vicolo cieco; se invece lo interpretiamo più correttamente nel suo signi!cato etimologico
18
ossia ‘trasmissionÈ (dal lat. traditio–onis), allo-ra possiamo procedere con la nostra indagine su una strada ricca di spunti di ri"essione. Per comprendere meglio la natura della Sacra Fa-miglia, dunque, si deve partire da lontano, dagli anni della formazione di Majani, ossia da quel periodo nel quale, come ci suggerisce ancora una volta Cinti, “s’intrecciano germi molteplici, il cui sviluppo si compenetra e si compendia nel-la maturità”42. In altre parole, è necessario ana-lizzare, seppur brevemente, l’ ambiente e il clima in cui viveva e respirava Majani quando anco-ra era studente alla Regia Accademia della città felsinea e frequentava, parallelamente, gli artisti operanti fuori di essa. Inoltre, occorrerà anche tenere conto, almeno in parte, del successivo soggiorno romano dell’ artista terminato proprio a ridosso del fatidico 1895, l’ anno di esecuzione della pala.All’ Accademia Majani ebbe come insegnanti An-tonio Muzzi (1815-1894) per il corso di disegno di !gura, Antonio Puccinelli (1822-1897) per il corso di pittura, Salvino Salvini (1824-1899) per quello di scultura, Tito Azzolini (1837-1907) per il corso di architettura, Gaetano Lodi (1830-1886) e, in!ne, Augusto Sezanne (1856-1935) per il corso di ornato. Muzzi, che era a !ne carriera quando Augusto Majani entrò in Accademia, non rappresentò per l’ artista budriese un punto di riferimento fondamentale per i suoi successivi sviluppi arti-stici. L’ anziano insegnante infatti, abile ritrattista e uno dei più valenti pittori di storia bolognesi, era legato a una visione dell’ arte oramai sorpas-sata e non poteva più fornire ai suoi giovani al-lievi quegli stimoli utili per intraprendere nuove strade più consone alla loro sensibilità contem-poranea. Lo stesso Majani d’altronde lo ricorda nel suo libro con bonaria ironia43.Un ruolo molto importante per la formazio-ne delle giovani generazioni, lo svolse invece il Puccinelli. Come ha dimostrato Alessandra Borgogelli, infatti, quest’ultimo, chiamato nel 1861 a ricoprire la cattedra di pittura, intrapre-se all’ interno della riordinata Regia Accademia di Belle Arti di Bologna una salutare opera di rinnovamento introducendo quelle novità del Purismo sino ad allora avversate con forza in
favore di un trito revivalismo del Seicento lo-cale44. Al centro dei suoi insegnamenti c’era la volontà di un ritorno “a una semplicità di im-pianto e a una sobrietà di temi cromatici”45, vale a dire, egli introdusse nella città felsinea quel gusto arcaizzante, stilisticamente di stam-po neo-quattrocentesco, che sarà una delle vie di partenza battute da quella parte dell’ arte contemporanea fondata sul concetto di sinte-si. Puccinelli, sottolinea ancora Borgogelli, non ebbe vita facile all’ interno dell’ accademia bolo-gnese perché osteggiato dai colleghi più conser-vatori, ma i suoi giovani alunni più talentuosi dell’ epoca accolsero il suo messaggio, portando così avanti quel processo di svecchiamento del-la cultura artistica locale46. Tra questi si posso-no annoverare Luigi Busi (1838-1884), Ra#aele Faccioli (1845-1916), Luigi Serra (1846-1888) e Mario de Maria (1852-1924), artisti tutti molto apprezzati non a caso proprio da Majani47. La !gura di Serra in particolare è molto im-portante ai !ni del presente scritto, in quanto
Fig. 5 Francesco Raibolini detto Francia, Madonna con Bambino in trono e i santi Paolo, Francesco e Giovannino (Pala Scappi), Bologna, Pinacoteca Nazionale
19
l’ artista budriese nelle sue memorie si dilunga particolarmente sulla sua persona, citando addi-rittura un estratto dell’ orazione funebre fatta in suo onore dal professore Enrico Panzacchi nel 188848. Cosa più importante però, Majani testi-monia nel suo scritto di avere assistito da sot-to le impalcature alla realizzazione del famoso Irnerio che glossa le antiche leggi di Giustiniano (1886)49, opera quest’ultima particolarmente si-gni!cativa nel panorama dell’ arte bolognese di quegli anni quale alto esempio di una pittura non solo dal contenuto medioevaleggiante, ma anche in perfetto stile neo-quattrocentesco (tav. 6)50. Di Serra, inoltre, si deve qui ricordare un altro dipinto particolarmente signi!cativo, spe-cie per il tema trattato a%ne a quello di Majani, l’ olio su tela l’Apparizione della Vergine ai santi Francesco e Bonaventura (1882)51. Destinato ini-zialmente al convento del Cestello di Bologna, il dipinto venne presentato all’ Esposizione Nazio-nale di Belle Arti di Bologna del 1888 suscitando molto interesse da parte della critica52. Come si evince da alcune lettere dell’ artista bolognese in-dirizzate all’ amico Enrico Barbieri, egli s’ispirò apertamente per la realizzazione del suo quadro alla tradizione iconogra!ca quattrocentesca, in modo particolare per quel che riguarda la com-posizione e i ‘tipi’ dei Santi53.Da questa prima premessa, risulta allora più chiara parte dell’origine della pala della Sacra famiglia. L’ impostazione generale dell’ opera, di fatto, richiama esplicitamente i modelli dell’ arte sacra italiana del Quattrocento. L’ architettura complessiva della composizione infatti, con la !gura della Madonna collocata in posizione ri-gidamente centrale seduta su un trono rialzato e con un drappo retrostante a chiudere lo sfondo, è tipica della pittura della seconda metà del quin-dicesimo secolo, in particolare di area padana. Tra gli esempi più importanti si possono ricor-dare la famosa Pala di San Cassiano di Antonello da Messina54, la Pala Portuense di Ercole dÈ Ro-berti55 e persino la nota Pala di Castelfranco di Giorgione56; per quanto riguarda invece i modelli speci!catamente emiliani, si possono qui citare la Pala Scappi di Francesco Francia (!g. 5)57 e la pala della Madonna col Bambino in trono tra i santi Petronio e Tecla di Lorenzo Costa58.
Ovviamente, i riferimenti a queste opere sono da intendersi solo in senso generale e non come citazioni dirette da parte dell’ artista budriese, tanto è vero che la somiglianza fra la pala del-la Sacra Famiglia e queste ultime è riscontrabile più nell’ insieme che non nelle singole parti.Detto questo, non possiamo però de!nire l’ ope-ra di Majani un dipinto interamente ‘neo-rina-scimentalÈ. Qualcosa difatti sfugge ancora a una comprensione profonda di questa pala e sarà quindi utile prendere in considerazione anche altri fattori, riguardanti sempre la formazione dell’ artista, per potere procedere verso un’analisi più esauriente.L’ altra personalità su cui concentrare la no-stra attenzione ora è quindi Augusto Sezanne. Quest’ultimo, di poco più grande dell’ artista budriese, fu, come già ricordato, il suo docen-te di ornato. Il “professor direi”59 è rievocato da Majani come “pittore di tenui, delicati e poetici paesaggi, incisore di pregevoli acqueforti, dise-gnatore di tante eleganti, squisitissime illustra-zioni”60. Oltre al ruolo d’insegnante però, Sezan-ne risulta essere importante per Majani anche come tramite tra il mondo artistico istituzionale e quello operante al di fuori dalle rigide maglie dell’ Accademia. Sezanne infatti era, come noto, in stretta comunione con altre personalità ar-tistiche molto importanti della città, primo fra tutti Alfonso Rubbiani (1848-1913), il celebre ‘rifondatorÈ della Bologna medievale61. Questo ultimo, a dire il vero, era probabilmente già co-nosciuto dal giovane artista in quanto, proprio a Budrio, Rubbiani aveva svolto un ruolo di primo piano sia come politico, essendo stato consiglie-re comunale dal 1879 al 1889 e più volte assesso-re e vicesindaco62, sia come ideatore e regista di una serie d’interventi edilizi più o meno impor-tanti, primo fra tutti il rifacimento del Palazzo del Municipio (in collaborazione con l’ ingegne-re Luigi Menarini e il pittore Achille Casanova) (!g. 6, tav. 8)63.In generale l’ opera di Rubbiani e della sua fa-mosa ‘Gilda’, ispirata a una sorta di reinvenzione dell’ arte medievale sulla scorta sia delle teorie dell’ architetto francese Viollet-le-Duc (1814-1879) che sugli esempi proposti dai Prera#aelliti, non lascia profonde e manifeste tracce nell’ ope-
20
ra pittorica del Majani maturo, ma nel caso tut-to particolare della pala per i Cappuccini invece una certa in"uenza è alquanto ravvisabile. Infat-ti, lo stile prera#aellita !ltrato a Bologna grazie appunto a Rubbiani e ai suoi sodali (e tra questi lo stesso Augusto Sezanne)64, bene si concilia con quello spirito purista introdotto, come già ricordato, dal Puccinelli nella locale Accademia. Entrambi, di fatto, puntano su quel recupero di uno stile semplice e sintetico di stampo neoquat-trocentesco di cui si è parlato sopra. In altre pa-role, lo spirito ‘arcaizzantÈ operante a Bologna, arrivato in tempi e per vie diverse, trova negli ultimi anni dell’ Ottocento un crescendo di con-sensi, anche se variamente interpretato. Lo stes-so Cinti del resto riconosce questo legame tra i vari artisti ‘primitivisti’, mettendo in comunione proprio i Prera#aelliti e Majani (oltre a Previati e a Segantini). Scrive il critico:
le epoche si agganciano con mille !li sotterranei, e gli artisti e i poeti spaesati nella loro età, non sono che le radici lontane di quella veniente. [...] Dante Gabriel Rossetti e i prera#aelliti, il nostro Previati, certo Segantini, Majani stesso, sono dei solitari an-nunciatori di una grandissima epoca65.
Tornando ora alla Sacra Famiglia, oltre ad ave-re qui un’ulteriore conferma circa l’ ascenden-za quattrocentesca dell’ impostazione generale dell’ opera, possiamo anche trovare delle corri-spondenze più precise di ordine stilistico icono-gra!co per quanto riguarda alcuni particolari presenti nel dipinto. Si osservino, ad esempio, le decorazioni a mosaico del trono della Vergine e della parte bassa del muro di fondo o, ancora, i gigli posti in primo piano. Questi singoli ele-menti fanno eco sia a quelli realizzati dai Pre-ra#aelliti (in particolare quelli di Rossetti e di Burne-Jones), sia alle decorazioni eseguite nel medesimo periodo dagli artisti operanti nel can-tiere di San Francesco a Bologna sotto la guida di Rubbiani. Inoltre si deve qui menzionare an-cora una volta il dipinto di Serra l’Apparizione della Vergine ai santi Francesco e Bonaventura. Come si può rilevare da alcuni studi di parti-colari conservati al Gabinetto Disegni e Stampe della Pinacoteca Nazionale di Bologna66, Majani sembra quasi ‘ricalcarÈ perfettamente i gigli del più anziano artista (tav. 7)67.Un discorso analogo a quello appena fatto, si può ripetere anche per quanto riguarda i possi-
Fig. 6 Palazzo Comunale di Budrio
21
bili in"ussi artistici ricevuti da Majani durante i sei anni trascorsi a Roma (dal 1889 al 1894) per completare gli studi alla Scuola libera del nudo presso l’ Accademia di Belle Arti di via Ripet-ta. La frequentazione di questa istituzione però non pare avere inciso particolarmente sul gio-vane artista, tanto che lui stesso la nomina solo di passaggio nel suo testo. L’ unico artista su cui Majani spende qualche parola è, non a caso, il senese Cesare Maccari (1840-1919), un allievo del pittore Luigi Mussini, autore dei celebri af-freschi della Sala Gialla di Palazzo Madama, oggi “Sala Maccari” (1882-88)68, e di altre importanti opere di chiara impronta purista69. Più congeniale e ricco d’idee e di suggerimenti utili per la formazione dell’ artista di Budrio ri-sulta essere invece l’ ambiente del Circolo degli Artisti di via Margutta. Qui Majani entra in con-tatto, molto probabilmente grazie al già citato collega e conterraneo Mario de Maria (Marius Pictor), con il gruppo di artisti guidato da Nino Costa riuniti nella società di pittori “In Arte Li-bertas” fondata nel 1886. Tra i protagonisti di questo sodalizio, Majani ricorda in modo par-ticolare Enrico Coleman (1846-1911), Onorato Carlandi (1948-1939) e Giulio Aristide Sartorio (1960-1932)70 i quali, seppur in modi molto di-versi sia rispetto alla ‘Gilda’ bolognese sia fra di loro, ra#orzano e rinnovano lo slancio verista di origine macchiaiola (e quindi di ascendenza purista) conciliandolo con un a$ato lirico e ide-alizzante derivato, oltre che da Ruysdael, Corot, Constable, Turner e in generale da tutti i pae-saggisti romantici della scuola francese e inglese, proprio dagli esempi della pittura prera#aellita. Costa in particolare, che è il decano e il leader riconosciuto del gruppo, insiste infatti su un ri-torno alla pittura dei ‘primitivi’ tanto che, come osserva il critico Diego Martelli, “talvolta par che si metta gli occhiali del Quattrocento per il grande amore che porta a quell’ epoca onesta”71.Detto questo, e sempre in riferimento alle ‘ori-gini’ della pala della Sacra Famiglia, bisogna quindi riconoscere che Majani arriva all’ appun-tamento romano già ben preparato ad assorbi-re quelle lezioni sul primitivismo che metterà in atto nel suo dipinto. Altre, difatti, saranno le suggestioni artistiche legate al soggiorno roma-
no che l’ artista elaborerà sin da subito in modi del tutto personali come, ad esempio, la predile-zione per i paesaggi serotini (derivati soprattutto da De Maria) e, più in generale, quella capacità di far convivere nel quadro le due opposte ten-denze del verismo e dell’ idealismo-spirituale72. Quest’ultima considerazione in particolare è molto importante in quanto ci permette di fare ora alcune ri"essioni più speci!che sulla Sacra Famiglia inerenti la sua qualità interna. Se si os-serva attentamente questo dipinto, infatti, si può rilevare una certa disarmonia fra le varie parti che lo compongono e questo proprio perché Ma-jani qui non riesce a fondere in sintesi le due ten-sioni contrarie del verismo e dell’ idealismo ma, più semplicemente, si limita a giustapporle. Vale a dire, l’ artista tratta i diversi personaggi della pala con uno spirito molto diverso, tanto che la prima impressione che si ha guardandola è quella di tro-varsi di fronte a un’opera realizzata ‘a più mani’. A un trattamento verista, ad esempio, è riconduci-bile la !gura del San Giuseppe ritratto di pro!lo e il San Francesco stigmatizzato inginocchiato da-vanti al trono (entrambi quali!cati da una precisa ricerca di caratterizzazione !siognomica), men-tre le immagini della Madonna e del Bambino, elaborati con un segno molto più astratto, asse-condano la vocazione idealista dell’ artista.Fatte queste precisazioni, resta ora da risponde-re al primo e forse più importante quesito che ci siamo posti indirettamente sin dall’ inizio di questo scritto: perché Majani adotta questo sti-le neo-quattrocentesco che, seppure trova come abbiamo cercato di dimostrare una sua giusti!-cazione, non ha uguali nel resto del suo reper-torio e, soprattutto, nella sua produzione coeva?Prima di tentare di rispondere a questa doman-da, è utile prendere in esame brevemente un’al-tra opera di un artista molto vicino a Majani, il dipinto La Madonna col Bambino e i Santi fran-cescani Lorenzo da Brindisi, Felice da Cantalice e Fedele da Sigmaringa di Flavio Bertelli (1865-1941) (tav. 9)73. La disamina di questa tela s’im-pone con forza alla nostra attenzione in quanto anch’essa fu commissionata nel 1895 dal barone Federico Dalla Noce e destinata al medesimo convento dei frati Cappuccini di Budrio, esat-tamente all’ altare della seconda cappella laterale
22
dedicata ai Santi dell’ Ordine 74. Da un punto di vista della composizione e dell’ iconogra!a, an-che il quadro di Bertelli ricalca le opere religio-se del Quattrocento (centralità della !gura della Vergine incastonata in una nicchia, il grande nimbo dorato alle sue spalle, il bambino con le braccia aperte a rappresentare la futura croci!s-sione e i tre santi posti ai suoi piedi di cui uno guarda verso lo spettatore), tuttavia molto diver-so è lo stile con cui esso venne realizzato. Bertel-li, infatti, a di#erenza di Majani, adotta per la sua opera l’ allora ‘nuovissima’ tecnica divisionista che gli permette di modellare le sue !gure con una sintesi molto più potente rispetto a quella del suo collega, tanto che la Madonna, il Gesù bambino e i Santi da lui realizzati si stagliano nel ridottissimo spazio circostante come delle sem-plici e ben delineate silhouette. Da un rapido confronto fra quest’ultima opera e la Sacra Famiglia dunque, si rileva subito la po-
sizione leggermente ‘attardata’ di Majani rispetto a quella del suo collega. Se è vero infatti, come abbiamo visto, che il ‘nuovo’ nella realtà artistica bolognese passava principalmente per il ‘ritorno all’ antico’ (Puccinelli, Serra, Rubbiani e alla sua ‘Gilda’ in primis), è altrettanto certo che l’ avan-guardia di allora aveva preso una strada diversa, quella appunto del divisionismo. Eppure, come si sa, anche l’ artista budriese sapeva esprimersi in quelle date con questo tipo di linguaggio pit-torico come testimoniano, ad esempio, i già ci-tati Vittime. Lasciate che i fanciulli vengano a me (1896) e I disoccupati. Ama il prossimo tuo come te stesso (1896) in cui Majani sperimenta proprio “quell’ uso di moderato divisionismo, che allora voleva dire modernità”75.Quest’ultima constatazione quindi complica ul-teriormente la questione e rende ancora più dif-!cile dare una risposta sicura e ferma sul perché di questa opera ‘anomala’ di Majani. Meglio al-
Fig. 7: Veduta della chiesa della Sacra Famiglia di Nazaret, detta “dei Frati”, di Budrio
23
lora a questo punto proporre solo delle ipotesi che, seppur non confortate da prove irrefutabili, hanno però un certo grado di ragionevolezza. Prendiamo in considerazione innanzitutto l’ edi-!cio a cui l’ opera di Majani era destinata. L’ archi-tettura dell’ intero complesso conventuale, realiz-zata dall’ ingegnere Francesco Gualandi valente esponente del neogotico italiano, si presenta molto sobria con mattoni a vista e con un chio-stro centrale circondato da un portico a pilastri. L’ annessa chiesa ha anch’essa un aspetto molto semplice. La pianta è a navata centrale con due profonde cappelle sul lato destro, mentre la fac-ciata è segnata da un ampio fornice a tutto sesto sovrastato da un timpano che riecheggiano vaga-mente i modelli albertiani (come, ad esempio, la chiesa di S. Andrea di Mantova del 1472) (!g. 7). Questa architettura dunque avrebbe potuto indi-rizzare la scelta stilistica di Majani, il quale, an-cora una volta in accordo ideale con il pensiero rubbianesco, avrebbe concepito così un’opera ‘in tema’, a%ne cioè all’ ambiente che l’ avrebbe ospi-tata. Accanto a questa tesi inoltre, si può ugual-mente avanzare l’ idea che l’ opera dell’ artista sia stata pensata anche in sintonia con la vocazione alla semplicità implicita in ogni opera riferibile alla tradizione cappuccina, una concezione este-tica questa evidentemente fatta propria dal baro-ne Dalla Noce e da lui trasmessa agli artisti coin-volti nella costruzione del nuovo tempio.
Note
1 M&'())* ( C*+,* 1947.2 B&'*-+* ( C*+,* 1960.3 S,&'())* 2002, pp. 14-20; A. Storelli e C. Ugolini in Au-gusto Majani pittore 2002, pp. 21-95.4 R. e D. Forni in Ritorno a Budrio 2007.5 Majani (Nasìca) ritrovato 2011.6 Per quanto riguarda la vicenda legata al recente ritrova-mento e acquisizione dell’ opera sul mercato antiquario, si veda l’ esauriente intervento di Cesare Fantazzini in questo volume.7 Impiego questo termine prendendolo in prestito dallo studioso Storelli che nel catalogo per la già citata mostra Augusto Majani, pittore, illustratore e uomo di spirito lo usa per indicare un fondo di fotogra!e che ritraggono le ope-re più importanti eseguite dall’ artista (cfr. S,&'())* 2002, p. 20, nota 5). Questo fondo, costituito e conservato da
Majani stesso sino alla sua morte e oggi di proprietà del Comune di Budrio, risulta molto importante perché su ogni fotogra!a l’ artista annota di proprio pugno il titolo dell’ opera, la data di esecuzione, la committenza o l’ ac-quirente ed eventuali esposizioni. A proposito di questo fondo e del suo arrivo a Budrio, si veda S('.(,,* 2007, pp. 21-23.8 B&'*-+* 1960, p. 15.9 C&/*01-P*+())* 1968, p. 48; M-2-+* 1950.10 Il Campione del convento (Campione del convento di Budrio secc. XIX-XX), seppure si presenti molto confuso, con note ai margini redatte da diverse persone e spesso in date di#erenti, rappresenta in ogni modo la fonte d’infor-mazione più attendibile cui si possa riferirsi per ricostrui-re le vicende che qui interessano. 11 Campione del convento di Budrio sec. XIX-XX, p. 3. La !gura del Barone Federico Dalla Noce è particolar-mente importante in quanto è alla sua persona che si deve il ritorno dei frati Cappuccini a Budrio. Egli, infatti, non solo cedette parte dei suoi terreni per permettere l’ edi!ca-zione del nuovo complesso religioso, ma contribuì in pri-ma persona alla quasi totalità degli oneri !nanziari legati all’ impresa (cfr. Campione del convento di Budrio secc. XIX-XX, pp. 1-2; D&+-,& /- S. G*&.-++* *+ P('3*0(,&, 1946, pp. 12-13; D&+-,& /- S. G*&.-++* *+ P('3*0(,&, 1959, pp. 146-148; S('.(,,* D&+-,*, 1993, pp. 344-345). Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, si rimanda al te-sto di Elena Rossoni.12 Campione del convento di Budrio secc. XIX-XX, p. 3.13 Ibidem.14 Questa notizia la si ricava incrociando diverse anno-tazioni sparse in punti diversi del Campione del convento di Budrio secc. XIX-XX. In una di queste note, infatti, si dice che il quadro della cosiddetta Madonna della scodel-la, copia di un originale del Correggio, fu sostituita in un primo tempo dal “profanissimo e tecnicamente meschi-no” quadro del Majani, mentre in un’altra nota si dice che tale copia del Correggio era situata appunto nel coro della chiesa. Si veda al proposito il testo di Elena Rossoni.15 Campione del convento di Budrio secc. XIX-XX, pp. 165-166.16 Campione del convento di Budrio secc. XIX-XX, pp. 165-166 e nota a p. 168. 17 Ibidem.18 Per la questione conservativa, si veda il testo di Gam-berini.19 C*+,* 1960, p. 54.20 Campione del convento di Budrio secc. XIX-XX, p. 168.21 D&+-,& /- S. G*&.-++* *+ P('3*0(,&1946, p. 15.22 Campione del convento di Budrio secc. XIX-XX, nota a p. 168. 23 C&/*01-P*+())* 1968, p. 48.24 M&'())* 1947, p. 20.25 B&'*-+* 1960, p. 15.26 C&/*01-P*+())* 1968, p. 48.27 S,&'())* 2002 p. 17.28 Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente legati
24
al restauro della pala, si rimanda ancora una volta al testo di Gamberini.29 Bologna, collezione privata.30 Bologna, collezione privata.31 Budrio, Palazzo Comunale.32 Bologna, collezione privata.33 Como, Museo Storico Giuseppe Garibaldi34 A questo riguardo, è importante ricordare l’ attività espositiva svolta dall’ artista presso la neonata “Associazio-ne per le Arti Francesco Francia” di Bologna. Alla prima mostra organizzata dalla suddetta associazione nel 1895, lo stesso anno dell’ esecuzione della pala, Majani infatti partecipa con tre tele signi!cative, E!etto di luna sul mare, il citato E!etto di luna e Senza lavoro e senza pane. L’ artista sarà poi presente in quasi tutte le successive edizioni. Su questa istituzione e il ruolo svolto da Majani presso di essa si veda P-345-)* 1995.35 Budrio, Comune (donazione Alessandra e Andrea Marcovigi).36 Bologna, Museo d’Arte Moderna.37 Bologna, collezione privata.38 Bologna, Museo San Giuseppe dei Cappuccini.39 Bologna, collezione Privata.40 Budrio, Palazzo Comunale (donazione Alessandra e Andrea Marcovigi).41 Per quanto concerne quest’opera, si rimanda qui anco-ra una volta al testo di Cesare Fantazzini.42 C*+,* 1960, p. 47.43 M-2-+* 1950, pp. 30-32.44 Cfr. B&'6&6())* 1983, pp. 21-29; B&'6&6())* 1989, pp. 281-290.45 B&'6&6())* 1983, p. 186.46 Cfr. B&'6&6())* 1983, pp. 28-29; B&'6&6())* 1989, p. 289.47 Cfr. M-2-+* 1950, pp. 38-46. 48 M-2-+* 1950, pp. 43-46. 49 Bologna, Palazzo d’Accursio. 50 Cfr. M-2-+* 1950, p. 46. Sulla !gura di Luigi Serra si veda Il segno e il colore 2003; L’ artista e l’ amico 2008.51 Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.52 Cfr. C-+,-)-7(33- 1882; G-,,* 1883; S-7&66*- 1888; P-+8-009* 1888, p. 585; P-+8-009* 1888.53 Cfr. S-:&'* 1922, pp. 60-62, 68-75.54 Vienna, Kunsthistorisches.55 Milano, Pinacoteca di Brera. 56 Castelfranco Veneto, Duomo.57 Bologna, Pinacoteca Nazionale.58 Bologna, Pinacoteca Nazionale.59 M-2-+* 1950, p. 30. 60 M-2-+* 1950, p. 29.61 Su Alfonso Rubbiani e sulla sua opera si veda Alfon-so Rubbiani 1981, B(',())* e M-88(* 1986 e Aemilia Ars 2001.62 Cfr. S('.(,,* D&+-,* 1981, pp. 237-249. 63 Cfr. S('.(,,* D&+-,* 1993, pp. 211 e sgg.; per quan-to riguarda Achille Casanova (e di suo fratello Giulio), si veda invece F-+,-88*+* 1997, pp. 267-295.
64 Oltre alle opere note compiute da Sezanne a Bologna e provincia (ripristino e decorazione di alcune parti della chiesa di San Francesco a partire dal 1889, restauro e de-corazione nel 1892 di Casa Stagni - “Canton dÈ !ori”- e nel 1894 le decorazioni del Palazzo del marchese Carlo Al-berto Pizzardi in collaborazione con Achille Casanova), si deve ricordare anche la collaborazione dell’ artista !oren-tino alla rivista diretta da Majani «Italia Ride» nel 1900.65 C*+,* 1947, p. 46.66 La gran parte dei disegni preparatori per la pala della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma sono conser-vati presso il Gabinetto Disegni e Stampe della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Per le vicende relative al dipinto e ai disegni si veda la scheda di A. Zacchi e C. Pirani in Fi-gure 1998, pp. 392-393. I fogli relativi allo studio dei gigli corrispondono ai numeri di inv. 2853, 2859, 2860, 2861 e 2862. Il disegno riprodotto alla tav. 8 riproduce il numero di inv. 2860.67 Molto rilevanti risultano in questo contesto le osserva-zioni di Poppi circa il quadro di Serra. Egli, infatti, pone il problema dei possibili rapporti intercorsi fra l’ artista bo-lognese e i Prera#aelliti, in particolare Burne-Jones, avve-nuti molto probabilmente grazie alla mediazione di Costa. Inoltre sempre Poppi rileva giustamente come questo qua-dro sia molto importante anche per i successivi sviluppi del "oreale bolognese. Non a caso, infatti, Rubbiani dedicherà all’ opera di Serra un suo scritto (R5;;*-+* 1925) venendo così a costituire una sorta di cerniera ideale fra due epo-che (Cfr. C. Poppi, in Dall’ accademia al vero 1983, pp. 223-224).68 M-2-+* 1950, p. 88. Sono forse riconducibili proprio ai dipinti della Sala Gialla, oltre che a quelli di Sartorio, alcu-ne tele e tavole realizzate da Majani in quegli anni aventi per tema soggetti tratti dalla storia della Roma antica. In-teressante altresì ricordare che al concorso del 1881 per la decorazione della sala del Senato avesse concorso anche Luigi Serra.69 Tra le altre opere più importanti di Maccari di impron-ta più marcatamente purista, ricordiamo gli a#reschi nella Sala del Risorgimento nel Palazzo Pubblico di Siena, quelli per il Camposanto della Misericordia sempre di Siena e il vasto ciclo pittorico per una cupola della Basilica di Lore-to, realizzato tra il 1888 e il 1895 e considerato il più gran-dioso e signi!cativo di tutta l’ arte sacra di !ne Ottocento. Sull’ opera di Maccari si veda O)*.(,,* 1999; P&)*09(,,* 2001; C-::())& ( L-0('(+8-, 2001. 70 M-2-+* 1950, pp. 88-89.71 M-',())* 1871.72 Cfr. C*+,* 1960, p. 50.73 Attualmente questa tela di Bertelli è conservata pres-so il Museo San Giuseppe di Bologna. Su Bertelli si veda G&,,-'())* 1987 e S,*.-+* 1991 (con bibliogra!a pre-cedente).74 Cfr. Campione del convento di Budrio secc. XIX-XX, p. 3 e p. 165; D&+-,& /- S. G*&.-++* *+ P('3*0(,& 1946, p. 15; D&+-,& /- S. G*&.-++* *+ P('3*0(,& 1959, pp. 152.75 S,&'())* 2002, p. 16.
33
Tav. 1 Augusto Majani, Sacra Famiglia con San Francesco d’Assisi, Budrio, già chiesa della Sacra Famigliadi Nazareth, detta “dei Frati”, ora chiesa di Sant’Agata
34
Tav. 2 Riproduzione fotogra!ca del dipinto di Augusto Majani, Sacra Famiglia con San Francesco d’Assisi,post 1895, Budrio, Biblioteca Comunale “Augusto Majani”
35
Tav. 3: Augusto Majani, Il Salvatore del mondo, Budrio, Palazzo Comunale
Tav. 4: Augusto Majani, I disoccupati. Ama il prossimo tuo come te stesso, Bologna, Museo d’Arte Moderna
37
Tav. 6 Luigi Serra, Irnerio che glossa le antiche leggi di Giustiniano, Bologna, Palazzo Comunale
38
Tav. 7 Luigi Serra, Fiori (disegno preparatorio per il dipinto L’ apparizione della Vergine ai santi Francesco e Bonaventura), part., Bologna, Pinacoteca Nazionale, Gabinetto Disegni e Stampe
Tav. 8 Interno del palazzo Comunale di Budrio
39
Tav. 9 Flavio Bertelli, La Madonna con Bambino e i Santi francescani Lorenzo da Brindisi, Felice da Cantalicee Fedele da Sigmaringa, Bologna, Museo di San Giuseppe
62
Fonti archivisticheBaldassari sec. XVIID. Baldassarri, Memorie antiche di Budrio, ms. post 1673, Budrio, Archivio parrocchiale della chiesa di San Lorenzo, Titolo XIV, Rubrica 1 (le pagine citate fanno riferimento alla trascrizione dattiloscritta, Budrio, Archivio parrocchiale della chiesa di San Lorenzo, sezione Convento). Campione del convento di Budrio sec. XIX-XXCampione del Convento dei Padri Cappuccini di Budrio, Archivio Storico Padri Cappuccini di Bologna, Classe I, serie I, B 11.Documenti 1606-1899Documenti 1606-1899, Archivio Storico Padri Cappuccini di Bologna, Classe I, serie I, B 11.Memorie sec. XVIIIMemorie per l’ archivio di questo convento di Budrio Archivio di Stato di Bologna, Demaniale, Cappuccini di Budrio, 3/7866.Piante della chiesa e del convento secc. XVII-XVIIIPiante, Archivio di Stato di Bologna, Demaniale, Cappuccini di Budrio, 1/7864, mazzo II.Oretti ms. sec. XVIIIM. Oretti, Pitture nelle chiese fuori della città di Bologna, sec. XVIII, Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, ms. B 110.Vendita di quadri 1927Vendita di quadri di scarto giacenti nei magazzini della Pinacoteca Comunale, Ferrara, Archivio Comunale, fasc. 9, 1927.
Bibliogra!aMalvasia 1678C.C. Malvasia, Felsina pittrice vite de pittori bolognesi, 2 voll., Bologna, 1678.Giordani 1836G. Giordani, Indicazioni sulle cose notabili di Budrio, in «Almanacco Statistico Bolognese», VII, 1836, pp. 172-247.Avventi 1838F. Avventi, I Servitori di piazza. Guida per Ferrara, Ferrara, 1838.Cittadella 1844L.N. Cittadella, Indice manuale delle cose più rimarcabili in pittura, scultura e architettura della città e Borghi di Ferrara, Ferrara, 1844.Chiese parrocchiali 1847 Le chiese parrocchiali della diocesi di Bologna ritratte e descritte, vol. II, Bologna, 1847.Martelli 1871D. Martelli, Biogra"e. Nino Costa, in «L’ Arte in Italia», 1871, III, n.5, 1871.Cittadella 1873L.N. Cittadella, Guida per forestiere in Ferrara, Ferrara, 1873.
Cantalamessa 1882G. Cantalamessa, Un quadro di Luigi Serra, in «Stella d’Italia», 16 dicembre 1882.Gatti 1883A. Gatti, Luigi Serra e l’ arte religiosa, in «La Patria», 8, 9, 10, 11, ottobre 1883.Panzacchi 1888aE. Panzacchi, Luigi Serra pittore, in «Nuova Antologia», vol. XVI, 1888, p. 585.Panzacchi 1888bE. Panzacchi, A Luigi Serra, in «Bologna, Esposizione 1888», n. 27, 1888.Samoggia 1888G. Samoggia, Luigi Serra, in «Gazzetta dell’ Emilia», 13 luglio 1888.Sapori 1922F. Sapori, Luigi Serra pittore bolognese, 1922.Rubbiani 1925A. Rubbiani, Su un quadro di Luigi Serra, in Scritti vari editi e inediti, 1925.Raule 1937A.Raule, La nuova pala d’altare nel Santuario del Sacro Cuore, in «Il Santuario del S. Cuore», VIII, 10, Ottobre 1937, p. 107.Donato da S. Giovanni in Persiceto 1946P. Donato da S. Giovanni in Persiceto, I Frati Minori Cappuccini a Budrio, Budrio, 1946. Morelli e Cinti, 1947A. Morelli e I. Cinti, Augusto Majani, a cura del Circolo Artistico e della Famèja Buglnèisa, Bologna, 1947.Majani 1950A. Majani, Ricordi fra due secoli. Memorie di un caricaturista bolognese, Milano,1950.Donato da San Giovanni in Persiceto 1956 P. Donato da San Giovanni in Persiceto, I conventi dei frati minori Cappuccini della Provincia di Bologna. I conventi fondati negli anni 1537-1554, I, Budrio, 1956.Raule 1958A. Raule, Il Santuario del Sacro Cuore in Bologna, Bologna, 1958Donato da San Giovanni in Persiceto 1959Donato da San Giovanni in Persiceto, I conventi dei frati minori Cappuccini della provincia di Bologna, I conventi fondati negli anni 1559-1578, Faenza, 1959.Boriani e Cinti 1960A. Boriani e I. Cinti, Augusto Majani (Nasìca) pittore, Bologna, 1960.Boriani 1960A. Boriani, Rievocazione di Augusto Majani “Nasìca”, in Augusto Majani (Nasìca) pittore, Bologna, 1960, pp. 9-35.Roversi 1967G. Roversi, Santuario del Sacro Cuore, Bologna, 1967.AA.VV. 1968AA.VV., Nasìca (Augusto Majani) e la sua Bologna, scritti di M. Bianconi, A. Cervellati, F. Codicè-Pinelli, A. Marcovigi, G. Marzocchi, M. Missiroli, G. Spadolini, Bologna, 1968.Codicè Pinelli 1968
63
F. Codicè Pinelli, Nasìca e Budrio, AA.VV., Nasìca (Augusto Majani) e la sua Bologna, scritti di M. Bianconi, A. Cervellati, F. Codicè-Pinelli, A. Marcovigi, G. Marzocchi, M. Missiroli, G. Spadolini, Bologna 1968, pp. 45-58.Lombardi 1974P.T. Lombardi, I Francescani a Ferrara, 3, Il convento e la chiesa di S. Maurelio dei frati minori Cappuccini, Bologna, 1974.Benezit 1976E. Benezit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, II, Parigi, 1976.Il Liberty a Bologna 1977Il Liberty a Bologna e nell’ Emilia Romagna: architettura, arti applicate e gra"ca, pittura e scultura, retrospettiva di Roberto Franzoni, Adolfo De Carolis e Leonardo Bistol", prima indagine sull’ art-deco, catalogo della mostra a cura di F. Solmi (Bologna 1977), Bologna.Alfonso Rubbiani 1981Alfonso Rubbiani: i veri e i falsi storici, catalogo della mostra a cura di F. Solmi, M. Dezzi Bardeschi (Bologna 1981), Bologna, 1981.Novelli 1981M. Novelli, Dipinti ferraresi nei depositi dell’ Alte Pinakothek di Monaco, in Cultura "gurativa ferrarese tra XV e XVI secolo: in memoria di Giacomo Bargellesi, Venezia, 1981, pp. 167-178.Servetti Donati 1981F. Servetti Donati, Alfonso Rubbiani a Budrio (decennio 1879-1888): appunti per una biogra"a, in «Strenna storica bolognese», 31, 1981, pp. 237-249.Dall’ accademia al vero 1983Dall’ accademia al vero. La pittura a Bologna prima e dopo l’ Unità, catalogo della mostra a cura di R. Grandi (Bologna 1983), Bologna, 1983.Borgogelli 1983 A. Borgogelli, Rapporti della pittura bolognese con la cultura toscana (1830-1870), in Dall’ accademia al vero. La pittura a Bologna prima e dopo l’ Unità, catalogo della mostra a cura di R. Grandi (Bologna 1983) Bologna, 1983, pp. 21-29 e schede biogra!che.Le collezioni d’arte 1984Le collezioni d’arte della Cassa di Risparmio di Ferrara, A. M. Fioravanti Baraldi, B. Giovannucci Vigi, A.C. Venturini, Ferrara, 1984.Bertelli e Mazzei 1986L. Bertelli e O. Mazzei, Alfonso Rubbiani e la cultura del restauro nel suo tempo (1880-1915), Milano, 1986.Fioravanti Baraldi 1987A.M. Fioravanti Baraldi, Il contributo della Confraternita dell’ Orazione e Morte alla cultura "gurativa ferrarese del secondo Cinquecento: l’ Oratorio dell’ Annunziata, in L’ impresa di Alfonso II: saggi e documenti sulla produzione artistica a Ferrara nel secondo Cinquecento, a cura di J. Bentini e L. Spezzaferro, Bologna, 1987, pp. 259-278.Gottarelli 1987E. Gottarelli, Flavio Bertelli (1865-1941), Bologna, 1987.Borgogelli 1989A. Borgogelli, La pittura nell’ Ottocento, in Storia illustrata
di Bologna, a cura di Walter Tega, Voll. III, San Marino, 1989, pp. 281-290.Casazza 1989O. Casazza, Il restauro pittorico nell’ unità di metodologia, Firenze, 1989.Stivani 1991P. Stivani, Flavio Bertelli, Bologna, 1991.Servetti Donati 1993F. Servetti Donati, Budrio casa nostra, Budrio, 1993.Pasquali 1995M. Pasquali, Francesco Francia. Associazione per le Arti, 1894-1994, Bologna, 1995.Gemäldegalerie 1996Gemäldegalerie Berlin, Berlino, 1996.Mazza 1996A.Mazza, Domenico Maria Fratta (Bologna 1696-1763), in I Panduri a Bologna. Il “Libro” di Domenico Maria Fratta in palazzo Abatellis di Palermo, catalogo della mostra a cura di F. Varignana e A. Mazza (Bologna 1996), Bologna, 1996, pp. 61-77.Cammarota 1997G.P. Cammarota, Le origini della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Una raccolta di fonti, I, 1797- 1815, Argelato, 1997.Fantazzini 1997C. Fantazzini, I fratelli Achille e Giulio Casanova: celebri artisti di origine minerbese, in «Strenna storica bolognese», 47, 1997, pp. 267-295.Figure 1998Figure. Disegni dal Cinquecento all’ Ottocento nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, catalogo della mostra a cura di M. Faietti e A. Zacchi (Bologna 1998), Milano, 1998.Cartoni di Cesare Maccari 1999Cartoni di Cesare Maccari per gli a!reschi nel Palazzo Pubblico di Siena, catalogo della mostra a cura di A. Olivetti (Siena 1998-1999), Milano, 1999.Fioravanti Baraldi 1999A.M. Fioravanti Baraldi, Le Storie di Cristo di Nicolò Roselli per la chiesa di San Cristoforo alla Certosa a Ferrara, in Torquato Tasso e la cultura estense, II, atti del convegno a cura di G. Venturi (Ferrara 1995), Firenze, 1999, pp. 669-681.Aemilia Ars 2001Aemilia Ars, 1898-1903: Arts&Cra#s a Bologna, catalogo della mostra a cura di C. Bernardini, D. Davanzo Poli, O. Ghetti Baldi (Bologna 2001), Milano, 2001.Cappello e Lacerenza 2001A. Cappello e B. Lacerenza, La cattedrale di Nardò e l’ arte sacra di Cesare Maccari, Galatina, 2001.Maggioli 2001A.Maggioli, I Cappuccini in Emilia-Romagna e a Bologna, Ferrara, 2001.Ianua Coeli 2001Ianua Coeli. Disegni di Cristoforo Roncalli e Cesare Maccari per la cupola della Basilica di Loreto, catalogo della mostra a cura di M. L. Polichetti (Roma 2001-2002), Roma, 2001.
64
Sernicola 2001San Giuseppe ai Cappuccini, a cura di R. Sernicola, Ferrara, 2001.Augusto Majani Nasìca 2002Augusto Majani Nasìca 1867-1959. Pittore, illustratore e uomo di spirito, catalogo della mostra a cura di A. Molinari Pradelli, G. Roversi, A. Storelli (Budrio 2002), Modena, 2002. Fantazzini 2002C. Fantazzini, Omaggio a Nasìca, artista senza con"ni, in «Il Resto del Carlino», sezione Bologna, 2 ottobre 2002, p. XIV.Molinari Pradelli, Roversi e Storelli 2002A. Molinari Pradelli, G. Roversi e A. Storelli, Finalmente Majani, in Augusto Majani Nasìca 1867-1959. Pittore, illustratore e uomo di spirito, catalogo della mostra a cura di A. Molinari Pradelli, G. Roversi, A. Storelli (Budrio 2002), Modena, 2002, p. 12.Spadoni 2002C. Spadoni, Per un naso diventò caricaturista, in «Il Resto del Carlino», 4 ottobre 2002, p. 6.Storelli e Ugolini 2002A. Storelli e C. Ugolini, Catalogo dei dipinti, in Augusto Majani Nasìca 1867-1959. Pittore, illustratore e uomo di spirito, catalogo della mostra a cura di A. Molinari Pradelli, G. Roversi, A. Storelli (Budrio 2002), Modena, 2002, pp. 22-95.Biagi Maino 2002D. Biagi Maino, Per una storia quantitativa dell’ arte. Assenze e presenze nelle chiese Custodie di Bologna, di Ferrara e della Romagna, in I Cappuccini in Emilia-Romagna, a cura di G. Pozzi e P. Prodi, Bologna, 2002, pp. 364-409.Cremonesi 2003Materiali tradizionali ed innovativi nella pulitura dei dipinti e delle opere policrome mobili, atti del convegno a cura di P. Cremonesi (Piazzola sul Brenta 2002), Padova 2003.Il segno e il colore 2003Il segno e il colore: nell’ atelier di Luigi Serra, catalogo della mostra a cura di C. Poppi (Bologna 2003), Cinisello Balsamo, 2003. Cammarota 2004G.P. Cammarota, Le origini della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Una raccolta di fonti. Dalla rifondazione all’ utonomia (1815-1907), Argelato, 2004.Wolbers 2004R. Wolbers, Un approccio acquoso alla pulitura dei dipinti, Padova, 2004.Elisabetta Sirani 2004-2005Elisabetta Sirani “pittrice eroina” 1638-1665, catalogo della mostra a cura di J. Bentini e V. Fortunati (Bologna 2004-2005), Bologna, 2004.Salviamo il Nasìca 2005Salviamo il Nasìca dei frati, in «Il Resto del Carlino», sezione Bologna, 3 aprile 2005, p. XI.Fantazzini 2006C. Fantazzini, Ritrovata la Sacra Famiglia, il più grande quadro di Majani, da anni si erano perse le tracce della pala
dipinta per la chiesa dei frati, in «Il Resto del Carlino», sezione Bologna, 15 marzo 2006, p. XIV.Rossoni 2006E. Rossoni, Sulle tracce di un’antica tradizione: dipinti d’altare a Budrio tra storiogra"a artistica e attività di tutela, in Splendori riscoperti a Budrio. Dipinti restaurati di Prospero Fontana, Bagnacavallo junior, Bartolomeo Cesi, Lorenzo Garbieri, Francesco Albani, Antonio Gionima, Ercole Graziani junior, Ubaldo Gandol", catalogo della mostra a cura di E. Rossoni (Budrio 2006), Bologna, 2006, pp. 25-64.Donato 2007A. Donato, Girolamo Marchesi da Cotignola, San Marino, 2007.Fantazzini 2007C. Fantazzini, Quattro luoghi per raccontare un artista, in «Il Resto del Carlino», sezione Bologna, 13 aprile 2007, p. 23.Ritorno a Budrio 2007Ritorno a Budrio. L’ arte di Augusto Majani (18967-1959), catalogo delle mostre a cura di A. Molinari Pradelli (Budrio 2007), Bologna, 2007.Sughi 2007C. Sughi, Gra$a ancora il segno di Nasìca, in «Il Resto del Carlino», sezione Bologna, 13 aprile 2007, p. XXIII.Zama 2007R. Zama, Girolamo Marchesi da Cotignola: pittore ; catalogo generale, Rimini, 2007.L’ artista e l’ amico 2008 L’ artista e l’ amico. Ritorno a Luigi Serra: opere e documenti dalla raccolta di Enrico Guizzardi, catalogo della mostra a cura di S. Pezzoli, O. Piraccini (Bologna 2008-2009), Bologna, 2008.Bonora 2009M. Bonora, Da Bologna a Ferrara: il Novecento nell’ arte della vetrata istoriata: un viaggio itinerante lungo un secolo fra chiese e luce cangiante, alla riscoperta della storia degli artisti e degli stili che mutano, della tradizione dei maestri vetrai, della memoria degli uomini, Ferrara, 2009.Majani (Nasìca) ritrovato 2011Majani (Nasìca) ritrovato, catalogo della mostra a cura di C. Testoni con testi di M. Messori. U. Cavezzali (Budrio 2011), Imola, 2011.
































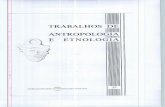





![Lo sguardo malinconico sullo spazio-evento: elegia del paesaggio dipinto [su Biamonti e Morlotti]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633172dd576b626f850cf17a/lo-sguardo-malinconico-sullo-spazio-evento-elegia-del-paesaggio-dipinto-su-biamonti.jpg)






