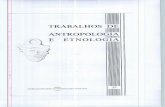La pala d'altare di Maubuisson
Transcript of La pala d'altare di Maubuisson
«Conosco un ottimo storico dell’arte...»Per Enrico CastelnuovoScritti di allievi e amici pisani
a cura di Maria Monica DonatoMassimo Ferretti
EDIZIONI DELLA NORMALE
Indice
Premessa ixMaria Monica Donato, Massimo Ferretti
1953-2012 Paola Barocchi 1
Un periegeta greco a Roma. Pausania e i theoremata nel centro dell’ImperoFrancesco de Angelis 5
Un trionfo per due. La matrice di Olbia: un unicum iconografico ‘fuori contesto’Maria Letizia Gualandi, Antonio Pinelli 11
Il volto di Cristo e il dilemma dell’artista: un esempio di IX secoloFrancesca Dell’Acqua 21
Rappresentare il Giudizio a Roma al tempo della Riforma Gregoriana: il caso di San Benedetto in PiscinulaEleonora Mazzocchi 29
Sul ‘bestiario’ del reliquiario di san Matteo: Montecassino, Roma e la ‘Riforma’ tra Occidente cristiano e Oriente islamicoStefano Riccioni 35
Un frustolo disegnato. Lucca, Biblioteca Statale, ms. 370, c. 102Alessio Monciatti 43
I Leoni custodesGigetta Dalli Regoli 51
Il Medioevo lucchese rivisitato a Villa GuinigiMaria Teresa Filieri 61
Da Limoges a Lucca: modelli iconografici per l’oreficeria sacraAntonella Capitanio 69
Iconografia per Sacrum Imperium. Rilievi nella facciata del Duomo di San DonninoYoshie Kojima 77
Un volto per due dame, tra Poitiers e l’abbazia di CharrouxChiara Piccinini 83
Le casse-reliquiario di san Giovanni Battista per il Duomo di Genova: strutture narrative e percezione pubblicaAnna Rosa Calderoni Masetti 89
Luoghi e immagini nelle Storie degli Anacoreti di PisaAlessandra Malquori 97
Un frammento della chiesa della Spina nel Museo BardiniRoberto Paolo Novello 105
Nino Pisano e la scultura lignea franceseMax Seidel 111
SpigolatureMariagiulia Burresi 117
La pala d’altare di Maubuisson: note sull’iconografiaMichele Tomasi 125
L’Offiziolo bolognese della Biblioteca Abbaziale di KremsmünsterRoberta Bosi 131
Una ‘maniera latina’ nel Levante tardomedievale?Michele Bacci 141
Un tema di origine altomedievale nella pittura gotica: nota su tre cicli pittorici del TiroloFabrizio Crivello 149
Intorno a un trittico in muratura di Pietro di MiniatoElisa Camporeale 155
Alla ricerca della Fontana di giovinezza. Il programma iconografico degli affreschi della sala baronale del castello della Manta: riflessioni e nuove proposteRomano Silva 163
La fontana ‘del melograno’ di Issogne: due sogni e qualche indizioPaola Elena Boccalatte 173
FouquetianaMaria Beltramini, Marco Collareta 181
L’«officina» e il «padiglione fiorito». Appunti sulla pratica artistica ferrarese nel QuattrocentoCarmelo Occhipinti 189
Dalla cartella «Geografia della scultura lignea nel Quattrocento»Massimo Ferretti 197
Due false attribuzioni a Giovanni Bastianini falsario, ovvero due busti di Gregorio di Lorenzo, ex «Maestro delle Madonne di marmo»Francesco Caglioti 207
L’epitaffio del VecchiettaRoberto Bartalini 219
«Se pensa levare lo Arno a Pisa». A proposito della Mappa del Pian di Pisa di LeonardoEmilio Tolaini 223
Sulle tentazioni iconoclaste ebraiche in Italia fra tardo Medioevo e prima età moderna Michele Luzzati 227
Formiche assetate, tartarughe in viaggio, architetture incrollabili. Sulla lunga fortuna di un topos epigraficoFulvio Cervini 239
Il doppio ritratto della maga AlcinaLina Bolzoni 245
Ariosto, schede di censoriAdriano Prosperi 255
Intorno alla cappella Guidiccioni in Santo Spirito in SassiaBarbara Agosti 259
Le pinceau et la plume. Pirro Ligorio, Benedetto Egio et la «Aegiana libraria»: à propos du dessin du Baptistère du LatranGinette Vagenheim 267
«Come dice l’oppositione»: Aurelio Lombardi, Pellegrino Tibaldi e Leone Leoni nel presbiterio del Duomo di Milano (1561-1569)Walter Cupperi 271
Giovanni Battista Adriani e la stesura della seconda edizione delle Vite: il manoscritto inedito della Lettera a messer Giorgio VasariEliana Carrara 281
‘Anticomoderno’: significati ed usi del termine nella letteratura artistica tra Cinque e SettecentoFabrizio Federici 291
Tre medaglie per Joachim von SandrartLucia Simonato 297
Città e santi patroni nell’età della ControriformaLucia Nuti 307
Inediti sul Porto Pisano a San Piero a Grado con schemi dell’iconografia portuale Fulvia Donati 315
«Un torso di un Fauno, non inferiore al torso di Belvedere». Note sulla ricezione critica del Fauno Barberini nel SeicentoLucia Faedo 323
La scoperta di Giunta PisanoAntonio Milone 331
L’Antiquité expliquée e i Monumens de la monarchie française di Bernard de Montfaucon: modelli per una storia illustrata del Medioevo franceseElena Vaiani 337
Intreccio e dramma, provvidenza e misericordia nella storiografia lanzianaMassimiliano Rossi 347
Rapporti tra Galleria degli Uffizi e Accademia di Belle Arti nel periodo leopoldino (1784-1790)Miriam Fileti Mazza 353
Un quadro disperso di Pietro Benvenuti e le ‘razzie’ francesi a Firenze dell’autunno 1800Ettore Spalletti 359
Voyage en Suisse, Belgique, Hollande et à Paris (1846). Un diario di Costanza d’AzeglioCristina Maritano 365
Appunti di Giovanni Morelli per un catalogo della Pinacoteca di BreraDario Trento 373
«Il Buonarroti». Cronaca ed erudizione artistica a Roma nel secondo OttocentoMarco Mozzo 381
Fotografia e giapponismo: ancora sull’Alzaia di SignoriniVincenzo Farinella 389
L’Exposition des Primitifs flamands de Bruges (1902), «une œuvre patriotique»?Claire Challéat 399
Firenze 1911: la mostra del ritratto italiano e le radici iconografiche dell’identità nazionaleTommaso Casini 407
Un paesaggio ‘moderno’ a Torino: il Torrente in inverno (1910) di Giuseppe BozzallaFlavio Fergonzi 415
Les promenades péripatéticiennes: appunti su e di Filippo De Pisis al LouvreMaria Mimita Lamberti 423
Aby Warburg, il Déjeuner sur l’herbe di Manet. La funzione di modello delle divinità pagane elementari in rapporto alla evoluzione del moderno sentimento della naturaMaurizio Ghelardi (a cura di) 431
«Maestri in tournée». Aby Warburg ed Ernst Robert Curtius a Roma, il 19 gennaio 1929Silvia De Laude 445
Il XIII congresso internazionale di storia dell’arte (1933) e la geografia artistica. Le origini di un metodo e le sue inflessioni ideologicheMichela Passini 453
Musei e multimedialità: cenni per una frammentaria archeologiaDonata Levi 461
Conosco un ottimo storico dell’arte, uomo di vastissime letture, che fra tutti i libri ha concentrato la sua predilezione più profonda sul
Circolo Pickwick, e a ogni proposito cita battute del libro di Dickens, e ogni fatto della vita lo associa con episodi pickwickiani. A poco
a poco lui stesso, l’universo, la vera filosofia hanno preso la forma del Circolo Pickwick in un’identificazione assoluta. Giungiamo per
questa via a un’idea di classico molto alta ed esigente.
Quando Italo Calvino così rispondeva all’eterna domanda Perché leggere i classici, nell’intervista comparsa sull’«Espresso» nel 1981, gli amici di Enrico Castelnuovo non avranno esitato un istante a riconoscere il personaggio che agli occhi dello scrittore era diventato l’incarnazione stessa di ‘come leggere’ (piuttosto di ‘perché’). Altrettanto facilmente lo avranno poi identificato generazioni di allievi, dopo che l’intervista fu ripubblicata, dieci anni dopo ed ormai postuma, nella raccolta di scritti a cui darà il titolo. I più giovani, magari, avranno avuto l’impressione che il romanzo di Dickens non fosse scalzato da quel ruolo, questo no, ma che stesse ormai trovando concorrenti come l’île des pengouins di Anatole France.
La ragione per cui ci è parso utile usare un frammento di quel ritratto per il frontespizio (una specie di ritratto tipologico, e perciò senza didascalia e solo da alcuni riconoscibile) sta tutta nel verbo che fa da incipit: nel privilegio di aver conosciuto Enrico da vicino, come colleghi o allievi. Questo privilegio è largamente condiviso. Gli amici sono sparsi ovunque e gli estimatori della sua intelligenza non stanno soltanto fra gli storici dell’arte. Di allievi, poi, ne ha avuti molti: a Torino, a Losanna, di nuovo a Torino, e infine in Normale, per venti anni (dal 1983-1984 al 2004). Sarebbe stato impossibile riunirli tutti in una raccolta en hommage. Si è così scelto subito, sia pure a malincuore, di limitare l’invito a chi ha frequentato Enrico nella sua lunga e così fruttuosa stagione pisana. Ma la sua presenza a Pisa non si è fatta sentire solo nelle aule della Normale. Enrico ha frequentato diversi colleghi dell’Università. Dal suo studio sono passati allievi di ‘San Matteo’. Ha preso parte, anche direttamente, oltre che assieme ad alcuni di questi allievi interni ed esterni, ad alcune importanti mostre di ricerca organizzate a Pisa, Lucca, Sarzana dai colleghi della Soprintendenza. Ha rinsaldato i legami con il maggiore centro di studio, nel nostro ambito disciplinare, presente in Toscana: il Kunsthistorisches Institut.
Anche se l’invito a partecipare al volume è stato rivolto soltanto a quanti fossero entrati in questo pur parziale raggio della geografia e della biografia di Enrico, le risposte sono state davvero numerose. E se qualcuno non ce l’ha fatta a scrivere, non ne iscriveremo il nome in un elenco epigrafico. Si riconoscerà comunque nell’omaggio cumulativo: assieme a chi fosse stato dimenticato, malauguratamente e non di proposito; assieme agli allievi più giovani del corso
Premessa
x Maria Monica Donato, Massimo Ferretti
ordinario e del perfezionamento che ne hanno semplicemente seguito le lezioni durante gli anni del ‘fuori ruolo’. Il contributo di uno di noi due, che ha riservato il suo impegno per questa raccolta al lavoro organizzativo e redazionale, comparirà a breve in altra sede. Il volume è comunque davvero corposo, tanto da farci rabbrividire al solo pensiero della battuta con cui Roberto Longhi accolse il volume a lui dedicato, uno degli incredibili episodi di vita che Enrico ha tante volte ricordato: «grazie Bottari di questa bella… pizza» (i puntolini, per chi ha sentito raccontare l’episodio, corrispondono al gesto del festeggiato che soppesa il volume). Non ci preoccupa invece l’estrema varietà degli argomenti perché confidiamo che richiami qualcosa dell’inesauribile curiosità intellettuale di Enrico.
La gestazione editoriale di questo volume è stata più impegnativa di quanto si fosse pensato. Ce ne dispiace, pensando agli autori più solleciti nella consegna; e soprattutto ad uno dei primissimi, Romano Silva, improvvisamente mancato l’autunno scorso (era contento – diceva, rinviando le bozze – che l’articolo per Enrico gli avesse fatto maturare un più largo progetto di studio sul salone della Manta). Per la complessa opera di preparazione dei testi e di correzione delle bozze siamo grati in modo particolare a Matteo Ferrari e Elena Vaiani. Grazie anche, per ragioni diverse e differentemente gravose, a Gabriele Donati, Miriam Fileti Mazza, Miriam Leonardi, Michela Passini, Stefano Riccioni, Ludovica Rosati, Lucia Simonato, Giovanna Targia. Un ringraziamento particolare a Maria Vittoria Benelli e Bruna Parra sarebbe dovuto, da parte nostra, se non fosse che anche loro fanno parte a pieno titolo degli amici pisani che hanno contribuito a questo omaggio ad Enrico Castelnuovo.
Maria Monica DonatoMassimo Ferretti
1953-2012
Carissimo Enrico, mi piacerebbe saper raccontare quello che in più di cinquanta anni abbiamo
vissuto insieme nella nostra lunga ed intensa attività storico-artistica, in modo da conoscere meglio noi stessi e molti altri.
Partirei dal 27 ottobre 1953, quando nell’Istituto Germanico di Firenze, allora in Palazzo Guadagni di piazza Santo Spirito sentii risuonare in stanze eccezio-nalmente vuote, un grido di profonda soddisfazione. Proveniva da Enrico che leggeva sghignazzando nel «Nuovo Corriere» i famosi Dubbi su una ‘tegola’ (o su un ‘mattone’) alla Mostra del Signorelli di Roberto Longhi. Evidentemente il gioco allusivo delle parole (tegola e mattone) trovava in Castelnuovo un con-senso divertito e sonoro, che fu per me una rivelazione.
Erano gli anni della netta contrarietà tra due fronti: un Salmi, che all’ultimo momento era succeduto all’Università di Roma a Pietro Toesca ed un Longhi che era approdato all’Università di Firenze, quale successore di Salmi (sempli-cemente menzionato come «la passata amministrazione»). Gli allievi dei due protagonisti dovevano rispettare le distanze e non c’era possibilità, salvo casi eccezionali, di deroghe. L’ironia con cui Enrico accoglieva la burla longhiana dimostrava una capacità di indipendenza del tutto estranea ad una doverosa e passiva partecipazione accademica. Tutto ciò mi fece sperare in una possibilità di colloquio, favorito dalla inaspettata recensione di Longhi al mio Rosso Fio-rentino (alla contemporanea mostra di Napoli da parte di Causa e Bologna si parlava della: «Barocchi col Rosso negli occhi») e dalla imprevista neutralità con cui risposi agli inviti di mutare partito. Intanto le rare lezioni del docente fio-rentino erano per me, come per Castelnuovo un modello di esperienze formali e testuali che induceva a riflettere.
Se Enrico prediligeva le ‘mappe inconsuete’ della pittura umbra e bolognese, io mi stupivo alla lettura, a viva voce dell’autore, della Antologia della critica caravaggesca, nella quale ogni parola veniva valutata nelle particolari accezioni e quindi in un particolare contesto, confermando la ragione della scelta, nella precedente prolusione (Proposte per una critica d’arte), del passo di Vasari su Giorgione, che aveva sconvolto Mary Pittaluga (che mi sedeva accanto). Così cadevano le categorie mentali e ambientali (il ‘disegno’ dei Fiorentini e il ‘colo-re’ dei Veneti) e maturava nei testi una attenzione puntuale e una valutazione linguistica che implicava una osservazione storica specifica.
In campi diversi si aprivano invitanti prospettive: Enrico amava approfondire situazioni di frontiera (Avignone e Matteo Giovannetti), forse favorito anche dal suo spostamento a Losanna (1964-1978), a me toccò la commissione del buon Salmi di un commento alla Vita di Michelangelo di Vasari nelle due reda-zioni del 1550 e del 1568, che implicò un lavoro di ben dieci anni (1952-1962), dal quale risultò molto chiaramente che le due edizioni rispondevano ad ottiche del tutto diverse (romana la prima e cosimiana la seconda), pur restando spesso identica la lettura stilistica. La valorizzazione e la sua eccezionalità stimolaro-
2 Paola Barocchi
no ovviamente anche l’edizione laterziana dei Trattati del Cinquecento (1960-1962) e quella ricciardiana degli Scritti d’Arte del Cinquecento (1971-1977), che rinnovava la partitura per temi, allargando una problematica specifica e geogra-ficamente più varia.
Maturava in tali esperienze il bisogno di evadere da un longhismo che dive-niva, dopo la morte di Longhi (1970), sempre più bloccato nel mero figurativo, mentre i fortunati scritti correnti sulla storia sociale dell’arte (Hauser) rischia-vano di tutto appiattire nell’infelice parallelo tra figurativo e letterario.
La pubblicazione degli scritti d’arte dell’«Antologia» di Vieusseux e la ferma volontà di Sandra Pinto di organizzare un convegno intitolato La cultura ro-mantica e l’«Antologia» mi indussero ad invitare nel 1976 anche Castelnuovo, che presentò il suo contributo Arti e rivoluzione. Ideologie e politiche artistiche nella Francia rivoluzionaria (poi pubblicato in «Ricerche di storia dell’arte» nel 1981). La sorpresa di un’indagine così innovatrice ci rincuorò notevolmente e ci indusse ad ascoltare in massa, il giorno dopo, alla Facoltà di Lettere, le prime riflessioni su Una storia sociale dell’arte, subito pubblicate in «Paragone» nello stesso anno. Se la brillante storia del nesso tra storia dell’arte e storia della so-cietà suscitò molto interesse, non mancarono i dubbi di un crociano convinto; Roberto Salvini dichiarò pubblicamente che per lui l’Arte era solo quella con l’A maiuscola. Ed Enrico sorrise con piena comprensione.
Dal 1976 al 1983, Enrico divenne un interlocutore costante alla Scuola Nor-male, dove teneva seminari prolungati sulla museografia francese (rivoluzio-naria e post-rivoluzionaria), sul rapporto ‘centro e periferia’ (insieme a Carlo Ginzburg), sfoggiando letture inusitate e profondamente innovative. II rappor-to periodico portò ad un insolito scambio di vedute, rafforzato dalla presenza di altri ospiti. Penso a Carlo Dionisotti (1979-1981) ascoltatore paziente del-le ricerche in corso e conferenziere vivacissimo, quando, ad esempio, leggeva con enorme divertimento e gusto la lettera del Vasari sull’albero della Fortuna. Quasi in tema, ricordo che proprio a Pisa i funzionari einaudiani concordarono con lui la pubblicazione delle Machiavellerie (1980).
Si era così formata, grazie anche ad Enrico, una consuetudine tra persone di varia esperienza e di varia età che riconosceva ad ognuno libertà e dignità di invenzione e proposizione. L’eccezionalità della situazione fu confermata, in un certo senso, dal convegno promosso da Previtali nel decennale della morte di Longhi (1980). Vi predominava una lode del passato (talvolta drammaticamen-te sceneggiata; penso all’intervento di Garboli che ammaliò Castelnuovo), ma non si intravedevano linee future, quelle che altrove si cercavano assiduamente.
Ricordo ancora con meraviglia vari incontri romani promossi dalla casa edi-trice Einaudi in una sede vicino a Trinità dei Monti, ai quali partecipavano Pao-lo Fossati e vari amici, tra i quali Enrico. Si parlava di ciò che ci veniva in mente e si poteva passare agevolmente da un argomento all’altro sotto il severo con-trollo di esperti non solo di editoria, ma della più recente produzione culturale.
A livello più alto fummo invitati, dopo la partecipazione alla Storia dell’ar-te Einaudi, anche nella residenza montana del Presidente, dove tra sobrie pa-stasciutte al burro e salvia e tradizionali giochi di carte si poteva scambiare le ipotesi più immaginarie. Gianni Romano, sempre attento ed arguto, Settis sem-pre intraprendente ed asseverativo, Enrico familiarmente dimesso ed io molto timorosa e costretta, per cortesia, a bere da astemia un vino assai decantato, eravamo guidati da Paolo Fossati e dovevamo esibirci. Naturalmente i meno
3 1953-2012
aggressivi eravamo Enrico ed io, e spesso passeggiavamo nei corridoi in modo interlocutorio. Alla resa dei conti la palma fu conquistata da Salvatore Settis, che ottenne la pubblicazione dei volumi sulla Memoria dell’antico, mentre io mi limitai a proporre gli studi di Donata Levi su Cavalcaselle (poi usciti nel 1988).
A Pisa intanto le cose procedevano più semplici e fattive. L’esperienza della mostra di Palazzo Vecchio del 1980 mi aveva confermato i profondi legami tra collezionismo e storiografia artistica ribaditi dal centenario della Galleria degli Uffizi (1982) in un lungo saggio, che Enrico giudicò positivamente e ne propose un ampliamento einaudiano.
La consultazione reciproca fu poi facilitata dalla chiamata di Castelnuovo alla Scuola Normale nel 1983, dove fu accolto con grandi speranze di una collabo-razione intensa anche da parte della Soprintendenza (di cui la mostra Niveo de marmore di Sarzana, 1992, fu una riprova). Si pensò, insieme a Clara Baracchini, ad iniziative relative al Camposanto e fu deciso di comune accordo di iniziare dai secoli più vicini per favorire l’intervento di molti (si ricordi il Camposanto di Pisa edito da Einaudi nel 1996). Intanto la presenza di Paolo Fossati alla Scuola Normale diveniva sempre più frequente e molti ricordano ancora i suoi energici seminari che spesso anticipavano gli scritti quasi come una prova preliminare. La sua guida alle opere di Burri a Città di Castello e al Vittoriale dimostrò sem-pre una esemplare vitalità d’approccio del tutto originale. Sul versante edito-riale concordammo proprio a Pisa una Storia moderna dell’arte in Italia (1795-1990) che cercasse di colmare il divorzio tra gli strumenti della storia dell’arte e quelli della storia della critica d’arte, offrendo in ordine cronologico le testimo-nianze più diverse (non solo di storici dell’arte ma di artisti, critici, giornalisti ecc.) in modo che il presente e il passato riuscissero a colloquiare su vari piani.
Nel culmine di tante imprese – e riprese (mi piace ricordare due interventi cortonesi: Che cos’è la storia dell’arte da me tenuto nel 1980, Di che cosa par-liamo quando parliamo di storia dell’arte di Castelnuovo nel 1982) – nelle quali Enrico ed io avevamo sempre una compartecipazione sia pure meramente in-formativa, che ci rendeva comunque compresenti in una istituzione nella quale gli studenti avevano piena libertà di colloquio con entrambi, ci giunse la notizia del premio Feltrinelli dell’Accademia Nazionale dei Lincei. L’abbinamento so-stenuto da Argan superava evidentemente frontiere di scuola ed evidenziava i nostri intenti anche su binari allora inconsueti, quali le applicazioni informati-che, da me sostenute fin dal 1978.
Il riconoscimento non poteva che avvalorare le strade da tempo intraprese, e in parte condivise da allievi, divenuti a loro volta professori. Ricordo con viva nostalgia Alessandro Conti, che ci ha lasciato nel 1994. Lo abbiamo conosciuto nel suo pieno vigore di cultore delle arti, le cui ricerche sapevano affrontare gli itinerari più vari e proprio in essi potevamo vedere una traccia comune.
E siamo arrivati così alla pensione (io nel 1999, Enrico nel 2001), siamo di-venuti emeriti e non demordiamo. Io sono impegnata nella Memofonte, fonda-zione nazionale dedicata alle applicazioni informatiche sulle fonti e i documenti storico-artistici, cercando di valorizzare il lavoro di sessanta anni, Enrico ha continuato (dal 1990) i suoi studi sulla fortuna dei primitivi francesi ed ha in-trapreso con Giuseppe Sergi Arte e storia nel Medioevo (Einaudi 2002-2004), alla cui progettazione aveva contribuito Paolo Fossati. Oggi Enrico è festeggiato in questo volume come uomo di grande cultura che ha saputo tentare vie nuove e generose.
4 Paola Barocchi
Ci unisce ancora l’affetto di tanti allievi ormai divenuti amici solidali e il ri-cordo di anni fiorentini e pisani, che per noi sono stati importanti, come ho cercato di ricordare.
Paola Barocchi
La fotografia mostra Roberto Longhi, in visita alla mostra di Antonello da Messina. Con lui c’è il ventiquattrenne Enrico Castelnuovo, il terzo da sinistra. Sapere che nel marzo del 1953 Enrico era arrivato «nell’isola terribile e luminosa» in compagnia del maestro fa subito pensare al suo primo grande libro, quello su Matteo Giovanetti, pubblicato nel 1962 sotto l’‘anti-monografico’ titolo di Un pittore italiano alla corte di Avignone. Introducendone la riedizione, Enrico ricordava che ad occuparsi dell’argomento fu spinto dallo stesso Longhi nel dicembre del 1952: poco prima di quel viaggio in Sicilia. Non è difficile immaginare i loro dialoghi davanti alle opere esposte, con il pensiero del più giovane tutto rivolto al progetto di lavoro appena avviato. Longhi gli avrà subito indicato nella Madonna dell’Umiltà di Bartolomeo da Camogli «un capolavoro di arte senese dipinto» in Liguria da un pittore che doveva aver appreso «la proprietà del parlare senese e in accento puramente martiniano non già a Siena, ma in curia, ad Avignone». Enrico, fra sé, avrà pensato che la formula iconografica confermava in pieno l’ipotesi: se ne parlava, della Madonna dell’Umiltà, nel libro recentissimo di Millard Meiss, dove l’opera palermitana veniva però detta di qualità mediocre; e proprio per simili giudizi il libro non era piaciuto a qualche compagno di studi, a Firenze. Enrico avrà cominciato a pensare che un argomento a così largo raggio era davvero ‘suo’.
La pala d’altare di Maubuisson: note sull’iconografia
La pala marmorea proveniente dall’altare maggio-re dell’abbazia cistercense femminile di Maubuis-son occupa un posto importante nell’immagine che abbiamo dell’arte francese del Trecento, da quando Françoise Baron ne ha riunito i frammenti e rico-struito la storia, in un magistrale articolo pubblicato nel 19711. Intrecciando analisi stilistica, lettura di descrizioni antiche e documenti d’epoca rivoluzio-naria, la studiosa ha identificato i resti dell’antica pala, smantellata e venduta all’asta nell’ottobre 1793, in un rilievo inserito, sin dall’inizio dell’Ottocento, nell’altare della chiesa parigina di Saint-Joseph-des-Carmes (fig. 1) e in quattro rilievi oggi conservati al Museo del Louvre. Questi figurano, nell’ordine in cui erano disposti da sinistra a destra (per l’osser-vatore) ai lati della scultura centrale, Mosé, Davide e un profeta, la Comunione di san Dionigi (fig. 2), Tre profeti e un Angelo con ampolle (fig. 3). Le an-tiche descrizioni indicano, con qualche contraddi-zione sulla disposizione esatta, che in origine questi personaggi erano accompagnati dalle figure del re Carlo IV il Bello e della regina Giovanna d’Évreux, e delle loro figlie Maria e Bianca, rappresentati come
donatori. Se qualche incertezza rimane sulla possi-bile presenza di un fondo di marmo nero o di un’e-ventuale cornice architettonica, comuni nelle pale d’altare coeve, la ricostruzione dell’insieme, nelle sue linee generali, è dunque assodata. Anche la da-tazione proposta da Baron, verso il 1340, e l’attribu-zione dell’insieme a Évrard d’Orléans, riscuotono il quasi unanime consenso della critica, benché il dibattito attorno all’esatta consistenza del corpus di opere attribuibili a Évrard d’Orléans non sia del tut-to sopito, e il problema della vera natura dell’attività del maestro (scultore in prima persona o anzitutto capo di una bottega in seno alla quale si dedicava principalmente a fornire modelli e organizzare il la-voro) non abbia trovato una soluzione definitiva2. Dato che Évrard d’Orléans è uno degli artisti meglio documentati del XIV secolo in Francia, tra il 1292 e il 1357, anno della morte, e vista la sua posizione di spicco come artista al servizio di vari sovrani e membri della corte, la riflessione sul suo stile e sulle frontiere della sua produzione hanno in effetti as-sorbito molta dell’attenzione degli studiosi. Anche l’illustre donatrice della pala, Giovanna d’Évreux, è
1. Évrard d’Orléans (?), Istituzione dell’Eucarestia, 1340 ca. Parigi, Saint-Joseph-des-Carmes (dalla pala dell’altare maggiore dell’abbazia di Maubuisson) (foto: Lessing archive).
126 Michele Tomasi
rilievo centrale (fig. 1) avrebbe rappresentato l’Ulti-ma Cena, esibendo un tema eucaristico appropria-to per una pala d’altare, ancora sottolineato dalla rappresentazione della Comunione di san Dionigi e dell’angelo che tiene le ampolline con il vino e l’ac-qua5 (figg. 2-3). In un lavoro recente, dedicato alle arti figurative del basso Medioevo in seno all’ordine cistercense, centrato soprattutto sul mondo tede-sco, è stata opportunamente sottolineata la rarità di questa esclusiva concentrazione del programma sull’Eucaristia6. Un’osservazione più attenta della scena principale permette di spingere più avanti l’a-nalisi. A ben guardare, in effetti, il rilievo di Saint-Joseph-des-Carmes non raffigura l’Ultima Cena. Certo, il Cristo è raffigurato al centro, circondato dai dodici apostoli, davanti ad un tavolo imbandi-to, su cui sono disposti pani, piatti di pesce, caraffe, secondo un’iconografia che sembra, di primo ac-
all’origine di una bibliografia abbondante e di qua-lità3.
Entrambe queste linee di ricerca, pur feconde, hanno sempre gettato sulla pala di Maubuisson uno sguardo per così dire obliquo, senza mai farne il centro dell’analisi. Questo spiega probabilmente perché altri aspetti interessanti di quest’opera pre-stigiosa e di alta qualità sono rimasti in ombra. Il fatto che, a differenza di quanto è avvenuto per altri paesi, le pale d’altare del periodo gotico in Francia non siano quasi mai state oggetto di una riflessione sistematica, sino alla mostra bella e intelligente or-ganizzata al Louvre nella primavera del 20094, ha ul-teriormente pesato in questo senso. Anche in questa sede uno studio globale non sarà possibile; vorrei tuttavia allargare il dibattito e suggerire qualche pi-sta di approfondimento a partire da una semplice constatazione relativa all’iconografia dell’opera.
Il programma della pala è sempre parso chiaro: il
3. Évrard d’Orléans (?), Angelo con due ampolline, 1340 ca. Parigi, Musée du Louvre (dalla pala dell’altare maggiore dell’abbazia di Maubuisson) (foto: Musée du Louvre/ Pierre Philibert).
2. Évrard d’Orléans (?), Comunione di saint Denis, 1340 ca. Parigi, Musée du Louvre (dalla pala dell’altare maggiore dell’abbazia di Maubuisson) (foto: Musée du Louvre/Pierre Philibert).
127 La pala d’altare di Maubuisson: note sull’iconografia
chito, del tutto tradizionale. A un secondo sguardo, tuttavia, si notano alcune stranezze. Gli apostoli, anzitutto, non sono colti nell’atto di reagire anima-tamente all’annuncio del tradimento, ma siedono tutti ordinatamente, le mani giunte, leggermente rivolti verso il Signore. Tale attitudine appare tanto più insolita se si confronta la scena con una versio-ne più tradizionale dell’Ultima Cena, come quella che appare sul lato settentrionale della recinzione del coro a Notre-Dame di Parigi, risalente agli anni attorno al 13007 (fig. 4). Seconda stranezza: nessu-no dei presenti può essere identificato come Giuda, dato che nessuno degli apostoli appare di profilo, o intento a intingere il pane nel piatto di Cristo, o a ri-cevere il boccone dallo stesso, o ancora con tratti di una bruttezza caricaturale. Si può invece riconosce-re un personaggio che non fu storicamente presente all’ultima cena. Malgrado l’assenza di attributi e la relativa uniformità della rappresentazione dei dodi-ci, è possibile dare un nome con una certa sicurezza a tre dei commensali, oltre a Gesù. Il giovane imme-diatamente alla sua destra, il solo imberbe, non può
che essere Giovanni; alla sinistra del maestro, l’uo-mo dalla barba corta e ordinata, dalla capigliatura ricciuta, deve essere Pietro; alla destra del discepolo prediletto, invece, in posizione quasi simmetrica a Pietro, l’apostolo anziano, con la barba lunga ed appuntita, il cranio segnato dalla calvizie, dovrebbe essere Paolo. Non siamo dunque di fronte ad una rappresentazione dell’episodio evangelico, ma da-vanti ad una raffigurazione simbolica, dove la Chie-sa, incarnata dagli apostoli, attornia il Salvatore: una scena che potremmo chiamare l’Istituzione dell’Eu-caristia. Un ultimo dettaglio conforta questa lettura: davanti al Cristo, che tiene nella sinistra il calice e benedice con la destra, sono disposte sul tavolo tre-dici particole, una per ognuno dei commensali8. Il programma eucaristico si rivela dunque ancora più meditato e originale di quanto si fosse sinora pensa-to, e piuttosto eccezionale9.
In questo senso, vale la pena d’insistere, più di quanto non sia stato fatto, anche sulla singolari-tà costituita dalla Comunione di san Dionigi (fig. 2). In effetti, tale scena appare soprattutto nei ci-
4. Ultima cena, 1300 ca. Parigi, Cattedrale di Notre-Dame, recinzione del coro, lato nord (foto: CMN/Caroline Rose).
128 Michele Tomasi
cli narrativi dedicati al santo, come in una vetrata duecentesca della cattedrale di Tours10. Essa figu-ra anche, prevedibilmente, nelle copie miniate dei manoscritti agiografici, sia due sia trecenteschi11. Isolata, essa risulta invece assai rara, dato che di solito, se un solo episodio della leggenda del san-to è rappresentato, questo è il martirio12. Anche lo schema iconografico adottato per il rilievo del Louvre merita qualche osservazione. Si può infat-ti notare che dal timpano del portale destro sulla facciata occidentale dell’abbaziale di Saint-Denis (ante 1140), al celebre manoscritto del 1317 conte-nente la leggenda del santo, la Comunione prevede tendenzialmente la presenza dei compagni di Dio-nigi, raffigurati entro una sorta di cinta muraria13. Sul dossale di Maubuisson, invece, il vescovo ap-pare solo entro la torretta che gli serve da prigione, con un’impaginazione che si ritrova, nel 1416, sulla pala di Henri Bellechose proveniente dalla Certosa di Champmol e oggi al Louvre14. Il tema merita cer-to un approfondimento, ma abbiamo forse qui un indizio supplementare dell’intensa riflessione che dovette presiedere alla concezione della pala. Altri aspetti del programma ci sfuggono. In mancanza di attributi univoci, almeno due dei profeti non sono più identificabili con assoluta certezza, e non è chiaro se le antiche descrizioni riconoscano in essi i quattro profeti maggiori sulla base della semplice probabilità o fondandosi su elementi oggi perduti – per esempio eventuali iscrizioni dipinte sui cartigli che essi esibiscono oggi vuoti15.
Queste incertezze, benché limitanti, non impedi-scono di tentare di restituire un contesto plausibile per la pala d’altare, che ne illumini almeno in parte le scelte singolari. Una prima indicazione preziosa viene da una seconda opera che è necessario acco-stare alla nostra. Si tratta della deliziosa Madonna col Bambino in alabastro custodita al Metropolitan Museum of Art di New York, proveniente dall’ab-bazia di Pont-aux-Dames che, secondo un’ipotesi ben argomentata di Françoise Baron, potrebbe es-sere anch’essa un dono della regina Giovanna di Évreux16. La statuetta presenta un’iconografia uni-ca in Francia, con la Vergine che tiene nella destra una pisside, che Gesù benedice, secondo uno sche-ma che appare raramente altrove. Lo si ritrova in particolare in alcune immagini lignee di area ger-manica, appartenenti tutte a contesti cistercensi17. È rilevante allora ricordare che anche Pont-aux-
Dames era un monastero cistercense femminile, come Maubuisson.
Questa densità di iconografie eucaristiche in am-bito cistercense non è casuale. Nella percezione co-mune, la spiritualità cistercense è spesso descritta come interamente costruita attorno al culto ma-riano; gli storici hanno tuttavia chiarito da tempo il peso notevole della devozione all’Eucaristia in seno all’ordine. Senza insistere in questa sede sul-la quantità e qualità dei trattati eucaristici prodotti da esponenti di spicco della famiglia cistercense nel corso del XII secolo, basterà qui ricordare che, dal XIII secolo, in un’epoca in cui la tendenza genera-le in seno alla Chiesa spinge a comunicare di rado, nei monasteri dell’ordine monaci e monache sono incoraggiati a ricevere la Comunione di frequente, anche più volte in settimana. I cistercensi sembra-no anche aver svolto un ruolo determinante nella diffusione del culto dell’ostia consacrata al di fuori della messa. I due fenomeni, Comunione frequente e devozione al di fuori della messa, furono parti-colarmente intensi e diffusi proprio nei monasteri femminili18. L’implicazione delle cistercensi si situa in una cornice ben più ampia, vigorosamente deli-neata da Caroline Walker Bynum, che ha chiarito quanto e come le donne abbiano contribuito allo sviluppo della devozione eucaristica bassomedie-vale19. In questo quadro, è legittimo chiedersi se la gestualità singolare degli apostoli nell’Istituzione dell’Eucaristia non vada interpretata alla luce delle pratiche proprie alla celebrazione del sacramento in questione. È interessante segnalare al riguardo che un trattatello illustrato contenuto in un mano-scritto inglese del 1310-1320 ca., che si prefigge di mostrare «ceo qe vous devez fere & penser a cha-scon point de la messe», rappresenta i fedeli che, al momento della Consacrazione, tengono le mani giunte in preghiera20.
Il contesto cistercense era dunque favorevole all’apparizione di un’iconografia singolare come quella della pala di Maubuisson21. Quel che vale a un livello generale, sembra inoltre confermato per il caso dell’abbazia di Notre-Dame-la-Royale in particolare22. Una traccia isolata ma affascinante ed eloquente dell’attitudine della comunità locale nei riguardi del Santissimo Sacramento si trova in un lussuoso manoscritto che appartenne alla biblio-teca del monastero. Il codice, oggi separato in due volumi, entrambi pervenuti, per vie diverse, alla
129 La pala d’altare di Maubuisson: note sull’iconografia
British Library di Londra, conteneva in origine vari trattati: la celebre Somme le Roi (Add. ms. 28162) e quattro scritti minori, La Sainte Abbaie, un’ope-retta sull’amore divino, i Livres de l’estat de l’ame e una traduzione francese del De XII utilitatibus tri-bulationis di Pietro di Blois (ms. Yates Thompson 11). La provenienza del manoscritto da Maubuis-son è stata scoperta da Richard e Mary Rouse, che hanno identificato il volume nell’inventario della biblioteca monastica risalente al 1463. I due autori hanno anche provato che il codice dovette essere eseguito espressamente per il monastero23. Miniato probabilmente verso il 129424, il manoscritto inte-ressa qui soprattutto per l’immagine che illustra «le trois estaz de bones ames» (c. 29r). Impersonata da una monaca cistercense, l’anima compare nei quat-tro scomparti in cui è divisa la miniatura a piena pagina (fig. 5): in alto a sinistra essa è inginocchiata davanti a un domenicano e ne riceve l’assoluzione dopo la confessione (è lo stadio che corrisponde alla «contricion»), mentre il alto a destra la stessa prega, sempre inginocchiata, davanti a un gruppo scolpito dell’Incoronazione della Vergine, posato su di un altare («devocion»). Al registro inferio-re, si passa al livello della «contemplacion»: prima
di accedere alla visione della Trinità che le appare nella forma dello Gnadenstuhl, in basso a destra, la monaca si prostra, in basso a sinistra, davanti a un altare su cui è posato il calice, dentro il quale cola il sangue di Cristo, che emerge da una nube nella parte superiore del riquadro, accompagnato da un angelo che tiene la croce25. Il codice londinese at-tende tuttora uno studio d’insieme, che ne metta in valore i testi, in larga parte ancora inediti, e le im-magini, sinora mai esaminate in modo sistematico. Esso indica comunque che a Maubuisson la pala marmorea offerta da Giovanna di Évreux rispon-deva, con la sua singolare iconografia, alle attese devozionali delle monache.
Michele Tomasi
1 F. Baron, Le maître-autel de l’abbaye de Maubuisson au XIVe siècle, «Fondation Eugène Piot. Monuments et mémoires», 57, 1971, pp. 129-151.
2 G. Schmidt, Évrard d’Orléans und die Gräber der vier letzten Kapetinger, in Id., Gotische Bildwerke und ihre Meis-ter, Wien 1992, I, pp. 59-71; F. Baron, Évrard d’Orléans, in Saur. Allgemeines Künstlerlexikon, München-Leipzig 2003, 35, pp. 444-446; P.-Y. Le Pogam, M. Tomasi, scheda n. 20, in Les premiers retables (XIIe-XVe siècle). Une mise en scène du sacré, catalogo della mostra (Paris 2009), a cura di P.-Y. Le Pogam, Paris 2009, pp. 101-105.
3 B. Drake Boehm, Le mécénat de Jeanne d’Évreux, in 1300 ... L’art au temps de Philippe le Bel, actes du colloque inter-national (Paris 1998), a cura di D. Gaborit-Chopin, F. Avril, Paris 2001, pp. 15-31, con bibliografia. Da ultimo, D. Berné, L’action mémorielle des princesses capétiennes à Saint-Denis au XIVe siècle, «Histoire de l’art», 63, 2008, pp. 35-44.
4 Les premiers retables. Si veda anche, in generale, per le pale d’altare nel periodo gotico, l’eccellente raccolta di studi The al-tar and its environment: 1150-1400, a cura di J.E.A. Kroesen, V.M. Schmidt, Turnhout 2009.
5 Sul dibattuto problema del rapporto tra pala d’altare ed Eucaristia mi limito a indicare la messa a punto critica di B. Williamson, Altarpieces, Liturgy and Devotion, «Speculum», 79, 2004, pp. 341-406.
6 E.P. Wipfler, ‘Corpus Christi’ in Liturgie und Kunst der Zisterzienser im Mittelalter, Münster 2003, pp. 125-126, 162.
7 D. Gillerman, The Clôture of Notre-Dame and Its Role in the Fourteenth Century Choir Program, New York-London 1977; F. Baron, La partie orientale détruite du tour du chœur
5. Les trois états de l’âme, Paris o Maubuisson (?), 1294-1295 ca. Londra, British Library, ms. Yates Thompson 11, c. 29r (foto: The British Library).
130 Michele Tomasi
de Notre-Dame de Paris, «Revue de l’Art», 128, 2000, pp. 11-29. Il confronto è tanto più significativo se si rammenta che Gillerman insiste sulla centralità dei temi eucaristici nell’ico-nografia della recinzione. Si veda anche la raffigurazione sul registro inferiore del timpano al portale del transetto nord del-la Cattedrale di Bordeaux, databile verso il 1330-1340: J. Gar-delles, Aquitaine gothique, Paris 1992, pp. 82-85.
8 Si tratta, a mia conoscenza, di un particolare unico. Non ho trovato esempi simili né in G. Schiller, Ikonographie der chri-stlichen Kunst, II. Die Passion Jesu Christi, Güthersloh 1968, pp. 35-51, né in D. Rigaux, À la table du Seigneur: l’eucharistie chez les Primitifs italiens, 1250-1497, Paris 1989.
9 Si può tuttavia ricordare il caso della pala scolpita dell’abba-zia cistercense di Fontenay, in Borgogna (1330 ca.), nella quale il tema eucaristico è allusivamente evocato attraverso l’iconografia di dodici scene della vita di Cristo e di Maria, che attorniano la Crocifissione centrale: D. Sadler, The Retable of the Abbey of Fontenay, in Studies in Cistercian Art and Architecture, a cura di M. Parsons Lillich, Kalamazoo 1993, IV, pp. 89-109, 251-263.
10 Sull’iconografia della leggenda di san Dionigi, in generale, I. Bähr, Saint Denis und seine Vita im Spiegel der Bildüberlie-ferung der französischen Kunst des Mittelalters, Worms 1981; per Tours, pp. 49-50.
11 Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. nouv. acq. fr. 1098, c. 42r (1250 ca.); ibid., ms. fr. 2092, c. 33v (1317). Bähr 1981, rispettivamente pp. 80-98, XI-XX, e 133-200, LX-LXXXI. Cfr. anche, per il secondo, L’art au temps des rois maudits. Phi-lippe le Bel et ses fils, 1285-1328, catalogo della mostra (Paris 1998), a cura di D. Gaborit-Chopin, Paris 1998, pp. 285-286, n. 190 (scheda di F. Avril). Immagini a colori di entrambi i codici sono facilmente accessibili sul sito <http://mandragore.bnf.fr> (9 aprile 2010).
12 Bähr 1981, passim e D. Kimpel, Dionysius (Denis) von Paris, in Lexikon der christlichen Ikonographie, a cura di E. Kirschbaum, VI, Roma et al. 1974, coll. 61-67.
13 Per i manoscritti, cfr. supra nota 11; per la facciata di Saint-Denis, F. Joubert, La sculpture gothique en France XIIe-XIIIe siècles, Paris 2008, p. 120.
14 Les premiers retables 2009, pp. 188-193, n. 51 (scheda di P.-Y. Le Pogam), anche per il rapporto con Maubuisson.
15 La corona, i corni, il berretto frigio e i piedi scalzi, per-mettono d’identificare rispettivamente Davide, Mosè, Daniele e Isaia: Baron 1971, pp. 138-139.
16 Les Fastes du Gothique. Le siècle de Charles V, catalogo della mostra (Paris 1981-1982), a cura di F. Baron, Paris 1981, pp. 91-92, n. 36 (scheda di F. Baron).
17 A. Laabs, Malerei und Skulptur in Zisterzienserorden. Zum Bildgebrauch zwischen sakralem Zeremoniell und Stifter-memoria 1250-1430, Petersberg 2000, pp. 24-25 (ma l’autrice scambia la copia ottocentesca della statuetta newyorkese oggi
a Couilly per una replica); Wipfler 2003, p. 103. L’esempio tedesco più celebre è la statuetta che occupava il centro della pala d’altare della chiesa cistercense maschile di Doberan, del 1300 ca.; oggi la statuetta è integrata, nella chiesa stessa, entro un candeliere del 1400 ca. (ibid.).
18 M.M.C. Hontoir OCR, La dévotion au Saint Sacrément chez les premiers cisterciens (XIIe-XIIIe siècle), in Studia Eucha-ristica. DCCI anni a condito festo Sanctissimi Corporis Chri-sti 1246-1946, Anvers 1946, pp. 132-156. L’impatto di questo vivace culto del Corpo di Cristo sulla produzione artistica è peraltro al centro di due volumi recenti: Laabs 2000; Wipfler 2003. In generale per il culto eucaristico alla fine del Medioevo, M. Rubin, Corpus Christi: the Eucharist in late medieval cultu-re, Cambridge-New York-Oakleigh 1992.
19 C. Walker Bynum, Holy Feast and Holy Fast. The Reli-gious Significance of Food to Medieval Women, Berkeley-Los Angeles-London 1987, in part. pp. 48-69.
20 Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 13342, cc. 45-48v. Cfr. F. Wormald, Some Pictures of the Mass in an English XIVth Century Manuscript, «The Walpole Society», 41, 1966-1968, pp. 39-45 e J.-Cl. Schmitt, La raison des gestes dans l’Occident médiéval, Paris 1990, pp. 346-355.
21 Noto qui, senza poter sviluppare lo spunto, che il frontale e il dossale d’altare del 1330-1340 circa del Museu Nacional d’Art de Catalunya di Barcellona, che presentano un’iconogra-fia singolarissima centrata sull’Eucaristia, e che costituiscono un caso eccezionale nel panorama spagnolo, provengono dal monastero cistercense femminile di Vallbona de les Monges; J.E.A. Kroesen, Staging the Liturgy. The Medieval Altarpiece in the Iberian Peninsula, Leuven 2009, p. 302, figg. 176-177.
22 Per la storia di Maubuisson, bisogna tuttora ricorrere a A. Dutilleux, J. Depoin, L’abbaye de Maubuisson (Notre-Dame-la-Royale): Histoire et cartulaire, 4 voll., Pontoise 1882-1885.
23 R.H. e M.A. Rouse, Manuscripts and their Makers. Com-mercial Book Producers in Medieval Paris 1200-1500, London 2000, I, pp. 155-157. Qui e nella maggior parte delle altre pubblicazioni che lo menzionano, il ms. Yates Thompson 11 è citato sotto la vecchia segnatura Add. 39843. Per la biblio-teca di Maubuisson, A. Bondéelle-Souchier, Les moniales cisterciennes et leurs livres manuscrits dans la France d’Ancien Régime, «Cîteaux», 45, 1994, pp. 193-337, in part. 300-303.
24 Cfr. L’art au temps 1998, pp. 281-283, n. 188 (scheda di F. Avril); da ultimo, Krone und Schleier. Kunst aus mittelal-terlichen Frauenklöstern, catalogo della mostra (Bonn-Essen 2005), a cura di Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesre-publik Deutschland, Bonn e Ruhrlandmuseum Essen, Mün-chen 2005, p. 384, n. 273 (scheda di A. Kumler).
25 Il commento più articolato in J.F. Hamburger, The Vi-sual and the Visionary: art and female spirituality in Late Me-dieval Germany, New York 1998, pp. 131-134 e note relative.
Finito di stampare nel mese di gennaio 2012in Pisa dalle
Edizioni ETSPiazza Carrara, 16-19, i-56126 Pisa