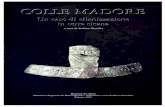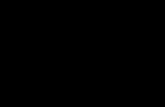La decorazione parietale della domus del quartiere di San Teodoro in Pola
L'antica decorazione absidale della chiesa di San Francesco a Sansepolcro: nuove proposte di...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of L'antica decorazione absidale della chiesa di San Francesco a Sansepolcro: nuove proposte di...
ALTOTIBERINE
ANNO XVI, FASC. 48, SETTEMBRE-DICEMBRE 2012
DELL’ALTA VALLE DEL TEVEREASSOCIAZIONE STORICA
PAGINEALTOTIBERINE
PAGINE
PAG
INE
A
LTO
TIB
ER
INE
XVI
48
48
DELL’ ALTA VALLE DEL TEVEREASSOCIAZIONE STORICA
ANNO XVI 2012
INDICE
Silvia Palazzi - Alvaro Tacchini La Pinacoteca Comunale di Città di Castello dall’Unitàalla definitiva sede di Palazzo Vitelli alla Cannoniera nel 1912 .................. 7
Elda FontanaIl canto del maggio ...................................................................................... 43
Simonetta RiccardiniLo “sgherro” della Crocifissione di Citerna: un esempiodi pittura anti-ebraica nel territorio dell’Alta Valle del Tevere .................. 61
Luciano Vanni“L’affare Riguccini”. Due bozzetti per la chiesa di Santa Maria Maggiore a Città di Castello .............................................. 77
Elena Squillantini – Giacomo GuazziniL’antica decorazione absidale della chiesa di San Francesco a Sansepolcro: nuove proposte di ricostruzioneper un disperso ciclo pittorico del 1403 ...................................................... 91
Antonella LignaniEchi risorgimentali nel Tributo di gratulazione amichevoleper nozze Lottaringhi della Stufa - Pierleoni ............................................ 119
Marcello PellegriniIl Pensionato Sacro Cuore a Città di Castello .......................................... 135
Giuditta RossiUna committenza illuminata incontra un artista“di rarità e bonta d’opra” Il pittore Cristofano Gherardidetto Bocino nel Castello di San Giustino ................................................ 145
Beni artistici e culturali. Andrea Czortek, La riapertura della sede di Palazzo Ducci-Del Rossoper la Biblioteca Comunale “Dionisio Roberti” di Sansepolcro ...............165
Spigolature d’archivioGiulio Cerrini, Bizzarrie climatiche ...........................................................173Giuliana Rosini, Il colera ...........................................................................178Enrico Fuselli, L’esposizione tifernate del 1893in due incisioni d’annata ............................................................................180
elena SquillanTini - GiacoMo Guazzini
L’ANTICA DECoRAzIoNE ABSIDALE DELLA ChIESA DI SAN FRANCESCo A SANSEPoLCRo: NUoVE PRoPoSTE DI RICoSTRUzIoNE
PER UN DISPERSo CICLo PITToRICo DEL 1403 *
La chiesa di San Francesco a Sansepolcro, eretta entro le mura urbane attorno al 1258, tra XIII e XV secolo venne pre-sto a delinearsi come un centro religioso particolarmente attivo, capace di canalizzare le “nuove forme di vita religiosa e di de-vozione” promanate dagli ordini mendicanti 1. Particolarmente significativo si rivelò infatti il culto di un minorita locale morto in odore di santità nei primissimi anni del Trecento, presto di-venuto oggetto di venerazione da parte dell’intera cittadinan-
* Questa ricerca rappresenta un approfondimento della tesi di laurea triennale di Elena Squillantini, Per un corpus della pittura gotica a Sansepolcro, a. a. 2009-2010, relatore prof. Andrea De Marchi e correlatore prof.ssa Sonia Chiodo. Desideriamo ringraziare il geom. Giorgio Guazzini per le elaborazioni grafiche, il prof. Andrea De Marchi per i preziosi consigli, la dott.ssa Mariangela Betti (Mu-seo Civico di Sansepolcro), il personale della Biblioteca Comunale e del Museo Civico di Sansepolcro, don Alberto Gallorini parroco della cattedrale di Sansepol-cro, Stefano Polchi, la dott.ssa Paola Refice e la dott.ssa Jane Donnini (Soprinten-denza di Arezzo), la dott.ssa Maria Matilde Simari (Soprintendenza di Firenze) e il personale del Gabinetto Fotografico degli Uffizi per la disponibilità dimostrata, il dott. Andrea Czortek per l’opportunità di pubblicare in questa rivista.1 a. czorTek, Eremo, convento, città. Un frammento di storia francescana: Sanse-polcro, secoli XIII-XIV, Assisi 2007, pp. 98, 129-131.
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini92
za, ovvero il beato Ranieri (Sansepolcro 1230/40 - 1 novembre 1304) 2. Tale figura agì da irrinunciabile catalizzatore della pia liberalità laica locale nei confronti della chiesa francescana: a seguito della morte del beato i frati minori collocarono quindi le venerate spoglie nella loro cripta, sopra la quale fu eretto l’altare maggiore col finanziamento del comune 3.
Sebbene l’altare trecentesco (1304) si erga ancor oggi nella chiesa francescana come segnacolo della tomba del beato, l’in-terno della chiesa ha subito profondi restauri alla metà del XVIII secolo ad opera di Anton Maria Lancisi, il quale ricavò in testa alla navata centrale una nuova abside semicircolare, obliterante l’antico coro 4. Nel complesso tuttavia la planimetria originale dell’edificio è rimasta sostanzialmente immutata, presentandosi infatti a croce latina con tre cappelle terminali, delle quali quella centrale leggermente sopravanzante.
Di recente l’edificio è stato oggetto di molteplici studi ed approfondimenti da parte di Donal Cooper e James Banker, i quali hanno avuto il merito di avviare una sistematica ricostru-zione degli assetti degli spazi ecclesiali interni, in special modo dell’ambiente absidale originale nonché di un importante ciclo di affreschi figuranti storie di Santa Caterina d’Alessandria, sul quale ci soffermeremo più avanti 5.
2 Si veda Il Beato Ranieri nella storia del Francescanesimo e della terra alto-tiberina, atti del convegno (Sansepolcro 2004), a cura di F. Polcri, Sansepolcro 2005.3 czorTek, Eremo, convento, città cit., pp. 120-128. Il comune svolse un ruolo fondamentale nella promozione del culto del beato, come si desume dal fatto che esso procurò il balsamo per l’imbalsamazione del corpo e diede inizio alla regi-strazione dei suoi miracoli.4 Per un’analisi approfondita sulla tomba del beato Ranieri e sull’altare maggiore si veda d. cooPer - J. r. banker, The church of San Francesco in Borgo San Sepolcro in the late Middle Ages and Renaissance, in Sassetta: the Borgo San Sepolcro alterpiece, a cura di M. Israëls, Firenze 2009, I, pp. 87-94.5 Sull’architettura della chiesa si veda Ivi, pp. 53-76.
93La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
L’abside si presenta di pianta rettangolare, dotato di tre mo-nofore oggi tamponate, quella maggiore sulla parete orientale (centrale), e altre due minori sui lati settentrionale (sinistro) e meridionale (destro). Gli elevati murari absidali originali ri-salenti alla fondazione duecentesca subirono tuttavia ingenti danni in occasione di un devastante terremoto che colpì l’intera città nel 1352: in quella circostanza crollò la volta della campa-ta absidale, causando inoltre la distruzione pressoché completa dell’antico giro di stalli lignei lì collocati 6. Un primo intervento per la sistemazione dell’abside fu promosso dalla Confraternita di San Bartolomeo nel 1376 7, mentre uno successivo fu reso possibile dai donativi di Uguccia, vedova di Paolo di maestro Francesco, la quale nel marzo 1378 conferiva 225 lire a Luca di Bernardo “magister lapidum”, già converso delle clarisse di Santa Maria della Strada, “pro […] refectionis volte supra chorum dicte ecclesie Sancti Francisci de Burgo” 8. Nel maggio dello stesso anno i frati commissionavano al medesimo “frater Luchas” il rifacimento del coro ligneo da collocare “post alta-re maius ecclesie”: in tale documento viene inoltre specificato che gli stalli dovevano esser realizzati “cum prosparis, sedibus, parietibus, coperta intalliis, remissis, tribus anditis a coro bas-so ad corum altum et quatuor legiis” 9. Furono incaricati del
6 Ivi, p. 71.7 In Sansepolcro, Archivio Storico Comunale, ser. XXXII, reg. 179, c. 28r, 1376 ottobre 21: il denaro fornito dalla Confraternita di San Bartolomeo doveva essere speso per “refare et reconciare del coro d’essa ecclesia […] e se alcuno ressiduo vi fusse che se devesse mettare in la concime de la volta d’essa chiesa”. Questo documento e quelli seguenti sono stati pubblicati in appendice al contributo di cooPer - banker, The church of San Francesco cit., II, pp. 585-587.8 In Firenze, Archivio di Stato [ASF], Notarile antecosimiano, 18635, 1378 mar-zo 13 (notaio Santi di Francesco).9 In ASF, Notarile Antecosimiano, 16185, 1378 maggio 14, cc. 93v-94r (notaio Paolo di Ciuccio di Jacopo).
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini94
completamento dell’opera i fratelli Giovanni e Angelo Schiatti, i quali portarono a compimento la commessa nel giro di pochi anni 10. Come osservato da Donal Cooper, nonostante questo ar-redo ligneo risulti ad oggi irrimediabilmente perduto, possiamo farcene un’idea grazie ad un manufatto similare conservato nel-la chiesa francescana di zara in Dalmazia: egli propone infatti di identificare il “magister Johannes de Burgo Sancti Sepulcri”, documentato nel 1394 nei lavori agli stalli dalmati, con il sopra-citato Giovanni Schiatti 11.
Per quanto riguarda invece il ciclo pittorico che in origine ornava l’abside della chiesa borghese, possiamo credere che tale decorazione dovette esser avviata dopo il terremoto del 1352, in singolare concomitanza alla realizzazione del coro ligneo, per il quale si conservano documenti attestanti lavori sino al 1395. Si rivelerà infatti cruciale l’iscrizione recante la data 1403, attestata ancora nell’abside all’inizio del secolo scorso da odoardo hil-lyer Giglioli 12. Sebbene non sia emersa sinora documentazione relativa alla committenza di tale decorazione, possiamo suppor-re che un ruolo significativo potesse esser svolto dall’omonima Confraternita di Santa Caterina, ampiamente documentata in città tra XIV e XVI secolo 13.
10 In ASF, Notarile Antecosimiano, 7149, 1392 giugno 24, fasc. 1390-99, n. 11 (notaio Matteo di Angelo Fedeli): gli operai di San Francesco incaricano i fratelli Schiatti del completamento del coro. I pagamenti relativi alla realizzazione del coro ligneo proseguono documentati sino al 2 febbraio 1395, si veda in cooPer - banker, The church of San Francesco cit., p. 72.11 Proposta avanzata da d. cooPer, Le tombe del Beato Ranieri a Sansepolcro e del Beato Giacomo a Città di Castello: arte e santità francescana nella terra altotiberina prima di Sassetta, in Il Beato Ranieri cit., pp. 109-111, e poi ripresa nella recente pubblicazione da cooPer - banker, The church of San Francesco cit., pp. 73-74.12 o. h. GiGlioli, Sansepolcro, Firenze 1921, p. 17.13 Per la Confraternita di Santa Caterina si veda J. r. banker, Death in the com-munity. Memorialization and Confraternities in an Italian Commune in the Late
95La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
Storia e ipotesi ricostruttiva del ciclo pittorico cateriniano
Nel Museo Civico locale e nella sala capitolare del convento minorita si conservano oggi vari affreschi strappati poco consi-derati, la cui originaria provenienza appare molte volte frainte-sa: tali opere appartengono in realtà, come correttamente indi-viduato da Banker e Cooper, all’originaria decorazione absidale della chiesa di San Francesco.
Quest’ampio ciclo pittorico nel corso dei secoli ha subito va-rie traversie che hanno in parte minato la leggibilità e la soprav-vivenza stessa dell’intero complesso; l’intervento settecentesco del Lancisi rinnovò in forme barocche gli spazi interni della chiesa (1752), innalzando un’abside semicircolare anteposta a quella originale: in tal modo, occultando gli affreschi preesi-stenti, si venne a creare un’intercapedine tra l’estradosso della nuova abside e le pareti di quella antica. Nel corso di questi lavori larga parte della decorazione campeggiante sulla parete settentrionale e meridionale fu inglobata nelle nuove strutture murarie, ragion per cui, per perfezionare la ricostruzione del ciclo dovremo far leva su vari aspetti 14. Un ultimo traumatico
Middle Ages, Athens – Georgia – London 1988, pp. 29-30; cooPer - banker, The church of San Francesco cit., pp. 83-84, e in seguito a. czorTek, La vita religio-sa a Sansepolcro tra medioevo e prima età moderna (1401-1520), in La Nostra Storia, a cura di A. Czortek, II, Sansepolcro 2011, pp. 62-63, il quale presenta le principali commissioni artistiche operate dalle confraternite tra XV e XVI secolo: si deve ricordare infatti che nel 1445 la Confraternita di Santa Caterina commis-sionava al pittore senese Pietro di Giovanni d’Ambrogio un gonfalone opistogra-fo, oggi conservato al Musée Jacquemart-André di Parigi.14 Per l’iconografia di Santa Caterina d’Alessandria si veda G. kaFTal, s.v. St. Catherine of Alexandria, in Iconography of the saints in Tuscan painting, Firenze 1952, pp. 225-234; id., St. Catherine of Alexandria, in Iconography of the saints in central and south italian schools of painting, Firenze 1965, pp. 256-268; id., St. Catherine of Alexandria, in Iconography of the saints in the painting of north east
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini96
frangente che tale complesso ha dovuto subire è stato lo strappo ed il trasporto su supporto mobile delle varie scene avvenuto ne-gli anni cinquanta e sessanta dello scorso secolo ad opera della Soprintendenza alle Gallerie di Firenze, Pistoia e Arezzo 15.
Tra le prime indicazioni che documentano tale ciclo ancora in situ, possiamo annoverare la testimonianza ottocentesca di Giacomo Mancini, il quale lo credeva riferibile alla mano di Giotto, attribuzione questa che ha avuto consenso per tutto il XIX secolo ed è stata singolarmente riproposta di recente da Ro-berto Manescalchi 16. Sebbene non sia questa la sede in cui po-tranno esser approfondite puntualmente le coordinate artistiche dell’anonimo pittore, rimandando per ciò ad un nostro contribu-to di prossima pubblicazione, basterà precisare che in questi af-freschi si avverte una cultura più complessa e composita rispetto a quanto sinora reputato 17. Vi sono infatti influenze promananti
Italy, Firenze 1978, pp. 188-201; id., St. Catherine of Alexandria, in Iconography of the saints in the painting of north west Italy, Firenze 1985, pp. 183-190.15 F. chieli, Il Museo civico di Sansepolcro: una corrispondenza tra i luoghi e le immagini, in Piero della Francesca. Il Museo civico di Sansepolcro, a cura di A. Brilli e F. Chieli, Cinisello Balsamo (Mi) 2002, pp. 31-32, nn. 23-25 a pp. 35-37.16 G. Mancini, Istruzione storico-pittorica per visitare le chiese e palazzi di Città di Castello, colle Memorie di alcuni artefici del disegno che in detta città fioriro-no, II, Perugia 1832, p. 268; G. SaccheTTi, Sansepolcro, Sansepolcro 1888, p. 7; l. coleSchi, Storia di Sansepolcro dalle origini al 1860, Città di Castello 1886, p. 169; r. ManeScalchi, Caterina, la santa ritrovata: un frammento di affresco opera di intensa emozione in grado di evocare il nome di Giotto, Sansepolcro 2006, pp. 27-28. 17 v. chiaSSerini, La pittura a Sansepolcro e nell’Alta Valle Tiberina prima di Piero della Francesca, Sansepolcro 1951, pp. 24-25, avvertiva “una fortissima analogia con le formose e robuste figure muliebri” di Ambrogio Lorenzetti, avan-zando poi il nome di un pittore locale, Agnolo di Maffuccio, documentato in la-vori marginali per la chiesa in anni attorno al 1384; e. aGnoleTTi, Il museo civico, Sansepolcro 1977, p. 48, in linea con la Chiasserini, sosteneva che gli affreschi “ricordano le figure femminili di Ambrogio Lorenzetti”, mentre a. M. MaeTzke, Il museo civico di Sansepolcro, Milano 1983 (II edizione aggiornata Milano 1991),
97La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
da un lato dal sensibile pittoricismo della pittura orvietana, at-torno a Cola Petruccioli, e dall’altro dalla soda e tagliente vo-lumetria di cultura spoletina, attorno all’anonimo Maestro della Dormitio di Terni. Per comodità nomineremo allora il nostro anonimo Maestro delle storie di Santa Caterina del 1403.
Tornando quindi alla ricognizione storica del complesso, nei primi decenni del secolo scorso Giglioli, seguito da Ivano Ric-ci, considerava succintamente le pitture francescane mettendo in luce il loro pessimo stato conservativo e indicandone una possi-bile datazione tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo 18. Vera Chiasserini attorno alla metà del secolo ne proponeva invece una descrizione più puntuale, specificando nel dettaglio alcune scene 19. La studiosa illustrava infatti nel complesso “in alto, a sinistra della composizione, uno sbirro [che] rimuove con vio-lenza un ordigno, mentre dietro a lui la santa di cui non è più visibile che il tronco sta in piedi, con le mani legate sul dorso,
pp. 89-90, li riteneva opera “di un pittore locale della seconda metà del Trecento di influenza senese e aretina”. Per a. M. MaeTzke - d. GaloPPi naPPini, Il museo civico di Sansepolcro, Firenze 1988, pp. 120-121 “sembrerebbe collegarsi con la scuola aretina di metà Trecento […] con le caratteristiche tipologiche del giotte-sco Buffalmacco”, giudicando che “l’affresco possa datarsi a cavallo tra la prima e la seconda metà del Trecento”; d. PeGazzano, Il museo civico di Sansepolcro, Montepulciano 2001, pp. 36-38, li reputa invece riferibili “ad un artista aretino di metà Trecento”; per cooPer - banker, The church of San Francesco cit., p. 76, l’intervento di Agnolo di Maffuccio “can now be discounted”, conseguendo poi a p. 83 che “an attribution to the local painter Agnolo di Maffuccio cannot be excluded, even if the cycle is unconnected to the payment of six florins discussed above”.18 GiGlioli, Sansepolcro cit., p. 17: “Nell’antico coro dietro l’attuale, avanzi di affreschi della fine del sec. XIV e del principio del sec. XV, in cattivo stato di conservazione. Si notano iscrizioni frammentarie e la data: 1403”; i. ricci, Borgo Sansepolcro, Sansepolcro 1932, p. 41: “La chiesa fu di bella architettura, a croce greca, in stile gotico (mirabili avanzi restano nell’antico coro, che ornato di affre-schi del sec. XIV e XV, oggi si trova in cattivo stato)”.19 chiaSSerini, La pittura a Sansepolcro cit., pp. 22-25.
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini98
trattenuta da due guerrieri. Più avanti l’imperatore assiste, im-passibile, accanto al suo cortigiano”, episodio identificabile per lei nel Martirio di Santa Caterina d’Alessandria 20. La Chias-serini tuttavia interpretava erroneamente la scena, dal momento che in basso a sinistra possiamo intravedere le fiamme relative all’episodio del rogo dei filosofi in cui rimangono frammenti dei piedi di un condannato, scena non certo identificabile nel mar-tirio delle ruote. Altro elemento frainteso appare la figura stes-sa della Santa, che risulta riconoscibile nella parte destra della composizione per la foggia dell’abito e l’aureola, personaggio questo additato dall’imperatore Massenzio assiso su un ampio trono: ragion per cui possiamo individuarvi Santa Caterina che disputa con i filosofi col Martirio dei filosofi (fig. 1) 21. La Chias-serini proseguiva quindi notando che nella parte inferiore vi era “un giovane recante una torcia, alcuni guerrieri e S. Caterina d’Alessandria benedicente l’imperatrice”, per poi distinguere significativamente “proprio a destra dell’affresco suddetto […] la data 1403” 22. Questa scena è stata riconosciuta da Banker e Cooper nella Visita dell’imperatrice Faustina a Santa Caterina in prigione conservata oggi nel Museo Civico (fig. 2) 23. Tali
20 Ivi, p. 22.21 JacoPo da varazze, Legenda Aurea, XIII secolo (ed. cons. a cura di A. e L. Vi-tale Brovarone, Torino 2007, p. 970), capitolo CLXVII: “Accorgendosi dunque il Cesare che non poteva muoversi contro la sapienza di Caterina, mandò una lettera per convocare con urgenza tutti i grammatici e i retori al pretorio di Alessandria: avrebbero guadagnato un fortissimo compenso se fossero con le loro obiezioni riusciti a vincere le argomentazioni di quella vergine oratrice”. Una volta che l’imperatore venne a sapere che gli oratori erano stati confutati da Santa Caterina dette ordine che fossero arsi vivi: questi tuttavia si convertirono prima dell’esecu-zione della condanna.22 chiaSSerini, La pittura a Sansepolcro cit., pp. 23-24.23 Si possono proporre alcuni confronti iconografici per la scena della Visita dell’Imperatrice Faustina a Santa Caterina in prigione, quali l’affresco della fine del XIII secolo strappato dalla chiesa di Sant’Agnese fuori le mura a Roma adesso
99La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
Figg. 1-2 Maestro delle storie di Santa Caterina del 1403, Santa Caterina che disputa con i filosofi col Martirio dei filosofi (in alto), e (in basso) Visita dell’im-peratrice Faustina a Santa Caterina in prigione (Sansepolcro, Museo Civico).
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini100
indicazioni sono di primaria importanza sia per la ricostruzione del ciclo pittorico proposta da questi studiosi, sia per le conside-razioni che tra poco svolgeremo 24. Come risulta dai documenti dell’archivio vescovile locale le scene del ciclo furono distac-cate dal supporto murario per volere della Soprintendenza in due distinti interventi, uno databile tra 1954 e 1958, e l’altro tra 1965 e 1966 25. Se da un lato sappiamo che nella prima opera-zione furono strappati Santa Caterina che disputa con i filosofi e loro martirio, e la Visita dell’imperatrice Faustina a Santa Ca-terina in prigione (oggi nel Museo Civico), per il secondo inter-vento purtroppo non si rintracciano notizie che possano fornire indicazioni puntuali 26. Nel corso degli anni gli affreschi esposti nelle collezioni civiche sono stati ritenuti provenienti da molte-plici luoghi: secondo Anna Maria Maetzke e Daniela Galoppi Nappini 27 sarebbero state “staccate dall’ex chiesa di San Nic-colò”, riconducibili a due diverse mani 28, e rappresenterebbero una scena della vita di Sant’Amelia e una di Santa Caterina 29.
collocato in Pinacoteca Vaticana, il lacerto rimasto a Scandicci (Firenze) nella chiesa di San Jacopo presso Villa Castelpulci, l’omonima scena affrescata da An-drea de’ Bartoli nella Basilica inferiore di Assisi e da Spinello Aretino nell’orato-rio di Santa Caterina dell’Antella (Bagno a Ripoli, Firenze). Inoltre nella Legenda Aurea (Legenda Aurea cit., p. 972) questo episodio narra che “quando la regina entrò nella prigione, la vide [sc. Santa Caterina] rifulgere di una luce indicibile, e vide gli angeli che curavano con unguenti le ferite della vergine. Subito la vergine cominciò a predicarle le gioie eterne, la convertì alla fede e le predisse la corona del martirio. Anche Porfirio udì tutte quelle parole e cadde ai piedi della vergine e ricevette la fede di Cristo, con duecento altri soldati”.24 Cfr. cooPer - banker, The church of San Francesco cit., pp. 76-84.25 Ivi, p. 77, n. 118; chieli, Il Museo civico cit., nn. 23-25 a pp. 35-37. 26 cooPer - banker, The church of San Francesco cit., pp. 77-78.27 MaeTzke - GaloPPi naPPini, Il museo civico cit., pp. 120-123; MaeTzke, Il mu-seo civico cit., pp. 89-90.28 MaeTzke - GaloPPi naPPini, Il museo civico cit., p. 120. 29 Ivi, pp. 120-123. In realtà l’episodio della vita di Sant’Amelia deve essere iden-tificato con la Visita dell’imperatrice Faustina a Santa Caterina in prigione.
101La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
D’altra parte si può constatare come nei cataloghi più recenti sia stata correttamente riconosciuta la provenienza dalla chie-sa francescana per la Santa Caterina che disputa con i filosofi e loro martirio 30, mentre l’altro affresco del museo, la Visita dell’imperatrice Faustina, appare ancora erroneamente identifi-cato con “un episodio della vita di Sant’Amelia”, strappato dalla chiesa di San Niccolò 31.
La prima a riconoscere queste opere come pertinenti al ciclo cateriniano è stata Francesca Chieli, seguita da James Banker e Donal Cooper 32, i quali hanno ricondotto allo stesso com-plesso altri affreschi attualmente situati nella sala capitolare del convento raffiguranti il Matrimonio mistico di Santa Caterina (fig. 3) 33 e un gruppo di Soldati (fig. 4) facenti originariamente
30 PeGazzano, Il museo civico cit., pp. 36-38; a. brilli - F. chieli, Sansepolcro e i suoi musei, Sansepolcro 2004, p. 73.31 PeGazzano, Il museo civico cit., p. 37. La studiosa propone di riconoscere la scena della Visita dell’imperatrice Faustina a Santa Caterina in prigione con un episodio della vita di Sant’Amelia, ipotizzando che la “donna nella nicchia” po-tesse essere “la nobile romana Amelia, vissuta nel VI secolo, che raccomanda alla sorella Tanzilla il loro nipote, il futuro San Gregorio Magno, che fu allevato ed educato, come narra la tradizione, dalle due donne”.32 chieli, Il Museo civico cit., nn. 23-25 a pp. 35-37; cooPer - banker, The church of San Francesco cit., pp. 79-80.33 Per uno studio approfondito sul tema del Matrimonio mistico di Santa Caterina, si rimanda a P. iacobone, Il matrimonio mistico di Santa Caterina d’Alessandria nell’arte italiana (XIV-XVI secolo), in «Annali della Pontificia Insigne Accade-mia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi del Pantheon», VI, 2006, pp. 187-212. Per quanto riguarda l’iconografia, l’opera borghese non si allinea con la canonica raffigurazione della santa genuflessa o stante davanti al Bambino tenuto in braccio dalla Madonna seduta in trono: Caterina è infatti rappresentata nella sua camera completamente distesa sul letto, mentre in sogno appaiono la Vergine e il Bambi-no. Tale raffigurazione iconografica può essere rintracciata in poche altre opere, come negli affreschi del Maestro di Offida nella chiesa di Santa Maria della Rocca nell’omonima città, in quelli di Spinello Aretino in San Domenico ad Arezzo. Si veda G. croceTTi, Una nota sul Maestro di Offida pittore marchigiano del sec. XIV, in «Arte cristiana», LXXIX, 1991, pp. 353-362; a. TarTuFeri, Qualche
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini102
Figg. 3-4 Maestro delle storie di Santa Caterina del 1403,Matrimonio mistico di Santa Caterinae Soldati(Sansepolcro, San France-sco, sala capitolare).
Fig. 5 Visitadell’imperatriceFaustina a Santa Caterina in prigione (ricostruzione in cooPer-banker, The church of San Francesco cit.).
103La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
parte della Visita dell’imperatrice Faustina a Santa Caterina in prigione (fig. 5) 34.
La Chieli ha segnalato infatti un’importante corrispondenza degli anni sessanta dello scorso secolo intercorsa tra il conven-to francescano e la Soprintendenza di Arezzo, ove il parroco della chiesa Tarcisio della Rovere richiedeva un sopralluogo nel coro temendo un “imminente pericolo di distacco dell’af-fresco nell’abside dugentesca” 35. In occasione dell’ispezione ri-chiesta, il funzionario Corrado Rosini descriveva l’affresco del Martirio dell’imperatrice Faustina notando nella parte inferiore dell’opera “un’iscrizione frammentaria in caratteri gotici: … se-gio imperatore fece decollare l’imperatr … e di fianco la data 1403” 36.
Utilizzando quindi le informazioni fornite da Rosini e dalla Chiasserini, i recenti studi hanno avuto modo di proporre una ri-costruzione complessiva del ciclo pittorico valutando che la data da un lato risultava strettamente collegata alla scena del Martirio dell’imperatrice Faustina, e dall’altro era collocata alla destra della Disputa di Santa Caterina e della Visita dell’imperatrice
osservazione sul Maestro di Offida e alcuni appunti sulla pittura del Trecento nell’Abruzzo teramano, in «Arte cristiana», LXXXVIII, 2000, pp. 249-258; S. WePPelMann, Spinello Aretino e la pittura del Trecento in Toscana, Livorno 2011, pp. 277-278.34 cooPer - banker, The church of San Francesco cit., p. 80, fig. 60.35 chieli, Il Museo civico cit., n. 25 a pp. 36-37; cooPer - banker, The church of San Francesco cit., p. 77, n. 119. 36 Iconograficamente l’affresco appare confrontabile all’omonima scena affrescata da Spinello Aretino nell’oratorio di Santa Caterina all’Antella (Bagno a Ripoli, Firenze) e in quella dipinta nel dossale di Santa Caterina d’Alessandria e storie della sua vita realizzato da Gregorio e Donato d’Arezzo adesso conservato al J. Paul Getty Museum di Los Angeles. Si veda S. WePPelMann, Spinello Aretino e la pittura del Trecento cit., pp. 226-227; r. barTalini, Da Gregorio e Donato ad An-drea di Nerio: vicende della pittura aretina del Trecento, in Arte in terra d’Arezzo. Il Trecento, a cura di A. Galli e P. Refice, Firenze 2005, p. 13, fig. 2.
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini104
Faustina 37. Ne consegue quindi che il Martirio dell’impera-trice doveva trovar spazio alla destra della Disputa e della Vi-sita dell’imperatrice. Considerando inoltre le dimensioni degli affreschi strappati in relazione agli spazi originari delle pareti absidali, è stata avanzata l’ipotesi che il ciclo, impostato ad una notevole altezza dal pavimento (per permettere l’inserzione del doppio giro di stalli lignei), si svolgesse su un duplice registro sovrapposto, occupante la metà inferiore delle pareti per un to-tale di otto scene: due sul lato Nord, quattro sul lato Est e due a Sud 38. Secondo questa ricostruzione lo svolgimento narrati-vo procederebbe quindi dalla parete settentrionale dell’abside (lato sinistro), verso quella meridionale (lato destro): per questo motivo è stato ipotizzato come primo episodio, da collocarsi in alto sul lato settentrionale, la Santa Caterina e la madre che visitano l’eremita, con sotto Il Battesimo di Santa Caterina, purtroppo perduti. Procedendo oltre è stato supposto che sul-la parete orientale, alla sinistra della monofora centrale, si tro-vasse in alto il Matrimonio mistico e in basso la scena non più esistente della Santa che appare all’imperatore Massenzio; alla destra dell’apertura invece in alto Santa Caterina che disputa con i filosofi e loro martirio e in basso la Visita dell’imperatrice Faustina a Santa Caterina in prigione. Sulla parete meridionale
37 Nella Legenda Aurea di Jacopo da Varazze (Legenda Aurea cit., p. 973) è raccontata la cruenta scena del martirio dell’imperatrice avvenuta a seguito del suo veemente risentimento per l’efferato operato del marito: questi aveva infatti ordinato di uccidere Caterina con un marchingegno composto da quattro ruote. Massenzio ordinò tuttavia ai suoi sgherri di condurre fuori città la moglie e di de-capitarla; quando il giorno successivo si giunse a cercare il corpo dell’imperatrice, ci si accorse che questo era stato portato via e seppellito ad opera di Porfirio. Non trovando quindi il corpo della moglie, Massenzio impose l’uccisione di numerosi uomini: Porfirio confessò allora di averla sepolta e di aver abbracciato il cristiane-simo, seguito poco dopo dai suoi soldati. Sentendosi dunque tradito dai suoi stessi uomini, Massenzio comandò che tutti questi rei fossero brutalmente decapitati.38 cooPer - banker, The church of San Francesco cit., pp. 81-82.
105La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
infine avrebbe dovuto trovare spazio il Martirio dell’imperatri-ce Faustina nel registro superiore e in quello inferiore, essendo presente un frammento di affresco raffigurante la testa di Santa Caterina orante, il Tentato martirio con le ruote assieme alla Decollazione della Santa 39.
Questa ricostruzione appare suscettibile tuttavia di qualche puntualizzazione, da una parte riconsiderando le notizie storiche già citate, e dall’altra facendo leva su nuovi indizi e documen-tazioni fotografiche inedite. Rammentando dunque le sfuggen-ti descrizioni del secolo scorso, desumiamo che la Disputa di Santa Caterina sormontava la Visita dell’imperatrice Faustina: la questione è dunque stabilire se il Martirio di Faustina fosse collocato originariamente sul lato meridionale del coro (come proposto da Banker e Cooper) o piuttosto, come crediamo, nella parte destra del lato orientale. Nel corso delle ricerche si è potu-to rinvenire nel Gabinetto Fotografico degli Uffizi la riproduzio-ne fotografica di quest’ultimo affresco strappato oggi introvabi-le, ma che speriamo grazie a questa segnalazione possa essere individuato (fig. 6) 40. La scena, caratterizzata da una struttura complessa, appare popolata da una moltitudine di figure dram-maticamente clamanti tra le quali si nota in basso a sinistra la fi-gura dell’imperatrice posta di sbieco, franante a terra pochi atti-
39 Ivi, p. 78, n. 121. Gli studiosi propongono il confronto iconografico tra la testa di Caterina e la figura della Santa nella scena del Tentato martirio con le ruo-te negli affreschi di Spinello Aretino in San Domenico ad Arezzo, si veda WeP-PelMann, Spinello Aretino e la pittura del Trecento cit., pp. 277-278. Potremmo inoltre confrontare tale episodio con quello rappresentato da Gregorio e Donato d’Arezzo nel dossale con Santa Caterina d’Alessandria e storie della sua vita del J. Paul Getty Museum di Los Angeles, si veda barTalini, Da Gregorio e Donato ad Andrea di Nerio cit., p. 13, fig. 2.40 Le fotografie del Gabinetto Fotografico degli Uffizi (negg. 177851 e 177853) mostrano la scena del Martirio dell’imperatrice Faustina dopo il restauro, senza indicare alcun riferimento dimensionale.
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini106
Fig. 6 Maestro delle storie di Santa Caterina del 1403, Martirio dell’imperatrice Faustina e Decapitazione di Porfirio assieme ai soldati convertiti (ubicazione scono-sciuta, G.F.U neg.177851).
mi dopo la decapitazione. Intorno ad essa si dispiega un gruppo di dolenti panneggiate con vesti ampie e frastagliate, mentre in secondo piano è posta una donna con le braccia levate al cielo. Nella porzione superiore sinistra dell’affresco è raffigurato in-vece l’imperatore Massenzio affacciato da un alto loggiato or-dinante col braccio teso la condanna della moglie e dei soldati convertiti: sotto di lui uno sgherro colto di profilo con la spada sguainata nell’atto di colpire un malcapitato è echeggiato nella parte opposta della scena da un secondo manigoldo che compie il medesimo raccapricciante ufficio. Nella parte centrale, in alto, due angeli appaiono intenti a sorreggere l’animula dell’impera-trice, mentre altri due, dotati di un ampio e candido panneggio, accorrono da destra. Sebbene nella precedente ricostruzione si
107La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
Figg. 7-8 Maestro delle storie di Santa Caterina del 1403, sinopia del Martirio dell’imperatrice Faustina e Decapitazione di Porfirio assieme ai soldati converti-ti (Sansepolcro, San Francesco); Martirio dell’imperatrice Faustina e Decapitazione di Porfirio assieme ai soldati convertiti (part., ubicazione sconosciuta, G.F.U neg.177851).
sia valutato opportuno porre tale episodio sulla parete meridio-nale, vi sono indizi precisi che ci permettono di posizionarlo puntualmente nel registro inferiore della parte destra del lato orientale. Se si osserva infatti con particolare attenzione tale pa-rete, in corrispondenza del registro inferiore destro, al lato della monofora tamponata, è possibile ancor oggi intravedere estesi resti di una sinopia in cui si distingue sia la sagoma del gruppo di figure centrale, sia in particolare il corpo di Faustina posto in diagonale, accompagnato da altre figure disposte in semicer-chio, delle quali si percepiscono gli ampi panneggi. In secondo piano riconosciamo le linee compositive della figura femminile con il braccio destro levato e quelle di una figura maschile sul-la sinistra, rappresentata di spalle con il profilo rivolto verso l’esterno. Questa sinopia appare quindi chiaramente pertinente al Martirio dell’imperatrice Faustina, indicandoci esattamente il punto in cui tale affresco era originariamente collocato e con-
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini108
sentendoci quindi di riposizionarlo con grande precisione (figg. 7, 8; tav. II, f).
Ritornando brevemente alla scena scoperta, nella parte bas-sa dell’affresco si sviluppa un’iscrizione purtroppo frammen-taria, già trascritta in parte da Rosini, in cui si possono legge-re queste parole: “[Mas]se[n]tio i[m]pera[to]re fece decollare lampera[trice] camortale per[…]nio”. Nei depositi della Soprin-tendenza fiorentina di Palazzo Pitti, è stato possibile inoltre ri-trovare altri due frammenti strappati pertinenti a questa decora-zione: il primo presenta solo alcune lettere “[Ca]ter[ina]”, men-tre l’altro conserva alcune lettere “[…]inata” seguite in basso dall’importante data 1403 riportata in caratteri romani “MCCC-CIII”, relativa al Martirio di Faustina (fig. 9).
Nella fotografia dell’affresco possiamo notare due grandi lacune presenti nell’iscrizione in corrispondenza dell’angolo sinistro e circa al centro: queste perdite sono dovute all’antica inserzione in rottura di una serie di peducci pensili tardorina-scimentali, dei quali si conserva un esemplare (nella parte più meridionale), e di cui si distingue ancora chiaramente il punto di innesto di altri tre mensoloni non più in situ (tav. II). Dal mo-mento che in corrispondenza di tali rotture non potrebbe esser sopravvissuta alcun tipo di decorazione, sembra evidente che il frammento datato provenga dalla parte destra dell’iscrizione, subito a fianco del peduccio conservato.
Poco sopra, in corrispondenza del registro superiore, a de-stra della monofora, si possono intravedere sparuti resti di una seconda sinopia, stavolta molto più frammentari e problematici: al centro si distingue una forma ovoidale inclinata sulla destra, adagiata su una più ampia linea arcuata rivolta verso il basso, in cui possiamo riconoscere la sinopia relativa al Matrimonio mistico, con ciò che rimane della testa della Santa adagiata su un ampio cuscino e del suo braccio destro disteso verso Gesù Bam-
109La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
bino (figg. 10-11; tav. II, c). Considerando che l’episodio del Matrimonio mistico appare solitamente tra le prime scene dei cicli cateriniani, dopo Conversione e Battesimo, potremmo in prima battuta pensare che tale scena dovesse collocarsi piutto-sto in seconda posizione, ovvero nella parete settentrionale: tale ipotesi non risulta tuttavia sostenibile per ragioni dimensionali. La superficie muraria che si distende nel lato settentrionale dal punto d’innesto dell’abside settecentesco alla monofora, desti-nata ad accogliere due registri di scene, non appare infatti com-patibile con le dimensioni di questo affresco, poiché quest’ulti-mo risulta largo cm 305 (pur decurtato di parte del lato sinistro), mentre lo spazio disponibile si rivela di soli cm 245.
Per quanto riguarda la disposizione delle scene sulla parete settentrionale e meridionale, dobbiamo condurre qualche più at-tenta considerazione: dal momento che la data 1403 è ricordata dalla Chiasserini “a destra” della Disputa di Santa Caterina e della Visita dell’imperatrice Faustina, ne consegue che questi ultimi affreschi dovevano collocarsi alla sinistra di tale data, che come abbiamo visto stava sotto il Martirio dell’imperatrice Faustina, nel registro inferiore destro della parete orientale (tav. II, f). Dovrà quindi esser stabilito se questa collocazione a sini-stra valga per la parete settentrionale oppure per quella orienta-le. Elemento dirimente si rivela la valutazione dimensionale di affreschi e spazi disponibili: la larghezza della Disputa risulta infatti di cm 268, decurtata inoltre di una vasta parte della zona destra; nella parte sinistra si intravede invece la banda decorati-va certificante il termine del campo pittorico. La Visita dell’im-peratrice Faustina si presenta inoltre ancor più larga, misurando cm 319,5, mentre lo spazio disponibile sulla parete settentriona-le, come si è detto, consta di soli cm 245. Ne deriva quindi che ogni affresco ipoteticamente strappato da tale lato debba oggi esser non più largo di cm 245. La coppia di scene trovava quindi
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini110
Figg. 10-11 Maestro delle storie di Santa Caterinadel 1403, sinopia delMatrimonio misticodi Santa Caterina e part.(Sansepolcro, San Francesco).
Fig. 12 Maestro delle storiedi Santa Caterina del 1403,Tentato martirio con le ruote,particolare(Sansepolcro, San Francesco).
Fig. 9 Maestro delle storiedi Santa Caterina,Martirio dell’imperatrice Faustina e Decapitazionedi Porfirio assieme ai soldati convertiti, part. data(Firenze, depositi dellaSoprintendenza).
111La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
necessariamente posto nella metà sinistra della parete orientale, che presenta una ben più ampia superficie disponibile, ovvero cm 380 tra l’angolo settentrionale e l’imposta sinistra della mo-nofora centrale (tav. II, d-e). Un ultimo indizio corroborante tale ipotesi è la stessa lacuna di sagoma diagonale presente nel lato sinistro della Visita dell’imperatrice Faustina: è possibile in-fatti riconoscervi puntualmente, anche a livello dimensionale, l’impronta della rampa di scale immorsata sulla parete orientale obliterante in parte tale affresco (tav. II, e). Significativamente il frammento strappato dei Soldati proviene proprio da questa por-zione individuabile nello spazio di risulta del sottoscala. Si può quindi concludere che le quattro scene più estese afferiscono tutte alla parete orientale più libera e meno compromessa dagli interventi settecenteschi.
Passando alla parete meridionale, notiamo che nel registro inferiore rimangono alcuni lacerti pittorici raffiguranti la testa di Santa Caterina, parte del suo mantello, le braccia poste in posi-zione orante e una banda decorativa superiore (fig. 12). Sopra la testa della Santa è ancor in parte leggibile un oggetto di colore marrone di forma semicircolare dotato di particolari protube-ranze: ad una attenta analisi esso si rivela una porzione di ruo-ta lignea uncinata, ricollegabile quindi all’episodio del Tentato martirio con le ruote (tav. III, g) 41.
Utilizzando un altro scatto del Gabinetto Fotografico degli Uffizi presentiamo un secondo frammento strappato del ciclo, l’ubicazione del quale rimane ancora sconosciuta, con la speran-za poterlo un giorno rinvenire nei depositi della Soprintendenza
41 Il Martirio delle ruote dovrebbe trovarsi a rigor di logica dopo la Decapita-zione dell’imperatrice Faustina, come narra Jacopo da Varazze nella biografia (Legenda aurea cit., pp. 972-973). A seguito del rifiuto di Caterina di diventare nuova regina al fianco di Massenzio, egli condannò la santa al martirio delle ruote, supplizio che colpì profondamente l’imperatrice Faustina.
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini112
di Firenze o Arezzo (fig. 13) 42. Sebbene le condizioni conserva-tive appaiano molto compromesse da una diffusa caduta di pig-mento pittorico, nella parte alta si intravede un gruppo angelico elevante in cielo il corpo della martire disteso orizzontalmente, mentre un angelo poco sotto si dirige a precipizio verso il basso. Nella parte alta possiamo quindi riconoscere il Trasporto mira-coloso del corpo della Santa sul monte Sinai, mentre in basso doveva trovarsi la Decapitazione di Santa Caterina 43, come si osserva nell’omonima scena affrescata da Andrea de’ Bartoli nella cappella Albornoz nella Basilica inferiore di San France-sco ad Assisi databile attorno al 1367-68 (fig. 14) 44.
Le dimensioni di questo lacerto non sono specificate nella documentazione, ma possiamo indiziariamente ottenerle me-diante fotogrammetria, considerando che la fascia decorativa nella porzione superiore del frammento è costituita da tre bande – dall’interno verso l’esterno – di color ocra, rosso e bianco, ciascuna delle quali larga in media cm 3,5. Le dimensioni che otteniamo da questo computo si aggirano quindi sui cm 189 circa di altezza per cm 96 di larghezza: porzione allora relati-vamente piccola, giacché possiamo stimare la dimensione me-dia delle scene in cm 350 per cm 250, comprendendo le fasce
42 Gabinetto Fotografico degli Uffizi, neg. 177855.43 Nell’ultimo episodio della vita (Legenda aurea cit., p. 974) viene narrato che dopo la decapitazione iniziò a sgorgare dal corpo di Caterina “latte e non sangue”, dopodiché “gli angeli presero il suo corpo e lo trasportarono da quel luogo sino al Monte Sinai, con un viaggio di più di venti giorni, e lì lo seppellirono con tutti gli onori. Dalle sue ossa sgorga senza sosta un olio che sana le membra di tutti i malati”.44 c. aGlieTTi, L’iconografia della cappella di Santa Caterina d’Alessandria nella Basilica inferiore di Assisi: il rapporto tra le fonti agiografiche e la “legenda” affrescata, in «Iconographica», VI, 2007, p. 96, fig. 11; La cappella di S. Caterina di Alessandria, in La basilica di San Francesco ad Assisi, a cura di G. Bonsanti, Mirabiliae Italiae 11, 4 tomi, vol. III (Atlante fotografico Basilica Inferiore, 1), Modena 2002, p. 165.
113La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
decorative 45. Potremmo domandarci allora in quale punto tale brano dovesse collocarsi: dal momento che la parete orientale si presenta in questa ricostruzione già satura, e quella meridionale presenta il frammento del Martirio delle ruote, appare logico porlo in stretta relazione con quest’ultimo episodio, del quale la Decapitazione (da ritenersi perduta) ed Assunzione si configura-no come vicenda successiva (tav. III, h).
45 I fascioni decorativi sono costituiti da una banda pentapartita di colore bianco di cm 3,5 (media), verde di cm 3,5 (media), decorazione finto cosmatesca di cm 10 (media), verde di cm 3,5 (media) e bianco di cm 3,5 (media). Le scene presentano inoltre altre due fettucce che incastonano la figurazione principale: una ocra più interna (cm 3,5 in media) ed una rossa più esterna (cm 3,5 in media) in contatto con la più ampia banda pentapartita già descritta.
Fig. 13 Maestro delle storie di Santa Caterina del 1403, Decapitazione di Santa Ca-terina e Trasporto miracoloso sul monte Sinai (ubicazione sconosciuta, G.F.U. neg. 177855). Fig. 14 Andrea de’ Bartoli, Decapitazione di Santa Caterina e Trasporto miracolo-so sul monte Sinai (1367-1368, Assisi, Basilica inferiore di San Francesco, Cappella Albornoz).
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini114
Se sulla parete orientale trovano spazio gli avvenimenti cen-trali della vita di Caterina (quattro), ed in quella meridionale le vicende terminali (due), sembra plausibile disporre le tappe iniziali proprio sulla parete settentrionale, superficie ove pur-troppo si conservano solo minimi frammenti pittorici. Tra le vicende salienti che avrebbero dovuto qui anticamente trovar posto pare evidente dovesse esservi l’episodio della Conver-sione della Santa e il suo Battesimo: di questi non è rimasto purtroppo che un piccolo lacerto di panneggio e una parte della fascia decorativa centrale (figg. 15-16). La porzione che con-serva il panneggio parrebbe comunque riconducibile alla figura di Caterina, poiché la veste presenta la stessa colorazione rosso vinaccia con inserzione di verde scuro ricorrente abitualmente nel costume della Santa. Se osserviamo meglio il tratto d’into-naco circonvicino è possibile distinguere tracce di sinopia della stessa figura che vanno a delineare una sagoma rannicchiata verso il basso, colta come in un profondo inchino; per questo motivo potremmo cautamente proporre di individuarvi il Batte-simo della Santa (tav. I, b).
Ricapitolando, ipotizziamo di ricostruire il ciclo cateriniano secondo il seguente andamento, procedendo dalla parete set-tentrionale a quella orientale, per terminare poi in quella meri-dionale. Nel complesso i tabelloni pittorici inferiori dovevano collocarsi a circa cm 260/270 dal pavimento, per far spazio al doppio giro di stalli lignei corali che vi erano inseriti. Il secondo ed ultimo registro era posto invece a circa cm 520/530 dal pavi-mento, per giungere sino a cm 770/780 dal suolo 46. Il primo epi-
46 Si conservano inoltre alcuni frammenti di fascia decorativa fondamentali per conoscere precisamente il punto d’innesto delle scene, e quindi per la determi-nazione dei registri. Vi è una ampio frammento sulla parete meridionale, ed un secondo minore su quella settentrionale ad una altezza di circa cm 540 dal pa-vimento. Un ultimo indizio assai utile per la ricostruzione delle quote relative si
115La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
sodio, ovvero la Conversione della Santa ad opera dell’eremita, doveva dispiegarsi nel registro superiore della parete settentrio-nale (tav. I, a), seguito poi, in basso, dal Battesimo di Caterina (tav. I, b). Portandoci quindi sulla parete orientale, troveremmo quindi alla sinistra della monofora centrale, la Disputa di Santa Caterina (tav. II, d) 47, e sotto la Visita dell’imperatrice Faustina (tav. II, e) 48, mentre a destra dell’apertura il Matrimonio Misti-co in alto (tav. II, c) 49, ed in basso il Martirio dell’imperatrice Faustina (tav. II, f) 50. Il ciclo terminava quindi nella parete me-ridionale con il Martirio delle ruote in basso (tav. III, g) e la Decapitazione ed Assunzione in alto (tav. III, h) 51.
Come appare evidente, possiamo riscontrare varie irregolari-tà nell’ordine di lettura, poiché assistiamo sia ad un differimen-to dell’episodio del Matrimonio Mistico sia ad una prolessi del
rivela inoltre un netto e regolarissimo sgraffito di guida nell’intonaco che si trova nella parte sinistra della parete orientale a circa cm 510 dal pavimento. Tutti que-sti frammenti appaiono in tal modo pertinenti alla fascia decorativa che spartiva orizzontalmente i due registri pittorici.47 Le dimensioni sono cm 210,5 x 268.48 Cm 201 x 319,5.49 Cm 205 x 305.50 Cm 250 x 350 ca. 51 Cm 189 x 96,2 ca.
Figg. 15-16 Maestro delle storie di Santa Caterina del 1403, Battesimo (?),particolari (1403, Sansepolcro, San Francesco).
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini116
Martirio di Faustina, variazione evidentemente ponderata 52. Valutando meglio le conseguenze che questo mutamento d’or-dine produce, emerge che si vengono di fatto a creare due dittici en pendant esibiti nella parete absidale centrale: sopra due sce-ne cateriniane, sotto due con protagonista Faustina. Nel registro cateriniano sulla sinistra figura la Disputa della Santa dinanzi ai filosofi pagani, simbolo quindi dell’importanza e dell’efficacia dello strumento teologico cristiano nella confutazione del paga-nesimo e dell’eresia. Sulla destra invece il Matrimonio Mistico introduce al tema della fede e della dedizione totale a Cristo, ribadita con forza dalla particolare iconografia rievocante il cerimoniale d’origine pagana 53. Tale dittico viene come a ri-specchiarsi nel registro inferiore nelle storie di Faustina, episodi esemplari di conversione, secondo un collegamento col registro superiore di tipo causa-effetto. Così come Caterina confuta con sistematico raziocinio le tesi dei filosofi pagani, mettendone in discussione le false credenze e portandoli alla conversione, così l’imperatrice Faustina, assieme al pretorio Porfirio ed ai suoi soldati, abbandona l’idolatria pagana per abbracciare la verità cristiana propugnata da Caterina. Il martirio, ovvero l’esito ulti-mo della testimonianza di fede, si presenta quindi nella vicenda di Faustina come logica ed estrema conseguenza dell’adesione alla nuova dottrina cristiana, posto in puntuale parallelo con il Matrimonio Mistico di Caterina, evento in cui essa si vota inte-ramente all’amore in Cristo tramite l’anello nuziale.
Un’ultima interessante variatio nell’ordinamento scenico la si avverte anche nelle storie della parete meridionale, ove la
52 Riguardo all’ordine di lettura dei cicli pittorici ad affresco si veda M. a. lavin, The place of narrative: mural decoration in Italian churches, 431-1600, Chicago 1990.53 Si veda alla nota 33 iacobone, Il matrimonio mistico cit., e alla nota 44 aGlieTTi, L’iconografia della cappella cit.
117La decorazione della chiesa di San Francesco a Sansepolcro
Tav. I Ricostruzione del ciclo pittorico, parete settentrionale.La linea verticale tratteggiata indical’inserzionedell’absidesettecentesca(E. Squillantini-G. Guazzini 2012, elab. graficadi Giorgio Guazzini).
Tav. II Ricostruzione del ciclo pittorico, parete orientale(E. Squillantini-G. Guazzini 2012, elab. grafica di Giorgio Guazzini).
Elena Squillantini - Giacomo Guazzini118
lettura procede dal basso verso l’alto, con il Martirio delle ruo-te sotto, seguito nel registro superiore dalla Decapitazione ed Assunzione, quasi come a voler assecondare il vorticoso moto ascensionale dell’assunzione in cielo della Santa 54.
54 Il ciclo della santa martire va ad occupare la metà inferiore delle pareti del coro, lasciando sgombra un’ampia superficie nella metà superiore: nasce quindi una problematica controversa relativa alla decorazione che poteva sussistervi. Si dischiude infatti uno spazio sufficiente ad accogliere un terzo registro ed una lu-netta terminale. Considerando tuttavia il fatto che si conservano solo frammenti inerenti al ciclo cateriniano, e che non si riscontra traccia alcuna di affreschi nelle parti superiori, possiamo forse più plausibilmente credere che un secondo ciclo decorativo non fosse previsto ab origine, forse per problemi economici. Si deve tuttavia ricordare l’importante considerazione proposta da cooPer – banker, The church of San Francesco cit., p. 84, secondo cui il ciclo cateriniano sarebbe stato integrato a circa quarant’anni di distanza dalla grandiosa pala d’altare opistografa del Sassetta (1444) con Storie di San Francesco e Trionfo del Santo: in tal modo sarebbe giunto a compimento il complesso decorativo francescano comprendendo i necessari riferimenti al fondatore dell’ordine.
Quando ormai le bozze del presente contributo erano in correzione, abbiamo avuto modo di scoprire nei depositi della Soprintendenza di Firenze (Palazzo Pit-ti) un altro affresco quasi certamente proveniente da questo ciclo decorativo: esso rappresenta una Santa Barbara stante (cm 238 x 92), con caratteri stilistici e deco-razioni del fregio in tutto sovrapponibili a quelli presentati. Discuteremo quindi più organicamente tale affresco in un prossimo studio dedicato al ciclo francescano.
Tav. III Ricostruzione del ciclo pittorico, parete meridionale. La linea verticale tratteggiataindica l’inserzione dell’absidesettecentesca(E. Squillantini-G. Guazzini 2012, elab.