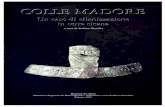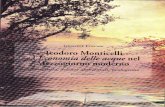Allegretti, Giovanni ; Mattiazzi, Giulio (2014), La Partecipazione Oltre il Quartiere. Padova: CSV.
La decorazione parietale della domus del quartiere di San Teodoro in Pola
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La decorazione parietale della domus del quartiere di San Teodoro in Pola
3
AntiCHitÀ AltOAdRiAtiCHe
lXXiii
lA pittuRA ROmAnAnell’itAliA SettentRiOnAlee nelle RegiOni limitROfe
a cura di flaviana Oriolo e monika Verzár
tRieSteeditReg 2012
CentROdi AntiCHitÀ
AltOAdRiAtiCHeCASA BeRtOli
AqVileiA
4
«Antichità Altoadriatiche»© Centro di Antichità AltoadriaticheVia patriarca poppone 6 - 33053 Aquileia (ud)www.aaadaquileia.it; e-mail:[email protected] responsabile: giuseppe CuscitoAutorizzazione del tribunale di udine n. 318 del 27 ottobre 1973
© editreg di fabio prencSede operativa: via g. matteotti 8 - 34138 triestetel./fax ++39 40 362879, e-mail: [email protected]
iSSn 1972-9758
le immagini di oggetti di proprietà dello Stato italiano provenienti dal friuli Venezia giulia sono state pubblicate su concessione del ministero per i Beni e le Attività Culturali - dipartimento per i Beni Culturali e paesaggistici - direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del friuli Venezia giulia - Soprintendenza per i Beni Archeologici del friuli Venezia giulia ed è vietata l’ulteriore riproduzione e duplicazione con ogni mezzo senza l’autorizzazione della Soprintendenza.
le riproduzioni delle immagini di oggetti provenienti da altri territori sono state autorizzate dai locali enti proprietari.ne è vietata ogni riproduzione con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazione dello stesso ente proprietario.
iniziativa promossa in collaborazione con:
Dipartimento di Storia e Culture dall’Antichità al Mondo Contemporaneo dell’università degli Studi di trieste
Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici delle università di trieste, udine e Venezia
e con il sostegno di:
in copertina: Brescia (Domus di dioniso), triclinio 4, sistema parietale in situ (da Le domus dell’Ortaglia 2003, p. 44).
55
PreMeSSA
È con piacere che diamo alle stampe questo 73° volume della nostra rivista che esce ad oltre due anni di distanza dal convegno nonostante le difficoltà finanziarie del momento.
Ci piace segnalare l’ampiezza degli orizzonti geografici toccati nelle 31 relazio-ni e negli 8 poster presentati al Convegno, che ci danno un quadro dettagliato della cultura pittorica dell’Italia Settentrionale e dei territori transalpini limitrofi: dalla Svizzera, all’Austria, alla Slovenia fino all’Istria medionale (Croazia), nonostante, per svariate ragioni, non siano state consegnate per la stampa i contributi sulla Val Camonica di Filli Rossi, su Calvatone-Bedriacum di Federica Giacobello ed Elena Mariani, su Parma e Piacenza con la relazione di Manuela Catarsi e il poster di Emiliana Mastrobattista, sulla Romangna di Maria Luisa Stoppioni, su Martigny di Michel E. Fuchs e su flavia Solva di Barbara Porod.
Particolare rammarico per l’assenza dei due contributi sull’area triestina a cura di Franca Maselli Scotti e della sua équipe di collaboratori e per la forzata man-canza dello studio della compianta Vesna Girardi Jurkić su Pola e Nesazio romana e sulle ville residenziali e ville rustiche dell’Istria meridionale con Kristina Dzin.
D’accordo con le curatrici del volume, Flaviana Oriolo e Monika Verzár, che si ringraziano per il lavoro svolto, si è deciso di non dare alle stampe gli esiti della tavola rotonda, le cui riflessioni sono state ampiamente accolte e rielaborate dagli autori nella fase di redazione.
Ci auguriamo che il volume trovi la giusta accoglienza presso la comunità scien-tifica ma anche presso il publico meno esperto visto l’interesse dei temi trattati e la chiarezza con cui sono stati esposti.
prof. giuseppe CuscitoPresidente del
Centro di Antichità Altoadriatiche
6
introduzione ai lavori .........................................................................................diario .................................................................................................................prefazione ..........................................................................................................
Studi
Monica Salvadori, I sistemi decorativi parietali in Cisalpina: per un aggior-namento dei dati .................................................................................................carla Pagani, ElEna Mariani, Considerazioni critiche sugli aspetti e sugli svi-luppi della pittura parietale in alcuni centri delle Regiones X e Xi alla luce dei più recenti ritrovamenti ......................................................................................Maria criStina PrEacco, La decorazione pittorica nel Piemonte romano: spunti e riflessioni tra vecchi e nuovi ritrovamenti ...........................................FrancESca BulgarElli, lucia gErvaSini, La pittura romana in Liguria alla luce delle testimonianze edite e inedite ..............................................................BarBara Bianchi, Intonaci dipinti d’epoca romana a Milano: nuovi dati da alcuni scavi recenti .............................................................................................BarBara Bianchi, EliSaBEtta roFFia, StEFania tonni, La decorazione pittorica dell’edificio di via Antiche Mura a Sirmione. Ricomposizione e analisi dei sof-fitti ..................................................................................................................criSina BaSSi, Testimonianze pittoriche in Trentino durante l’epoca romana .vEronica BarBacovi, Le pitture parietali tardoantiche del vano g di Piazza Verzeri a Trento: ricostruzione grafica bi- e tridimensionale degli alzati ........BarBara Maurina, La decorazione parietale della villa romana di Isera (TN)FaBrizio BiSconti, MattEo Braconi, L’ipogeo di S. Maria in Stelle: il pro-gramma iconografico e le vie significative ......................................................Maria grazia Maioli, L’apparato decorativo della domus augustea presso il S. Domenico a Imola ...........................................................................................Flaviana oriolo, Prime considerazioni sulla decorazione parietale di AltinoElEna PEttEnò, EManuEla Murgia, Monica Salvadori, Pittura romana da iulia Concordia: gli affreschi dalle terme nord-orientali ..................................Flaviana oriolo, Rivestimenti parietali ad Aquileia: catalogazione sistemati-ca e dati d’archivio per la restituzione dei contesti e la ricostruzione degli apparati decorativi .............................................................................................
p. 8» 12» 15
» 19
» 41
» 59
» 67
» 81
» 91» 107
» 115» 127
» 141
» 149» 157
» 171
» 191
INDICe
7
EManuEla Murgia, Pitture di I stile da Aquileia .............................................Marta novEllo, Monica Salvadori, Aquileia, Casa delle Bestie ferite: nuovi ritrovamenti ........................................................................................................Marina ruBinich, Intonaci dipinti dall’area delle ‘Grandi Terme’ di Aquileia: rapporto preliminare ..........................................................................................alka Starac, La decorazione parietale della domus del quartiere di San Teodoro in Pola ..................................................................................................vEronica ProvEnzalE, Testimonianze pittoriche dalle zone montuose della Svizzera .............................................................................................................inES dörFlEr, Römische Wandmalerei aus Virunum und teurnia ....................Kordula GostenčniK, Neue Wandmalereien vom Magdalensberg ..................irEna lazar, Una villa suburbana presso Celeia e la sua decorazione ad affresco e a stucco ..............................................................................................
PoStEr
BarBara Bianchi, Un ciclo figurato nella decorazione di III stile della villa delle “grotte di Catullo” a Sirmione? ...............................................................lynn arSlan PitchEr, ElEna Mariani, Nuovi intonaci dipinti dalla domus del Ninfeo di Cremona .......................................................................................MarghErita Bolla, Una tomba tardoromana dipinta di Cavaion Veronese ...giuliana cavaliEri ManaSSE, carla Pagani, ElEna Mariani, EManuEla Murgia, Progetto di studio sulla documentazione parietale di età romana a Verona e nel territorio veronese: prime osservazioni su alcuni nuclei pittorici katharina zaniEr, Decorazioni parietali nelle ville del Litorale sloveno: con-siderazioni preliminari .......................................................................................
tavolE .............................................................................................................
p. 207
» 223
» 233
» 241
» 251» 257» 269
» 281
» 289
» 293» 298
» 307
» 315
» 321
8
INTrODUZIONe AI LAVOrI
La pittura romana ci è scarsamente nota per la rarità dei monumenti superstiti e quasi soltanto nel genere, spesso decorativo e industriale, della pittura murale. I primi monumenti della pittura romana, come poi di quella dei cristiani, sono camere sepol-crali dipinte, dove i temi figurati riguardano sia la mitologia, come il filone dionisiaco, sia la vita quotidiana con scene di banchetto che possono raffigurare scene di vita familiare o forme di refrigeria consumati in onore dei defunti (E. MoorMann, la pittura romana fra costruzione architettonica e arte figurativa, in Romana pictura. la pittura romana dalle origini all’età bizantina, a cura A. Donati, Venezia 1998, p. 32).
Quando si parla di pittura romana si pensa subito alle città vesuviane, che, grazie a un custode insolito come il vulcano devastatore, hanno restituito un considerevole numero di apparati decorativi di case e di edifici pubblici eseguiti fra il I secolo a.C. e il 79 d.C. in tecniche diverse, dalla tempera all’encausto e all’affresco vero e proprio. Per il periodo successivo, alcuni siti hanno conservato complessi pittorici altrettanto notevoli, come Ostia, dove i caseggiati furono ricoperti dal fango del Tevere, o Roma stessa, rivelatasi una miniera più ricca di altri siti d’Italia, dove le pitture si limitano per lo più a singoli edifici cittadini o a ville suburbane (MoorMann, la pittura romana... cit., p. 16).
Com’è noto, il gran numero di monumenti recuperati a Pompei ha fatto sì che la critica moderna stabilisse una sequenza interna, articolata in quattro fasi che gli archeologi hanno denominato “stili”, i cui caratteri veterani, commercianti e viaggia-tori hanno contribuito a diffondere nelle altre aree del mondo romano, dove i resti sono meno rilevanti.
Nel presente incontro di studio, abbiamo inteso avviare un bilancio e una verifica per il territorio della Cisalpina e delle regioni limitrofe, dando seguito alle richieste giunteci per diversi canali dalla comunità scientifica, costretta a lamentare carenza di documentazione, oltre che di rassegne e di mappe della pittura parietale, dopo l’ottimo contributo del 1986 a firma di Antonio Frova sulle testimonianze pittoriche della X Regio, da lui riferite in prevalenza al I secolo d.C. e seguite da un vuoto fino all’età tar-doantica (A. Frova, pittura romana nella Venetia et Histria, «Antichità Altoadriatiche», 28, 1986, pp. 203-228 in particolare pp. 225-226).
Ad eccezione di pochi casi, egli lamentava allora la frammentarietà della docu-mentazione pittorica della Cisalpina, anche se non mancava di rilevare il nuovo qua-dro emergente dalla grande massa di frammenti d’intonaco dipinto che si andavano raccogliendo nella villa romana di Sirmione, nell’ambito di Verona che comprende gli importanti affreschi della casa romana di Valdonega con vivaci soggetti naturalistici, ma anche l’ipogeo di S. Maria in Stelle con affreschi di età cristiana (D. Dalla BarBa Brusin, una probabile “aedes catechizandorum” nell’ipogeo di S. maria in Stelle in Val pantena, «Aquileia Nostra», 48, 1977, cc. 257-272). Tuttavia, nonostante i recenti progressi qui registrati nel recupero degli intonaci dipinti, ancora nel catalogo della mostra Romana pictura organizzata a Rimini nel 1998, le testimonianze pittoriche utilizzate per il territorio in esame si riducono a poche unità su oltre un centinaio di esemplari paradigmatici lì raffigurati (Romana pictura... cit.). Per la Cisalpina, la
9
documentazione epigrafica ci offre nomi di pittori a Pavia (Cil V 6466), a Bologna («AE» 1945, 52), a Marano di Valpolicella (Cil V 3908), mentre Verona ci trasmette la testimonianza di un committente (Cil V 3408).
Lo stretto legame fra architettura e pittura è attestato dal De architectura di Vitruvio, che ha dedicato il VII libro del suo manuale alla pittura parietale, fornendoci utili indicazioni per la tecnica e per i gusti dell’epoca. La pittura parietale romana è, insieme col mosaico pavimentale, uno dei pochi elementi dell’arredo di edifici e di case di cui sia possibile seguire l’evoluzione dal tardo secolo II a.C. fino alla tarda antichità. Tuttavia occorre dire che, nella maggior parte dei casi, tali decorazioni ci giungono estrapolate e decontestualizzate per la rovina subita dai monumenti, così che della pit-tura antica si recuperano solo le briciole (MoorMann, la pittura romana... cit., p. 14).
Le decorazioni parietali non si limitavano quasi mai a pareti imbiancate o dipinte in un solo colore, secondo il gusto dei nostri tempi, ma, al contrario, la casa romana doveva presentarsi ricca di valori cromatici e allo stesso tempo tetra per la scarsa luce che riusciva a penetrarvi. Vi appaiono spesso elementi architettonici proprio perché una costante della decorazione pittorica è la finzione, nell’intento di imitare oggetti e materiali pregiati o di suggerire uno spazio virtuale.
Se una regola canonica era la suddivisione della parete in tre fasce orizzontali, zoccolo, zona mediana e zona superiore, il materiale pervenutoci consente di ricono-scere, fra i possibili schemi decorativi utilizzati dai pittori antichi, campiture delimitate da cornici; imitazioni di incrostazione marmorea e insieme eleganti elementi architet-tonici con sobri accenni prospettici, come, ad esempio, nei pannelli del noto santuario repubblicano di Brescia (prima metà del I secolo a.C.), che sono la più antica testimo-nianza della pittura romana conservata in Cisalpina (Frova, pittura romana... cit., p. 208); e schemi “liberi” con motivi figurati, come vedute marine o pitture di giardino provenienti dalla ricchissima materia cosmica e poi riprese nei contesti catacombali o basilicali come interpretazione del paradiso: significativa testimonianza di questa maniera in Cisalpina offrono le domus messe in luce a Brescia (Collegio Arici e domus di S. Giulia), i frammenti delle “grotte di Catullo” a Sirmione e della villa romana di Desenzano, anche se il Frova riteneva difficile e forse improprio collocare questa serie di affreschi nei sistemi parietali pompeiani (Frova, pittura romana... cit., p. 223). Forse a questa maniera possiamo associare anche il più tardo giardino con eroti e fontanella zampillante affrescato sullo zoccolo dell’aula teodoriana meridionale di Aquileia, di cui auspichiamo il restauro.
È soprattutto al tempo di Augusto e di Tiberio che emerge una sorta di classicismo dominante, quando il cosiddetto terzo stile, “che copre tipi piuttosto svariati” (Frova, pittura romana... cit., pp. 213-214.), si caratterizza per la stilizzazione delle forme, prive di corporeità, dove risaltano figurine disegnate con fare rapido e conciso secondo quel-la maniera che Plinio chiamava in senso spregiativo “compendiaria”: è una tendenza pittorica che si diffonde rapidamente, per cui non va dimenticata l’altissima qualità delle pitture del Magdalensberg (Austria), che resta un caso isolato in quei paesi d’Ol-tralpe (MoorMann, la pittura romana... cit., p. 24).
Fra II e III secolo, fra la tarda età antonina e il maturo periodo severiano, gli ele-menti architettonici sono ridotti a schemi lineari in rosso e in verde, semplice motivo di riempimento di pareti e di soffitti secondo il cosiddetto stile catacombale a “ragnatela”.
10
In questo periodo, agli esordi della pittura cristiana, le fantastiche scenografie teatrali, tanto care al decoro delle case di età neroniana e flavia, si riducono ad aerei e sottili padiglioni, che richiamano, solo come lontana memoria, il cosiddetto quarto stile pom-peiano (MoorMann, la pittura romana... cit., p. 27; F. Bisconti, la pittura paleocristiana, in Romana pictura... cit., p. 36).
In definitiva possiamo dire che la pittura parietale illustra il mutamento dei gusti e delle esigenze della gente comune ed è un elemento fondamentale per conoscere la vita privata dei Romani: per questo, dopo aver affrontato temi come quelli dell’edilizia e della vita sociale ed economica della Cisalpina, quest’anno abbiamo voluto proporre all’attenzione degli studiosi qui convenuti un confronto e una verifica sulla decorazione pittorica ormai arricchita di testimonianze anche per i territori in esame, con l’inten-zione di avviarne un censimento e una valutazione critica.
Dopo l’annuncio del tema, che ci vedrà impegnati per due giorni e mezzo con serrati ritmi di lavoro programmati dalla collega Monica Verzár, che ringrazio di cuore, desidero comunicare alcune informazioni sulle attività del Centro nel decorso anno 2009.
È stato accolto nella rivista delle «Antichità Altoadriatiche» il volume Anno Domini 1208. Ottocento anni della parrocchia di Cortina d’Ampezzo, curato da Giorgio Fedalto, con gli Atti di un Convegno per gli 800 anni della Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli di Cortina, voluto e sostenuto dal parroco don Davide Fiocco e dalla comunità locale.
È stato pubblicato come V numero delle Monografie affiancate alla nostra rivista il volume di chi vi parla Signaculum fidei. l’ambiente cristiano delle origini nell’Alto Adriatico: aspetti e problemi, presentato ad Aquileia in due momenti successivi rispet-tivamente dal prof. Fabrizio Bisconti e dal prof. Danilo Mazzoleni dell’Università di Roma 3.
Il Centro, promotore delle inscriptiones Christianae italiae, assieme al Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell’Università di Bari e al Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma, ha contribuito ad arricchire la collana con il volume XII relativo alle iscrizioni dei sei cimiteri minori di mediolanum, curato da me, che sto attendendo al secondo volume con l’edizione critica dei titoli provenienti dal cimitero ad martyres presso S. Ambrogio e da quello presso S. Nazaro Maggiore. L’opera è stata presenta-ta l’11 dicembre scorso alla Biblioteca Ambrosiana di Milano dai professori Danilo Mazzoleni e Marco Sannazaro.
Grazie al contributo della Fondazione CRUP, della Fondazione CaRiGorizia dell’Assessorato alla cultura della Regione, è stata avviata la catalogazione delle circa 500 epigrafi paleocristiane inedite conservate nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, affidando al Cristiano Tiussi la verifica e la catalogazione di 170 pezzi e ad Annalisa Giovannini la consultazione degli inventari austriaci per verificare l’entrata delle lapidi nelle collezioni museali durante l’amministrazione asburgica, oltre al sito del loro rinvenimento.
Ho infine il piacere di presentare il volume 68 della nostra rivista di 400 pagi-ne con gli Atti della Settimana del 2008 su Aspetti e problemi della romanizzazione. Venetia, Histria e arco alpino orientale, progettata scientificamente dai colleghi Gino Bandelli e Claudio Zaccaria, cui va la nostra gratitudine.
11
Tutto questo si è potuto fare grazie ai contributi erogati a vario titolo dal Ministero per i Beni Culturali, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Udine, dalla Fondazione CRUP, della Fondazione CRTrieste e dalla Fondazione CaRiGorizia, cui quest’anno si è aggiunta la Fondazione Aquileia: a tutti un sentito ringraziamento per il sostegno finora garantito. Per il futuro si profilano tempi bui che per ora non lasciano bene sperare, come abbiamo purtroppo appreso anche dalle colonne del Piccolo del 22 aprile scorso, ma resto fiducioso che quanti governano le sorti della politica e dell’eco-nomia per il bene comune non vorranno decapitare o lasciar morire un’iniziativa che da quarant’anni è strumento di dialogo e d’incontro fra studiosi italiani e stranieri nella capitale morale della regione.
Aquileia, 6 maggio 2010
Giuseppe Cuscitopresidente del
Centro di Antichità Altoadriatiche
12
DIArIO
GIOVeDÌ 6 MAGGIOAquilea - Sala del Consiglio Comunale
9.00 Apertura lavori
9.30 monica Salvadori (università di padova), I sistemi decorativi parietali in Cisalpina: per un inquadramento generale
10.00 elena Mariani, Carla Pagani (Soprintendenza Beni Archeologici della lombardia), Considerazioni critiche sugli aspetti e gli sviluppi della pittura parietale in alcuni centri delle Regiones X e Xi, alla luce dei più recenti ritrovamenti
10.30 maria Cristina PrEacco (Soprintendenza Beni Archeologici del piemonte e museo Antichità egizie), La decorazione pittorica nel Piemonte romano: spunti e riflessioni tra vecchi e nuovi ritrovamenti
11.30 francesca BulgarElli, lucia gErvaSini (Soprintendenza Beni Archeologici della liguria), La pittura romana in Liguria alla luce delle testimonianze edite e inedite
12.00 Barbara Bianchi (università Cattolica di milano), Intonaci dipinti d’epoca romana a Milano: nuovi dati da alcuni scavi recenti
12.20 filli roSSi (Soprintendenza Beni Archeologici della lombardia), Nuove testi-monianze di decorazione pittorica nella Valle Camonica romana
12.40 elisabetta roFFia, Barbara Bianchi, Stefania tonni (Soprintendenza Beni Archeologici della lombardia), Ricomposizione dei soffitti della villa di Via Antiche Mura a Sirmione
16.30 federica giacoBEllo, elena Mariani (università di milano), Intonaci da Calvatone-Bedriacum.
16.50 Cristina BaSSi (Soprintendenza Beni Archeologici della provincia di trento), Testimonianze pittoriche nel Trentino di età romana: tridentum e Riva del Garda
17.10 Veronica BarBacovi (Soprintendenza Beni Archeologici della provincia di trento), Le pitture parietali tardoantiche del vano “G” di Via Rosmini - Piazza Verzeri a Trento. Ricostruzione tridimensionale delle pareti
17.50 Barbara Maurina (museo Civico di Rovereto), La decorazione parietale della villa romana di Isera (TN) nel contesto Atesino
18.10 fabrizio BiSconti (università di Roma tre), L’ipogeo di S. Maria in Stelle: il programma iconografico e le vie significative
13
VeNerDÌ 7 MAGGIOAquilea - Sala del Consiglio Comunale
9.00 manuela catarSi (Soprintendenza Beni Archeologici dell’emilia Romagna - in collaborazione con pietro Baraldi dell’università di modena e danilo Bersani dell’università di parma), Intonaci dipinti da Parma: tecniche e materiali
9.30 maria luisa StoPPioni (museo della Regina, Cattolica), Intonaci in Romagna: spunti di riflessione per un’indagine comparativa
10.00 maria grazia Maioli (Soprintendenza Beni Archeologici dell’emilia Romagna), L’apparato decorativo della domus augustea presso il S. Domenico a Imola
10.30 margherita tirElli, flaviana oriolo (Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto), Prime considerazioni sulle decorazioni parietali di Altino
11.15 elena PEttEnò, monica Salvadori, emanuela Murgia (Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto),Affreschi dalle Terme nord-orientali di Iulia Concordia: per una rilettura dei dati.
11.40 flaviana oriolo (università Cattolica di milano), Aquileia: catalogazione sistematica e dati d’archivio per la restituzione dei contesti e la ricostruzione degli apparati decorativi
12.10 emanuela Murgia (università di trieste), Testimonianze di I stile dallo scavo di via Gemina ad Aquileia
12.30 monica Salvadori, michele BuEno, marta novEllo (università di padova), Aquileia, Casa delle Bestie ferite: nuovi ritrovamenti
12.50 marina ruBinich (università di udine), Un contributo allo studio della pittura di Aquileia tardoantica: affreschi dall’area delle Grandi Terme
15.00 franca MaSElli Scotti, flaviana oriolo (Società istriana di Archeologia e Storia patria), Vivere a margine di un centro urbano. Gli apparati decorativi di una villa tergestina
15.20 Vesna Girardi JurKić (Medunarodni istrazivaski Centrar za Arheologija, medulin), Gli affreschi come elemento decorativo di Pola e Nesazio romana
15.50 Kristina dzin (museo Archeologico dell’istria, pola), La pittura romana come rappresentante di status dei proprietari delle ville residenziali e ville rustiche dell’Istria meridionale
16.20 Alka Starac (museo Archeologico dell’istria, pola), La decorazione parietale della domus del quartiere di San Teodoro in Pola
17.15 Sezione poster Barbara Bianchi (università Cattolica di milano), Un ciclo figurato nella decora-
zione di III stile della villa delle “Grotte di Catullo” a Sirmione? emiliana MaStroBattiSta (università di parma), Frammenti di intonaci dipinti da
Parma e Piacenza lynn PaSSi PitchEr, elena Mariani (Soprintendenza Beni Archeologici della
lombardia), Nuovi intonaci dipinti dalla domus del Ninfeo a Cremona margherita Bolla (museo Civico Archeologico di Verona), Tomba tardoantica
dipinta di Cavaion Veronese
14
giuliana cavaliEri ManaSSE, Carla Pagani, elena Mariani, emanuela Murgia (Soprintendenza Beni Archeologici della lombardia), Progetto di studio sulla decorazione parietale di età romana a Verona e nel territorio veronese: prime osservazioni su alcuni nuclei pittorici
monica Salvadori, marianna BrESSan, giulia trEviSan (università di padova), Montegrotto Terme. Gli intonaci degli scavi di via Neroniana
franca MaSElli Scotti, paola vEntura, Valentina dEgraSSi, flaviana oriolo (Soprintendenza Beni Archeologici del friuli Venezia giulia), Testimonianze pittoriche dalle ville presso le foci del Timavo
Katharina zaniEr (università del litorale di Capodistria-pirano), Decorazioni parietali nelle ville del Litorale sloveno: considerazioni preliminari
SABATO 8 MAGGIOAquilea - Sala del Consiglio Comunale
9.00 michel e. FuchS (università di losanna), Enduits à Martigny / forum Claudii Vallensium: une peinture de passage
9.25 Veronica ProvEnzalE (università di losanna), Testimonianze pittoriche dalle zone montuose della Svizzera
9.50 ines dörFlEr (landesmuseum, Klagenfurt), Römische Wandmalerei aus den Municipien teurnia und Virunum
10.15 Kordula goStEncnik (Archäologischer park magdalensberg), Neue Wandmalereifunde vom Magdalensber
11.10 Barbara Porod (landesmuseum Joanneum, graz), Römische Wandmalerei aus flavia Solva
11.35 irena lazar (università del litorale, Capodistria-pirano), Una villa suburba-na vicino Celeia e la sua decorazione ad affresco
12.00 tavola Rotonda: ida BaldaSSarrE (università Orientale di napoli) michel e. FuchS (università di losanna) francesca ghEdini (università di padova) daniela Scagliarini corlàita (università di Bologna) monica Salvadori (università di padova) gemma SEna chiESa (università di milano)
15
PrefAZIONe
da tempo inseguivo l’idea di proporre ai colleghi dell’università di trieste il tema della pittura parietale romana in italia settentrionale e dei suoi rapporti con le province limitrofe per uno degli incontri delle Settimane di Studi Aquileiesi. mi avevano soprattutto stimolata i lavori, allora in corso, di flaviana Oriolo condotti sulla documentazione dell’italia nordorientale, con particolare riferimento al ricco e cospicuo materiale proveniente da Aquileia: in maniera evidente essi denunciavano che si trattava di un settore in forte sofferenza soprattutto in relazione allo studio delle vecchie acquisizioni museali, che dovevano essere messe a confronto con i ritrovamenti recenti avvenuti nell’ambito di indagini stratigrafiche. Sembrava dun-que importante offrire alla comunità scientifica un quadro aggiornato delle ricerche a più di venticinque anni di distanza dal fondamentale contributo di Antonio frova pubblicato proprio nel 1986 nella rivista «Antichità Altoadriatiche».
la Xli Settimana di Studi Aquileiesi del 2010 è stata dunque dedicata alla decorazione parietale in italia settentrionale e nei vicini territori provinciali e il grande interesse suscitato tra gli addetti del settore ha dimostrato quanto la tratta-zione dell’argomento sia stata condivisa dagli studiosi della pittura antica. l’ampia adesione all’incontro è ben evidente nelle pagine di questo volume che propone un vasto panorama delle novità connesse ai rivestimenti cisalpini e rimanda alle novità di alcuni importanti siti provinciali: il materiale presentato è frutto sia di vecchi ritrovamenti, che implicano, come noto, lunghi e faticosi lavori di “ricucitura” dei contesti all’interno dei depositi museali e degli archivi, sia di recentissime indagini e lo scavo di piazza marconi a Cremona rappresenta forse il caso più significativo in questo senso. Colpisce la ricchezza della documentazione, trattata e considera-ta secondo quell’approccio metodologico rigoroso anche verso gli aspetti di tipo tecnico, approccio che gli studi cisalpini hanno ben sviluppato sulla scorta delle esperienze transalpine, con le quali, va sottolineato, viene condivisa molto spesso la tipologia dei rinvenimenti.
l’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e riflessione sulle problematiche collegate agli allestimenti parietali al di fuori dell’area cen-troitalica. È stato pianificato secondo una impostazione di carattere territoriale per quanto riguarda l’italia settentrionale, dove si è proceduto da Ovest verso est, men-tre si è privilegiata la presentazione dei contesti provinciali a partire dalla Raetia verso Oriente nell’ottica di fornire un significativo quadro di confronto soprattutto per i territori dell’italia settentrionale centro-orientale. purtroppo sussistono alcune assenze rispetto al calendario dei lavori svolti nel 2010 ma nonostante questa man-canza gli atti apportano un significativo e stimolante nuovo quadro d’insieme. un altro rammarico riguarda i tempi di pubblicazione del volume: il protrarsi della rac-colta degli studi e la scelta di far confluire i materiali presentati entro tavole a colori hanno prolungato di molto l’uscita di questo prezioso aggiornamento. Soltanto di recente il problema si è risolto con un contributo speciale, per il quale vorrei porgere
16
il mio più sentito ringraziamento al responsabile della filiale della Banca di Credito Cooperativo di fiumicello ed Aiello ad Aquileia.
Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno consentito di portare a termine questo volume. il mio primo pensiero va agli studiosi che sono intervenuti all’in-contro. un particolare ringraziamento va alle colleghe che hanno animato il dibattito svolto a chiusura dei lavori, che purtroppo per cause varie non ha potuto essere incluso nella pubblicazione degli atti: gemma Sena Chiesa, francesca ghedini e monica Salvadori, che da anni si occupano di problematiche dell’italia settentrio-nale oltre che di Aquileia stessa, assieme a ida Baldassarre e daniela Scagliarini Corlaita, alle quali si devono contributi di ricerche e studi fondamentali nel campo della pittura romana, hanno arricchito le giornate di studio con stimolanti suggeri-menti e nuovi spunti per la ricerca.
monika VerzárUniversità degli Studi di Trieste
241
Alka Starac
lA deCORAziOne pARietAle dellA DOMUS del quARtieRe di SAn teOdORO in pOlA
introduzionE
le ricerche nell’ambito del progetto di archeologia preventiva in via Kandler, nell’antico nucleo di pola, si svolgono dalla primavera del 2005 1. gli scavi, realizzati ad una profondità di circa 6 metri, hanno rivelato sette principali fasi di edificazione compre-se nell’arco di 3000 anni. le strutture scavate includono la chiesa di San teodoro del XV secolo con il congiunto monastero di suore benedittine, la chiesa paleocristiana di Santa lucia, le terme pubbliche di epoca romana, un vasto santuario probabilmente dedicato a ercole e una domus. gli affreschi relativi alla domus rappresentanno il soggetto principale del presente lavoro.
dalla domus, situata nell’area più occidentale dell’area indagata, provengono numerosi frammenti di intonaco dipinto. Solo una minima parte della decorazione si è conservata in situ. il numero degli ambienti finora esplorati e il fatto che lo strato del crollo sia rimasto intatto fino ai giorni nostri portano a considerare questi affreschi quale il complesso pittorico più significativo dell’istria.
la parte scavata della casa occupa una superficie di oltre 750 metri quadrati 2 ma si può presumere che l’edificio abbia compreso almeno altri 700 metri quadrati. le strutture si impostarono al di sopra di un ampio complesso precedente posto nell’angolo nord-orientale della città, comprendente un edificio sacro tardorepubblicano provvisto di una fonte naturale, un edificio termale e un sistema di canalizzazione (fig. 1).
carattEriStichE gEnErali dElla DoMus (fig. 2)
i muri della domus, costruiti da pietra calcare tagliata in quadri regolari e malta dello spessore medio pari a 56 cm, sono stati rinvenuti in buono stato di conservazione per una altezza fino a 3,50 metri al di sopra dei pavimenti. i muri divisori e quelli del piano superiore vennero invece stati realizzati in opus craticium, composti da pezzi di tegole, anfore e malta in abbondanza: in tale maniera essi offrivano una struttura più leggera con uno spessore di 18-22 cm, compresa la decorazione su ambo i lati (muri divisori). le murature meglio conservate si trovano nel settore termale, dove la roccia naturale sale in modo verticale e sopporta il muro esterno meridionale della domus. per la neccessità di sistemazione della casa, la roccia viva venne tagliata e addatta in forma di piano con banco sotterraneo nel laconicum. Sulla parte settentrionale, la roccia viva arriva alla pro-fondità di oltre venti metri sotto il piano. il terreno fangoso prossimo al mare fu invece
1 Starac 2006a, pp. 135-140; Starac 2006b, pp. 235-238; Starac 2007a, pp. 263-265; Starac 2008a, pp. 121-129; Starac 2008b, pp. 301-313; Starac 2009a, pp. 379-389; Starac 2009b, pp. 271-290; Starac 2009c, pp. 123-168.
2 Relazione preliminare sulla domus: Starac 2009b, pp. 271-290.
242
stabilizzato con tecniche edilizie particolari, presubilmente con micropilotaggio. Sopra il livello del piano, il muro esterno settentrionale è rimasto conservato per una altezza di oltre un metro: misura esattamente due metri di spessore. per le difficoltà causate dalla presenza di una fonte abbondante di acqua dolce nella zona e per l’esistenza di un canale grande e profondo lungo la facciata settentrionale della casa, le indagini archeologiche non sono state condotte fino al termine delle fondamenta e l’ipotesi del micropilotaggio rimane da provare nei futuri interventi.
il settore indagato della domus si compone di due zone separate tenendo presente la fonte di luce e d’aria. Al centro della prima zona si trova un peristilio di rappresentanza, circondato dai vani semiaperti con colonne tuscaniche, del diametro di 33 cm, unite da cancelli lignei, intorno al quale si collocano ambienti destinati a uso domestico e pubblico. l’altra parte, marginale per dimensioni, si situa intorno a un piccolo atrio con impluvio posto nell’angolo nord-orientale di casa. l’ingresso dell’edificio si colloca lungo il fronte settentrionale: esso è costruito in tecnica monumentale con soglia a tre porte, due ortostati monolitici di sezione rettangolare in pietra calcarea, e con soprastanti capiteli di pilastri e arco. la facciata settentrionale era provvista di una costruzione aggiuntiva, verosimil-mente un portico, del quale rimangono solamente i muri di fondamenta modesti con uno o due filari di pietra.
il corridoio dell’ingresso (p7-O4) conduceva direttamente al peristilio, da dove si raggiungevano tutti gli altri ambienti; i muri del corridoio sono andati quasi completa-mente distrutti. il pavimento del portico del peristilio presentava un tessellato nero con doppia linea di bordo bianca e piccoli quadri bianchi disposti regolarmente nelle righe nel campo centrale. questo pavimento appartiene alla fase di rinnovamento della casa, mentre il pavimento originario, probabilmente in cocciopesto, venne distrutto. Verso occidente, immediatamente accanto all’ingresso, il corridoio si allarga in un ambiente (p11-O4) fornito di grande nicchia, composta da due parti, aperta fino a fondo del muro e realizzata in maniera tale da essere chiusa con un tramezzo in legno. Verso oriente, il corridoio principale (p7-O4) si apre in un corridoio stretto (p8-O4) intorno l’impluvio (p14-O4), pavimentato con lastre di calcare, accanto al quale si trovavano un piccolo ambiente pieno di bruciato e vasellami, probabilmente una cucina (p13-O4), e due ambienti di pianta quasi quadrata. il primo ambiente di pianta quadrata (p12-O4) ha una nicchia trapezoidale con fondo in mosaico bianco-nero e pareti dipinte in bianco. il mosaico rappresenta una conchiglia, un altare e iscrizione votiva in tabula ansata: Salus / [p?.......sac]r(um?) 3; la nicchia era incorniciata da una fascia rossa. l’altro ambiente (p9-O4), anch’esso fornito di nicchia purtroppo distrutta, ha un ingresso libero senza chiusura, con pavimento in opus spicatum e pareti dipinte in bianco, prive di decorazio-ne; il bordo orizzontale dell’intonaco, 80 cm sopra il pavimento, suggerisce l’esistenza di un banco di sedile. il canale, che non per caso passa sotto l’ambiente, suggerisce l’identificazione con una latrina.
due vani spaziosi circondavano l’impluvio in coincidenza della parte orientale (p15-O4) e meridionale (p16-O4). essi sono connessi con il corridoio p8-O4 intorno all’im-pluvio: nel momento di ristrutturazione della domus, il passaggio verso il vano p16-O4 venne chiuso, mentre la porta del vano p15-O4 fu semichiusa e transformata in passaggio. Ambedue i vani erano forniti da piccole nicchie. nella parte settentrionale del vano p15-O4 si trovava una vasca rettangolare con pavimento in opus spicatum e malta idraulica:
3 Starac 2008b, p. 303, fig. 3.
ALkA STARAC
243
l’apertura in fondo conduceva a un canale sottostante. dall’altra parte, nel punto del con-tatto con vano p16-O4, si trovava un focolare. il ritrovamento di numerosi frammenti di anfore e vasellame da tavolo fa pensare ad un magazzino per generi alimentari.
gli spazi più rappresentativi occupavano la parte posta a settentrione del peristilio. un grande oecus a una colonna tuscanica (p6-O4), connesso a un piccolo cubicolo late-rale (p5-O4), si apriva con un lato intero sul peristilio. il suo pavimento musivo combi-na motivi bicromi (stelle, quadri, essagoni) e policromi (treccie) composti in forma di tappeto, secondo una maniera databile non prima della fine del i sec d.C. 4. Sulla base dei dati preliminari stratigrafici, il mosaico appartiene alla seconda fase dell’edificio quando nei primi decenni del ii secolo i pavimenti più antichi degli ambienti di rap-presentanza e dei portici del peristilio vennero abbattuti e sostituiti con nuovi piani. il cubicolo p5-O4 mostra un tessellato bianco-nero con schema geometrico composto da quadri e rettangoli.
Ad oriente del peristilio si disponevano quattro stanze (p17-O4, p10A-O4, p10B-O4, p10-O4), legate da un passaggio comune aperto sul peristilio. A parte il piccolo magazzino p10A-O4 con pavimento in semplice cocciopesto, gli altri ambienti avevano piani in tessellato bianco-nero. nel momento di abbandono della casa causato da un incendio, il magazzino conteneva anfore con vini d’importazione. l’ala p10B-O4, dotata di mosaico bianco-nero con cantaro ed edere dell’uva in soglia verso il peristilio, presentava un mosaico con campo centrale bianco e bordo nero, 20 cm di spessore, effetuato durante gli ultimi rinovamenti di casa. dall’ala si proseguiva in due ambienti, uno a sinistra (p17-O4) e altro (p10-O4) a destra, identificabile con un triclinio inver-nale per abbondanza di ossa animali e un piccolo focolare aggiunto in fase posteriore, contemporamente al pavimento musivo nell’ala p10B-O4. Ambedue gli ambienti hanno mosaici bianchi con doppia linea nera di bordo, stesi al di sopra i più vecchi pavimenti a cocciopesto. il cementizio del triclinio p10-O4 era ornato da una linea di bordo in tesse-re nere. Accanto al triclinio è situata una cucina con focolare e numerosi ritrovamenti di vasellame da tavola (p18-O4), dal quale si entra in grande fornace di bagno (p21-O4).
la parte meridionale della casa è occupata da un vasto settore termale, di cui si sono riconosciuti una fornace a due aperture (p21-O4), il laconico (p19-O4) e il cali-dario con 84 (7x12) pilastrini (p1-O4). il laconico fu creato nella fase di rinnovamento del bagno: una parte del calidario fu “tagliata” con un muro che ha coperto gli affreschi della prima fase. già prima del rinnovamento, il calidario unico (p1-O4 + p19-O4) era ornato da un mosaico bianco e marmi preziosi di vari colori. Sulla parte superiore dei muri erano situati due ordini di cornici in marmo proconnesio.
l’esistenza del piano superiore si evince da molteplici testimonianze. Al piano superiore conducevano delle scale le cui tracce si osservano ancora nell’intonaco parie-tale in linea di bordo inclinata 40 gradi, situata in corridoio principale p7-O4. grazie al fatto che la casa si trovava incavata nella roccia del pendio della collina, nella sua parte meridionale il piano superiore appariva come pianoterra. numerosi segmenti murari di limitato spessore, realizzati con la modesta tecnica dell’opus craticium, insieme con resti di mosaici crollati testimoniano la richezza di decorazione del piano superiore. il piano superiore era verosimilmente occupato da camere da letto, in altre parole si trattava della parte privata della domus. dai resti si puo concludere che nel piano superiore esistevano almeno quattro ambienti, in rapporto tre stanze e un corridoio (ala). i muri del piano
4 rinaldi 2007, p. 99.
LA DECORAzIONE PARIETALE DELLA dOmuS DEL QUARTIERE DI SAN TEODORO IN POLA
244
superiore sono caduti esclusivamente negli ambienti situati nella parte orientale di casa (p15-O4, p16-O4, p17-O4, p10A-O4, p10B-O4, p10-O4, p18-O4) o fuori della casa, sempre verso oriente. Ciò fa presupporre che il piano superiore si estendesse unicamente in coincidenza del lato orientale rispetto al peristilio, mentre l’oecus di rappresentanza (p6-O4) con il cubicolo (p5-O4) sulla parte settentrionale e il bagno nella parte meridio-nale terminavano sotto il tetto e non erano sovrapposti da un livello superiore.
MEtodologia dEllo Studio
gli intonaci sono stati raccolti, puliti e sistemati in cassette, identificate da dati precisi relativi all’ambiente del ritrovamento e all’unità stratigrafica. Ogni frammento è stato fotografato con riferimento metrico e l’indicazione stratigrafica; i pezzi sono stati quindi digitalizzati e raggruppati secondo i dati stratigrafici e secondo la struttura del supporto. una prima analisi ha rapidamente confermato che, oltre gli ambienti ancora visibili in situ, la domus aveva un piano superiore con i muri divisori costruiti in opus craticium (uS 16-p7-O7, fig. 3). il supporto degli affreschi, considerato in rapporto con i dati stratigrafici, indica la presenza di nove diversi gruppi di insiemi pittorici principali. Va specificato che il carattere frammentario dei ritrovamenti non permette una restitu-zione sicura e completa dei programmi decorativi; i dati preliminari esposti in questa sede sembrano attestare l’esistenza di almeno due fasi decorative.
i soffitti rappresentano un problema particolare soprattutto per quanto riguarda la cronologia; essi rimangono perciò oggetto di studi futuri. Allo stato attuale del lavoro, sempre iniziale, è particolarmente difficile distinguere i soffitti del pianoterra da quelli del piano superiore. A questo punto non possiamo proporre alcuna ipotesi interpretativa dei soffitti o attribuire un sicuro schema al soffitto di un determinato ambiente, a parte quello del cubicolo p5-O4, dove sono ritrovati frammenti della seconda fase decorativa pertinenti all’attacco tra parete e soffitto.
SoFFitti
i soffitti dipinti sono riconoscibili dalle impronte dell’incannucciata sul retro. il cubicolo p5-O4 (uS 16-p5-O4) presentava un soffitto dipinto con motivi vegetali verdi in campi a fondo bianco divisi da linee rosse sottili (fig. 4). nelle macerie evidenziate a nord-est del peristilio (uS 16-p17-O4) sono stati ricuperati frammenti di soffitti a fondo bianco e frammenti dipinti con motivi vegetali, erbe e foglie a fondo di colore rosa (fig. 5). lo strato probabilmente appartenente al piano superiore (uS 16-p20-O4), individua-to a sud-est del peristilio, comprende intonaci con impronte dell’incannucciata sul retro, dipinti a rete di fiori con petali rossi e blu e spazi intermedi con erbe e foglie di color verde, tutto a fondo bianco (fig. 6). uguale motivo decorativo di soffitto, conosciuto in ambienti romani della Cisalpina 5, si riscontra anche sulle pareti del cubicolo p5-O4 (uS 16-p5-O4, fig. 20). lo stile pittorico con motivi vegetali schematizzati dipinti in colori transparenti, osservato negli ambienti p17-O4 e p20-O4 a sud-est del peristilio, corrisponde alla seconda fase del piano superiore. le pareti di un ambiente del piano
5 oriolo et alii 2007, p. 205.
ALkA STARAC
245
superiore non più conservato erano decorate nella seconda fase da rete di cassettoni con fiori stilizzati a petali verdi (figg. 44-47).
un altro gruppo di frammenti relativi a un soffitto, trovato a sud-est del peristilio nello strato posto immediatamente al di sopra pavimento (uS 22-p20-O4), è caratteriz-zato da fasce rosse con margini di color marrone e fiori delicati a petali rossi e blu su a fondo bianco (fig. 7); verosimilmente è attribuibile al supposto triclinio del pianoterra (p10-O4).
i frammenti di soffitto rinvenuti nell’angolo nord-orientale della domus (uS 16-p15-O4) mostrano infine su fondo rosso scuro delicati disegni di frutta di color giallo (fichi?) (fig. 8).
aFFrESchi dElla PriMa FaSE in PianotErra
la quantità più ingente di intonaci dipinti proviene da strati di macerie. gli affre-schi assegnabili alla prima fase decorativa, solo in minima parte conservati in situ, corrispondono alla prima fase edilizia della casa. Si distinguono in gran parte per la presenza di picchiettature sulla superficie dipinta, eseguite intenzionalmente nel proces-so di rinnovamento dell’edificio (uS 16-p7-O4, fig. 9). gli ambienti p17-O4 e p10-O4 conservano solamente una fase decorativa degli affreschi con divisione da presumere tripartita: sullo zoccolo campi rossi marmorizzati e nella zona mediana pannelli neri con bande rosse e fasce bianche sottili (figg. 10-11). lo zoccolo a campi rossi marmorizzati “a goccie” (uS 16-p17-O4, fig. 12) mostra la stessa tecnica decorativa attestata a Emona nella prima fase della casa di C. Decius Avitus, databile alla seconda metà del i secolo o agli inizi del ii secolo d.C. 6. Anche l’ala p10B-O4 conserva la decorazione di una sola fase, con pareti dipinte a fondo nero nella parte inferiore. limitati sono i resti della decorazione sulle pareti dell’ambiente p12-O4: si possono distinguere due strati d’into-naco posti uno sopra l’altro. nella prima fase l’ambiente era dipinto di bianco con fasce rosse ai bordi dei muri e della nicchia (fig. 13); nella nicchia con il mosaico e la dedica a Salus l’intonaco bianco dalla prima fase è stato mantenuto fino al momento dell’abban-dono della casa. la nicchia dell’ambiente p11-O4 era dipinta in bianco con fasce rosse verticali e orizzontali, analogamente al resto dell’ambiente. l’ornato con fasce sottili e accurate su fondo bianco appare nella fase avanzata del stile ii pompeiano (50-25 a.C.) 7; una esecuzione meno accurata con fasce più larghe si riscontra nei rivestimenti di iii stile 8. le pareti della cucina p13-O4 erano dipinte in bianco semplice, mentre il cubicolo accanto all’oecus (p5-O4) mostra uno zoccolo rosso e la zona mediana dipinta in giallo (fig. 14); il grande calidario (p1-O4 unito con p19-O4) era invece decorato con pannelli neri delimitati da bande rosse (fig. 15).
Si puo concludere che gli affreschi seguivano lo scopo e la destinazione degli ambienti. i corridoi (p7-O4, p8-O4, p11-O4), le cucine (p13-O4, p18-O4), il magazzino (p10A-O4), la supposta latrina (p9-O4; fig. 16) e altri ambienti simili di rango minore (p15-O4, p16-O4) erano connotati da semplici rivestimenti in bianco o in bianco con fasce rosse. i portici intorno al peristilio (p2-O4, p3-O4, p4-O4), destinati a rappresen-
6 Plesničar-Gec, toman 1997, pp. 120-121, fig. 33.7 Stabiae, villa Varano, MiElSch 2001, p. 11, abb. 3.8 Oplontis, c.d. villa di poppea, cubicula, MiElSch 2001, p. 73.
LA DECORAzIONE PARIETALE DELLA dOmuS DEL QUARTIERE DI SAN TEODORO IN POLA
246
tanza e ricezione di ospiti e clienti, presentavano nella prima fase uno schema tripartito con pannelli rossi e bande nere nella zona mediana e vice versa (fig. 17; uS 16-p5-O4, fig. 18). dei più antichi affreschi dell’oecus rimane poco oltre i frammenti molto limitati trovati nella preparazione del pavimento musivo di seconda fase: essi hanno fondo nero con fascia sottile di color rosso cinabro e fascia più larga verde. partizioni dipinte con accurati motivi vegetali a fondo rosso, trovati nei vani p11-O4 (uS 16-p11-O4, fig. 19) e p7-O4 (uS 16-p7-O4, fig. 9) accanto all’oecus, recano traccia della picchiettatura e certamente appartengono alla prima fase pittorica della domus.
aFFrESchi dElla SEconda FaSE in PianotErra
nella fase di ritrutturazione della casa vennero rispettate la planimetria dell’edi-ficio e le modalità dei rivestimenti in funzione degli ambienti. tutti i vani di rango minore rimasero dipinti con rivestimento semplice e poco costoso bianco, mentre quelli destinati alla vita sociale e di rappresentanza vennero allestiti con decorazioni ricche e a colori vivaci. i pavimenti originali in cocciopesto (p17-O4), cocciopesto con motivi musivi (p10-O4) o in malta (p16-O4, p15-O4), vennero sostituiti da piani posti imme-diatamente al di sopra. Contemporaneamente, i pavimenti dell’oecus (p6-O4) e dei portici (p2-O4, p3-O4, p4-O4) vennero realizzati in mosaico.
la seconda fase dei rivestimenti parietali non si osserva in tutti gli ambienti: non si rileva negli ambienti posti sul lato orientale del peristilio (ambiente p17-O4, ala p10B-O4, triclinio p10-O4) e nel settore termale (p1-O4, p19-O4). il bagno certamente doveva avere affreschi nuovi perché un muro di divisione fu aggiunto formando piccolo spazio di sauna (p19-O4). Affreschi ritrovati in strati archeologici invece non inducono a pensare che il nuovo muro portava nuovo tipo di decorazione. Al contrario, sembra che lo schema deco-rativo fu mantenuto. i portici del peristilio vennero rinnovati come documentano i segni della picchiettatura (uS 16-p5-O4, fig. 18): per la loro frammentarietà e per la mancanza di dati sicuri, rimana ancora tutto da definire il programma decorativo della seconda fase del portico.
le pareti dell’ambiente p11-O4 accanto all’ingresso con nicchia e le pareti della supposta latrina (p9-O4) vennero dipinte di nuovo in bianco anche nella seconda fase. l’ambiente p12-O4 con dedica musiva a Salus nella nicchia ricevette nella seconda fase una decorazione a schema tripartito verticale con zoccolo nero e pannelli rossi nella zona mediana. il cubicolo p5-O4 venne rinnovato con decorazioni parietali a fondo bianco e motivo di rete eseguita in linee incise sottili, ornato da fiori a petali rossi e blu disposti sui punti dell’incrocio (uS 16-p5-O4, fig. 20). nello stesso tempo, il soffitto venne decorato con motivi vegetali verdi in campi divisi da linee rosse sottili su fondo bianco (fig. 4). l’oecus (p6-O4) doveva presentare uno schema tripartito, caratteristico del iii stile pompeiano (15. a.C. - 30. d.C.) 9: zoccolo nero, pannelli rossi con ghirlande vegetali e motivi architettonici eseguiti in tecnica “a secco” nella zona mediana e nella zona superiore probabilmente una architettura stilizzata su fondo blu (fig. 21). questi affreschi conservano elementi presi dallo stile ii B pompeiano, come motivi di ghirlande (uS 16-p7-O4, fig. 22) tipiche per i pannelli del ii stile pompeiano (50-25 a.C.) 10.
9 croiSillE 2005, p. 68.10 Stile ii A pompeiano (50/30-25 del i secolo a.C.): pompei, Casa del Criptoportico, cryptopor-
ALkA STARAC
247
aFFrESchi dEl Piano SuPEriorE
le decorazioni pertinenti al piano superiore sono riconoscibili grazie al supporto che rivestiva le murature in opus craticium, presenti come detto al secondo piano, e grazie alla loro situazione stratigrafica distribuita nei diversi ambienti (p17-O4, p10-O4, p10B-O4). Sono stati rinvenuti in strato di crollo al di sopra degli affreschi del pianoter-ra. numerosi pezzi di muri divisori in opus craticium, decorati da vari motivi e diverse composizioni cromatiche, permettono una vasta gamma di ipotesi ricostrutive. il fatto che alcuni ambienti hanno ricevuto due diversi tipi di decorazione parietale, creati in epoche successive, comporta ulteriori problemi. l’ala p10B-O4 del pianoterra, costruita con muri sottili divisori realizzati in opus craticium senza rivestimento pittorico con-servato in posizione originaria, pone un altro problema di distinzione tra i muri divisori del piano superiore e quelli del piano inferiore. Conclusioni finali saranno fornite dopo l’analisi microscopica del supporto.
Alcuni frammenti trovati per lo più nell’angolo nord-orientale della domus (uS 16-p15-O4 e uS 16-p16-O4) mostrano vari motivi decorativi attribuibili al iii stile pompeiano 11. tra di loro si ricordano i frammenti con fasce bianche sottili che delinea- no degli spazi poligonali a fondo rosso (fig. 23). nell’ambiente p9-O4 (uS 16-p9-O4) furono trovati affreschi caduti da altri ambienti, tra cui si notano trecce orizzontali dipinte giallo e blu a fondo rosso (fig. 24), candelabri e figure alate (fig. 25) dipinti in colore bianco e blu chiaro a fondo rosso, fasce, motivi geometrici e vegetali stilizzati (figg. 26-29). fasce decorate “a cassettoni” rinvenute nel vano p11-O4 (uS 16-p11-O4, fig. 30) trovano analogie a lubiana, nella casa di C. Decius Avitus, in fase posteriore della seconda metà del ii secolo d.C. 12. Strutture architettoniche con motivi di capiteli e architravi rappresentati in prospettiva e dipinti in tecnica policroma “a secco” (uS 16-p15-O4, fig. 31) ornavano un ambiente non determinato. immagini dell’architettura in prospettiva del ii stile pompeiano 13 si riscontrano raramente nella Cisalpina e in casi dubbi; architetture fantastiche prospettiche trovano invece un uso prolungato nel iii e iV stile 14. pannelli di colore rosso cinabro con bande nere verticali decorate con motivi vegetali, trovati nella presupposta latrina p9-O4 (uS 16-p9-O4, fig. 32), sono tipici del tardo stile iii pompeiano (30-50. d.C.) 15. per il loro forte effetto visuale, si distinguono alcuni frammenti rinvenuti nelle macerie del corridoio d’ingresso (p7-O4) e probabil-mente provenienti dall’oecus p6-O4: pannelli di colore rosso cinabro decorati da motivi vegetali realistici (uS 16-p7-O4, fig. 33) e fasce policrome con linee curve bianche a fondo giallo (uS 16-p7-O4, uS 16-p11-O4, fig. 34).
grazie ad alcuni lacerti di murature divisorie dotati di due strati di intonaco dipin-to si possono distinguere due fasi decorative anche nel piano superiore. nella prima
ticus e oecus, EAA Vi, p. 360; MiElSch 2001, p. 49, abb. 45-46. pompei, Casa delle nozze d’Argento, oecus e exedra, EAA Vi, p. 358; MiElSch 2001, p. 54, abb. 51-52. inizi del stile ii B pompeiano (30-25 del i s. a.C.): Roma, palatino, Casa di livia, ala, EAA Vi, p. 358; MiElSch 2001, p. 60, abb. 60; croi-SillE 2005, pp. 27, 56, fig. 49.
11 MiElSch 2001, p. 69; croiSillE 2005, p. 68.12 Plesničar-Gec, toman 1997, pp. 116-117, fig. 31.13 nella prima fase del iii stile (15. a.C. - 30. d.C.), si trovano ancora architetture dipinte pros-
pettiche: pompei, Casa di Sp. mesor, croiSillE 2005, p.70, fig. 70; Pompei, Casa di Sulpicius Rufus, croiSillE 2005, p. 71, fig. 72.
14 MElli 1998, p. 422, fig. 4; Miranda 2001, p. 198, fig. 2; p. 206.15 MiElSch 2001, p. 73.
LA DECORAzIONE PARIETALE DELLA dOmuS DEL QUARTIERE DI SAN TEODORO IN POLA
248
fase, i muri degli ambienti posti nel piano superiore erano dipinti in almeno tre modi diversi: si distinguono quattro ambienti separati. due ambienti erano dipinti in modo più semplice: comprendevano pannelli bianchi con bordi neri (uS 16-p17-O4, fig. 35) o rispettivamente pannelli bianchi con bordi rossi (uS 16-p7-O7, fig. 3, uS 16-p15-O4, fig. 36). più elaborato lo schema di un nucleo pittorico a fondo giallo su supporto di malta bianca, decorato con figure architettoniche e animali dipinti in tecnica “a secco”. Sono presenti candelabri divisori dei pannelli a fondo giallo (uS 16-p9-O4, fig. 37), tipici del stile iii pompeiano 16. dallo stesso ambiente proviene un insieme con edicola di tempio (uS 16-p9-O4, fig. 38) e altri motivi architettonici privi di prospettiva (uS 16-p15/p16-O4, fig. 39). l’edicola centrale nella zona mediana è tipica della fase ini-ziale del stile iii pompeiano 17. motivi paesaggistici con alberi (uS zazid 1-zid 11a-O2, p11-O4, fig. 40) e cigni che portano ghirlande (uS 16-p9-O4, fig. 41) appartengono allo stesso insieme pittorico. lo schema iconografico del cigno in coppia rappresentato di profilo con il collo abbassato che tiene una ghirlanda riporta alle coppie dei cigni con ghirlande del cubicolo di Casa di Augusto del palatino (30-25. a.C.) 18. l’altro ambiente del piano superiore non più conservato, i cui rivestimenti sono stati rinvenuti in ambienti ad oriente di peristilio (uS 16-p10-O4; uS 16-p17-O4), decisivamente il più rappre-sentativo, aveva pannelli mediani a fondo giallo con rappresentazioni animali e natura morta. Si riconosce un uccello con ciliegie (uS 16-p10-O4, fig. 42). gli affreschi di questo ambiente erano stati eseguiti con una preparazione rosata e molto dura, diversa per qualità da tutti gli altri ambienti del domus, e coronati da cornice in stucco. Come è noto, cornici in stucco erano posizionate sotto il soffitto o sotto la volta, nei triclini, salotti, cubicoli, ecc. la cornice con kyma lesbio a gigli e righe inclinate sopra e sotto (uS16-p17-O4, fig. 43) mostra affinità con la decorazione architettonica dipinta di ii stile nel salotto con pavone della c.d. villa di poppea in Oplontis 19.
nella seconda fase, durante la ristrutturazione effettuata al piano superiore, le più antiche pitture a fondo bianco con bordi neri vennero sostituite nella zona mediana da un motivo di quadrati delimitati da fasce gialle e rosse su fondo bianco; al centro dei quadrati si trova un fiore fortemente schematizzato, composto da un cerchio rosso in linea sottile con fillamento giallo o senza fillamento, e petali verdi (uS 16-p17-O4, uS 25-p7-O7, figg. 44-47). lo zoccolo era invece dipinto a finto marmo, con gocce rosse e gialle a fondo bianco (uS 16-p17-O4, fig. 47): simile decorazione si riscontra a lubiana nella casa di C. Decius Avitus, nella seconda metà del ii secolo d.C. 20. la superficie decorata con la rete di quadrati, ad imitazione di cassettoni, aveva i campi intermedi stretti e verticali con rappre-sentazione di un cespuglio di rose (fig. 45). il sistema decorativo a cassettoni si riscontra già nella decorazione parietale del ii stile pompeiano 21; trova fortuna in età dei Severi e rimase usato nel iii e iV secolo 22. questo tipo di ornato era frequentemente impiegato nei soffitti, come dimostrano le impronte dell’incannucciata sul retro; attestazioni archeologi-che si riscontrano nell’area nordadriatica e nel norico 23.
16 clarkE 1987, pp. 267-294; MiElSch 2001, p. 68.17 croiSillE 2005, p. 71.18 Stile ii B pompeiano: Roma, palatino, Casa di Augusto (30-25 a.C.), cfr. EAA Vi, p. 358;
MiElSch 2001, p. 57, abb. 56; croiSillE 2005, p. 27.19 FErgola 2004, p. 41.20 Plesničar-Gec, toman 1997, pp. 112-113, fig. 29.21 MiElSch 2001, p. 13, abb. 3-4, Stabiae, villa Varano.22 Roma, villa grande s. Sebastiano, iii s., MiElSch 2001, p. 120, abb. 146.23 oriolo et alii 2007, p. 205, tav. 52; kEnnEr 1985, pp. 105-106, tav. 64.
ALkA STARAC
249
ElEMEnti di intErPrEtazionE E datazionE StratigraFici
l’intera superficie della domus era ricoperta da strati di crollo (uS 16). le macerie si estendevano tra i muri esterni, il muro meridionale alto 3,5 metri, il muro orientale alto da 1,5 a 1,8 metri e quello settentrionale alto 1,25 metri. gli strati di crollo conte-nevano pietre, resti musivi dei pavimenti del piano superiore, resti di malta, rivestimenti parietali e di soffitti e tegole e coppi dal tetto. le unità stratigrafiche e le tracce di bruc-ciato riscontrate sui pavimenti all’interno di ogni ambiente documentano un abbandono terminale a cavallo tra il quarto e il quinto secolo, causato da un incendio divambato nell’edificio termale vicino. dopo l’abbandono e il crollo della casa, la zona non fu mai più riedificata o utilizzata a scopi abitativi. i resti della domus vennero coperti in età successiva con il giardino della proprietà della chiesa e del relativo monastero femmi-nile benedettino (uS 24). in epoca moderna, nel 1873, il terreno fu colmato di sassi e terra per costruire il terrazzo di una caserma dell’infanteria austriaca (uS 3). il livello del suolo è stato così rialzato per cinque metri in altezza: tutte le costruzioni seguenti durante il ventesimo secolo vennero così fondate in questo strato di livellamento, non intaccando gli strati della domus profondamente sepolta. grazie a questa fortunata situa-zione, la domus è rimasta intatta com’era al momento del crollo, chiusa nella sua capsola invisibile e dimenticata, fino alla indagine archeologica in 2005.
l’utilizzo del color rosso cinabro e di diversi marmi colorati d’importazione nell’arredo del settore termale indicano la richezza del committente 24. le due fasi principali del programma decorativo riguardano i piani pavimentali e gli affreschi, posti uno sopra l’altro. gli intonaci intenzionalmente picchiettati si possono attribuire senza dubbio alla fase più antica. elemento di datazione di valore specifico sono certamente i frammenti delle anfore del tipo lamboglia 2 tarde e dressel 6B, inclusi insieme con frammenti di tegole e distrutti mosaici nella struttura muraria in opus craticium dei muri separativi. interventi posteriori della terza fase si notano nell’ala p10B-O4, dove accanto alla soglia musiva con cantaro fu aggiunto nella fase seconda un mosaico con campo bianco e bordo nero e succesivamente venne costruito un focolare sopra mosai-co, aperto nel triclinio. interventi contemporanei nella decorazione parietale non sono invece riconoscibili.
Seguendo i rapporti stratigrafici dell’area, si può concludere che la domus venne costruita negli anni 40-30. a.C., nei primi anni della colonia romana di pola, e abitata fino al V secolo d.C. Si distinguono due fasi principali del programma decorativo: la prima si data tra il 40 e il 30. a.C. e si inserisce nello ii stile (fase B) pompeiano; danni causati da fuoco furono la ragione per i restauri nei primi decenni del ii secolo. gli inter-venti della terza fase rimangono senza elementi chiari per loro distinzione nella pittura muraria. Con i suoi 22 ambienti scavati, la domus rappresenta uno dei più interessanti e meglio conservati esempi dell’architettura abitativa urbana nell’istria. la sua partico-lare importanza proviene dal rapporto con il santuario romano d’ercole e con l’edificio termale, inclusi insieme in un quartiere della città.
24 oriolo et alii 2007, pp. 194-195.
LA DECORAzIONE PARIETALE DELLA dOmuS DEL QUARTIERE DI SAN TEODORO IN POLA
250
BiBliOgRAfiA
EAA = Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale, istituto della enciclopedia italiana fondata da giovanni treccani, Roma.
BEyEn 1965 = H.g. BEyEn, Pompeiani, stili, in EAA Vi, pp. 356-366.clarkE 1987 = J.R. clarkE, The early third style at Oplontis, «mitteilungen des deutsches archäolo-
gischen instituts, Römische Abteilung», 94, pp. 267-294.FErgola 2004 = l. FErgola, Oplontis e le sue Ville, pompei.gnirS 1904 = A. gnirS, Zur Topographie des antiken Pola, «Jahrbuch der Kaiser-königlichen zentral
Kommission» 2, cc. 215-232.kEnnEr 1985 = H. kEnnEr, Die römischen Wandmalereien des Magdalensberges «Archäologische
forschungen zu den grabungen auf dem magdalensberg», Klagenfurt. lazar 2002 = i. lazar, Celeia, in The Autonomous Towns of noricum and pannonia, a cura di m. ŠašEl
koS e p. SchErrEr, Situla, 40, Ljubljana, pp. 71-96.MElli 1998 = p. MElli, Prospettive di ricerca a Genova e nel suo territorio. Genova, in Optima via 1998,
pp. 421-422.Miranda 2001 = S. Miranda, La decorazione parietale delle domus della Cisalpina occidentale,
«Antichità Altoadriatiche», 49, pp. 195-215.Optima via 1998 = Optima via (Atti del Convegno internazionale di Studi, “postumia. Storia e arche-
ologia di una grande strada romana alle radici dell’europa”, Cremona, 13-15 giugno 1996), a cura di g. SEna chiESa e e.A. arSlan, Cremona.
oriolo et alii 2007 = F. oriolo, v. ProvEnzalE, B. goBBo, g. a. Mazzocchin, F. agnoli, Intonaci dipinti, in Trieste Antica 2007, pp. 186-232.
Plesničar-Gec, toMan 1997 = l. Plesničar-Gec, V. toMan, The Roman Frescoes of Slovenia I, Katalogi in monografije, 31, 1, Ljubljana.
Plesničar-Gec, toMan 1998 = l. Plesničar-Gec, V. toMan, The Roman Frescoes of Slovenia I, Katalogi in monografije, 31, 2, Ljubljana.
rinaldi 2007 = f. rinaldi, Mosaici e pavimenti del Veneto. Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza (I sec. a.C. – VI sec. d.C.), Antenor quaderni, 7, Roma - Venezia.
SanadEr 1995 = m. SanadEr, O kultu Herkula u Hrvatskoj, «Opuscula Archaeologica», 18, pp. 87-114.Starac 2006a = A. Starac, Das antike Pula, seine Topografie und seine Denkmäler, «mitteilungen der
Berliner gesellschaft für Anthropologie, ethnologie und urgeschichte», 27, pp. 135-140.Starac 2006b = A. Starac, Gradska četvrt Sv. Teodora, Pula, «Hrvatski Arheološki Godišnjak», 2, pp.
235-238.Starac 2007a = A. Starac, Gradska četvrt Sv. Teodora, Pula, «Hrvatski Arheološki Godišnjak», 3, pp.
263-265.Starac 2008a = A. Starac, A Deposit of roman Amphorae in Pula (Croatia). A preliminary report.
«Rei Cretariae Romanae fautorum Acta», 40 (Congressus vicesimus quintus rei cretariae roma-nae fautorum dyrrhachii habitus mmVi) Bonn, pp. 121-129.
Starac 2008b = A. Starac, Salus, Herkul i izvor vode. Primjer Pule, «Archaeologia Adriatica», 2, pp. 301-313.
Starac 2009a = A. Starac, Depozit amfora u četvrti sv. Teodora, Pula, «Jurišićev zbornik. Zbornik radova posvećenih uspomeni na Marija Jurišića», pp. 379-389.
Starac 2009b = A. Starac, Quarter of St. Theodor in Pula, «Annales, Series Historia et Sociologia», 19, 2, pp. 271-290.
Starac 2009c = A. Starac, Nalaz rimskog svetišta u četvrti sv. Teodora u Puli. Arheološka istraživanja 2008, «Histria Archaeologica», 38-39, pp. 123-168.
Trieste Antica 2007 = Trieste Antica. Lo scavo di Crosada II. I materiali, a cura di C. MorSElli, trieste.
ALkA STARAC
419
Alka Starac
lA deCORAziOne pARietAle dellA DOMUS del quARtieRe di SAn teOdORO in pOlA
fig. 1. Carta dei ritrovamenti nell’area di S. teodoro, pola, nel terzo quarto del i secolo a.C. (elaborazione grafica A. Starac).
fig. 2. planimetria della domus nel quartiere di S. teodoro, pola (elaborazione grafica A. Starac).
fig. 3. Ritrovamento di parete in opus craticium (foto A. Starac).
fig. 4. Soffitto del cubicolo p5-O4 (foto A. Starac).
fig. 5. Soffitto (uS 16-p17-O4) (foto A. Starac).
420
ALkA STARAC
fig. 6. Soffitto (uS 16-p20-O4) (foto A. Starac).
fig. 7. Soffitto (uS 22-p20-O4) (foto A. Starac).
fig. 8. Soffitto (uS 16-p15-O4) (foto A. Starac).
fig. 9. picchiettatura (uS 16-p7-O4) (foto A. Starac).
fig. 10. Affreschi dell’ambiente p17-O4 (foto A. Starac).
fig. 12. zoccolo dell’ambiente p17-O4 (foto A. Starac).
fig. 11. decorazione parietale dell’ambiente p10-O4. prima ipotesi ricostruttiva (elaborazione grafica A. Starac).
421
LA DECORAzIONE PARIETALE DELLA dOmuS DEL QUARTIERE DI SAN TEODORO IN POLA
fig. 16. decorazione parietale dell’ambiente p9-O4. prima ipotesi ricostruttiva (elaborazione grafica A. Starac).
fig. 13. decorazione parietale dell’ambiente p12-O4, prima fase. prima ipotesi ricostruttiva (elabora-zione grafica A. Starac).
fig. 14. decorazione parietale dell’ambiente p12-O4, prima fase. prima ipotesi ricostruttiva (elabora-zione grafica A. Starac).
fig. 15. decorazione parietale dell’ambiente p19-O4. prima ipotesi ricostruttiva (elaborazione grafica A. Starac).
422
fig. 17. decorazione parietale degli ambienti p2-O4, p3-O4, p4-O4. prima ipotesi ricostruttiva (ela-borazione grafica A. Starac).
fig. 18. decorazione parietale della prima fase (uS 16-p5-O4) (foto A. Starac).
fig. 19. decorazione parietale della prima fase (uS 16-p11-O4) (foto A. Starac).
fig. 20. decorazione parietale della seconda fase (uS 16-p5-O4) (foto A. Starac).
fig. 21. decorazione parietale dell’ambiente p6-O4. prima ipotesi ricostruttiva (elaborazione grafica A. Starac).
ALkA STARAC
423
LA DECORAzIONE PARIETALE DELLA dOmuS DEL QUARTIERE DI SAN TEODORO IN POLA
fig. 22. Affreschi con motivi di ghirlanda (uS 16-p7-O4) (foto A. Starac).
fig. 24. Affreschi con trecce policromi a fondo rosso (uS 16-p9-O4) (foto A. Starac).
fig. 23. Affreschi con decorazione a fasce bianche a fondo rosso (uS 16-p15-O4) (foto A. Starac).
fig. 26. Affreschi con decorazione a fascie (uS 16-p9-O4) (foto A. Starac).
fig. 27. Affreschi con fasce a fondo rosso (uS 16-p9-O4) (foto A. Starac).
fig. 28. Affreschi con fasce verdi a fondo nero (uS 16-p9-O4) (foto A. Starac).
fig. 29. intonaco dipin-to con motivi vegetali stilizzati su fondo rosso (uS 16-p9-O4) (foto A. Starac).
fig. 25. Affreschi con candelabri e figure alate a fondo rosso (uS 16-p9-O4) (foto A. Starac).
424
fig. 35. decorazione parietale della prima fase (uS 16-p17-O4) (foto A. Starac).
fig. 30. Affreschi con motivi geometrici a fondo rosso (uS 16-p9-O4) (foto A. Starac).
fig. 31. Affreschi con motivi architettonichi (uS 16-p15-O4) (foto A. Starac).
fig. 32. Affreschi con motivi vegeta-li realistici a fondo nero (uS 16-p9-O4) (foto A. Starac).
fig. 33. Affreschi con motivi vegetali realistici a fondo rosso (uS 16-p7-O4) (foto A. Starac).
fig. 34. Affreschi con motivi geometri-ci (uS 16-p7-O4, uS 16-p11-O4) (foto A. Starac).
fig. 36. decorazione parietale della prima fase (uS 16-p15-O4) (foto A. Starac).
ALkA STARAC
425
LA DECORAzIONE PARIETALE DELLA dOmuS DEL QUARTIERE DI SAN TEODORO IN POLA
fig. 41. intpnaco dipinto con cigno che porta una ghirlanda a fondo giallo (uS 16-p9-O4) (foto A. Starac).
fig. 38. Affreschi con tempio su fondo giallo (uS 16-p9-O4) (foto A. Starac).
fig. 39. intonaco dipinto con motivi architettonichi su fondo giallo (uS 16-p15-O4) (foto A. Starac).
fig. 40. Affreschi con albe-ro a fondo giallo (uS zazid 1-zid 11a-O2, p11-O4) (foto A. Starac).
fig. 42. insieme con uccello e ciglie-gie a fondo giallo (uS 16-p10-O4) (foto A. Starac).
fig. 37. insieme con candelabri su fondo giallo (uS 16-p9-O4) (foto A. Starac).
426
fig. 43. decorazione in stucco (uS 16-p17-O4) (foto A. Starac).
fig. 44. decorazione parietale del piano superiore, seconda fase (uS 16-p17-O4) (foto A. Starac).
fig. 45. decorazione parietale con cespu-glio di rose. piano superiore, seconda fase (uS 16-p17-O4) (foto A. Starac).
fig. 46. decorazione parietale del piano superiore, seconda fase. ipotesi ricostruttiva (autore: A. Starac).
fig. 47. decorazione parietale del piano superiore, seconda fase. zoccolo (uS 16-p17-O4) (foto: A. Starac).
ALkA STARAC