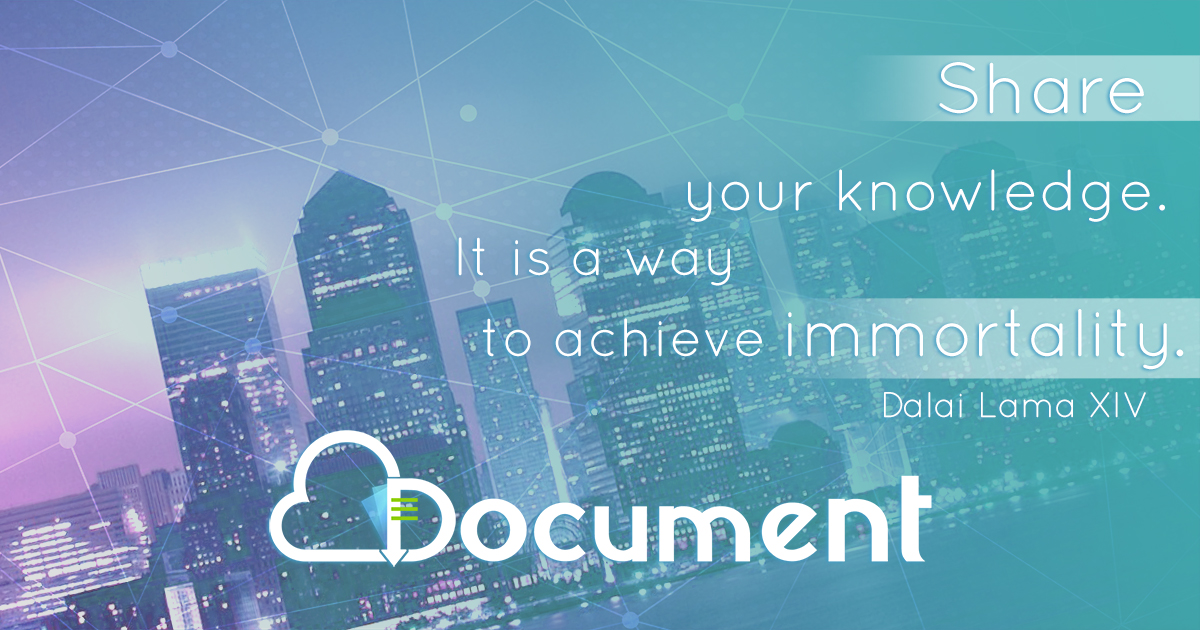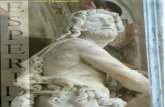F.Spatafora, E.Canzonieri, AL-KHĀLIȘA: ALCUNE CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE NUOVE SCOPERTE...
Transcript of F.Spatafora, E.Canzonieri, AL-KHĀLIȘA: ALCUNE CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE NUOVE SCOPERTE...
LES DYNAMIQUES DE L’ISLAMISATIONEN MÉDITERRANÉE CENTRALE ET EN SICILE :
NOUVELLES PROPOSITIONS ET DÉCOUVERTES RÉCENTES
LE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONENEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA:
NUOVE PROPOSTE E SCOPERTE RECENTIédité par a cura diAnnliese Nef, Fabiola Ardizzone
avec la collaboration de con la collaborazione di Lucia Arcifa, Alessandra Bagnera, Elena Pezzini
Roma-Bari 2014
E S T R AT T O - T I R É - A - PA R T
COLLECTION DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME487
10
© 2014 Edipuglia srl
L’autore ha il diritto di stampare o diffondere copie di questo PDF esclusivamente per uso scientifico o didattico.Edipuglia si riserva di mettere in vendita il PDF, oltre alla versione cartacea. L’autore ha diritto di pubblicare in internetil PDF originale allo scadere di 24 mesi.
L’auteur a le droit d’imprimer ou de distribuer des copies de ce document PDF exclusivement à des fins scientifiquesou pédagogiques. Edipuglia se réserve le droit de vendre le PDF, en plus de la version papier. L’auteur a le droit de publierle PDF d’origine sur internet seulement au bout de 24 mois.
The author has the right to print or distribute copies of this PDF exclusively for scientific or educational purposes.Edipuglia reserves the right to sell the PDF, in addition to the paper version. The author has the right to publish theoriginal PDF on the internet at the end of 24 months.
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
Due problemi fondamentali per la storia urbanisticadella città – originati da questioni di carattere storico-topografico ampiamente dibattute dalla storiografia mo-derna, seppure raramente sulla base di sostanzialievidenze archeologiche – hanno guidato l’attività svoltadalla Soprintendenza di Palermo, nel decennio 2000-2010, nel centro storico di Palermo e in particolare nelquartiere della Kalsa 1. Il primo riguardava la possibilitàche la città punico-romana potesse estendersi in manierapianificata al di fuori del perimetro fortificato per oc-cupare le aree del transkemonia dove, a parere di alcunistudiosi 2, potrebbe localizzare la neapolis, la città nuovache per prima subì l’assalto dei Romani sbarcati nel portodella città 3 e dove, invece, sorse probabilmente, in ma-niera spontanea e senza un piano preordinato, un sob-borgo legato alle attività portuali 4; il secondo problema,pertinente i secoli del dominio arabo e normanno di Pa-lermo, riguarda la localizzazione della Khāliṣa nell’am-bito di un quartiere che, seppure tradizionalmenteidentificato con la cittadella fatimide 5, non aveva mairestituito indicazioni significative sull’entità e i tempidella sua islamizzazione nonché su una sua precipua ca-ratterizzazione urbanistica e architettonica.
Pur non volendo richiamare in questa sede le diversetestimonianze letterarie attraverso cui la critica modernaha costruito l’immagine della nuova cittadella, legandolastrettamente alla sua utilizzazione da parte della classepolitica detentrice del potere, non posso non rilevarecome da tale tradizione sia nata l’idea di un luogo aulicodove aveva dimora l’emiro con il suo seguito di digni-tari e dove si curava il governo e l’amministrazionedella città 6; un quartier generale fortificato dove, se-condo Ibn Ḥawqal, non vi erano né mercati né fondaci,asserzione peraltro contraddetta solo qualche anno piùtardi da al-Muqaddasī a testimoniare, forse, una realtà inevoluzione e in continua trasformazione.
La documentazione archeologica di questi ultimianni non è forse dirimente per la soluzione delle innu-merevoli domande suggerite dalla complessità deltema, anche perché lo studio dei materiali recuperatinel corso delle numerose indagini stratigrafiche con-dotte in più punti è appena allo stadio iniziale, e in con-tinua evoluzione è del resto l’analisi stessa delle classiceramiche da attribuire ai vari periodi della domina-zione musulmana in Sicilia 7. Tuttavia, pur non po-tendo prendere in considerazione tutti quei contesti di
1 Le indagini, programmate nell’ambito di uno specifico progettodi archeologia urbana o condotte, in diverse occasioni, con carat-tere d’urgenza, si sono svolte sotto la direzione scientifica della scri-vente e grazie alla collaborazione sul campo di numerosi validiarcheologi e architetti, interni o esterni alla Soprintendenza. Sarebbetroppo lungo ricordarli tutti ma, tra tutti, non voglio dimenticare ilcontributo fondamentale dell’arch. Valeria Brunazzi con cui ho sem-pre condiviso progetti, letture di contesti, ipotesi di lavoro in un pro-ficuo e continuo scambio di idee che ha certamente favorito losviluppo della ricerca di quest’ultimo decennio.
2 DI STEFANO Carmela Angela 1993, p. 276-278; EAD. 1998,p.100-101; BELVEDERE Oscar 1998.
3 DIODORO XXXIII, 18, 4-5; POLIBIO I, 38, 7-9.4 SPATAFORA Francesca 2009, p. 226-227.5 Sulle diverse ipotesi di localizzazione, PEZZINI Elena 2006, p. 45-
47 e in particolare la nota 36 con ampia bibliografia di riferimento.6 DE SIMONE Adalgisa 2000, p. 97-98.7 A tal proposito, cfr. il saggio di ARCIFA Lucia, BAGNERA Ales-
sandra, NEF Annliese 2012 e l’ampia bibliografia in esso richiamata.
AL-KHĀLIṣA: ALCUNE CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE NUOVE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE
NEL QUARTIERE DELLA KALSA
Francesca Spatafora (Museo Archeologico Regionale di Palermo “Antonino Salinas”)
Emanuele Canzonieri (archeologo)
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
FRANCESCA SPATAFORA - EMANUELE CANZONIERI
scavo che permetterebbero alcune valide considera-zioni sull’argomento o che, comunque, potrebbero ri-sultare utili a determinare elementi di continuità o didiscontinuità nelle modalità di occupazione del quar-tiere, anche nel momento di passaggio all’età nor-manna, vale certamente la pena di sottolineare alcunielementi già chiaramente delineatisi e che, indubbia-mente, contribuiscono ad accrescere le nostre ancoralimitate conoscenze.
La necropoli islamica
Un elemento interessante in relazione alla possibilelocalizzazione della cittadella fatimide proviene, indi-rettamente, dalla localizzazione di una vasta necropoliche occupa la parte sud-orientale del quartiere. Non midilungherò sull’argomento avendone già dato notizia inpiù occasioni 8 ed essendo il dato ormai ampiamente ac-quisito in letteratura 9. Volevo solo sottolineare come, at-traverso lo studio dei materiali, si vada affinando lacronologia di questa estesa necropoli suggerendo, quindi,alcune interessanti considerazioni di carattere generale.
Si delinea, infatti, una situazione simmetrica che in-teressa le aree a Nord e a Sud dell’antica zona portuale,con l’esistenza di due grandi maqbara-s estese fino almare (fig. 1a), nate probabilmente nel momento in cuila città islamica era ancora racchiusa entro il perimetrodelle mura urbiche della città punica. La necropoli set-tentrionale, oggi tagliata dal sottopasso della Via Crispi,è documentata attraverso l’unico livello di sepolture diCastello San Pietro 10 e, adesso, dalle numerose tomberiportate alla luce nell’area del Castello a Mare 11. Allanecropoli meridionale, invece, possono attribuirsi – oltrealle sepolture del convento dei Crociferi e di Santa Te-resa alla Kalsa ricordate da Gaspare Palermo 12 – quelleriportate alla luce nel corso degli scavi alla Chiesa diS. Maria degli Angeli, nell’area di Palazzo Abatellis, aPiazza Kalsa a all’Oratorio dei Bianchi 13, oltre a qual-che più recente evidenza di cui accennerò oltre (fig. 1b).
Nel caso della necropoli nord, a fronte dell’unico li-vello di sepolture di Castello San Pietro, datato oggi alla
seconda metà del IX secolo 14, è stato possibile docu-mentare, nell’area del Castello a Mare, l’esistenza di de-posizioni funerarie stratificate (fig. 1c) che attestanol’uso prolungato del cimitero musulmano, testimo-niando quindi un abbandono della parte più occidentaledell’impianto necropolare man mano che le case delloḤarat al-ṣaqāliba si estendevano verso Est.
Analogamente, a Sud, è possibile che la vasta ne-cropoli, anch’essa probabilmente utilizzata in un primotempo dagli abitanti di Balarm, nel corso del X secoloabbia occupato un’area più ristretta. Alcune delle strut-ture murarie riportate alla luce in uno dei saggi nel sa-grato della chiesa di S. Maria degli Angeli, infatti,obliterano un unico livello di sepolture databile forsetra la fine del IX e i primi decenni del X secolo 15, sug-gerendo l’ipotesi che la fondazione di al-Khāliṣa abbiacomportato la contrazione dell’area cimiteriale verso SEdove la stratificazione delle sepolture del giardino di Pa-lazzo Abatellis e dell’Oratorio dei Bianchi dimostra unpiù lungo utilizzo della necropoli a servizio, forse, anchedi quei quartieri sviluppatisi più tardi a Sud e all’esternodell’antica cittadella murata.
A conferma di questa ipotesi richiamo anche alcuninuovi indizi emersi nel corso di recenti indagini ar-cheologiche, utili per delineare la più antica estensionedel cimitero islamico: tre sepolture in fosse semplici ta-gliate nella terra rossa che ricopre il banco roccioso ecaratterizzate dalle tipiche modalità di deposizione ditipo islamico sono state rinvenute nel corso di un in-tervento d’urgenza condotto all’interno di un lotto, oggiedificato, ad angolo tra la Via Butera e la Via Alloro 16
(fig. 1b) e resti assai frammentari di una deposizionefuneraria di rito islamico sono stati riportati alla lucenel corso di un’altra indagine preventiva realizzata an-cora lungo la Via Butera a ridosso del vicolo Niscemi 17.In quest’ultima area, tra l’altro, non si è evidenziata al-cuna struttura muraria databile dall’età islamica in poi,ma soltanto pozzi e silos, utilizzati come butti, chehanno restituito una discreta varietà di materiali attri-buibili anche ad età islamica, tra cui alcuni chiaramenteprovenienti da impianti artigianali per la produzionedella ceramica.
8 SPATAFORA Francesca 2004, p. 61-77; EAD. 2005, p. 60-65.9 BAGNERA Alessandra, PEZZINI Elena 2006, p. 239-246.10 DI STEFANO Carmela Angela 1993, p. 279-283. Cfr. in questo
stesso volume il contributo di ARCIFA Lucia e BAGNERA Alessandra.11 SPATAFORA Francesca 2005, p. 75.12 PALERMO Gaspare 1858, p. 370.
13 SPATAFORA Francesca 2004, p. 61-77.14 Cfr. infra ARCIFA Lucia, BAGNERA Alessandra.15 Cfr. infra il contributo di ARDIZZONE Fabiola, PEZZINI Elena,
SACCO Viva.16 Lo scavo è stato condotto sul campo da Monica Chiovaro.17 Lo scavo è stato condotto sul campo da Rosa Maria Cucco.
234
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
Fig. 1 - a - carta schematica dei quartieri medievali con l’ubicazione delle necropoli islamiche; b - carta schematica della necropoli meri-dionale con i recenti rinvenimenti; c - area del Castello a Mare, planimetria e veduta sepolture di rito islamico.
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
FRANCESCA SPATAFORA - EMANUELE CANZONIERI
Le ricerche allo Steri e a Piazza Marina
Neppure le estese ricerche condotte nel complessodello Steri (fig. 2a) hanno messo in evidenza alcuna strut-tura stabile a carattere abitativo di età islamica quantopiuttosto una semplice frequentazione dell’area docu-mentata attraverso numerosi e interessanti materiali re-siduali attribuibili, anche sulla base delle recentiproposte cronologiche, alla prima metà del X secolo. Sitratta soprattutto di lucerne a piattello e cupoletta (fig.2b), olle con tesa svasata (fig. 2c), catini invetriati diproduzione locale e di importazione, tra cui si segnalaun fondo a vetrina giallo chiaro (fig. 2d) recante al cen-tro del cavo un cartiglio in caratteri epigrafici distintiin due o tre righe, che potrebbero inquadrarsi in un con-testo poetico/amoroso 18.
Gli strati connessi all’impianto di un’area artigianaleper la lavorazione e produzione di vetro e ceramiche,scoperta nell’area delle carceri seicentesche e in vita finoal XII secolo, restituiscono, invece, reperti probabilmentedatabili tra la fine del X e la prima metà dell’XI secolo 19:tra essi segnalo frammenti di catini con decorazione inverde e bruno e vetrina opalescente e di catini carenaticon decorazione a cuori concatenati e motivi zoomorfio fitomorfi (fig. 2e) nonché filtri di brocche locali e im-portati.
Incerta rimane purtroppo anche la datazione in ter-mini di cronologia assoluta di alcune strutture murarieriutilizzate nella grande aula semipogeica rinvenutasempre al di sotto delle carceri seicentesche e posta im-mediatamente a Est di Palazzo Chiaramonte, ad essocoeva e collegata funzionalmente. La realizzazione del-l’aula comportò infatti, attraverso l’escavazione profondadel banco di roccia, la rimozione degli accumuli pre-cedenti e l’inclusione nella nuova architettura di tuttele preesistenze.
Alla luce della più ampia evidenza archeologica oggidisponibile, pertanto, nonché delle recenti proposte didatazione di alcuni importanti “indicatori” ceramici 20,appare oggi assai problematica una possibile localizza-zione della Khāliṣa in quella che, finora, era stata la zonamaggiormente indiziata 21 – e che io stessa avevo indi-
cato 22 prima degli scavi nell’area del Palazzo Chiara-monte – ovvero la lingua di terra che allungandosi versoNord delimita oggi il lato orientale di Piazza Marina,un’area piuttosto limitata per estensione, ma preminentee ben posizionata strategicamente in funzione del portoantico; una zona che in realtà, alla luce della nuova esignificativa documentazione, sembra piuttosto destinataa una utilizzazione di tipo funerario, per quanto riguardala fascia più vicina al mare, e di tipo artigianale per ilresto della sua estensione; un uso che del resto, almenoa mio parere, non contrasta con una eventuale area aservizio e a controllo del bacino portuale e degli ap-prestamenti con esso connessi.
In questa stessa direzione, inoltre, altre interessantinovità sono scaturite da uno scavo condotto con ca-rattere d’urgenza lungo il lato settentrionale di PiazzaMarina 23: solo per richiamare brevemente le conclu-sioni di quest’indagine voglio ricordare come la ri-cerca si sia rivelata particolarmente interessante inrelazione al tema dell’interramento dell’antica ansaportuale. La convergenza dei dati di scavo e delle ana-lisi scientifiche effettuate sui legni recuperati nel corsodello scavo ha permesso una plausibile interpretazionedell’interessante contesto indagato, caratterizzato dallapresenza di legni lavorati e semilavorati che giacevanoin situ, in un terreno umido costituito da sabbie limosee al di sotto di un consistente strato sabbioso di riem-pimento. Fondamentale è la datazione dell’intero con-testo che, sulla base della ceramica rinvenuta inassociazione con i reperti lignei, sembra compresa trail X e i primi decenni dell’XI secolo 24, cronologia con-fermata da una serie di analisi radiocarboniche su piùcampioni lignei 25.
Nella prima metà dell’XI secolo, dunque, ci trove-remmo in presenza non più di una zona portuale internaquanto piuttosto di un’area caratterizzata da terreniumidi e destinata all’attività cantieristica navale, un’areache, all’epoca, doveva essere solo lambita dal mare.Ovvio, naturalmente, il collegamento con l’arsenale ri-cordato da Ibn Ḥawqal e, quindi, altrettanto ovvia l’ideadi una destinazione di tipo artigianale/cantieristico del-l’intera spianata 26.
18 Si ringrazia la Prof.ssa Marilì De Luca per questa prima let-tura e interpretazione dell’iscrizione.
19 ARCIFA Lucia, BAGNERA Alessandra, NEF Annliese 2012; BA-GNERA Alessandra 2012, p. 27-37.
20ARCIFA Lucia, BAGNERA Alessandra, NEF Annliese 2012,p. 245-256 (con ampia bibliografia di riferimento). ARCIFA Lucia2012, p. 23-25; BAGNERA Alessandra 2012, p. 27-37.
21 BRESC Henri 1981, p. 25.22 SPATAFORA Francesca 2004, p. 78.23 SPATAFORA Francesca et alii 2012.24 SPATAFORA Francesca et alii 2012, p. 25-27.25 SPATAFORA Francesca et alii 2012, p. 27-28.26 SPATAFORA Francesca et alii 2012, p. 31-32.
236
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
Fig. 2 - a - Steri, carceri dei Penitenziati, planimetria dei saggi di scavo e dell’aula semi-ipogeica; b - Steri, lucerne residuali di età islamica; c -Steri, olla con tesa svasata; d - Steri, fondo di catino con vetrina gialla e cartiglio con versi amorosi; e - Steri, catino carenato con lepre al centrodel cavo.
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
FranCESCa SPaTaFOra - EManUELE CanzOnIErI
Lo scavo di Palazzo Statella Spaccaforno
Sempre all’interno del quartiere Kalsa, particolar-mente significative si sono rivelate le indagini condottenell’area di Palazzo Statella Spaccaforno, su cui forniròsolo alcune brevi notizie preliminari trattandosi di uncontesto ancora del tutto inedito e in corso di studio cheha restituito, per la prima volta, un lembo organico diabitato di età islamica (fig. 3a).
Lo scavo è stato condotto preventivamente al restauroe alla riconfigurazione del Palazzo, situato sul lato set-tentrionale dell’attuale Piazza Magione tra la via Vetrierae Piazza S. Euno. L’indagine, conclusa nel 2010, ha in-teressato uno spazio rettangolare di circa 46 x 22 metri,entro cui sono stati effettuati undici saggi 27 (fig. 3b).
Sorvolando, per brevità, sulla stratigrafia dei livellisuperiori, precedenti l’edificazione del palazzo del XVI-XVII secolo, mi soffermerò brevemente sulle due fasiedilizie di età medievale.
La prima e più antica, probabilmente risalente allaprima metà del X secolo, è caratterizzata da uno schemaortogonale entro cui si inseriscono una serie di ambientia pianta irregolarmente quadrangolare orientati in senson-nE/S-SO, secondo uno schema non estraneo ad altricontesti coevi dell’isola 28. Un elemento che caratterizzal’intero contesto è la presenza di pozzi: nell’area inda-gata ne sono stati rinvenuti nove, probabilmente ognunodestinato ad una unità abitativa. L’analisi di alcune ca-ratteristiche ricorrenti, ha permesso di delineare tre prin-cipali tipologie edilizie, tutte caratterizzata dall’affacciosulla strada e dalla presenza del pozzo (fig. 3c): il tipoa presenta una corte interna pavimentata in terra bat-tuta, con pozzo a uno degli angoli, da cui si accede agliambienti distribuiti sui lati nord e sud; il tipo b ha unamaggiore articolazione dei vani, in numero non infe-riore a quattro, che ruotano intorno al cortile rettango-lare con pozzo. Il terzo tipo (C), riconosciuto solo in uncaso, presenta una corte più estesa: il lato nord è lungoquasi 5 m, con pozzo all’angolo, da cui si accede agliambienti, anch’essi di maggiori dimensioni rispetto aiprecedenti.
Le unità abitative si distribuiscono lungo due assiviari disposti in senso SO-nE, il cui rinvenimento è difondamentale importanza per un primo tentativo di ri-costruzione dell’organizzazione urbanistica di un settore
dell’abitato di età islamica. Le strade, infatti, realizzatecon uno strato di tufo costipato spesso circa 15 cm esostenuto da una preparazione di piccole pietre informi,sono larghe tra m 1,60 e m 2,20 e distano tra loro circa10 m; hanno andamento parallelo che curva lievementeverso nO, con leggera pendenza verso il mare e cana-lizzazioni coperte da lastre per l’irreggimentazione delleacque piovane. La larghezza dei blocchi abitativi deli-mitati dalle strade si aggira tra i m 9,20 e m 11,70.
I muri perimetrali delle case ha uno spessore mediocompreso tra i 60 e gli 80 cm mentre quelli divisori in-terni misurano tra i 50 e i 70 cm; tutte le strutture sonorealizzate con tecnica abbastanza regolare a conci bensquadrati lunghi non più di 50 cm e alti non più di 25cm, legati con terra rossa di consistenza plastica. Unarisega più o meno marcata all’altezza dei piani d’usosegna le fondazioni che poggiano direttamente sul pianodi roccia (fig. 3d).
La cronologia si fonda sulla presenza negli strati dia-gnostici – battuti pavimentali e strati da essi sigillati sinoal banco roccioso – di numerosi frammenti di catini “acarena alta”, di lucerne a piattello e cupoletta, di ansedi brocche e anfore segnate dalla solcatura lungo l’assemediano, materiali recentemente datati alla prima metàdel X secolo (cfr. ultra). Tuttavia è utile sottolineare,per contribuire ad un più preciso inquadramento cro-nologico anche di altre classi ceramiche o per meglioprecisare, eventualmente, qualcuna delle datazioni pro-poste, l’associazione negli stessi livelli con altri tipi dimateriali (cfr. ultra).
Il secondo momento costruttivo, riscontrato in tuttii saggi, coincide con una fase di ricostruzione e parzialimodifiche dell’assetto precedente e si data sulla basedei materiali presenti sui piani d’uso e rinvenuti nellecolmature dei pozzi. Per quanto riguarda le strade, men-tre viene dismessa quella più orientale, su cui si impo-stano due larghi muri fondati sul tenace battuto stradalee un pozzo, rimane in uso quella occidentale da cui pro-babilmente si accede a un complesso ipogeico di cuidirò brevemente più avanti. In altri settori dello scavoil riutilizzo delle strutture più antiche è documentato dauna serie di raddoppi delle murature, probabilmentecollegati all’innalzamento delle case, e dalla realizza-zione di due forni domestici, lasciando intendere la ne-
27 Lo scavo, realizzato a più riprese nel corso di diversi mesi eliberalmente sostenuto dal proprietario dell’immobile Ing. Feca-
rotta, è stato condotto sul campo da Emanuele Canzonieri a cui sidevono anche i rilievi e lo studio dei materiali.
28 PEnSabEnE Patrizio 2008, p. 35; barrESI Paolo 2008, p. 150-152.
238
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
Fig. 3 - a - area nord-est di piazza Magione, ubicazione di palazzo Statella; b - palazzo Statella, planimetria dei saggi di scavo; c - palazzoStatella, tipologie delle case della prima fase edilizia; d - palazzo Statella, ortofoto delle strutture murarie di età islamica.
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
FranCESCa SPaTaFOra - EManUELE CanzOnIErI
cessità di un ampliamento degli spazi abitativi connessoa un probabile incremento demografico (fig 4a-b).
La datazione alla fine del X-inizi XI secolo si fonda,anche in questo caso, sulla presenza di una serie di pro-duzioni locali e d’importazione (cfr. ultra).
Con questa seconda e ultima fase, obliterata da unlivello omogeneo di terreno marrone scuro dello spes-sore di oltre un metro su cui venne costruito il palazzo,è collegato, come accennavamo prima, un complessoipogeico: si tratta di due camere comunicanti a piantapressoché circolare, di cui è stata indagata esaustiva-mente quella occidentale, dal diametro di circa m 4,50(fig. 4c-d). riutilizzato in età moderna per gli scarichidel palazzo, l’ambiente, interamente scavato nel bancodi calcarenite e caratterizzato sul lato nord-orientale dauna banchina, ha un’altezza di circa m 2.00; sul latoorientale vi si trova un pozzo a sezione quadrangolaree sullo stesso lato si apre un varco in parete largo 90cm e alto 80 che immette in una seconda camera di cui,tuttavia, non è stato possibile effettuare lo scavo. Le di-mensioni, il probabile accesso dalla strada, la presenzadei pozzi, lascia pensare che possa trattarsi di luogo de-stinato a un’utilizzazione pubblica. I livelli di abban-dono e di colmatura della camera restituiscono materialidatabili entro la prima metà dell’XI secolo (cfr. ultra)ma è interessante il fatto che essi comprendano anche,in giacitura secondaria, alcuni reperti provenienti da uncontesto tardo antico – piatti in T.S., del IV secolo(Hayes forma 46), brocchette monoansate di poco piùtarde, una lucerna di produzione africana – attestandoquindi, per quell’epoca, una frequentazione dell’area do-cumentata anche nei livelli più antichi dello scavo diS. Maria degli angeli 29.
Concludo con una notazione di carattere topograficoche nasce anche dall’osservazione dell’evidenza ripor-tata alla luce rispetto al tessuto urbano moderno, rite-nendo che ciò, pur suscitando tutta una nuova serie diproblemi, possa forse costituire un interessante puntodi partenza per la ricerca futura.
Una semplice osservazione della la foto aerea e dellacarta tecnica di Palermo ha permesso di notare, infatti,una netta discontinuità nel tessuto urbanistico dell’areasu cui insiste il Palazzo Statella Spaccaforno rispettoalla rimanente parte del quartiere della Kalsa: tutta laviabilità “moderna” sembra delineare un rettangolo ca-ratterizzato da una maglia regolare con orientamentoSO/nE che si distacca nettamente dal tessuto circo-stante sia a nord che a Sud dove, rispettivamente, laviabilità è chiaramente riferita al successivo taglio della
Via alloro – la Ruga Nova de Alammannis 30 che di-verge di diversi gradi rispetto all’orientamento dellestrade di “Piazza Magione” – e al segno forte costituitodalla cinta muraria (fig. 5). Questa maglia, che ha quindieguale orientamento rispetto al tratto di abitato ripor-tato alla luce al di sotto del Palazzo Statella Spacca-forno, si segue agevolmente in un’area che ha comelimite sud-occidentale l’attuale via Teatro garibaldi ecome confine nord-occidentale la via Francesco riso,delineando un rettangolo il cui lato breve misura circa150 m ovvero 300 cubiti. anche il lato nord-est appareabbastanza chiaramente indicato dal fronte orientale, di-vergente rispetto all’allineamento sulla strada, dellastecca di case lungo la Via Vetriera e ugualmente il frontesud-orientale è segnato dalla moderna via che ne segnaoggi il limite su quel lato. all’esterno di questa ampiaarea, due vie, che incrociano perpendicolarmente i latilunghi del rettangolo, sono caratterizzate da ugualeorientamento, una a nO e una a SE: la prima, ricalcataall’attuale vicolo Caccamo all’alloro, scende in dire-zione delle aree portuali; la seconda, più ampia e coin-cidente con l’attuale Via Carmelo Pardi, è postaperfettamente al centro del lato lungo sud-orientale.
Ovviamente non è possibile, sulla base di questa sem-plice osservazione connessa all’attuale viabilità, tirareconclusioni di carattere generale sull’organizzazione to-pografico-urbanistica della città in periodo islamico nétantomeno è possibile al momento stabilire l’eventualepertinenza del tratto di abitato di Palazzo Statella Spac-caforno alla Khāliṣa o al più popoloso e popolare Ḥaratal-jadīda. Vorrei però sottolineare come sia oggi pro-blematico, anche alla luce delle scoperte dello Steri edi Via butera, sostenere l’ipotesi di localizzazione dellacittadella emirale in una zona dove la documentazionearcheologica indica, per l’età islamica matura, l’esi-stenza di un’ampia area artigianale che, almeno versoil mare, soppianta una precedente necropoli della primaetà islamica sviluppatasi nei decenni successivi in di-rezione Sud-Est. È indispensabile, invece, e senza pre-clusioni, incrociare i nuovi dati con quelli relativi aicontesti rinvenuti a Palazzo Campofranco (fig. 5.a), Pa-lazzo bonagia 31 (fig. 5.b), Palazzo Sambuca 32 (fig. 5.C)
29 Cfr. supra il contributo di ardIzzOnE Fabiola, PEzzInI Elena,SaCCO Viva.
30 d’angELO Franco 1998, p. 29.31 dI STEFanO Carmela angela 1997-1998, p. 575-577; TISSEyrE
Philippe 1997, p. 485-486.32 SPaTaFOra Francesca 2005, p. 65-66.
240
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
Fig. 4 - a - palazzo Statella, schema con i principali interventi della seconda fase edilizia; b - palazzo Statella, il muro della seconda fase che in-terrompe la strada orientale; c - palazzo Statella, planimetria e sezione del complesso ipogeico; d - palazzo Statella, l’interno del complesso ipo-geico.
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
e al Convento della Magione 33 (fig. 5.d) nonché congli interessanti ambiti produttivo-artigianali, alcuni deiquali più tardi, scoperti in Via Lungarini 34 (fig. 5.E) eal Teatro Santa Cecilia 35 (fig. 5.F), precisando quantopiù possibile la cronologia e la tipologia dei vari con-testi di scavo attraverso lo studio analitico della cera-mica e delle strutture in modo da delineare, in unavisione di lunga durata, la fisonomia del quartiere nelcorso delle sue diverse fasi di utilizzazione.
F. S.
Palazzo Statella Spaccaforno: i materiali
Il contesto stratigrafico rilevato nei saggi di PalazzoStatella Spaccaforno ha offerto la possibilità di isolaredue principali fasi di vita grazie a gruppi di materiali
associati ai livelli di calpestio delle strutture abitative.altre informazioni provengono inoltre dai riempimentidei pozzi che restituiscono materiali ceramici e resti dipasto. I reperti più recenti di queste colmature datanol’abbandono dell’insediamento o, almeno, la definitivacessazione della struttura abitativa casa/pozzo unifami-liare.
La prima fase ediliziaUna selezione preliminare dei reperti associati alla
prima e più antica fase edilizia consente di individuarealcune principali classi ceramiche (fig. 6a).
Tra le forme da mensa invetriate si segnalano alcuniframmenti di catini importati dall’Ifrīqiya, come unfondo recante un uccello stilizzato, forse uno struzzo,databile alla fine del IX secolo 36. al medesimo periodo
33 dI STEFanO Carmela angela 1993, p. 271-275; dI STEFanOCarmela angela, TOMaSELLI Franco, d’angELO Franco, garOFanOIrina 1997.
34 SPaTaFOra Francesca 2005, p. 66; d’angELO Franco 2005;
gIOIa Caterina, d’angELO Franco 2007.35 SPaTaFOra Francesca, dI LEOnardO Laura, CanzOnIErI Ema-
nuele, in c.d.s.36 LOUHICHI adnan 2000a, p. 122, p. 131, fig. 8/11.
Fig. 5 - Carta schematica dell’area della Kalsa con l’ubicazione di contesti residenziali, produttivi e funerari.
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
Fig. 6 - a - Palazzo Statella, esemplificazione dei materiali associati alla prima fase edilizia; b - palazzo Statella, esemplificazione dei ma-teriali associati alla seconda fase edilizia.
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
FRANCESCA SPATAFORA - EMANUELE CANZONIERI
potrebbero appartenere alcuni frammenti di catini conalta carena e parete sub-verticale desinente in un orloestroflesso, decorati a motivi in verde e bruno a scom-parti sotto una vetrina di colore giallo intenso, ed ungrande catino (diametro superiore a 30 cm), sempre convetrina gialla, in cui si riconosce il motivo zoomorfodell’uccello con alto collo rettilineo e piccola testa trian-golare. Lo stesso profilo a parete sub-verticale e carenaalta si documenta anche in esemplari non rivestiti, al-cuni dei quali con orlo dentellato. Gli esemplari non ri-vestiti, forse appartenenti ad una produzione localeleggermente più tarda, appaiono generalmente di di-mensioni più contenute rispetto ai manufatti invetriati.
A produzioni di pregio importate si riferiscono anchealcuni catini rivestiti con una vetrina verde-azzurro chepresenta un effetto dorato, un esemplare dei quali pre-senta una dentellatura sul piede 37. Per quanto concernele forme chiuse da mensa, al X secolo rimanda ancheun residuo ricomponibile di una brocca ad impasto ca-moscio scuro, con carena fra corpo e spalla, becco ver-satoio e decorazione applicata a nastri verticaliseghettati 38.
Il panorama dei contenitori è rappresentato da un’an-foretta a profilo globulare con collo restringente ed ansesegnate da una marcata solcatura che determina quasidue nervature parallele, simile al tipo D’AngeloB1/B2 39, e da un piccolo orcio con collo verticale de-corato con una pennellata ondulata e corpo segnato dapennellate a tratti verticali. Ai contenitori da senia ri-mandano alcuni frammenti di due principali tipi di ma-nufatti: il vaso da noria appartenente alla tipologiarecentemente proposta come indicatore del periodo isla-mico precoce 40 e un tipo caratterizzato da un orlo ar-rotondato ripiegato su se stesso, profilo lievementecarenato, corpo tozzo ed estremità inferiore ingrossatae ombelicata, mentre le pareti presentano uno spessorenotevole. Questo stesso tipo di contenitore è stato rin-venuto anche all’interno di un butto nello scavo del cor-tile del Palazzo Arcivescovile 41.
Tra la ceramica da fuoco si segnala una piccola ollacon orlo ingrossato modellato a dentelli ed estroflessoe un’olla caratterizzata da una piccola ansa impostatasu un orlo a nastro con scanalatura 42. Alla cottura ri-manda anche un nutrito gruppo di frammenti di un testoin pietra grigia levigata (calcare) che rimandano ad unaforma piatta con breve orlo a sezione triangolare e preserettangolari 43.
Per quanto riguarda la ceramica per l’illuminazione,ben rappresentata numericamente è la lucerna a vascachiusa con presa rampante appena accennata e cortobecco triangolare, sia con uno spesso rivestimento ve-troso e decorazione in verde e giallo, sia acroma 44.Un’altra tipologia è quella della lucerna a cupoletta conrivestimento vetroso e decorazione ad archetti alternatiin verde e giallo 45.
Tra i materiali della prima fase edilizia sembra inol-tre opportuno segnalare anche alcuni frammenti di te-gole con superficie segnata da striature, chetroverebbero confronti con esemplari rinvenuti nella Si-cilia centro-orientale 46.
La seconda fase edilizia
I reperti ceramici associati ai livelli d’uso e allestrutture di questa fase denunciano un ambito cronolo-gico compreso tra la metà del X secolo e l’inizio del-l’XI, con una nutrita serie di produzioni locali ed’importazione (fig. 6b). Tra le forme da mensa con ri-vestimento vetroso, si segnalano sostanzialmente due tipidi catino. Al primo appartengono frammenti con pro-filo carenato ed alta parete verticale, orlo lievemente ar-rotondato ed estroflesso, decorati in verde, giallo ebruno e recanti sul cavo una composizione fitomorfa acomparti radiali. La parete è scandita da motivi sinuosiintrecciati all’interno, mentre all’esterno si alternano lar-ghe pennellate ed archi in verde e giallo 47. Il secondotipo, di probabile importazione nordafricana, è rappre-sentato, oltre che da resti frammentari, anche da un esem-plare integro di catino con corpo emisferico desinente
37 Il profilo di questo manufatto appare più morbido, con carenasub-verticale e orlo semplice.
38 Il manufatto trova confronti con un frammento della Magioneed un frammento di Brucato, recentemente riproposti in CACCIA-GUERRA Giuseppe 2009, p. 295-96, fig. 12.
39 Cfr. in ultimo GRAGUEB Soundes, TRéGLIA Jean-Christophe,CAPELLI Claudio, WAKSMAN yona 2011, p. 211, fig. 11.
40 D’ANGELO Franco 2012, p. 52-53.41 SPATAFORA Francesca, DI LEONARDO Laura, CANZONIERI Ema-
nuele c.d.s.
42 Cfr. la sintesi in ARCIFA Lucia, LESNES Elisabeth 1997, p. 406,fig. 2, tipo 2.
43 Tutti i frammenti presentano consistenti tracce di combustionesia all’esterno, sia all’interno, per cui si potrebbe ipotizzare la cot-tura di una sorta di focaccia piatta.
44 DOLCIOTTI Anna Maria 2007, p. 260, fig. 20 e 22 (museo diSultan).
45 Di recente ad es. proposta come indicatore di contesti islamici,in ARCIFA Lucia 2012, p. 21-22, fig. 2b nella versione acroma.
46 Cfr. ARCIFA Lucia 2010, p. 108-111.47 Cfr. in ultimo BAGNERA Alessandra. 2012, p. 30-33.
244
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
in una piccola tesa inclinata verso l’esterno ed aventesuperficie lievemente arrotondata. La stessa tesa marca,con una rientranza, lo stacco con il cavo. Il piede è anu-lare e la parte centrale del cavo è marcata con una leg-gera solcatura circolare. Il manufatto è rivestito con unaspessa vetrina 48 e decorato con quattro larghe pennel-late a colori alternati in verde-azzurro e giallo, ruotantiattorno ad una pennellata centrale resa in giallo 49. Altipo con cavo emisferico appartengono anche alcuniframmenti di catini con profilo più schiacciato, minorecurvatura del cavo e piccola tesa quasi piana. In questocaso la decorazione è resa con motivi triangolari cam-piti fittamente con linee di eguale spessore ed alternatinei colori bruno e verde. La vetrina, molto erosa, è deltipo opalescente 50. Gli strati connessi alle strutture diquesta fase restituiscono anche frammenti di tazze conpresa ad anello e corpo carenato a parete sub-verticale.L’orlo è sottolineato all’esterno da una solcatura, men-tre la decorazione è affidata a pennellate verticali inverde. Anche questi manufatti sono rivestiti con vetrinaopalescente.
Per quanto concerne l’illuminazione, il tipo più dif-fuso, sia acromo che rivestito, è quello a vasca chiusacon profilo tronco-conico e foro di alimentazione se-gnato da un orlo a sezione triangolare. Il becco è cortoe triangolare, con desinenza arrotondata, mentre la presaè rampante ed anch’essa arrotondata. Questo tipo di lu-cerna, ben rappresentato numericamente, presenta alcuneanalogie con esemplari di produzione nordafricana 51 rin-venuti a Sabratha, Sultan e Sidi Khrebish ed anche conesemplari siciliani più tardi, datati tra la fine del X el’XI secolo 52. Un altro tipo, documentato da pochi fram-menti e da un esemplare quasi integro presenta una mor-fologia determinata da una grande presa ad occhielloeccedente l’orlo, un lungo becco canale ed un alto ser-batoio bi-troncoconico con orlo svasato 53.
Per quanto riguarda la ceramica da fuoco, si è quasiintegralmente ricostruita una pentola con quattro preseorizzontali alternate a quattro serie orizzontali di den-tellature a rilievo. Il corpo è cilindrico e modellato altornio lento, il fondo piatto e la parte superiore rien-trante verso l’interno 54.
AL-KHĀLIṣA: ALCUNE CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE NUOVE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE NEL QUARTIERE DELLA KALSA
48 Il colore non è facilmente determinabile, in quanto il manufattoha subito una combustione che ne restituisce un colore grigio scuro.
49 Per le caratteristiche morfologiche generali cfr manufatti ana-loghi rinvenuti al Castello della Pietra, D’ANGELO Franco 1997, p.451-463, ARDIZZONE Fabiola, D’ANGELO Franco, PEZZINI Elena,SACCO Viva 2012, p. 40, fig. 4. e gli esemplari prodotti a Mazaradel Vallo, MOLINARI Alessandra 2012, p. 37.
50 D’ANGELO Franco, 1995, p. 461-463.51 Cfr. DOLCIOTTI Anna Maria 2007, p. 260, fig. 20 e 22 (museo
di Sultan).
52 Per Piazza Armerina, PENSABENE Patrizio, SFAMENI Carla 2006,p. 205.
53 Prodotti simili ma non eguali sono stati rinvenuti fra i mate-riali di scarico della fornace di via Lungarini, D’ANGELO Franco2009, p. 394, fig. 4/foto 5. Cfr. anche ROSSELLO-BORDOy Guil-lermo, CAMPS COLL Juan, CANTARELLA CAMPS Catalina 1969, p. 143-147, tipo II, p. 154, fig. 11.
54 ARCIFA Lucia, LESNES Elisabeth 1997, p. 406-407, fig. 2°, AR-DIZZONE Fabiola, D’ANGELO Franco, PEZZINI Elena, SACCO Viva2012, p. 40, fig. 3/a.
245
Fabiola ardizzone et annliese Nefles dYNamiQUes de l’islamisatiON eN mÉditerraNÉe CeNtrale et
eN siCile : VariatiONs d’ÉCHelle
LA SICILE DANS LA MÉDITERRANÉE ISLAMIQUE
Piero FoisPeUt-ON dÉGaGer UNe stratÉGie militaire islaimiQUe PrOPre aUX
Îles de la mÉditerraNÉe aUX Viie -Viiie sièCles ?david bramoulléla siCile daNs la mÉditerraNÉe Fatimide (Xe-Xie sièCle)Christophe Picardla mÉditerraNÉe CeNtrale, UN territOire de l’islam
LE PROCESSUS D’ISLAMISATION EN MÉDITERRANÉECENTRALE : LE CADRE RÉGIONAL
annliese Nef QUelQUes rÉFleXiONs sUr les CONQUÊtes islamiQUes, le PrOCes-
sUs d’islamisatiON et imPliCatiONs POUr l’HistOire de la si-Cile
adalgisa de simone iN marGiNe alla FisCalitÀ islamiCa iN siCiliamaria amalia de lucal’islamiZZaZiONe del sistema mONetariO iN siCilia Nel PeriOdO
aGHlabita (827-909): l’aPPOrtO del medaGliere del mUseO ar-CHeOlOGiCO a. saliNas di PalermO
Vivien Prigent l’ÉVOlUtiON dU rÉseaU ÉPisCOPal siCilieN (Viiie-Xe sièCle)marie legendreHiÉrarCHie admiNistratiVe et FOrmatiON de l’État islamiQUe
daNs la CamPaGNe ÉGYPtieNNe PrÉ-ṬŪlŪNidemario re, Cristina rognoniCristiaNi e mUsUlmaNi Nella siCilia islamiCa. la testimONiaNZa
delle FONti letterarie italOGreCHe
ÉVOLUTIONS SOCIALES, STRUCTURES URBAINES ETCULTURES MATÉRIELLES : LES VILLES,
UN TERRAIN D’OBSERVATION PRIVILÉGIÉ ?Chokri touihrila traNsitiON UrbaiNe de bYZaNCe À l’islam eN iFrĪQiYa VUe de-PUis l’arCHÉOlOGie. QUelQUes NOtes PrÉlimiNairessobhi bouderbala Les mawāLī À FUsṬāṬ aUX deUX Premiers sièCles de l’islam et leUr
iNtÉGratiON sOCialeroland-pierre Gayraud arabisatiON, islamisatiON et OrieNtalisatiON de l’ÉGYPte À la
lUmière de l’arCHÉOlOGielucia arcifa, alessandra bagnera islamiZZaZiONe e CUltUra materiale a PalermO: UNa riCONside-
raZiONe dei CONtesti CeramiCi di CastellO - saN PietrOrenato Giarrusso, angelo mulone CaratteriZZaZiONe miNeralOGiCO-PetrOGraFiCa di CamPiONi Ce-
ramiCi PrOVeNieNti da CastellO - s. PietrO, dalla CHiesadella GaNCia (PalermO) e da CastellO della Pietra (Castel-VetraNO)
Fabiola ardizzone, elena Pezzini, Viva saccolO sCaVO della CHiesa di saNta maria deGli aNGeli alla GaNCia:
iNdiCatOri arCHeOlOGiCi della Prima etÀ islamiCa a PalermOViva saccol’islamiZZaZiONe a PalermO attraVersO dUe CONtesti di PalaZZO
bONaGia (sCaVi di steFaNO)Francesca spatafora, emanuele Canzonieri al-KHāliṢa: alCUNe CONsideraZiONi alla lUCe delle NUOVe sCO-
Perte arCHeOlOGiCHe Nel QUartiere della KalsaCarla aleo Nero, monica Chiovaro PiaZZa bOlOGNi (PalermO): OsserVaZiONi sU alCUNi CONtesti di etÀ
islamiCa eNtrO il PerimetrO della “madĪNat balarm”Fabiola ardizzone, Francesca agrò l’islamiZZaZiONe a PalermO attraVersO UNa rilettUra della
CeramiCa da FUOCO dei bUtti di Via imeraemanuele Canzonieri, stefano VassalloiNsediameNti eXtraUrbaNi a PalermO: NUOVi dati da maredOlCeFabiola ardizzone, elena Pezzini la PreseNZa dei CristiaNi iN siCilia iN etÀ islamiCa: CONsidera-
ZiONi PrelimiNari relatiVe a PalermO e ad aGriGeNtOletizia arcoleo, luca sineoaNalisi arCHeOZOOlOGiCa di dUe CONtesti della CittÀ aNtiCa di
PalermO: la GaNCia e i “sili” di Via imera (PalermO, iX-X se-COlO d.C.)
ÉVOLUTIONS DES STRUCTURES FONCIÈRES ET DU PEUPLEMENT DANS LES ZONES RURALES :
L’ÉCHELLE MICRO-RÉGIONALE
mohamed Hassen GeNèse et ÉVOlUtiON dU sYstème FONCier eN iFriQĪYa dU Viiie aU
Xe sieCle : les CONCessiONs FONCières (QaṬI‛a), les terres rÉ-serVÉes (ḤIma) et les terres HaBOUs
antonio rotolo, José maría martín CivantossPUNti di riFlessiONe sUll’iNsediameNtO di ePOCa islamiCa Nel
territOriO dei mONti di traPaNialessandra molinari le riCerCHe Nel territOriO di seGesta-CalatHamet-CalataFimi:
riPeNsaNdO ad UN VeNteNNiO di riCerCHe Nella siCilia OCCi-deNtale
alessandro Corretti, antonino Facella, Claudio Filippo mangiaracina CONtessa eNtelliNa (Pa). FOrme di iNsediameNtO tra tarda aN-
tiCHitÀ e etÀ islamiCamaria serena rizzo, laura danile, luca Zambitol’iNsediameNtO rUrale Nel territOriO di aGriGeNtO: NUOVi dati
da PrOsPeZiONi e sCaViOscar belvedere, aurelio burgio, rosa maria CuccoeVideNZe altOmedieVali Nelle Valli dei FiUmi tOrtO e imera set-
teNtriONaleJohannes bergemann FUNde der islamisCHeN PHase im Gebiet VON Gela UNd im HiN-
terlaNd VON aGriGeNtGiuseppe Cacciaguerra l’area meGarese tra il iX e l’Xi seCOlO: UN PaesaGGiO iN traNsi-
ZiONebibliOGraPHie GÉNÉrale
table des matières
Edipuglia srl, via Dalmazia 22/b - 70127 Bari-S. Spiritotel. 0805333056-5333057 (fax) - http://www.edipuglia.it - e-mail: [email protected]